|
GIANNI CASTAGNERI, 30 ANNI DI MISURE
METEOROLOGICHE A BALME (VALLI DI LANZO, TORINO)
Daniele Cat Berro, SMI / Redazione Nimbus
1° aprile 2025
Oggi facciamo gli auguri allo "storico" socio
SMI Gianni Castagneri, da sempre vicino alle attività della nostra
associazione, attento cultore della montagna e per anni sindaco del
piccolo paese di Balme (Alpi Graie, Torino).
Sono passati esattamente trent'anni da quando, il 1° aprile 1995,
prese in carico per conto del Servizio Idrografico e Mareografico
Nazionale / Ufficio Idrografico del Po i rilievi quotidiani delle
precipitazioni, dell'altezza totale del manto nevoso e della neve fresca
in questa bella località a 1450 m nelle Valli di Lanzo, a pochi
chilometri dal confine con la Francia e sovrastata dalle imponenti "Uje"
di Ciamarella (3676 m), di Bessanese (3604 m) e di Mondrone (2964 m).

Balme - frazione Cornetti, marzo 2025: Gianni Castagneri durante la
misura manuale mattutina delle precipitazioni raccolte al pluviometro.
Sullo sfondo, alla testata della Val d'Ala di Lanzo e al confine con la
Francia, la sommità dell'Uja di Bessanese (3604 m).
Qui, peraltro, le misure meteorologiche
iniziarono già nel lontano giugno 1876 per iniziativa di padre Francesco
Denza e del Club Alpino Italiano, nel quadro della
"Corrispondenza Meteorologica Alpino-Appennina" (in seguito
trasformatasi in Società Meteorologica Italiana), riprendendo poi nell'ottobre
1913 per opera del neonato Servizio Idrografico dopo un'interruzione di
21 anni (inizio delle misure continue nel 1929, invece, per quanto
riguarda la neve).
Le misure di Gianni, puntualmente condivise a cadenza mensile con la
redazione di Nimbus, permettono dunque la sopravvivenza di una
lunga serie storica di dati, tra le più interessanti delle Alpi
occidentali italiane soprattutto per l'evoluzione dell'innevamento,
in una fascia di media-bassa montagna in cui il riscaldamento
atmosferico sta sempre più trasformando le nevicate in pioggia.

Il pluviometro manuale di Balme - Frazione Cornetti,
per la misura di pioggia e neve fusa.
Con dedizione e pazienza, Gianni ha proseguito la sua attività fino a
oggi per interesse personale anche a seguito della dismissione - nei
primi Anni Duemila - delle reti di misura manuali e meccaniche del
Servizio Idrografico, sostituite dalle nascenti reti automatiche in capo
alle regioni.
Perché misurare ancora manualmente precipitazioni e innevamento nell'era
dei sensori elettronici? La misura manuale di pioggia e neve
(impegnativa in termini di risorse umane e oggi spesso inattuabile,
peraltro possibile non in continuo ma solo una o poche volte in un
giorno) se condotta con diligenza comporta dei vantaggi in termini di
accuratezza rispetto agli apparecchi automatici, soprattutto in
montagna e in caso di nevicate, consentendo anche di apprezzare
meglio fenomeni che sfuggirebbero alla telemisura (pensiamo ad
esempio a sottili cadute di neve di 1-2 cm che talora sfuggono ai
nivometri a ultrasuoni, o il cui segnale di altezza è talora
difficilmente distinguibile rispetto all'erba sottostante in autunno e
primavera, rendendo difficile la validazione dei dati).
Sia chiaro: non vogliamo apparire anacronistici e nostalgici, giacché
l'automazione e l'evoluzione dei sistemi di misura sono ovviamente
fondamentali nel moderno e capillare monitoraggio atmosferico e
idrologico (che è egregiamente condotto da istituzioni come
Arpa Piemonte,
ente detentore di un'altra stazione, termo-pluviometrica, a Balme-paese).
Ma ci piace ricordare
come anche nell'epoca del telerilevamento e delle rianalisi
meteorologiche a scala globale ci sono ancora qua e là degli
appassionati (ma anche dei professionisti, presso vari osservatori
meteorologici) che come prima attività del mattino si occupano del
"rito" quotidiano delle misure meteorologiche, versando in un
misurino graduato l'acqua raccolta dal pluviometro nelle 24 ore
precedenti, facendo fondere la neve caduta per misurarne l'equivalente
idrico, leggendo l'altezza del manto nevoso e della neve nuova e
annotando i dati su un registro o su un foglio elettronico.
Laddove sia
ragionevolmente possibile mantenerli, i rilievi manuali possono
dunque rappresentare un supporto e un'integrazione delle misure
automatiche, oggi d'altronde fondamentali per garantire un
monitoraggio capillare, continuo e in tempo reale, anche in zone remote
e d'alta montagna prive di presidio umano.
Nel suo primo giorno di attività da osservatore, il 1° aprile 1995,
Gianni rilevò "cielo sereno" e assenza sia di precipitazioni, sia di
neve residua al suolo. Stava infatti terminando un inverno che - dopo la
catastrofica
alluvione di novembre 1994 in Piemonte - si rivelò molto secco, in
attesa di nuove e copiose piogge, e nevicate in montagna, dalla fine di
aprile.
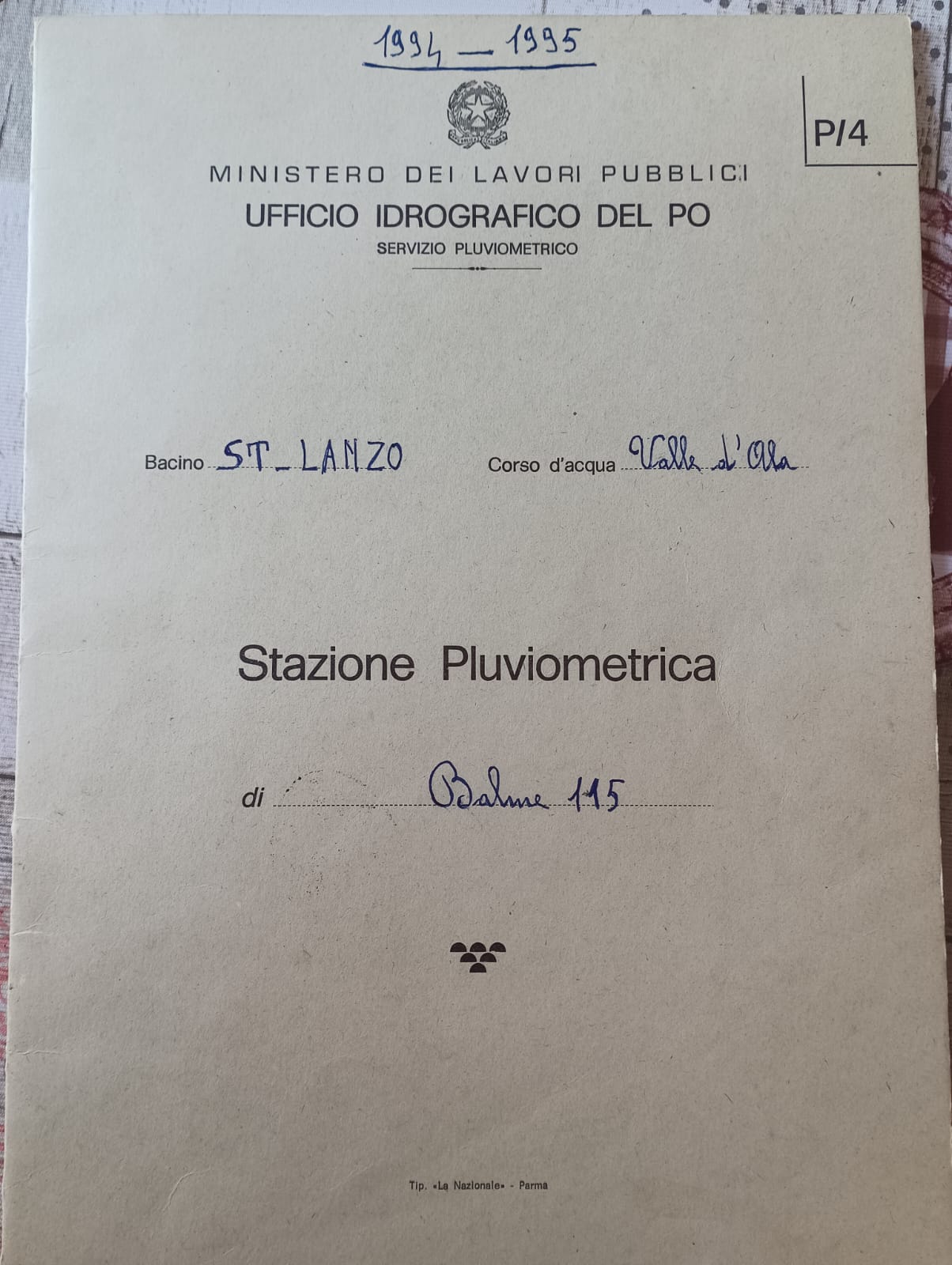
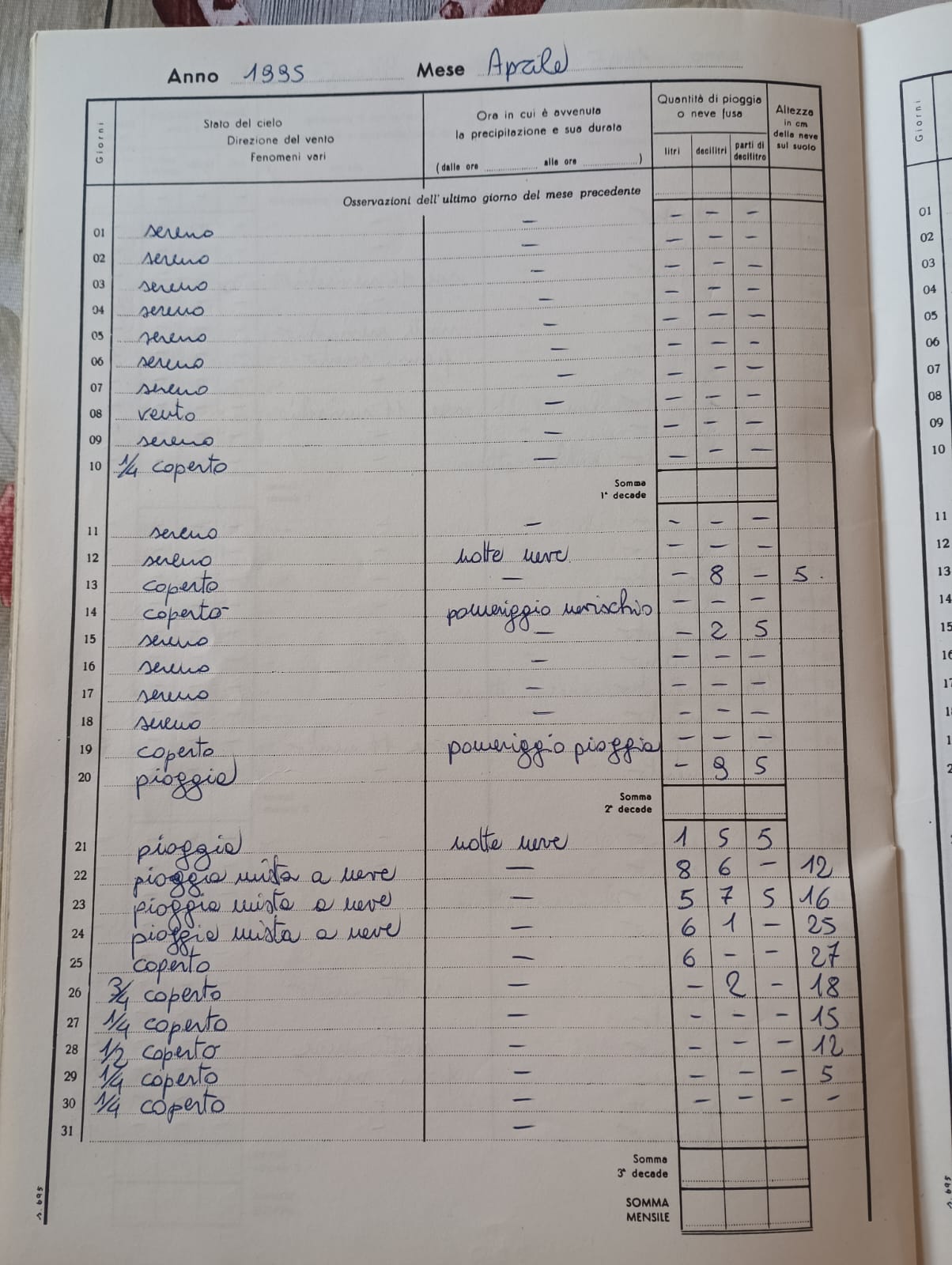
Registro meteorologico di Balme, modello Ufficio Idrografico del Po:
copertina e prima pagina compilata da Gianni Castagneri nell'aprile
1995.
Ma vediamo allora qualche curiosità sul clima di Balme.
Nel trentennio di riferimento standard 1991-2020 risultano in media 1308
mm di pioggia e neve fusa all'anno, con spiccati massimi nelle stagioni
intermedie (prevalente quello primaverile, 178 mm a maggio), 106 giorni
con pioggia e/o neve, 285 cm di neve fresca, e 111 giorni con suolo
innevato per lo più tra fine novembre e metà marzo.
Tra gli estremi giornalieri di tutta la serie secolare, 410 mm di
pioggia durante l'alluvione del 26 settembre 1947, ben 405 cm di neve
totale al suolo il 22 febbraio 1972 e 140 cm di neve fresca il 6 aprile
1969.
Nevicata più precoce il 15 settembre 1972 (12 cm), la più tardiva il 19
giugno 1983 (15 cm), eventi che nel più caldo clima attuale ci paiono
incredibili.
Benché a scala secolare le precipitazioni totali (pioggia e neve
fusa) siano nel complesso stazionarie a Balme, soprattutto dagli
Anni Ottanta l'aumento della temperatura sta notevolmente riducendo
l'innevamento, in termini sia di neve fresca (-28% nell'ultimo
secolo) sia di durata della copertura nevosa (-32%), come attestato pur
tra varie sfumature anche nel resto della regione alpina (vedi gli studi
di
Matiu et al., 2021 per la neve al suolo, e di
Bozzoli et al., 2024 per la neve fresca).
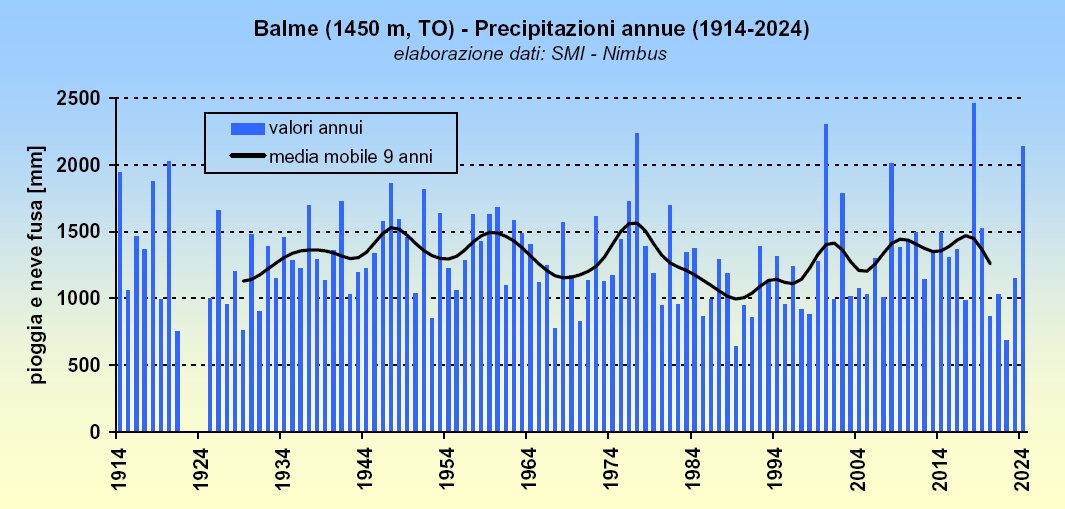
Serie delle precipitazioni annue totali a Balme (pioggia e neve fusa),
serie completa 1914-2024 a eccezione di una lacuna tra il 1922 e il
1924. Al netto di oscillazioni irregolari su scale dell'ordine del
decennio o inferiori - evidenziate dalla linea della media mobile
calcolata su 9 anni con applicazione del filtro di Lanczos - la
serie non mostra tendenze a lungo termine, risultando stazionaria.
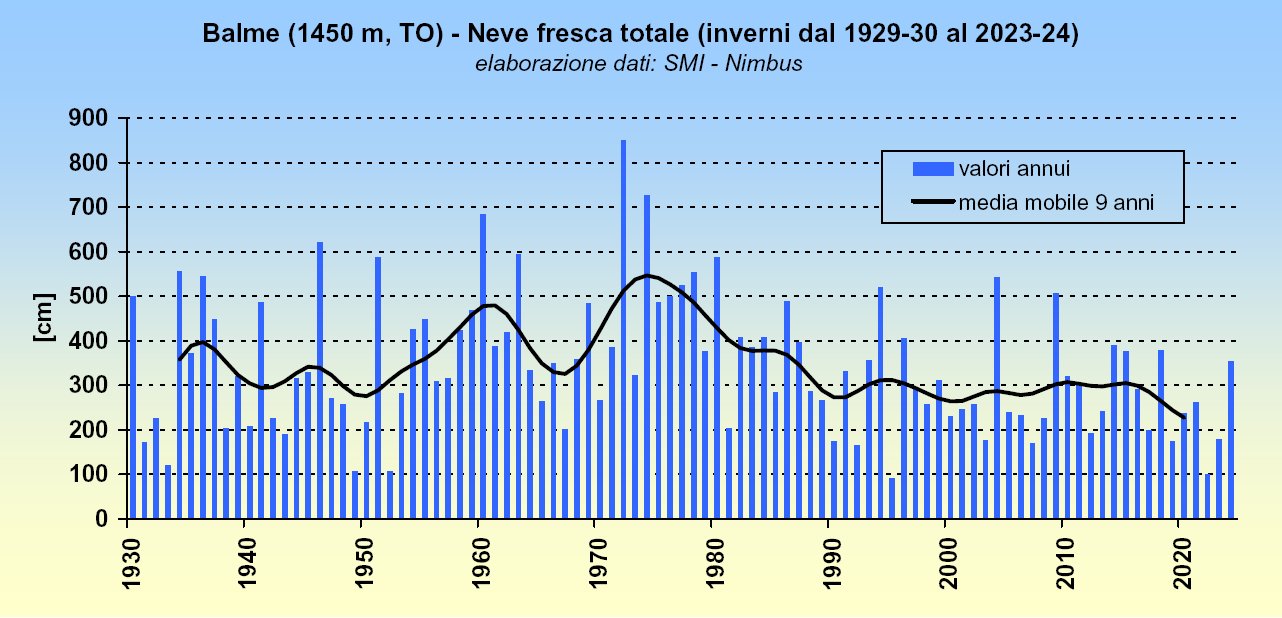
Serie dei totali annui di neve fresca, disponibile con continuità
dall'inverno 1929-30. Per quanto anche in passato non mancassero di
quando in quando inverni poveri di neve, la media mobile raggiunge un
minimo (quasi) secolare proprio negli anni recenti, con il contributo
non tanto di una riduzione delle precipitazioni invernali, quanto
dell'aumento delle temperature che ha trasformato in pioggia parte delle
nevicate di un tempo, soprattutto in autunno e primavera.
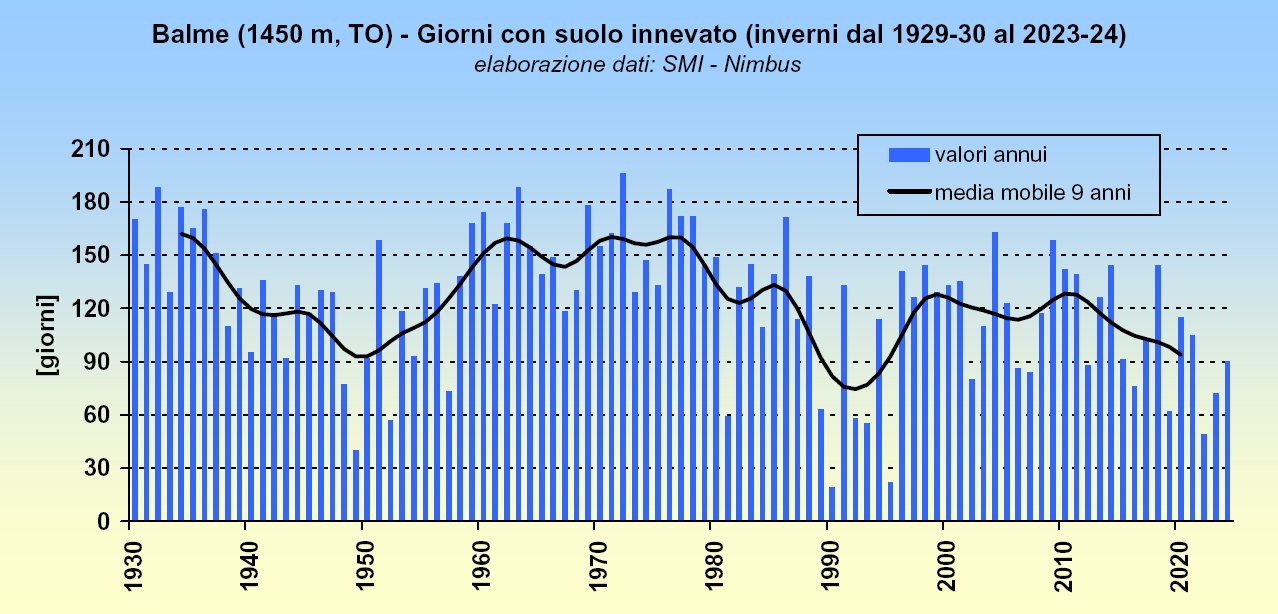
Serie del numero di giorni con suolo coperto da almeno 1 cm di
neve.
Si notano periodi di effimero innevamento già intorno al 1950 e 1990, ma
la riduzione di durata del manto nevoso si mantiene tuttora con una
tendenza netta (-32%) a scala pressoché secolare. La neve, anche
quando cade abbondante, dura meno rispetto alla maggior parte degli
inverni del passato a causa della più rapida
fusione dovuta alle temperature più elevate.
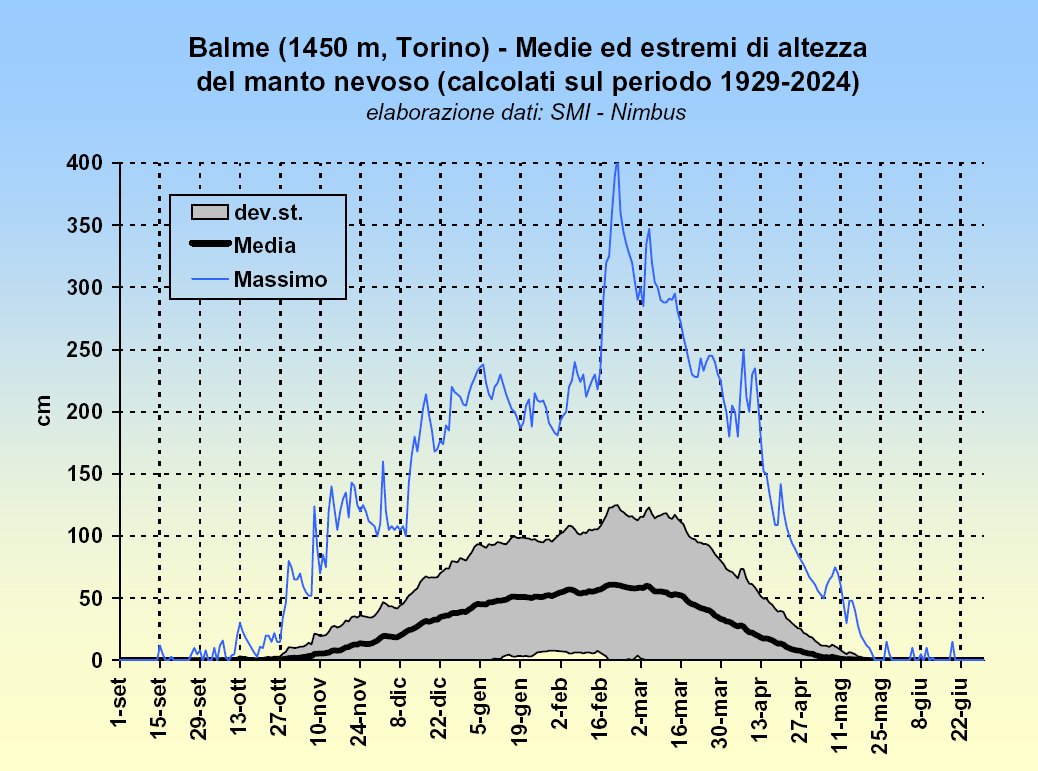
Valori medi, massimi e deviazione standard dell'altezza della neve al
suolo a Balme, calcolati per ciascun giorno della stagione nevosa sui
dati dell'intera serie continua 1929-2024. L'area grigia (compresa tra
le linee di una deviazione standard sopra e sotto la media) indica la
normale (e marcata) variabilità del parametro intorno ai valori medi. Il manto
nevoso comincia solitamente a formarsi nel corso di novembre, culmina
intorno al 20 febbraio (media: 61 cm) per poi esaurirsi in genere entro
aprile, salvo episodi tardivi.
Non ci resta che
augurare a Gianni altri trent'anni di osservazioni, ringraziandolo per
la fedeltà verso la SMI e per l'assiduità nella condivisione dei dati e
di foto che da anni compaiono tra le pagine della cronaca meteorologica
di Nimbus.

|