|
Tra pomeriggio e tarda sera di sabato 29 giugno 2024 violenti
temporali autorigeneranti hanno colpito le Alpi occidentali, con
massimi effetti tra le Valli di Lanzo e il Gran Paradiso, e tra
Cervino, Monte Rosa e Sempione, nonché nelle valli Bavona
e Maggia (Canton Ticino, Svizzera), zone che hanno subito
gravissimi danni per alluvioni-lampo e colate detritiche (5
vittime accertate e 5 dispersi nel comune di Cevio, distretto di
Vallemaggia, Svizzera, e un'ulteriore vittima a Saas-Grund, nel
Vallese).
Le linee temporalesche hanno solo sfiorato le pianure sottostanti in
serata, ma in Alto Canavese (Torino) hanno avuto modo di produrre
episodi distruttivi di grandine e vento.
L'episodio, tra i più rilevanti nel suo genere degli ultimi decenni,
si è esaurito entro le prime ore di domenica 30 giugno, quando
all'alba le prime luci del giorno hanno rivelato appieno la gravità
della situazione.

Distruzione della strada regionale 47 a
valle di Cogne a opera della piena del
T. Grand Eyvia (fonte:
pagina FB Regione Valle d'Aosta).

Cervinia, si lavora per lo sgombero
dell'enorme massa di detriti lasciati
dal T. Marmore (f. Enrico Martinet, La Stampa).

L'impressionante ingrossamento della
cascata del T. Noaschetta, tributario sinistro dell'Orco a Noasca
(Valle Orco, Torino), fin superiore agli episodi storici del 24
settembre 1993 e del 14-15 ottobre 2000 in base a testimonianze ed
evidenze locali, e in ogni caso
eccezionale per la rapidità con cui si è sviluppato, in meno di tre
ore
(f. Danilo Aimonino).
Le cause meteorologiche:
convergenza tra venti da Sud in quota e Sud-Est
al suolo, aria caldo-umida molto instabile
e ricca di vapore acqueo, sbarramento orografico
I fenomeni si sono sviluppati all'avvicinarsi di una
saccatura alle quote della media-alta troposfera sull'Europa
occidentale, con annesso minimo barico al suolo che alle h 16 UTC di
sabato 29 giugno era posizionato sulla Francia centrale (1006 hPa).
Sul loro fianco orientale, al di sopra delle Alpi soffiava un
vigoroso flusso da Sud-Sud-Ovest (in prossimità di un ramo della
corrente a getto), mentre nei bassi strati atmosferici masse d'aria
caldo-umida e molto instabile, con elevati livelli di energia
potenziale per la convezione nonché di vapore acqueo, fluivano da Sud-Est - dall'afosa Valpadana - verso i rilievi torinesi, aostani e
dell'alto Piemonte.
Dal radiosondaggio eseguito alle h 12 UTC (le 14 locali
italiane) del 29 giugno all'aeroporto di Novara-Cameri risultava un indice
CAPE di 2974 J/kg (indicativo di energia disponibile per la
formazione di forti temporali) e ben 46 mm di acqua precipitabile
sull'intera colonna atmosferica, un valore molto elevato e segnale di
un'atmosfera molto umida e propensa allo sviluppo di precipitazioni
intense. Ciò significa che se tutta l'acqua presente nell'aria in
un certo momento sotto forma di vapore condensasse in forma liquida e
precipitasse istantaneamente, produrrebbe una pioggia di 46 mm.
Tuttavia questa non è la massima precipitazione teoricamente possibile
in tali condizioni, perché durante un evento piovoso/temporalesco la
continua avvezione di aria umida (e la sua aspirazione entro i sistemi
temporaleschi) nel corso di svariate ore è in grado di produrre totali
di precipitazione di gran lunga più elevati.
Tra pomeriggio e sera si è quindi venuta a creare una situazione sia
di rotazione del vento con la quota - proveniente da Sud-Sud-Ovest a
circa 5000-6000 m e da Sud-Est al suolo (wind shear) - sia di
convergenza alle quote medio-basse e di divergenza in prossimità
della tropopausa (12-13 km di quota), responsabile della marcata
aspirazione di aria caldo-umida e instabile verso l'alto, dunque di intensi
moti verticali all'origine di celle temporalesche autorigeneranti
per più ore sulle stesse zone. Ad alimentare la produzione di violente
precipitazioni ha pure contribuito la componente di sbarramento
dei venti umidi sud-orientali contro i rilievi.
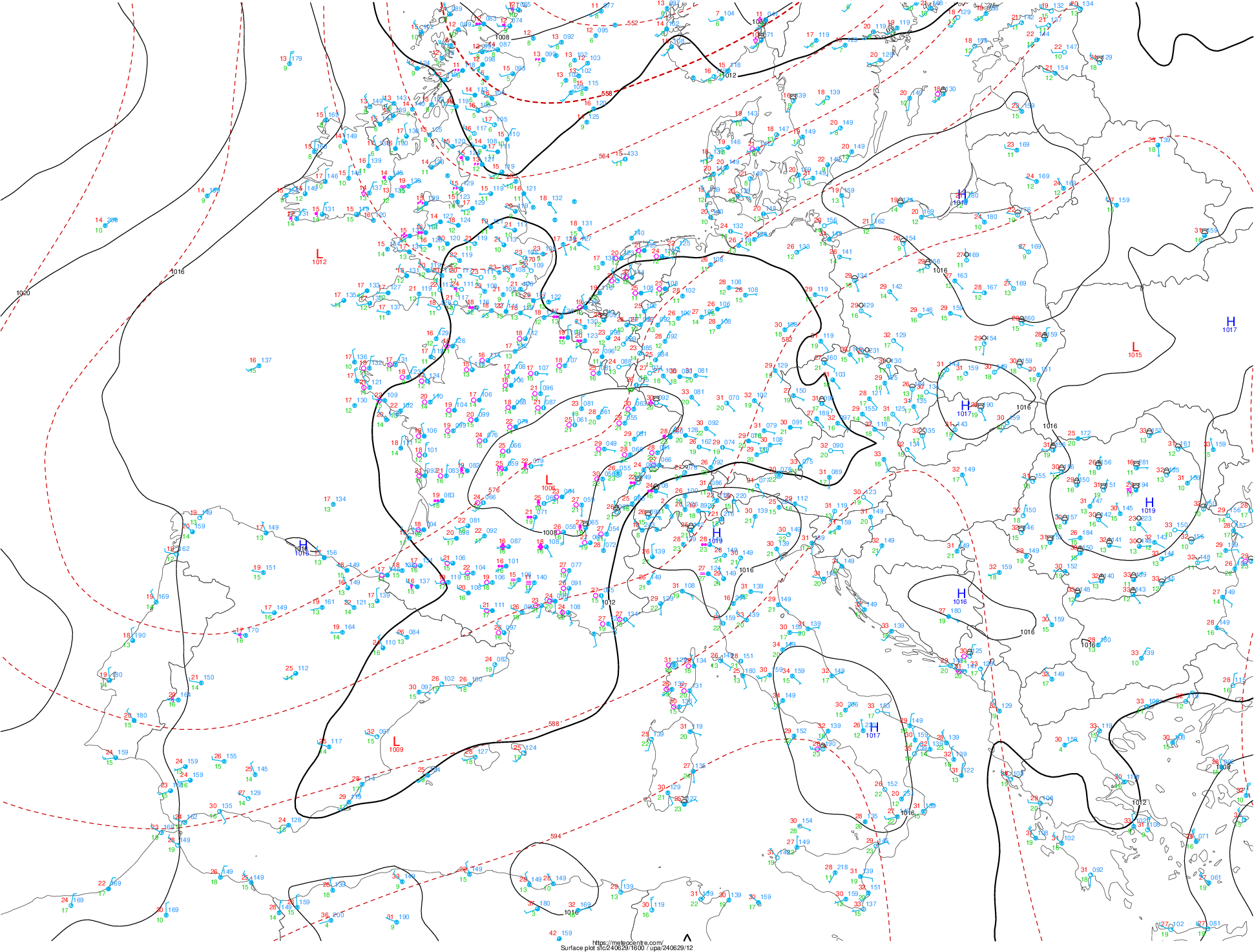
Analisi della situazione
meteorologica in Europa alle h 16 UTC di sabato 29 giugno 2024 (le 18
ora legale italiana), con le isobare e il tempo in atto in superficie,
e (in tratteggio rosso) le isoipse del geopotenziale al livello di 500
hPa, più semplicemente l'altitudine (circa 5800 m sulle Alpi) a cui si
raggiunge tale valore di pressione atmosferica (più in basso nelle
depressioni, più in quota negli anticicloni).
Il tratteggio delinea una saccatura in quota con asse SW-NE
sull'Europa occidentale, contrapposta a un promontorio nord-africano
sul Centro-Sud Italia. Le isoipse a curvatura ciclonica sulle Alpi
occidentali indicano una situazione favorevole all'avvezione di
vorticità positiva, propensa a produrre moti verticali dell'aria,
dunque nubi e precipitazioni. In superficie, tra una depressione sulla
Francia e una blanda alta pressione sulla Valpadana si genera un
flusso di aria caldo-umida e instabile da Sud-Est verso le Alpi
piemontesi e valdostane, con conseguente situazione di sbarramento
orografico (fonte:
Meteocentre).
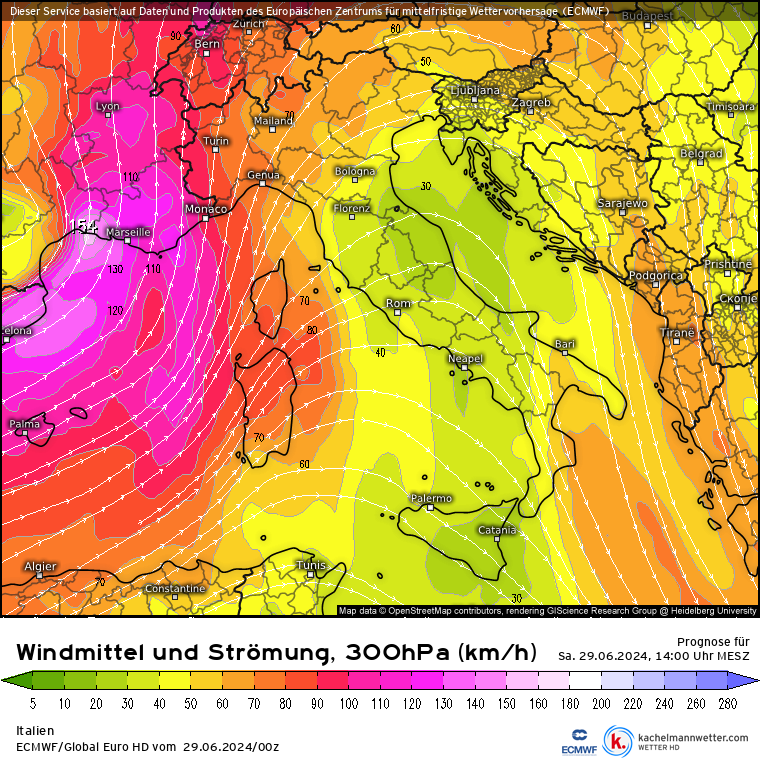
Campi di direzione e velocità del
vento alla superficie isobarica di 300 hPa (circa 9000 m di quota)
previsti alle h 00 UTC del 29 giugno 2024 per le h 12 UTC dello stesso
giorno (le 14 locali in Italia). L'area in magenta delinea, tra il
Golfo del Leone e la Provenza, il "jet-streak", ovvero la regione di
brusco rinforzo del vento in alta quota in seno al ramo ascendente
della corrente a getto, in questo caso con direzione da Sud sulle Alpi
occidentali. Proprio in corrispondenza del getto da Sud si vengono a
creare le condizioni propizie alla brusca aspirazione di aria
caldo-umida e instabile dalla Valpadana, all'origine dello sviluppo di
celle temporalesche autorigeneranti (fonte: ECMWF, via
Kakekmannwetter).
Un primo sistema di celle temporalesche, ben visibile
nelle immagini Meteosat h 13, 14 e 15 UTC (sotto), si è formato nel
primo pomeriggio di sabato 29 ed è migrato dalle montagne torinesi verso N-NE, ma -
per quanto esteso e appariscente - ha prodotto temporali a rapido
spostamento senza ancora generare criticità di sorta.
A produrre i fenomeni più violenti e stazionari in area
alpina, nonché, in serata, le tempeste di grandine grossa e vento
sull'Alto Canavese, sono state invece le celle temporalesche
sviluppatesi in seguito, e visibili nelle immagini dalle h 16 UTC in
poi.
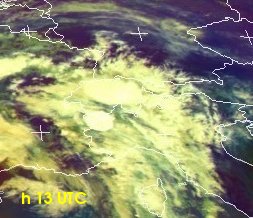
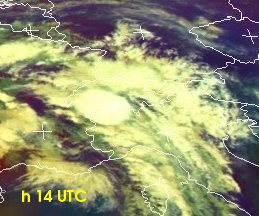
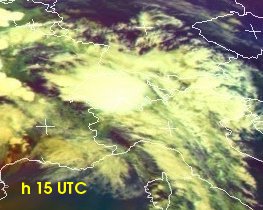 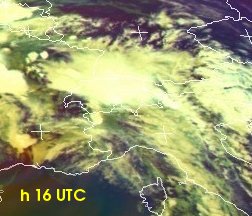
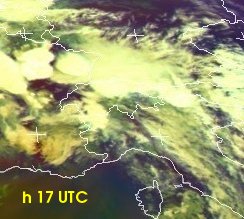
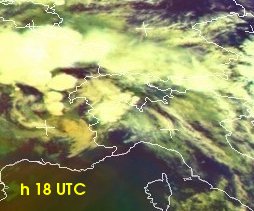
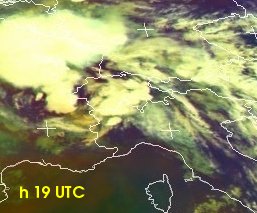 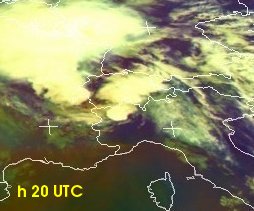
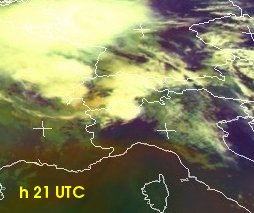
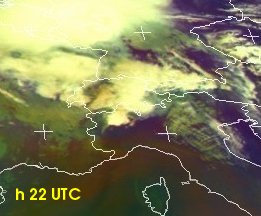
Sequenza oraria di immagini
satellitari Meteosat Second Generation nel canale RGB Airmass, dalle h
13 UTC alle 22 UTC del 29 giugno 2024
(fonte:
visualizzatore immagini Eumetsat).
Rovesci temporaleschi di rara intensità
fin oltre i 3500 metri, e su suoli già saturi d'acqua
per le piogge e la fusione nivale pregresse
(e non tanto per la fusione in corso d'evento)
I più intensi rovesci temporaleschi hanno colpito
dapprima un "corridoio" esteso tra la bassa Val Susa, le Valli di
Lanzo, la media valle Orco e quella di Cogne tra le h 17 e le 21
locali, dopodiché, in serata e nella notte, questi si sono concentrati
maggiormente tra il Monte Rosa e il Sempione, e sul limitrofo Canton
Ticino.

Il frame
radar
Arpa Piemonte delle h 18:50 locali del 29 giugno 2024 mostra lo
sviluppo dei sistemi temporaleschi autorigeneranti lungo un
"corridoio" che dalle valli pinerolesi risale verso N-NE fino alla
bassa Val Susa, alle Valli di Lanzo e al Gran Paradiso. Ulteriori
celle temporalesche si formeranno nelle ore serali più a Nord,
migrando poi fino all'alto Piemonte e al Canton Ticino.
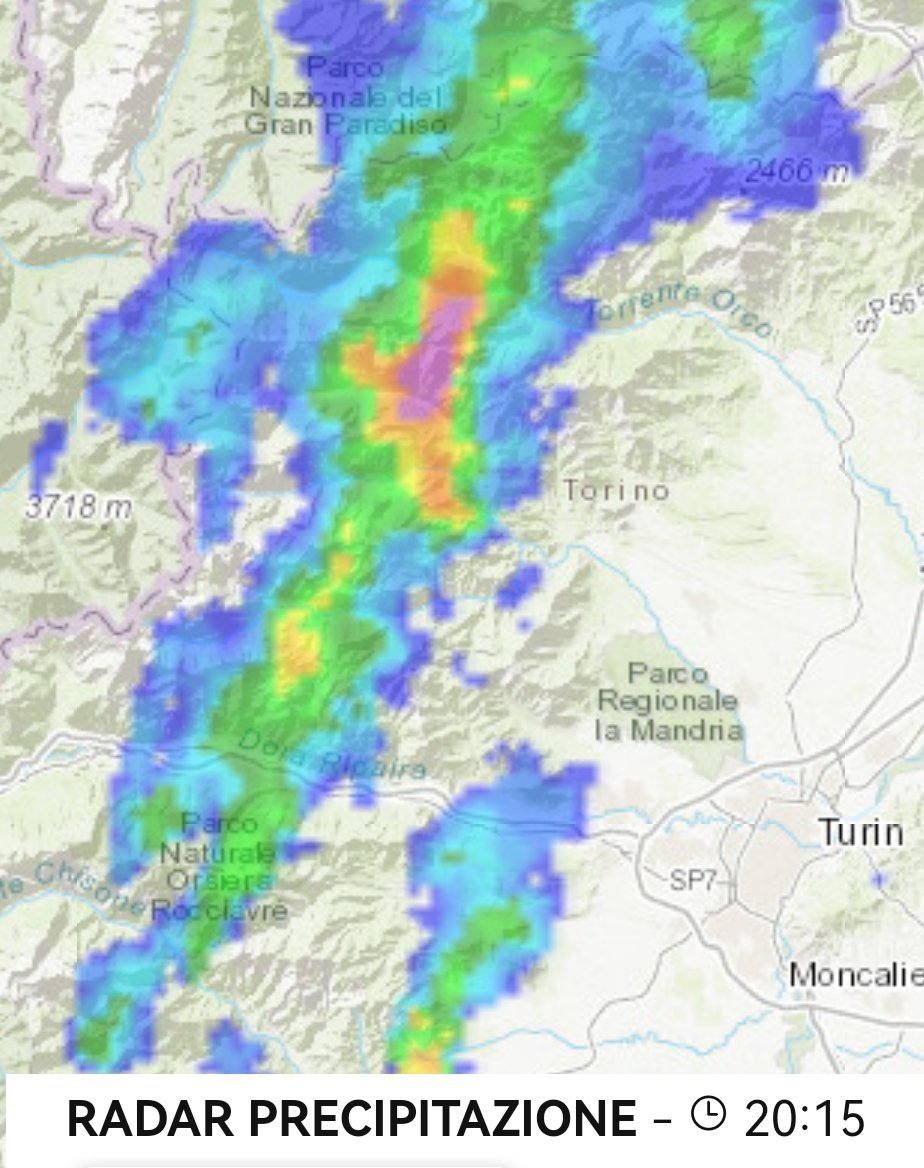
Frame
radar
Arpa Piemonte delle h 20:15 locali del 29 giugno 2024, dettaglio
tra la bassa Val Susa e il Gran Paradiso. In viola un nucleo
temporalesco di particolare intensità (rain rate istantaneo >100 mm/h)
si accanisce tra la Val Grande di Lanzo e la media Valle Orco,
innescando da un lato l'impetuosa piena del T. Vassola a Chialamberto,
dall'altro la colata detritica sulla ex SS 460 a Locana-Fornolosa, e
alimentando la notevole piena del T. Orco e affluenti.
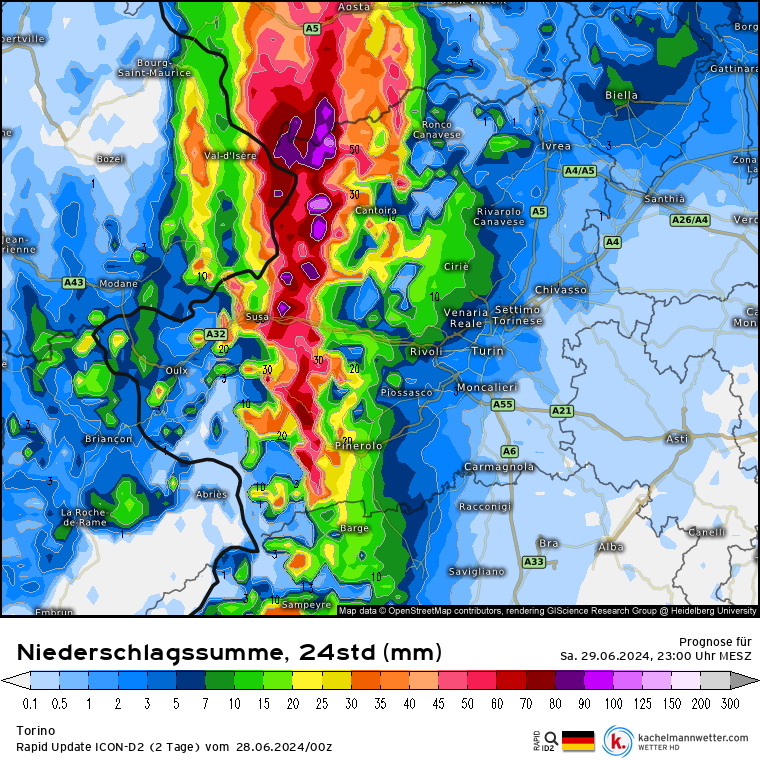
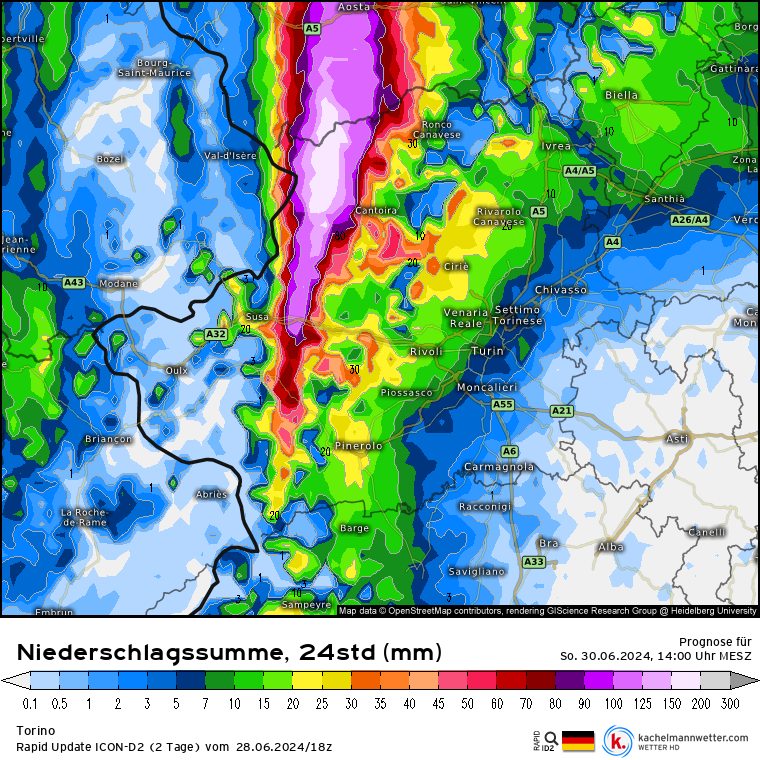
Carte di previsione delle
precipitazioni cumulate in 24 h durante l'evento sulle Alpi Cozie e
Graie (modello ICON-D2), emesse rispettivamente alle h 00 (in alto) e
h 18 UTC (qui sopra) del 28 giugno 2024. La localizzazione del
"corridoio" percorso dai temporali autorigeneranti tra bassa Val Susa
e Gran Paradiso è sorprendentemente corretta, e l'uscita più recente,
a 24 ore dall'evento, migliora nettamente anche la previsione delle
quantità, superiori a 150 mm tra Val Grande di Lanzo e Gran Paradiso
(fonte: modello ICON-D2, via
Kakekmannwetter).
Considerando i totali dell'evento registrati fino al mattino di
domenica 30 giugno dai pluviometri dell'Arpa
Piemonte e del
Centro
Funzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, il centro di
scroscio in territorio italiano si è localizzato all'Alpe Veglia (Valle Cairasca,
Ossola) con 226,3 mm di precipitazione, a seguire in ordine
decrescente troviamo 179,8 mm al Rifugio Zamboni (Macugnaga), 179,0 mm
a Macugnaga-Pecetto, 176,4 mm a Noasca (Valle Orco), 133,6 mm a
Cogne-Lillaz, 130,6 mm ad Alagna Valsesia, 119,6 mm a Cogne-Valnontey,
108,5 mm a Forno Alpi Graie, per citare solo alcuni tra i valori più
appariscenti.
Su intervalli più brevi, di 1, 3 e 6 ore, vale
la pena segnalare:
Noasca (TO): rispettivamente 62,5 mm, 127,2 mm e 155,7
mm
Cogne-Lillaz (AO): 44,6, 96,2 e 114,0 mm
Macugnaga-Pecetto (VB): 34,3, 82,6 e 121,6 mm
Alpe Veglia (VB): 46,8, 95,8 e 162,2 mm
Lago Larecchio (VB): 62,0, 86,7 e 114,9 mm
Le quantità di pioggia più anomale e rare a vedersi
(con tempi medi di ritorno valutati talora in più di 100-200 anni)
sono state registrate in periodi di 3 e 6 ore, che corrispondono
anche alla durata delle fasi di pioggia più intensa.
Ulteriori dettagli sulle precipitazioni registrate si trovano in un
primo approfondimento di Arpa Piemonte, pubblicato domenica 30
giugno, a evento terminato.
Ancora più abbondanti le precipitazioni in
territorio ticinese, con 250 mm caduti a Bignasco (Valle Maggia),
zona particolarmente disastrata (vedi
l'analisi preliminare di MeteoSvizzera).
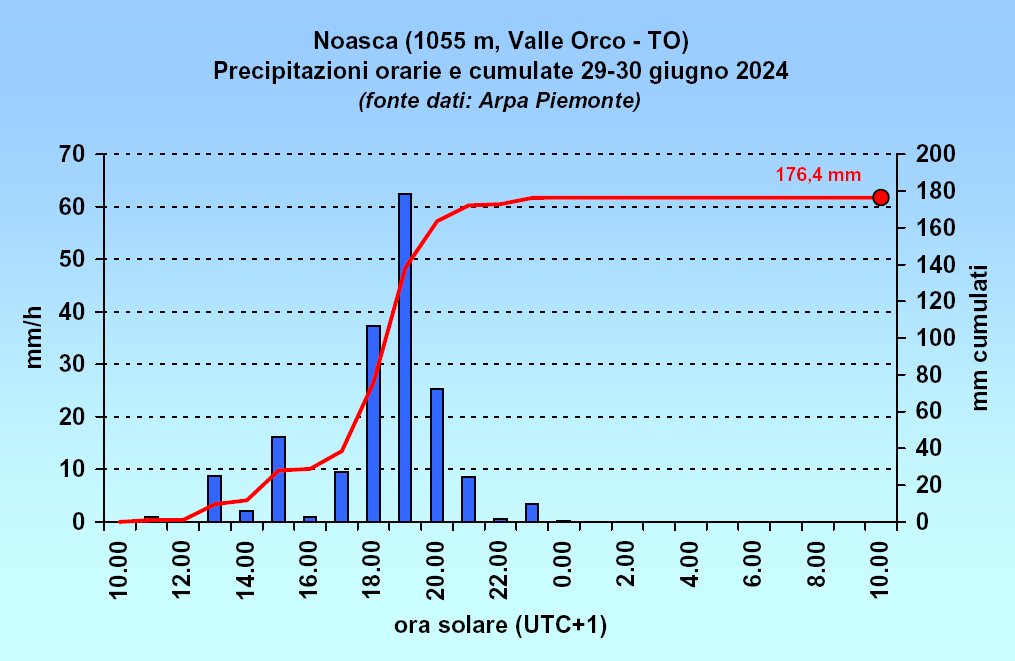
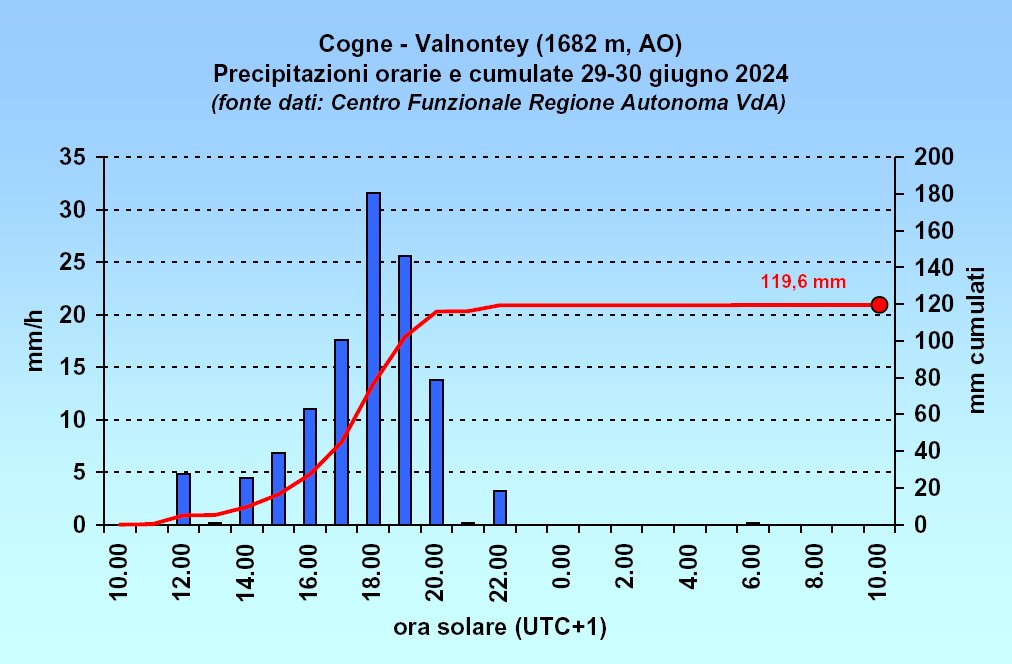
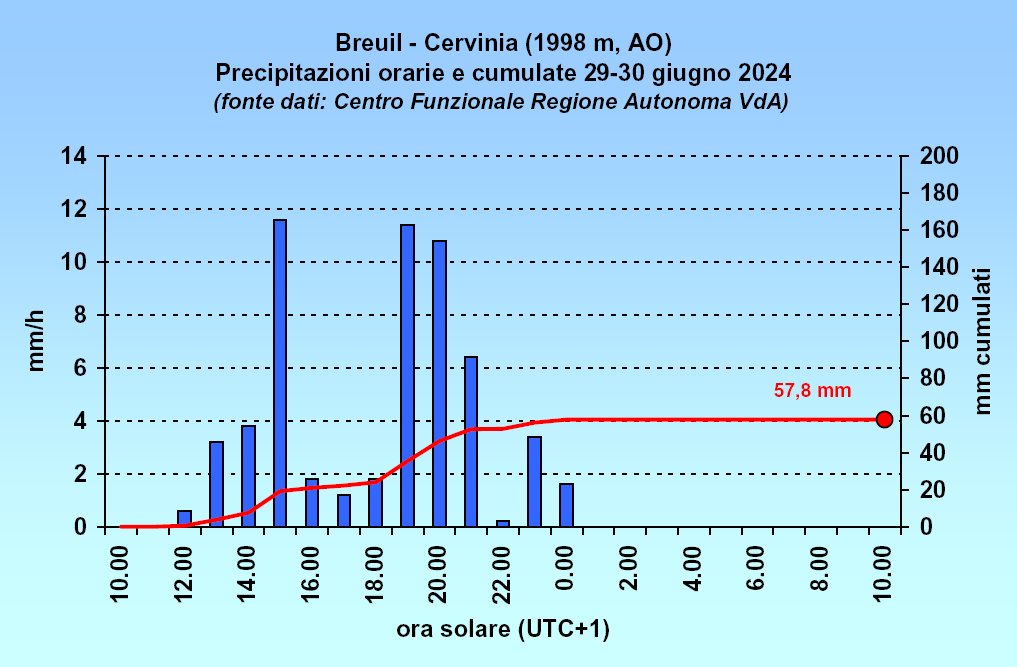
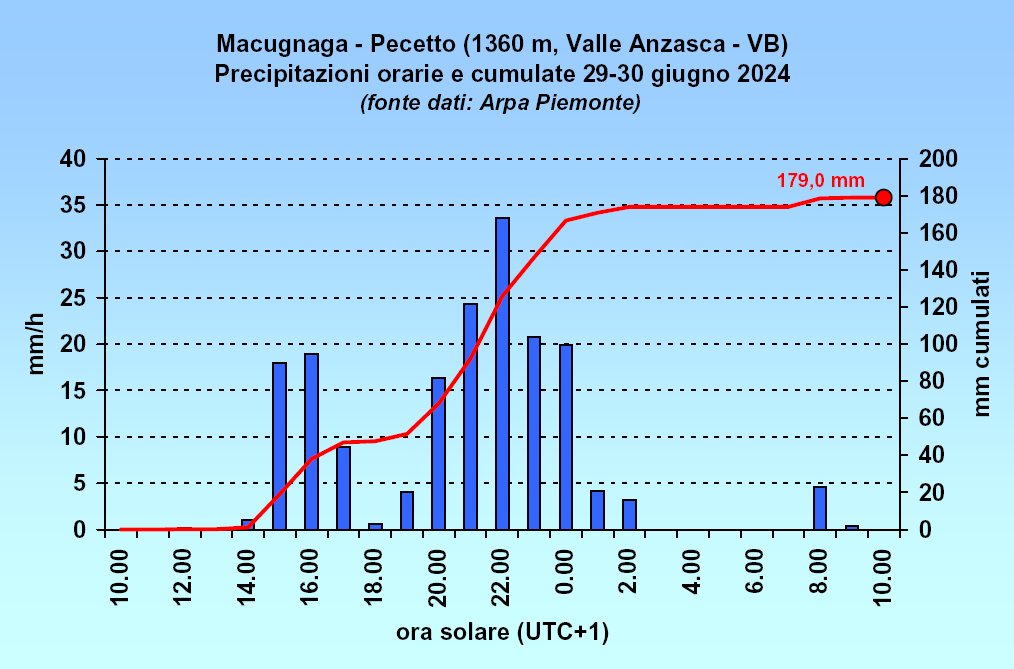
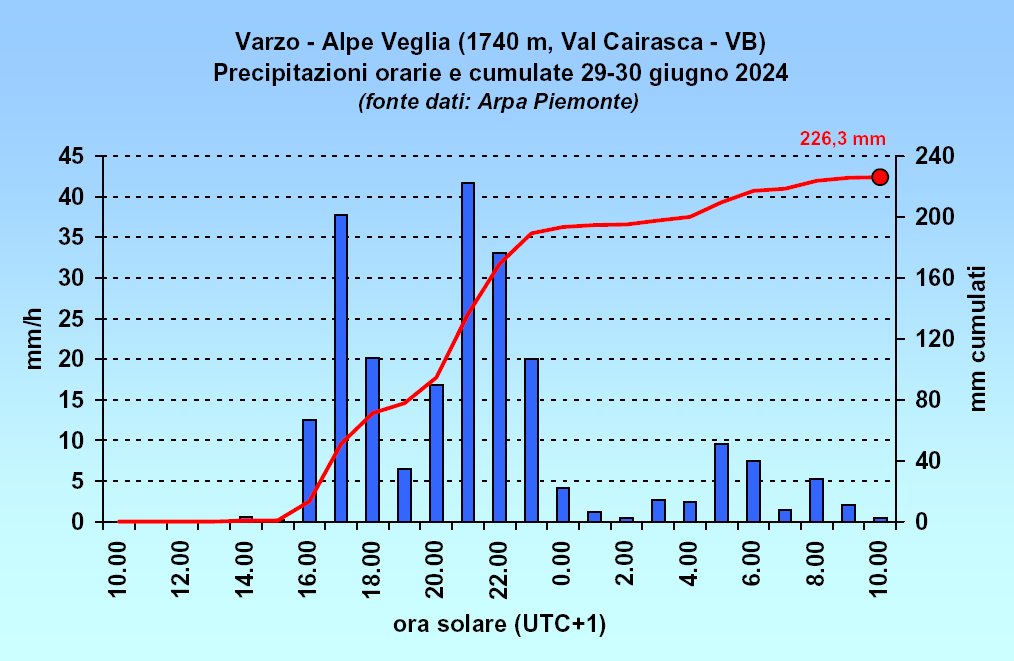
Precipitazioni orarie e cumulate
durante l'evento in alcune località più colpite del Piemonte e della
Valle d'Aosta.
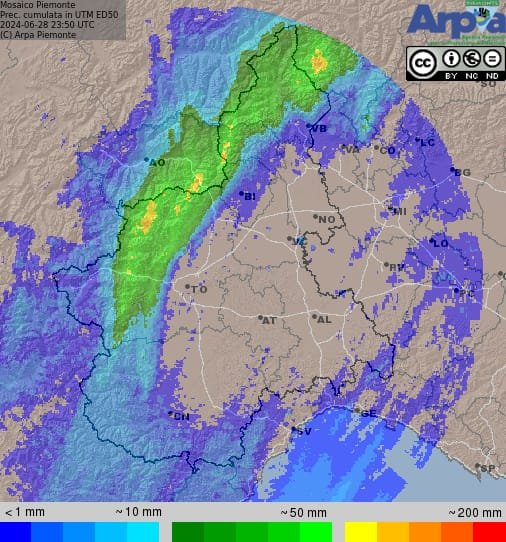
La stima delle precipitazioni
cumulate da radar (Arpa Piemonte), per quanto affetta da sottostime
nelle zone alpine interne soggette a schermatura orografica del
segnale radio, mostra bene la fascia geografica più colpita
dall'evento, estesa dalle valli pinerolesi al Canton Ticino, passando
per il Gran Paradiso e il Monte Rosa, mentre la quasi totalità delle
pianure del Nord-Ovest è rimasta all'asciutto.
Oltre all'intensità in sé dei fenomeni, ai gravi
effetti sul territorio hanno contribuito:
1) la caduta di pioggia fino a quote molto
elevate, probabilmente fino ad almeno 3600-3700 m, all'interno
della massa d'aria calda subtropicale che precedeva l'arrivo del
fronte freddo; durante la fase di precipitazione, alla stazione
meteorologica SMI al Ghiacciaio Ciardoney (2850 m, Gran Paradiso) la
temperatura ha oscillato per lo più tra 6 °C e 7 °C, scendendo poi a
una minima giornaliera di 4,0 °C solo a fine evento, alle h 20 del 29
giugno;
2) lo stato di diffusa saturazione dei suoli,
l'abbondante circolazione di acqua all'interno degli ammassi rocciosi
e gli elevati livelli dei corsi d'acqua
già prima dell'evento, a causa delle straordinarie
precipitazioni pregresse del periodo febbraio-giugno 2024 e della
fusione nivale in corso in queste settimane di inizio estate.
Riteniamo invece che - a differenza di un'opinione
comune - la fusione della neve in corso di evento, sotto la
pioggia intensa, abbia potuto contribuire in misura molto modesta
in proporzione alle precipitazioni.
Sempre riferendosi al pianoro frontale del Ghiacciaio Ciardoney, sia
le misure del nivometro automatico sia le osservazioni dell'asta
nivometrica da webcam indicano che nelle 6 ore di massima intensità
dell'evento pomeridiano-serale lo spessore della neve al suolo (145
cm) non è cambiato in maniera significativa, riducendosi di non più di
2 cm (equivalenti a < 15 mm di acqua equivalente considerando una
densità della neve dell'ordine di 650-700 kg/m3
come rilevato il 5 giugno 2024, e peraltro in porzioni di
territorio relativamente ridotte rispetto ai bacini idrografici
colpiti, dunque con scarso incremento dei volumi defluiti a valle).
Al contrario, la presenza di una copertura nevosa
ancora piuttosto estesa sopra i 2500-2800 m può talora aver limitato
l'azione erosiva delle acque ruscellanti sui fragili sedimenti
morenici in ambiente periglaciale, rispetto a una situazione di tarda
estate in cui questi sarebbero stati maggiormente esposti a
dilavamento ed erosione, con ulteriore contributo all'innesco di
colate detritiche fin dalle quote più elevate e al trasporto solido da
parte delle piene a valle.
In sintesi, la violenta attività torrentizia e i dissesti osservati
sono da ascriversi principalmente al pregresso stato idrologico del
territorio montano (fattore predisponente) e alle straordinarie
quantità di pioggia cadute in 3-6 ore (fattore innescante).
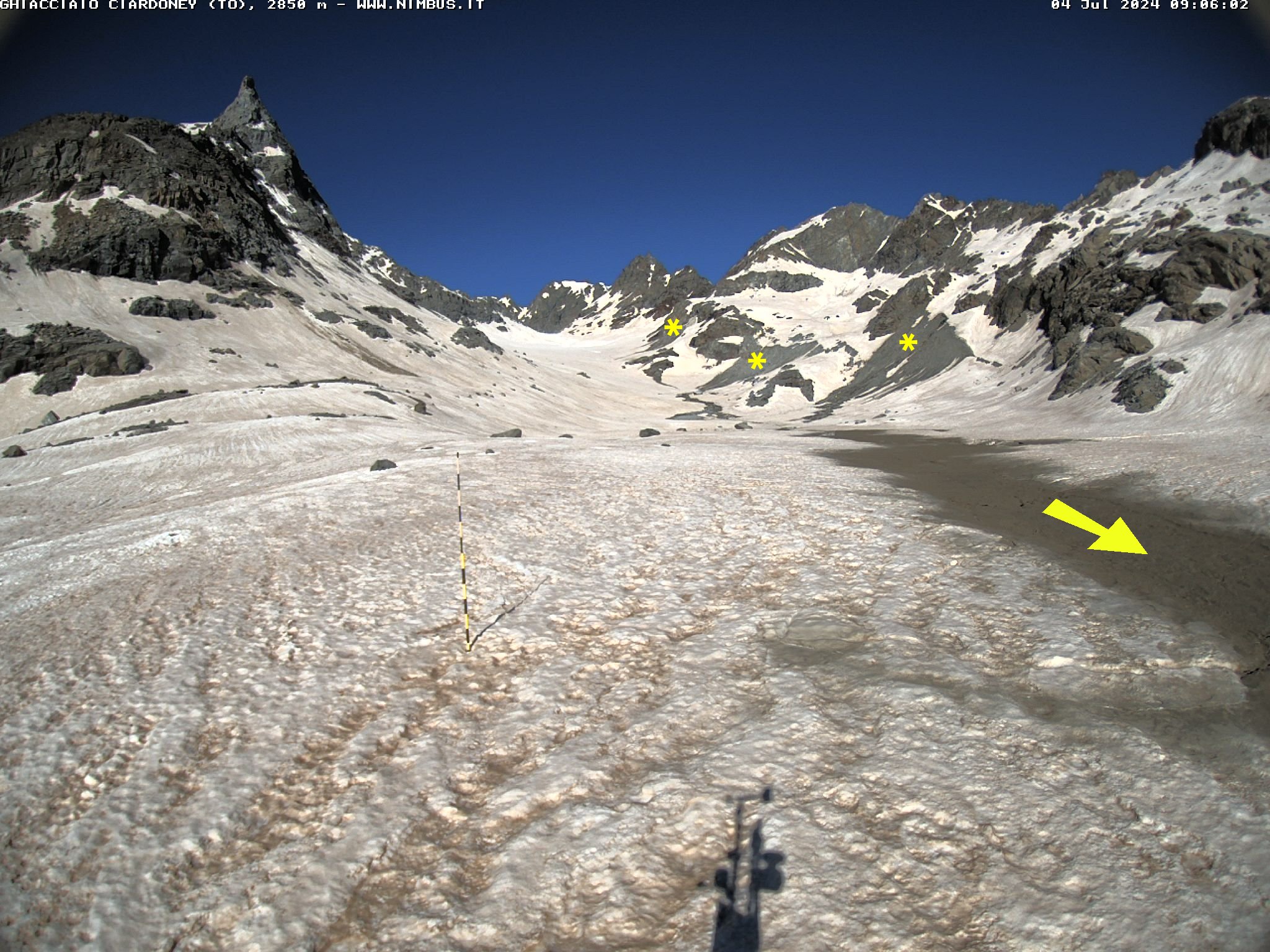
Nell'immagine ripresa dalla
webcam SMI del Ghiacciaio Ciardoney alle h 09 del
4 luglio 2024 si notano (asterischi) le zone di innesco di colate
detritiche avvenute nel tardo pomeriggio-sera del 29 giugno, in
corrispondenza degli unici tratti di morena laterale sinistra già
privi di manto nevoso. Il flusso torrentizio concentrato si è poi
propagato a valle scorrendo sulla superficie della neve fino ai pressi
della stazione meteorologica e oltre. In condizioni di innevamento
meno esteso, come sarebbe stato a fine estate o inizio autunno, a
parità delle altre condizioni meteo-idrologiche l'innesco di processi
torrentizi sarebbe stato potenzialmente ancora più diffuso e marcato.
Lo spessore del manto il 4 luglio 2024 all'asta nivometrica è ancora
di 120 cm, analogo al massimo per la data nella breve serie dal 2012
(125 cm il 4 luglio 2013).
Gli effetti sul territorio: piene torrentizie
e colate di detriti
a rapido innesco
L'aspetto forse più sorprendente dell'evento del 29
giugno 2024 è la rapidità (meno di 3-4 ore) con cui si sono
attivate impetuose piene torrentizie e violente colate detritiche
su molteplici bacini compresi tra la Val Grande di Lanzo e il gruppo
Gran Paradiso-Emilius, tra il Cervino-Monte Rosa e le valli del
Sempione, nonché nella svizzera Valle Bavona.
Pur senza scendere in dettagli di cui la cronache
giornalistiche si sono diffusamente occupate, segnaliamo che le
località più colpite, con pesante coinvolgimento di centri abitati,
infrastrutture e viabilità, sono state, da Sud a Nord:
- Chialamberto (Val Grande di Lanzo), dove il
torrente Vassola, tributario sinistro della Stura di Val Grande, si è
ingrossato come raramente visto nell'ultimo secolo, invadendo alcune
vie del paese (evacuate alcune persone dalle abitazioni più esposte).
- Il tratto di media Valle Orco tra Rosone e Noasca,
località minacciata dalla spettacolare cascata del T. Noaschetta, che
ha sormontato il ponte della ex SS 460, delineando localmente un
evento fin superiore a quelli storici (ma ben più duraturi ed
estesi) del 24 settembre 1993 e 14-15 ottobre 2000; una colata
detritica lungo un minuscolo rio in sinistra Orco ha interrotto la ex
SS 460 presso Fornolosa (transitabilità ripristinata entro il tardo
pomeriggio del 30 giugno); gravemente danneggiata la strada Iren per
la diga del Telessio, diffusamente coinvolta da erosioni e colate di
detriti di grandi dimensioni.
- L'intera Valle di Cogne, interessata dagli
impetuosi straripamenti dei torrenti Valnontey e Grand Eyvia, causa di
ampie erosioni spondali, inghiaiamento di pascoli, asportazione di
vetture da strade e parcheggi, e la distruzione per lunghi tratti
della strada regionale 47. L'abitato di Cogne, rilevato di alcuni
metri sulle aste torrentizie, non ha subito danni significativi, ma è
rimasto per un paio di giorni privo di acqua potabile per la
compromissione dell'acquedotto, ed è tuttora privo di rete internet e
isolato via terra; centinaia di turisti sono stati evacuati in
elicottero; quanto a viabilità è il paese più penalizzato dall'evento
sulle Alpi occidentali.
- L'alta Valpelline, in cui si segnala in
particolare il collasso di una morena del Ghiacciaio delle Grandes
Murailles, con propagazione di un'imponente lava torrentizia nel
vallone sottostante in direzione di Prarayer, e interruzione del
sentiero di accesso al Rifugio Aosta. Il fenomeno ricorda quanto
accaduto il 24 settembre 1993 sulle morene del Ghiacciaio di Mulinet,
a monte di Forno Alpi Graie (Valli di Lanzo). Poco a monte di Prarayer,
asportati i ponti sui percorsi per il Rifugio Aosta e per i colli di
Valcornera e di Livournea.
- L'abitato di Breuil-Cervinia, raggiungibile
via strada regionale 46, ma gravemente sinistrato dall'esondazione del
T. Marmore nella notte tra il 29 e 30 giugno, con ingente trasporto in
massa di detriti derivanti da erosioni di morene ai piedi del Cervino
(settore compreso tra l'Oriondé e il Furggen); gravi danni ad
abitazioni, negozi e alberghi. Per gravità degli effetti, l'evento non
ha precedenti per lo meno da quando la località turistica si è
sviluppata alla metà del Novecento (sviluppo edilizio che
evidentemente ha concorso esso stesso a moltiplicare gli impatti
dell'evento).
- Bassa Valle d'Aosta ed Eporediese: la Dora
Baltea ha inondato in più punti il fondovalle dalla zona di Arnad ai
dintorni di Ivrea (Lessolo, Fiorano, Salerano), con allagamento e
interruzione di strade, pur rimanendo al di sotto dei livelli della
recente
piena del 3 ottobre 2020 (tempesta Alex).
- L'alta Val Sesia, da Alagna fino a Scopa e
Campertogno, nonché nella laterale Val Vogna, ha subito danni a
strade, ponti, sentieri e strutture turistiche.
- Sul versante ossolano del Monte Rosa, Macugnaga
è tra le località più penalizzate dall'evento: ha sofferto
soprattutto, intorno a mezzanotte, gli effetti dello straripamento e
del massiccio trasporto di detriti da parte del Rio Tambach (che
scende dal versante meridionale del Monte Moro) in centro a Staffa,
con grave alluvionamento di abitazioni, esercizi commerciali e
viabilità; erosioni di strade e danni a edifici e infrastrutture
turistiche (tra cui le piste del Burki-Belvedere, con interessamento
dei piloni della seggiovia) anche lungo l'asta del T. Anza, in piena
straordinaria. A memoria degli abitanti del posto, si è trattato
dell'evento alluvionale più grave per il paese in almeno mezzo secolo.
- Valli Divedro e Cairasca: isolata l'Alpe
Veglia per interruzione della strada di accesso da parte di una grande
colata detritica scesa lungo il Rio Croso in località Nembro poco
prima delle h 18 di sabato 2 giugno, evacuati in elicottero 102
turisti.
Chiusa anche la strada del Sempione per analogo fenomeno avvenuto
alle 16:30 di sabato 29 in prossimità della galleria Engi, tra
Simplon-Dorf e il valico.
- Valli Bavona, Lavizzara e Maggia (Canton Ticino): il
nubifragio serale-notturno ha sconvolto i territori a monte di Cevio,
adiacenti all'italiana Val Formazza. Qui si sono avute almeno
cinque vittime (tre delle quali in un imponente trasporto
torrentizio in massa lungo il Ri di Larechia presso la frazione Fontana,
in sinistra orografica della Valle Bavona), ma altrettanti
sono i dispersi. Molti danni anche a Prato Sornico, nella
limitrofa Val Lavizzara.
Piena eccezionale del fiume Maggia, la cui portata a Bignasco in sole
tre ore è passata da meno di 50 a 721 m3/s, massimo in una
serie si misura avviata nel 1982 (nel basso corso del fiume, nel
Locarnese, resta peggiore invece l'evento dell'agosto 1978). Più a valle, presso Cevio, il fiume
ha fatto cedere il ponte di Visletto.
Per il territorio svizzero posto al Sud delle Alpi si tratta della
seconda grave alluvione-lampo nell'arco di una settimana, dopo
l'evento avvenuto il 21 giugno in Valle Mesolcina (Grigioni) sotto
un nubifragio da 84 mm in due ore a Grono (due morti e un disperso, piena storica
della Moesa e autostrada A13 asportata).
Inoltre, sempre riguardo alla Svizzera, le piogge intense cadute nel
pomeriggio-sera del 29 giugno lungo il confine italo-elvetico hanno
determinato ulteriori situazioni alluvionali anche nel Vallese, già
colpito dall'episodio del 20 giugno scorso.
Così lo straripamento
della Vispa ha di nuovo invaso Zermatt,
un uomo è rimasto vittima di una lava torrentizia a Saas-Grund, un
altro è disperso a Binn, e a fondovalle si è propagata una piena
secolare del Rodano (portata di oltre 900 m3/s a Sion), imponendo
l'evacuazione di centinaia di abitanti tra Sierre e Sion e
l'interruzione del traffico autostradale e ferroviario.
Tornando al territorio italiano, la propagazione delle
piene a valle nella notte tra il 29 e il 30 giugno ha portato al
superamento delle soglie "rosse" di livello di pericolo presso
alcune stazioni idrometriche, in modo più appariscente lungo l'Anza a
San Carlo (transito del colmo alle h 00 UTC del 30 giugno), ma anche
lungo l'Ovesca a Villadossola, la Dora Baltea a Champdepraz e a Hone,
l'Orco a Spineto, la Stura di Valgrande a Cantoira e, poco più a
valle, lungo la Stura di Lanzo a Mezzenile (Valli di Lanzo).
In Valle di Cogne l'eccezionale piena della Grand Eyvia ha asportato
la stazione di misura di Cretaz.

Straordinaria piena della
cascata del T. Noaschetta a Noasca, Valle Orco
(f. Danilo Aimonino).

Il T. Orco in piena a Noasca, appena
ricevute le acque del T. Noaschetta. Queste sono riuscite a sormontare
il ponte della ex SS 460 (non visibile nell'immagine), nonostante la
maggiore luce complessiva della nuova struttura realizzata dopo
l'alluvione del 2000
(f. Danilo Aimonino).

A monte di Noasca, il T. Noaschetta
in piena storica ha eroso le sponde e ha notevolmente ampliato il
proprio alveo, coprendo con grossi blocchi e tronchi d'albero la piana
in cui sorgono l'opera di captazione Iren per la centrale
idroelettrica di Rosone, e la casa di servizio con l'annesso
Rifugio Noaschetta della sezione
CAI di Rivarolo
Canavese (quota 1520 m), i cui arredi all'interno hanno subito
danni importanti. Qui i processi torrentizi hanno superato per
violenza quelli (già notevolissimi) del 24 settembre 1993 e 14-15
ottobre 2000. Si notino, in primo piano a destra, gli effetti
dell'impetuoso ruscellamento di acque "selvagge" con notevole
trasporto solido lungo il pendio al di fuori del reticolo idrografico,
anche minore.

Fornolosa (Locana, Torino),
interruzione della ex SS 460 per Ceresole Reale a seguito di una
colata detritica scesa lungo un piccolo rio in sinistra orografica
(foto Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco).
_DanieleCatBerro.JPG)
2_DanieleCatBerro.JPG)
Fornolosa (Locana, Torino),
operazioni di sgombero dei detriti e ripristino
della percorribilità della ex SS 460 nelle ore centrali del 30 giugno
2024
(f. Daniele Cat Berro).

La strada del Vallone di Piantonetto
verso la diga del Telessio (Valle Orco) sconvolta da erosioni e colate
di detriti (f. Sonia Calderola).

Straripamento del T. Valnontey
nell'omonima frazione di Cogne,
la sera del 29 giugno 2024.

Valnontey (Cogne), la piena travolte
auto e camper parcheggiati al campeggio "Gran Paradiso".

Effetti della rovinosa piena
a Valnontey, Cogne.

Cogne, distruzione della strada della
Valnontey a opera della piena dell'omonimo torrente (fonte:
pagina FB Regione Valle d'Aosta).


Cogne, due immagini di alluvionamenti e
danni a ponti
nel Vallone di Grauson (f. Damien Charrance).

Erosione al piede e conseguente
cedimento della SR 47 a valle di Cogne, a opera del T. Grand Eyvia (f.
Marco Foretier).

Il centro di Cervinia invaso dai
sedimenti deposti dall'alluvione del T. Marmore nella notte tra il 29
e 30 giugno 2024 (fonte:
pagina FB Regione Valle d'Aosta).

Cervinia, si lavora per lo sgombero
dell'enorme massa di detriti lasciati
dal T. Marmore (f. Enrico Martinet, La Stampa).
3_EmilianoStabile.jpg)
La Dora Baltea in piena al Ponte
Vecchio di Ivrea all'alba del 30 giugno 2024. Qui il livello delle
acque, per quanto impressionante per il tumulto dei flutti nella forra
che separa il centro della città (a destra nell'immagine) dal rione
del Borghetto (a sinistra), è inferiore agli eventi del 24 settembre
1993, 15 ottobre 2000 e 3 ottobre 2020 (f. Emiliano Stabile).

Alagna Valsesia, il fiume Sesia al
colmo di piena al ponte di Zam Tackj
nella tarda sera del 29 giugno 2024 (f. Michele Cucchi).

Alagna Valsesia, strada della Val Vogna
interrotta da una colata di detriti di grossa pezzatura a Sant'Antonio
(f. Michele Cucchi).

Alagna Valsesia, il fiume Sesia al
termine dell'evento, in località Kreas, presso le antiche miniere (f.
Michele Cucchi).


Due immagini degli effetti dello
straripamento del Rio Tambach nel centro di Staffa, frazione-capoluogo
del comune di Macugnaga (f. Beba Schranz).


Altre immagini dell'alluvionamento di
Staffa di Macugnaga (f. Beba Schranz).

Macugnaga-Staffa: il Rio Tambach ha
cambiato alveo e ora scorre tra le abitazioni
(f. Beba Schranz).


Fontana, frazione di Cevio (Canton
Ticino) prima e dopo il violentissimo trasporto torrentizio in massa
del Ri di Larechia, tributario sinistro del Fiume Bavona. All'evento
sono imputate almeno tre delle cinque vittime accertate dell'alluvione
nell'insieme della Valle Maggia, che alla testata si biforca nelle
valli Bavona e Lavizzara (fonte:
Corriere del Ticino).
Confronto storico: categoria di eventi
relativamente comune d'estate sulle Alpi, ma episodio sorprendente per
intensità, rapidità di innesco ed estensione dei territori coinvolti
Data la varietà di fenomeni meteorologici e dei
relativi effetti sul territorio che hanno colpito molteplici vallate
delle Alpi dal Torinese, alla Valle d'Aosta, all'Ossola, fino al
Vallese e Canton Ticino, una classificazione storica complessiva
dell'evento è complessa e richiederà tempi più lunghi.
Di certo si può affermare che le quantità di pioggia
superiori a 100 mm (talora >200 mm) osservate in alcune località come
Noasca, Cogne, Alagna Valsesia, Macugnaga e l'Alpe Veglia - già di
tutto rispetto se registrate nell'arco di un'intera giornata - a
maggior ragione appaiono rare e straordinarie essendo cadute per lo
più nell'arco di 3-6 ore tra pomeriggio e sera del 29 giugno 2024.
Ad esempio, a Noasca (Torino) nella serie di misura dal 1913
una precipitazione giornaliera di 176 mm (o più) si è verificata in
media una volta ogni 12 anni (massimo di 312,8 mm il 15 ottobre 2000),
ma i 155,7 mm misurati in 6 ore il 29 giugno 2024
rappresentano un massimo su tale intervallo nella serie di dati
orari dal 1943.
Le alluvioni estive sulle Alpi non sono una novità, giacché
svariati episodi punteggiano le cronache storiche anche di decenni
recenti. Restando solo sulle Alpi occidentali, ricordiamo gli
eventi rovinosi del 7-8 agosto 1978 tra Val Vigezzo e Locarnese, del
24-25 agosto 1987 in Val d'Ossola, del 23-24 luglio 1996 in Valle
d'Aosta occidentale, del 13 giugno 2000 nelle Alpi Cozie e Marittime,
del 15 luglio 2002 nelle valli cuneesi...
Tuttavia alcuni elementi rendono peculiare l'evento
recente:
1) L'estrema rapidità con cui violenti processi
torrentizi e di versante si sono sviluppati (talora meno di 3
ore), complici anche condizioni meteo-idrologiche pregresse
particolarmente favorevoli al loro innesco.
2) L'interessamento di svariate località in un
territorio molto ampio compreso tra le Valli di Lanzo, il Vallese
e il Canton Ticino (150 km in linea d'aria separano Chialamberto nelle
Valli di Lanzo dalla Valle Bavona, estremi rispettivamente
sud-occidentale e nord-orientale dell'area in cui sono stati osservati
danni).
3) L'inserirsi dell'episodio in una sequenza di
eventi alluvionali ravvicinati, essendo stato preceduto, solo a
distanza di pochi giorni, dalle gravi alluvioni del 20 giugno 2024
nel massiccio francese degli Ecrins e nell'alto Vallese, e del
21 giugno in Valle Mesolcina, nei Grigioni (analisi
dell'evento di MeteoSvizzera).

La Bérarde, frazione di
St-Cristophe-en-Oisans (Parco Nazionale degli Ecrins), sommersa dai detriti
dell'alluvione del 20 giugno 2024 (foto tratta dall'articolo
sull'evento apparso sulla rivista francese
Alpine).
Benché nei dintorni delle zone oggi colpite non
manchino episodi passati fin peggiori (tra tutti, ricordiamo i
gravissimi eventi estivi del 19-20 agosto 1958 nelle valli del
Sempione, con 387 mm di pioggia in meno di 24 ore a Varzo, e del
7-8 agosto 1978 tra Val Vigezzo, Centovalli e Locarnese, con
apporti superiori a 300 mm e 21 vittime), attenti testimoni
locali affermano che effetti al suolo rovinosi come quelli sofferti
il 29-30 giugno 2024 non abbiano precedenti almeno nell'arco di 50-70
anni, come nel caso di Cervinia e di Macugnaga.
Per quanto riguarda l'eventuale ruolo del
riscaldamento globale, sul singolo evento è molto difficile
pronunciarsi, tuttavia i dati osservativi e modellistici dicono
che precipitazioni brevi e intense all'origine di eventi come
quelli recenti sulle Alpi sono in aumento, in linea con
l'accresciuta evaporazione dagli oceani in surriscaldamento e con la
maggiore capacità dell'aria calda di contenere vapore acqueo, dunque
acqua precipitabile (+7% per ogni grado °C di aumento della
temperatura, secondo la legge di Clausius-Clapeyron).
Di conseguenza le simulazioni
modellistiche per l'Europa indicano che le precipitazioni più intense
osservate nel clima attuale raddoppieranno di frequenza per ciascun
ulteriore aumento di 1 °C di temperatura (Myhre
et al., 2019), con incrementi più marcati sull’Europa
settentrionale e sulla regione alpina.
La sempre maggiore propensione a
piogge intense e concentrate - unita alla tendenza a precipitazioni
liquide a quote vieppiù elevate con l'aumento delle temperature,
nonché alle crescenti instabilità strutturali di ammassi rocciosi e
morene al degradarsi del permafrost - impone riflessioni sulla
gestione dei territori di montagna e la revisione dei criteri di
progettazione di infrastrutture e opere di smaltimento delle acque e
difesa geoidrologica, evidentemente non più adeguati di fronte
agli incalzanti eventi estremi di un clima in cambiamento.
Tempeste di vento e grandine gigante in
Canavese
Oltre ai rovinosi danni alluvionali sulle Alpi, di
assoluto rilievo sono quelli causati da una supercella temporalesca
che verso le h 22 locali di sabato 29 giugno 2024 si è affacciata
sull'estremità nord-occidentale della pianura piemontese, colpendo la
fascia prealpina-pedemontana dell'Alto Canavese (Torino).
Il temporale associato ha prodotto grandine di straordinarie
dimensioni (fino a 8-10 cm di diametro) responsabile della
devastazione di tetti in particolare nel paese di Forno Canavese, ma
danni a edifici, vetture e colture si sono verificati anche in altre
località quali Valperga, Cuorgné, Pont Canavese e sulle colline di
Castellamonte.
Inoltre il fronte di violente raffiche discendenti dai
cumulonembi (downburst) si è spinto verso il bordo orientale della
supercella fino a Busano, Oglianico, San Ponso e Salassa,
scoperchiando edifici e atterrando svariate decine di alberi d'alto
fusto. Una raffica di 118 km/h è stata registrata a Salassa
(stazione amatoriale
SalassaMeteo,
cortesia Gianni Cena), peraltro un po' al di fuori della zona più
colpita.
La dettagliata analisi dei danni, eseguita tramite un sopralluogo sul
posto e il sorvolo della zona con un drone da parte di un gruppo
coordinato da Andrea Vuolo (meteorologo RAI Meteo per il Piemonte),
in collaborazione con il team
Pretemp, ha
permesso di chiarire la natura dell'evento (raffiche "lineari"
discendenti dal sistema temporalesco) e di escludere il passaggio
di un tornado, di cui in un primo tempo vi era il sospetto.
In ogni caso la tempesta di vento e grandine è stata tra le più
intense e dannose di cui vi sia memoria nella zona, per lo meno negli
ultimi decenni, mostrando elementi in comune con la sequenza di eventi del 31 luglio-2 agosto 1998 tra Alto
Canavese ed Eporediese.
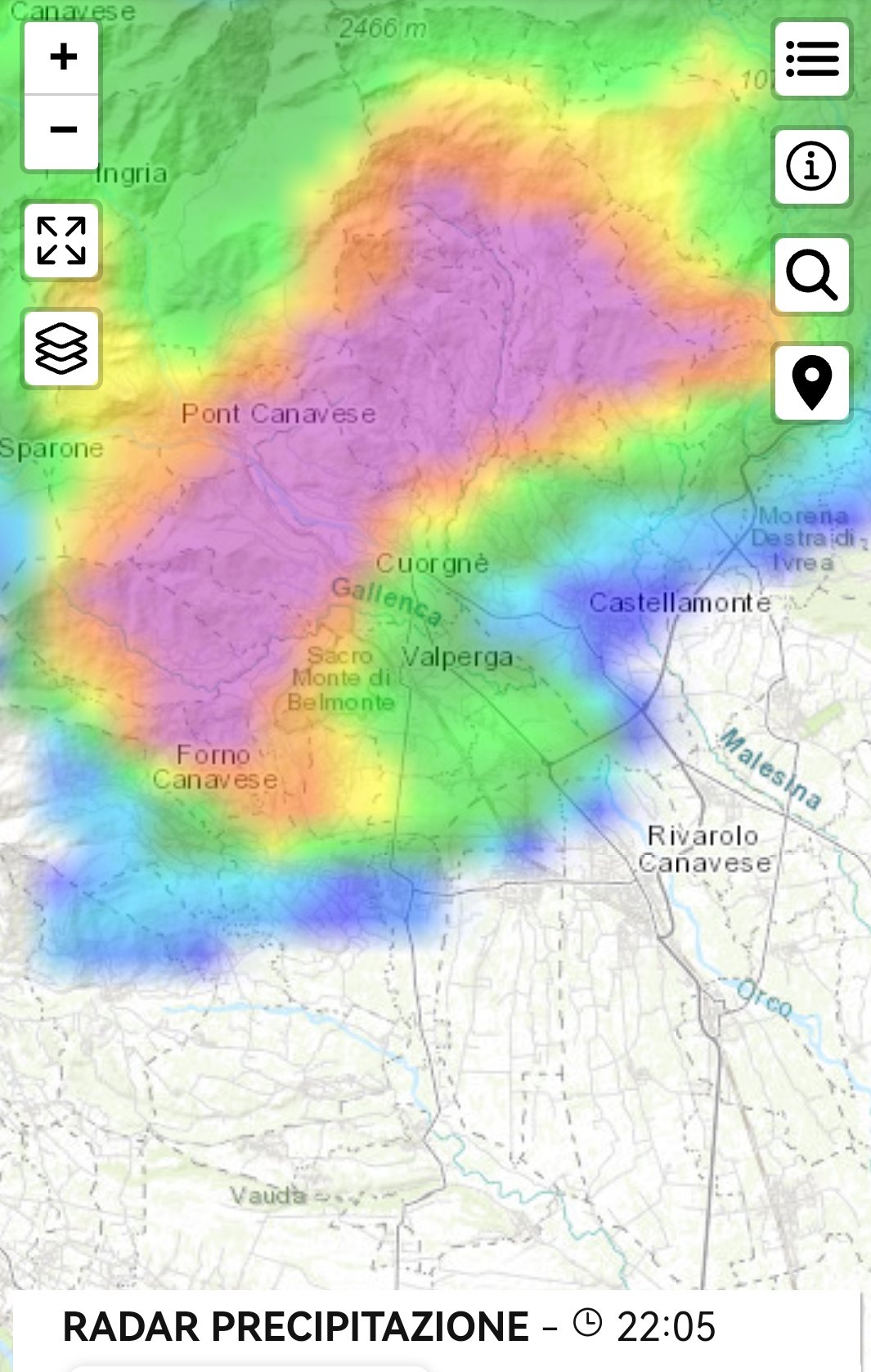
Il frame
radar Arpa Piemonte delle h 22:05 locali del 29 giugno 2024
segnala,
in viola, il violentissimo temporale con intensità pluviometriche
istantanee
>100 mm/h e presenza di grandine sull'Alto Canavese.

Chicchi di grandine di eccezionali
dimensioni raccolti a Sant'Anna dei Boschi, frazione di Castellemonte
(Torino), con diametro fino a circa 10 cm
(f. Chiara Querio, via
pagina FB Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte).

Un chicco di grandine pesato la sera
del 29 giugno 2024, tra i più grandi recuperati nell'Alto Canavese, si
è rivelato di massa di circa 180 g
(autore ignoto, via
pagina FB Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte).

Tetto distrutto dalla grandine a
Forno Canavese (Torino)
(f. AL.PI
Edilizia, via
pagina FB Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte).

Busano (Torino), parabrezza anteriore
di un auto danneggiato dalla grandine
(f. Daniele Cat Berro).

Busano (Torino), abitazione
scoperchiata dalle furiose raffiche di vento da Sud-Ovest, le cui
immagini sono divenute virali nelle cronache nazionali e
internazionali
(f. Daniele Cat Berro).
Ringraziamenti
Oltre a tutti gli enti e agli autori di
immagini citati nel testo, un ringraziamento particolare va a
Gabriele Savio (socio SMI e collaboratore esterno
CNR-IRPI
Torino), a Gianni Mortara e Fabio Luino (CNR-IRPI,
Torino), ad Alessio Golzio (socio SMI e meteorologo
Arpa
Piemonte) e ad Andrea Vuolo (meteorologo RAI Meteo) per i
numerosi confronti e scambi di informazioni durante e dopo l'evento.
Inoltre, per l'aiuto nel rintracciare informazioni e immagini:
Enrico Martinet e Andrea Parodi (giornalisti
La Stampa),
Luca Lorenzini (responsabile portale
DiscoveryAlps),
Elisabetta Bottinelli (Valtournenche), Piero Giorgis e
Bruno Merlo (Noasca),
Giuseppe Cutano e Marco Foretier (Cogne), nonché ai
contributori del gruppo Facebook
Memoria storica dei processi geo-idrologici.
Devolvi il 5 per mille alla SMI!
Sosterrai
le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,
e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|