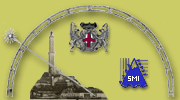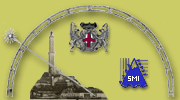|
CHE COSA E' IL PROGETTO ICG
di Massimo Riso
|
Versione stampabile  |
Innanzitutto che cosa significa ICG?
e' l'acronimo di Isola di Calore di Genova.
Il progetto IGC si propone di misurare se a Genova
esiste un'isola di calore imputabile all'attività umana.
L'isola di calore è dovuta non solo al
riscaldamento domestico come molti pensano ma anche alla diminuzione
dell'albedo a causa dell'antropizzazione del territorio: l'asfalto delle
strade, così come il cemento delle case, assorbe molto più calore dal
sole rispetto al terreno naturale (innalzamento dell'albedo), ma non solo,
la vegetazione ed il terreno umido evaporano raffreddando il terreno e
l'aria circostante, abbiamo così due fattori concomitanti che contribuiscono ad innalzare la temperature:
diminuzione dell'albedo e
mancanza di evaporazione del terreno e della vegetazione.
Oltre a verificare l'isola di calore questo progetto
si propone di scoprire se esistono microclimi locali.
Le misure vengono rilevate lungo le tre direttrici
principali:
- Linea costiera: Nervi - Voltri
- Valbisagno: Foce - inizio comune di Bargagli
- Valpolcevera: Piazza Massena - inizio comune di
Mignanego
Dopo alcune uscite preliminari abbiamo individuato
una serie di punti caratteristici di rilevamento delle temperature, questi
punti sono stati memorizzati con un GPS e contemporaneamente è stato
anche memorizzato il tracciato completo dei tre itinerari.
Per il sistema di misura ci siamo rifatti ad una
esperienza simile fatta per la città di Firenze:
Metodologia:
Le misurazioni sono state effettuate con termometro
digitale a termocoppia dotato di sonda aerotermica, con caratteristiche: risoluzione = 0,1 °C;
precisione = +-0,0°C a 20°C, +0,7°C a 10°C (misure effettuate con due
termometri a mercurio ad alta precisione);
La sonda viene montata sopra l'auto a 2,1 m dal
livello stradale.
Le misurazioni vengono effettuate in giorni diversi,
tutte in un periodo centrato circa sulla quinta ora dopo il tramonto
quando, presumibilmente, la temperatura si è stabilizzata.
Il percorso viene effettuato due volte consecutive
per cui, ogni misura è caratterizzata da due letture termiche in due
tempi successivi. Deciso il tempo comune (t°) (5h circa
dopo il tramonto) a cui riportare tutte le letture, la (T°)
per ogni stazione è data da:
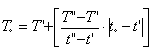 cioè per interpolazione, assumendo che fra (t') e (t") la
temperatura sia variata (nel nostro caso diminuita) in modo lineare.
cioè per interpolazione, assumendo che fra (t') e (t") la
temperatura sia variata (nel nostro caso diminuita) in modo lineare.
I tracciati di misura verranno ripetuti più volte
secondo le varie condizioni climatiche.
Le condizioni climatiche di Genova possono
raggrupparsi in 4 condizioni caratteristiche:
-
Alta pressione e leggero vento da sud.
In questa situazione si ha un effetto Stau che genera una cappa di
sottili nubi a bassa quota e un'alta umidità che impediscono
all'irraggiamento termico di raffreddare il terreno. Si ha una
situazione di livellamento della temperatura in tutta la città.
In questa situazione si ha sovente una leggera pioviggine.
-
Alta pressione e calma di vento
Il cielo è sereno e la temperatura scende notevolmente dopo il
tramonto a causa dell'irraggiamento termico.
In questa situazione si registrano le maggiori differenze di
temperatura fra le varie zone della città.
-
Forti venti da NE (raffiche>30 Km/h)
Seguono normalmente il passaggio di una perturbazione e possono
perdurare anche per diversi giorni.
Il cielo è sereno e la temperatura molto bassa e molto livellata.
-
Bassa pressione e forte vento da S - SW
Questa situazione genera un forte stau contro l'appennino e si hanno
di norma abbondanti precipitazioni.
Noi ci siamo riproposti di non fare misurazioni durante le
precipitazioni perché il bulbo del termometro si bagna e falsa le
misure, per cui sarà difficile trovare questa condizione senza
precipitazioni, difficile ma non impossibile, aspetteremo il momento
propizio e misureremo anche in questa situazione
Sul prossimo numero i tracciati dei percorsi e i
primi risultati delle misure.
Bibliografia:
MELHUISH E. e PEDDER M., Observing an urban heat island by bicycle,
1998,
Weather Vol. 53 N. 4, pp. 121-128
GUGLIELO ZANELLA, Il clima urbano di Parma, 1975, Rivista di meteorologia
aeronautica - Vol. XXXVI - N.2 - 1976 - pp125-144
PANTANI F. e CIANTELLI G., Alcune considerazioni sul clima di Firenze,
1977, Rivista di meteorologia aeronautica - Vol. XXXIX - N. 2 - 1979,
pp.163-167
NANNINI P., L'isola di calore di Firenze, 1983, Rivista di meteorologia
aeronautica, Vol. XLIII - N. 1/2 - 1983, pp.43-52
GRILLINI B., Milano: un'esperienza sul limite dell'isola di calore urbana,
1986, Rivista di meteorologia aeronautica - Vol. XLVVII - N.1 - 1987,
pp.39-42
|