|
|
|
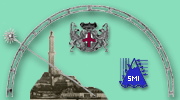 |
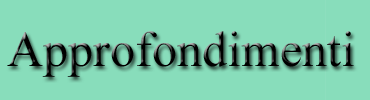 |
|
||
Prima parte Sommario Considerata la crescente necessità di disporre di dati pluviometrici sempre più affidabili, soprattutto nel campo delle acquisizioni di eventi di pioggia estremi, si è provveduto a sottoporre a verifica presso il Laboratorio dell’Istituto di Idraulica dell’Università di Genova una serie di strumenti di rilevazione già in uso presso il Servizio Idrografico e Mareografico di Genova ed altri disponibili in commercio. Tale verifica è stata condotta attraverso un’apposita apparecchiatura, che consente di realizzare intensità di pioggia costante e di valore noto. L’analisi dei risultati ha consentito di suffragare e trarre alcune utili indicazioni tra cui:
Si suggerisce inoltre di affiancare, nelle pubblicazioni tradizionali dei dati, anche il dato corretto con la curva di taratura dello strumento e/o i parametri caratteristici di essa per eventuali correzioni a posteriori. Quest’ultima informazione risulta particolarmente interessante nello studio di eventi intensi in quanto l’esperienza dimostra che gli errori più elevati sono associati a questa classe di eventi. Generalità L’invenzione del pluviometro viene attribuita a Castelli (1639), ma solo agli inizi di questo secolo diviene sistematica la raccolta di dati relativi a precipitazioni, anche intense, misurate mediante pluviometri. Con l'aumento dei sensori installati, e conseguente maggior numero di dati a disposizione dei ricercatori, é aumentata nel tempo l’esigenza di omogeneizzazione delle rilevazioni effettuate con differenti strumenti unitamente ad una maggiore accuratezza delle misure soprattutto in funzione della variabile intensità di precipitazione. La stima della precipitazione, nell’ipotesi di corretto posizionamento dello strumento di registrazione (strumento in bolla e non interferito da ostacoli vicini), è influenzata dalle condizioni climatologiche (intensità del campo di vento, temperatura, intensità delle precipitazioni ...) e dagli errori intrinsechi della strumentazione (bagnatura delle pareti, effetto splash, attriti interni) (WMO,1981). Tali fattori possono concorrere in maniera considerevole a sottostimare la quantità di pioggia nel caso di precipitazioni particolarmente intense (300 mm/h e oltre). Con il presente lavoro, gli autori hanno provveduto a verificare la curva di taratura di alcuni strumenti di rilevazione da tempo operanti sul campo unitamente ad altri in commercio analizzandone il loro comportamento soprattutto nel campo di precipitazioni particolarmente intense ( superiori a 100 mm/h) al fine di individuare le possibili procedure correttive da attuare sui dati registrati dagli strumenti. Analisi delle caratteristiche
meccaniche La strumentazione, oggetto dello studio, appartiene alla tipologia degli strumenti a bascula anche se caratterizzati da diversi volumi di raccolta. La maggior parte degli strumenti sottoposti a verifica, sono rappresentati da quelli in uso al Servizio Idrografico e Mareografico del Compartimento di Genova (SIM), unitamente ad altri presenti sul mercato ed in uso presso altri enti delle seguenti case costruttrici: SIAP, MTX, Salmoiraghi, CAE, LASTEM, SILIMET, ISCO, Kimoto, Micros, ETG. Agli strumenti legati ad una capacità della bascula di 20 g, con captatore da 0,1 mq e sensibilità S=0.2 mm di pioggia a scatto, appartengono gli strumenti del SIM, modello SIAP, ed i modelli MTX, Salmoiraghi, CAE, LASTEM, SILIMET Micros ed ETG, mentre gli strumenti Kimoto e ISCO, legati ad un captatore da 20 cm di diametro hanno una capacità della bascula di 3.14 g ed una sensibilità S=0.1 mm di pioggia a basculata. L’unica caratteristica comune a tutti gli strumenti esaminati è il meccanismo di regolazione della simmetria di basculamento delle vaschette, effettuata tramite vite, mentre per quanto concerne la forma, il materiale di costruzione, la capacità ed eventuale contrappeso di bilanciamento variano da modello a modello. Caratteristiche del sistema di acquisizione Durante un generico evento piovoso il meccanismo di basculamento genera una serie di impulsi più o meno regolari legati al rovesciamento della vaschetta che nella strumentazione analogica vengono diagrammati sulle apposite strisce, mentre in quella digitale sono memorizzati da apposita centralina elettronica. In quest’ultimo caso, le impostazioni e la configurazione delle centraline di acquisizione e memorizzazione dei dati sono in parte preimpostate nel firmware della stazione e in parte programmabili attraverso apposito software di gestione. Analizzando la tempistica di formazione della singola basculata, è possibile individuare dei parametri comuni agli strumenti analizzati tali da consentire una differenziazione in 3 classi ciascuna delle quali legata alla presenza o meno dei suddetti parametri caratteristici.
Tab.1 – Caratteristiche della strumentazione esaminata
in cui ti e tb sono legati all’evento di pioggia, tr è un parametro caratteristico che varia da strumento a strumento e tc è un parametro scelto dall’operatore.
Fig.1 – Schematizzazione della tempistica di basculamento
Tab.2 – Classi degli strumenti esaminati in funzione dei parametri disponibili In classe I si possono identificare quegli strumenti che memorizzano il numero di scatti o i mm di pioggia nel tempo prefissato tc, ma non operano alcuna correzione sui dati provenienti dal pluviometro. La classe II comprende quegli strumenti che danno i mm di pioggia caduti nel tempo tc, come la classe I, e rendono anche disponibile il tempo d’inizio di ogni basculata ma non operano alcuna correzione sui dati memorizzati. In classe III si collocano quei pluviometri che danno i mm di pioggia caduta nel tempo tc, fissato dall’operatore, tenendo conto dell’errore che compie lo strumento all’aumentare dell’intensità di pioggia. Metodologia d'indagine Le curve di taratura ricavate dai vari ricercatori sono risultate tutte di tipo esponenziale
dove Per la determinazione dei parametri sperimentali
Taratura volumetrica Il controllo di tipo volumetrico viene realizzato immettendo nel pluviometro un volume noto in un tempo conosciuto mediante un piccolo serbatoio da cui l’acqua fuoriesce attraverso ugelli di diametro diverso conteggiando il tempo con un cronometro. Così operando, si ottengono una serie di punti diversi di taratura, in modo da coprire il campo di funzionalità del pluviometro. Dalla conoscenza del volume immesso e del tempo intercorso si valuta il valore medio dell’intensità di pioggia di taratura da confrontare con il valore registrato dallo strumento. Per questo tipo di test si è preferito privilegiare la semplicità e maneggevolezza dello strumento per la taratura diretta dei pluviometri nelle stazioni meteo rispetto alla non perfetta costanza dell’intensità di pioggia generata dallo strumento. Taratura a portata costante La curva di taratura dello strumento, e quindi la determinazione dei
parametri
Bibliografia BECCHI, I. (1970). “Sulla possibilità di migliorare le misure
pluviometriche”. Pubbl. Istituto di Idraulica Università di Genova. · Acquedotto di Savona Sul prossimo numero la descrizione dei risultati ottenuti |