Meteo Quiz
a cura di Massimo RisoLa risposta
al test
Le inversioni termiche
E' noto che salendo in quota la
temperatura scende, ma di quale entità è questo abbassamento?
Quando l'aria è in stato di quiete, immobile, la temperatura scende di
6°C ogni 1.000 m. Se al livello del mare la temperatura è di 20°C a
4.000 m sarà di -4°C. Ma questa regola ha le sue eccezioni, e può
capitarci di osservare, durante un’escursione in montagna, che in uno
strato d'aria dello spessore da pochi metri fino a qualche centinaio
la temperatura sale.
La causa più comune é un forte irraggiamento termico notturno. A causa
del cielo sereno, durante la notte si produce un forte raffreddamento
del suolo che a sua volta raffredda il sottile strato d’aria a
contatto con esso. Se l’umidità é sufficientemente elevata e la
temperatura dell’aria diminuisce oltre la temperatura di rugiada si ha
la condensazione e quindi la formazione di nebbia. Più in alto,
lontano dal suolo l’aria rimane calda. Questa situazione é
caratteristica delle pianure, famose le nebbie della pianura
padano-veneta, e spesso l’alpinista osserva dall’alto la penetrazione
di queste nebbie nella parte inferiore delle valli.
Un’altra causa d’inversione termica e di nebbie conseguenti è invece
tipica della montagna. Quando non vi sono venti e l’atmosfera é in
stato di quiete, l’aria fredda, notoriamente più pesante, si raccoglie
nella notte nei fondovalle e nelle conche. Durante i mesi autunnali e
invernali il calore del sole non é sufficiente a scaldare i fondovalle
e di conseguenza far salire l’aria fredda e umida, per cui questa
ristagna in fondo alla valle anche per tutto il giorno e di
conseguenza la nebbia non si dissipa. In questa situazione é più
freddo il fondovalle delle vette, le quali godono dell’irraggiamento
solare per tutto il giorno. In inverno é facile trovare i fondovalle
ancora innevati e i pendii soleggiati in quota completamente spogli.
Questo fenomeno è la spiegazione degli insediamenti di pendio dei
villaggi che incontriamo nelle valli delle Alpi.
|
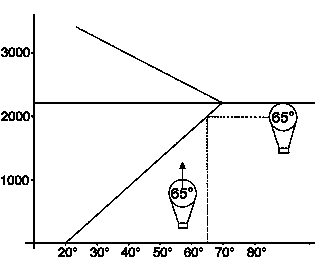 Quale meccanismo fisico è alla base di questi
fenomeni? Supponiamo di essere su una mongolfiera in cui l'aria
calda contenuta all'interno sia 65°C, e partiamo con una
temperatura al suolo di 20°C in una situazione di inversione
termica (i valori indicati sono paradossali, in realtà le
inversioni avvengono con valori di pochi gradi, e anche meno).
Man mano che saliamo di quota la temperatura dell’aria
circostante sale, e quando raggiunge i 65°C la densità dell'aria
all'interno e' uguale a quella dell'esterno, e ci fermiamo. Più
in alto, a 70°C, la temperatura riprende normalmente a scendere
con il crescere della quota, ma la nostra mongolfiera é bloccata
sotto l'inversione termica: nella stessa situazione si trova la
nebbia. Quale meccanismo fisico è alla base di questi
fenomeni? Supponiamo di essere su una mongolfiera in cui l'aria
calda contenuta all'interno sia 65°C, e partiamo con una
temperatura al suolo di 20°C in una situazione di inversione
termica (i valori indicati sono paradossali, in realtà le
inversioni avvengono con valori di pochi gradi, e anche meno).
Man mano che saliamo di quota la temperatura dell’aria
circostante sale, e quando raggiunge i 65°C la densità dell'aria
all'interno e' uguale a quella dell'esterno, e ci fermiamo. Più
in alto, a 70°C, la temperatura riprende normalmente a scendere
con il crescere della quota, ma la nostra mongolfiera é bloccata
sotto l'inversione termica: nella stessa situazione si trova la
nebbia. |
|
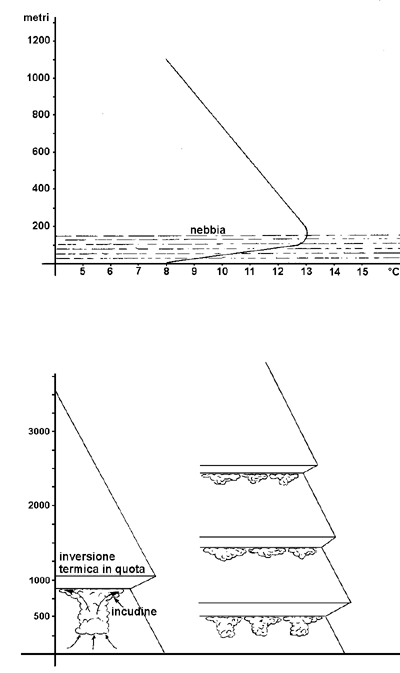 Nella doppia immagine a fianco e' ben visibile il fenomeno della
nebbia, l'inversione termica avviene a 150 metri e vi sono 5
gradi di differenza dal suolo, la nebbia non supera l'inversione
termica. Nelle pianure molto umide, sui laghi o lungo i fiumi si
possono avere inversioni termiche ad un solo metro di altezza
con strati di nebbia sottilissima.
Nella doppia immagine a fianco e' ben visibile il fenomeno della
nebbia, l'inversione termica avviene a 150 metri e vi sono 5
gradi di differenza dal suolo, la nebbia non supera l'inversione
termica. Nelle pianure molto umide, sui laghi o lungo i fiumi si
possono avere inversioni termiche ad un solo metro di altezza
con strati di nebbia sottilissima.
La nebbia e la foschia si possono considerare
come delle vere e proprie nubi al suolo. Vediamo le loro
definizioni (tratte da: Che tempo farà, di Edmondo Bernacca,
Oscar Mondadori):
nebbia: sospensione di
piccolissime (pressoché microscopiche) goccioline di acqua in
prossimità del suolo, tale da ridurre, per convenzione
internazionale, la visibilità orizzontale a meno di 1
Chilometro.
foschia: sospensione
nell’atmosfera di goccioline d’acqua microscopiche abbastanza
disperse in modo da consentire una visibilità orizzontale
superiore a 1 Chilometro.
Se l’inversione termica si forma in quota, la
sua presenza influenza direttamente le nubi. La formazione di
un’inversione termica in quota può essere causata da uno
scorrimento di aria calda sopra ad uno strato freddo: in questo
caso si ha la formazione di uno strato di nubi le cui sommità
non supereranno mai l'inversione termica. Si possono avere anche
più inversioni termiche, sviluppate in altezza, ciascuna con il
suo strato di nubi. |
Caso tipico, di
frequente osservazione in montagna nella stagione calda, è l’impatto
di una cellula temporalesca con l’inversione termica in quota.
Nell’immagine di sinistra si vede una bellissima nube temporalesca (Cumulonimbus,
Cb) la cui sommità, continuamente alimentata da correnti verticali, si
allarga e si addensa sotto l'inversione termica.

Nell’immagine di destra uno strato di nubi alla quota di circa 900 m,
al di sotto vi e' una giornata umida, piovigginosa e fredda, sopra e'
una giornata primaverile e calda, ideale per una bella escursione,
allietata dal pensiero che alcuni amici non sono venuti perché … il
tempo è brutto!
La fotografia a
destra è stata scattata il 14 febbraio 1998 dalla vetta del
Monte Leco (1.072 m), in provincia di Genova, dove avevamo cielo
sereno, una temperatura di +22°C e calma di vento: una splendida
giornata primaverile.
Contemporaneamente al Passo della Bocchetta (772 m) a poca distanza,
il cielo era coperto, la temperatura di +8°C e il vento moderato da
sud, una uggiosa e fredda giornata invernale.
I dati sono stati personalmente registrati.
|
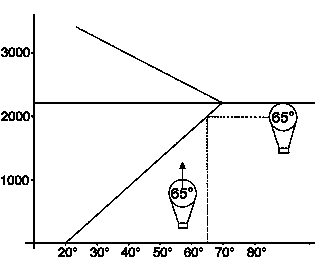 Quale meccanismo fisico è alla base di questi
fenomeni? Supponiamo di essere su una mongolfiera in cui l'aria
calda contenuta all'interno sia 65°C, e partiamo con una
temperatura al suolo di 20°C in una situazione di inversione
termica (i valori indicati sono paradossali, in realtà le
inversioni avvengono con valori di pochi gradi, e anche meno).
Man mano che saliamo di quota la temperatura dell’aria
circostante sale, e quando raggiunge i 65°C la densità dell'aria
all'interno e' uguale a quella dell'esterno, e ci fermiamo. Più
in alto, a 70°C, la temperatura riprende normalmente a scendere
con il crescere della quota, ma la nostra mongolfiera é bloccata
sotto l'inversione termica: nella stessa situazione si trova la
nebbia.
Quale meccanismo fisico è alla base di questi
fenomeni? Supponiamo di essere su una mongolfiera in cui l'aria
calda contenuta all'interno sia 65°C, e partiamo con una
temperatura al suolo di 20°C in una situazione di inversione
termica (i valori indicati sono paradossali, in realtà le
inversioni avvengono con valori di pochi gradi, e anche meno).
Man mano che saliamo di quota la temperatura dell’aria
circostante sale, e quando raggiunge i 65°C la densità dell'aria
all'interno e' uguale a quella dell'esterno, e ci fermiamo. Più
in alto, a 70°C, la temperatura riprende normalmente a scendere
con il crescere della quota, ma la nostra mongolfiera é bloccata
sotto l'inversione termica: nella stessa situazione si trova la
nebbia. 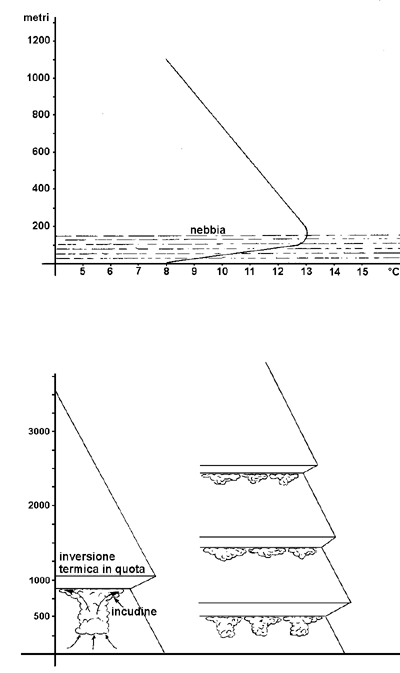 Nella doppia immagine a fianco e' ben visibile il fenomeno della
nebbia, l'inversione termica avviene a 150 metri e vi sono 5
gradi di differenza dal suolo, la nebbia non supera l'inversione
termica. Nelle pianure molto umide, sui laghi o lungo i fiumi si
possono avere inversioni termiche ad un solo metro di altezza
con strati di nebbia sottilissima.
Nella doppia immagine a fianco e' ben visibile il fenomeno della
nebbia, l'inversione termica avviene a 150 metri e vi sono 5
gradi di differenza dal suolo, la nebbia non supera l'inversione
termica. Nelle pianure molto umide, sui laghi o lungo i fiumi si
possono avere inversioni termiche ad un solo metro di altezza
con strati di nebbia sottilissima. 