|

di Roberto Pedemonte

Horace-Bénédicte de Saussure
Incisione di Ambroise Tardieu |
Lo scopo che ci prefiggiamo in questa
nuova rubrica è quello di rivisitare pagine di cronaca e di
storia della meteorologia del passato, tempi in cui l’uso di
strumenti, seppur in crescita, era limitato a pionieri,
tempi in cui la scienza meteorologica, ben lungi dall’essere
organizzata e codificata come al giorno d’oggi, era riserva
di pochi scienziati e appassionati che dedicavano ad essa la
loro vita. Studiosi che hanno compiuto, nel corso della loro
attività scientifica, esperimenti rivoluzionari, viaggi
pericolosi, costruito strumenti innovativi o dedicato il
loro tempo alla raccolta e delle osservazioni sui fenomeni
dell’atmosfera, descrivendoli, misurandone i valori con
apparecchiature non ancora normalizzate, spesso anche non
confrontabili. Per raccogliere queste informazioni ci
vengono incontro i libri ma anche i giornali dell’epoca,
spesso entusiasti nel redigere sulle loro pagine le notizie
di questa scienza in via di espansione. Uno di questi,
“Avvisi Patrii”, settimanale genovese stampato tra il 1777 e
il 1796, forniva resoconti, notizie e anche un’interessante
raccolta di dati meteorologici rilevati nella città di
Genova che avremo modo di pubblicare nel dettaglio nei
numeri futuri della rivista.
In questa prima puntata della rubrica, che abbiamo voluto
chiamare “Meteorologia d'altri tempi” per ricordare che è solo
grazie agli uomini a cui si faceva cenno prima che si è
potuti far progredire la Scienza, ci è sembrato interessante
riproporre il resoconto che fece Horace-Bénédict de Saussure
sulla spedizione che, insieme al figlio Theodore, fece al
Col del Gigante nel luglio 1788, dopo quella più famosa
durante la quale raggiunse la vetta del Monte Bianco il 3
agosto 1787. A spingerlo a compiere quest’impresa fu, come
si leggerà, la possibilità di effettuare misurazioni alle
alte quote non solo nelle ore centrali del giorno, come era
avvenuto fino ad allora, ma poter verificare l’andamento dei
“varj stromenti” lungo tutto il corso della giornata. Il
soggiorno durò infatti ben sedici notti.
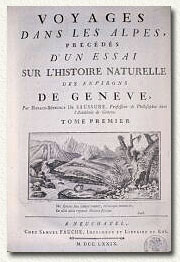
Il primo volume del Voyages dans les Alpes |
Pubblicato su tre numeri degli “Avvisi” nel febbraio 1794,
qui viene presentata in due parti (la seconda nel prossimo
numero di RLMet). Si è ritenuto di non modernizzare il
lessico e mantenere inalterata la traduzione che venne fatta
all’epoca della pubblicazione: la descrizione
particolareggiata delle difficoltà riscontrate durante la
scalata e delle condizioni meteorologiche estreme alle quali
sono stati sottoposti i partecipanti alla spedizione, una
ventina di persone, è sì più difficoltoso a leggersi ma
rende bene il sapore pionieristico dell’epoca in cui venne
scritto.
Horace-Bénédict de Saussure fu scienziato ma anche
naturalista. Nacque il 17 febbraio 1740 a Conches, vicino a
Ginevra, da una nobile e illustre famiglia che diede alla
storia numerosi uomini di scienza. Già a 22 anni fu nominato
professore di filosofia e scienze naturali all’Università di
Ginevra. A 34 ne fu rettore. Dal 1768 iniziarono i suoi
viaggi nelle Alpi. Introdusse il termine “geologia” nel
mondo scientifico, utilizzato nella sua opera più
importante, la monumentale “Voyages dans les Alpes” (Viaggio
attraverso le Alpi), resoconto di trent’anni di viaggi e
studi lungo la catena alpina. La gloria di de Saussure
culminò con la scalata al Monte Bianco che portò a termine,
come già scritto, il 3 agosto 1787. Nella sua vita, dedicata
alla scienza, scoprì numerosi minerali e, cosa che ci
riguarda più da vicino, fece accurate misurazioni
sull’umidità atmosferica, migliorò il termometro e
l’anemometro e sviluppò l’igrometro a capelli, forse il suo
strumento più conosciuto, e l’elettrometro, strumento per
misurare l’elettricità potenziale grazie all’attrazione o
alla repulsione di corpi caricati elettricamente. Dal 1794
la salute iniziò ad abbandonarlo e, a causa delle spese
sostenute per le sue ricerche scientifiche, si trovò anche
in ristrettezze economiche. L’illustre studioso ebbe però la
solidarietà di numerose personalità che non scordarono
quanto fosse stato il suo contributo al progresso della
scienza. La morte lo colse il 22 gennaio 1799 e fu
seppellito nel cimitero ginevrino di Plainpalais.
Da
“Avvisi Patrii” n° 5 del primo febbraio 1794
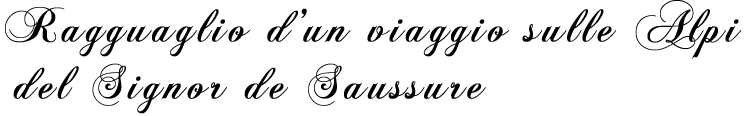
I Fisici, ed i Naturalisti che propongonsi di visitare la
vetta di qualche monte, prendono d’ordinario le loro misure
in modo da giungervi sul mezzo giorno, e quando vi sono
arrivati, si affrettano a fare le loro osservazioni per
discenderne pria della notte. Si trovan essi per ciò
sull’alte cime quasi sempre all’istess’ora, né vi si
trattengono che per breve tempo, onde non possono formarsi
una giusta idea dello stato dell’aria nelle altre ore del
giorno, e molto meno in tempo di notte.
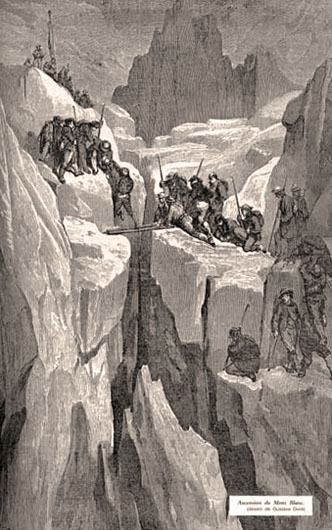
Ascensione al Monte Bianco |
Mi parve cosa interessante il riempiere, a dir così, questa
specie di lacuna nell’ordine delle nostre cognizioni
atmosferiche, facendo un’assai lunga dimora su di un’alta
cima affine di determinare l’andamento giornaliero di varj
stromenti meteorologici del barometro, del termometro,
dell’igrometro, elettrometro ec., e di cogliere l’occasione
di osservare in quel luogo l’origine delle meteore
differenti, come delle piogge, de’ venti, delle procelle ec.
A tal desiderio aggiungansi quello di tentare varie
esperienze che risoluto avea di fare sul Monte Bianco, ma
che la scarsezza del tempo, e’l disagio prodotto dall’aria
troppo rarefatta, m’impedirono di eseguire.
Difficil cosa era il trovare un luogo convenevole. Io voleva
collocarmi all’altezza di mille ottocento tese
[3.500 metri
circa, N.d.R] e in un luogo scoperto, ove i venti e tutte le
meteore potessero liberamente spiegarsi. Non mi sarebbe
stato difficile il trovare qualche vetta coperta di neve, la
quale in se riunisse tali proprietà; ma non m’era fattibile
il fissar sulla neve uno stabilimento durevole, per
l’instabilità degli stromenti che vi si sarebbono collocati,
sia a cagione del freddo, e dell’umidità. Era pertanto ben
difficile il trovare sulle nostre alpi a tanta altezza,
qualche rupe senza neve, accessibile, ed abbastanza
spaziosa, per potervi formare una specie di domicilio.
Il Sig. Exchaquer, con cui parlato avea del mio progetto, mi
assicurò che per la strada nuovamente scoperta conducente da
Chamouni a Courmayeur passando pel Tacul avrei trovate delle
situazioni quali io le bramava.
Affidatomi pertanto sulla sua asserzione, feci nella scorsa
primavera i miei preparativi per tale spedizione, e ai primi
di giugno andai con mio figlio a stabilirmi a Chomouni,
aspettando il bel tempo per tosto approfittarne.
Portai con me due piccole tende di tela; ma bramava inoltre
di avere colassù una specie di capanna formata di sassi.
M’era d’uopo aver varj domicilj, o luoghi riparati, divisi
l’un dall’altro, non solo per noi, e per le nostre guide, ma
altresì perché il magnetometro, e la bussola di variazione,
dovean esser fra se distanti per non influire sulle
reciproche loro variazioni; mandai perciò a costruire
anticipatamente la mentovata capanna.
Allorché questa fu terminata, e parve stabilito il bel
tempo, partimmo da Chamouni. Il primo giorno, ai 2 di
luglio, andammo a dormire sotto le nostre tende a Tacul;
così appellasi un fondo coperto di erbetta sul margine di un
piccol lago compreso fra l’estremità della ghiacciaja de’
boschi, ed il piede di una rupe detta Montagna del Tacul.
All’indomani di là partimmo alle cinque e mezzo del mattino,
e mezz’ora dopo il mezzo giorno giungemmo alla nostra
capanna. A questo luogo fu dato il nome di Colle del
Gigante, perché in effetto è posto all’ingresso del colle,
da cui si discende a Courmayeur, e perché la montagna più
rimarchevole che trovisi in que’ contorni dominante sul
colle è il Gigante, alta e dirupata vetta, che ben
distinguesi dalla sponda del nostro lago (di Ginevra). Il
nome del Tacul, distante cinque o sei ore di cammino da
queste rupi, non poteva in verun modo lor convenire.
Andando dal Tacul al Colle del Gigante non potemmo
attraversare la ghiacciaja di Trelaporte, per cui passarono
l’anno scorso quelli che ci precedettero; poiché le
fenditure di tal ghiacciaja trovavansi aperte e senza neve,
ond’erano affatto inaccessibili; e perciò fummo
costretti di costeggiare le falde di un’altra vetta detta la Nera, presso a’ dirupamenti di neve estremamente ripidi, e vicini a
profonde fenditure.
Le nostre guide ci assicuravano che tal passaggio è molto
più periglioso di quello che avevamo tenuto l’anno scorso;
ma io non fo gran caso delle loro asserzioni, sia perché il
pericolo presente ci pare sempre maggiore di quello ch’è già
passato, sia perché essi s’immaginano di adulare ai
Viaggiatori, dicendo loro che son campati da un grave
periglio. Vero è però, che il passaggio della Nera è
pericoloso, e che siccome alla notte avea gelato, sarebbe
stato impossibile l’attraversar quelle nevi sode e pendenti,
se nel giorno precedente, quando la neve era ammollita pei
raggi del sole, le persone del nostro seguito non fosser
andate a segnarvi le orme, ove mettere con sicurezza il
piede.

De Saussure durante la sua spedizione nelle Alpi |
Fummo quindi esposti, come al Monte Bianco, al pericolo
delle fenditure nascoste sotto sottili, e deboli strati di
neve. Tali fenditure son men larghe e men frequenti verso la
cima della montagna, e ci lusingavamo qui pure di uscirne
felicemente, quando tutto ad un tratto sentimmo gridare:
corde, corde. Chiedansi tai corde per cavar dal fondo della
ghiacciaja il povero Alessio Balmat, uno di quei che
portavano il nostro bagaglio, precedendoci di cento passi
all’incirca, e che in un batter d’occhio era scomparso agli
sguardi de’ suoi compagni ingojato da una larga fenditura
profonda ben sessanta piedi
[18 metri circa, N.d.R.], ma per
sua ventura alla metà dell’altezza era stato sostenuto da
una massa di neve ivi dianzi caduta. Precipitò egli su
questa neve senza essersi fatto altro male, che qualche
lieve scorticatura al volto. Il suo migliore amico P. G. Favret, si fe legare con delle corde, e mandar giù per
fortemente legare l’amico: ciò fatto, l’un dopo l’altro si
videro sortire dalla voragine. Alessio Balmat era bensì
pallido alquanto, ma non mostrò verun turbamento, e
riprendendo i nostri materazzi che formavano il suo carico,
si rimise in cammino con un’inalterabile tranquillità.
Non fu già, come esser suole, un istante felice per noi
l’arrivo al termine del nostro viaggio. M’avvidi tosto non
senza dispiacere, confrontando la situazione della nostra
capanna, colle altezze, ch’io ben conosceva altronde, che
non eravamo alti mille ottocento tese, come ci avevan fatto
sperare: trovai inoltre la nostra capanna troppo angusta,
non avendo che sei piedi
[1.8 metri, N.d.R.] in quadrato, e
sì bassa che non vi poteamo star ritti in piedi; e le
pietre, con cui era stata costruita, erano sì mal connesse,
che eravi entrata la neve, e l’aveva empiuta per metà. La
cresta degli scogli, su cui doveano spiegarsi le nostre
tende, e alla cui estremità saliente stava la nostra
capanna, era chiusa fra due ghiacciaje estremamente strette,
ineguali, e d’ogni intorno circondate da balze di nevi e da
rupi scoscese, che poteano chiamarsi precipizj. Per una
abitazione di molti giorni questa situazione non offriva
certamente una piacevole prospettiva, ma per un belvedere
era veramente magnifica. Dalla parte dell’Italia avevamo un
orizzonte immenso, formato da raddoppiate catene di monti
coperti bensì in gran parte di nevi, ma vi si scoprivano
frammezzo delle nere foreste, e alcune ridenti e ben
coltivate valli. Dalla parte della Savoja il Monte Bianco,
il Gigante, e le vette intermedie presentavano un maestoso
quadro variato e interessante.
Fine prima parte
|