|

di Roberto Pedemonte
Terminiamo in questo numero il resoconto
che Horace-Bénédict de Saussure fece sulla sua permanenza al
Col del Gigante nel 1788, pubblicato originariamente su due
fascicoli degli “Avvisi Patrii”, dati alle stampe a Genova
nel 1794, dove ritroviamo dettagliatamente descritto e, a
quanto ci risulta, per la prima volta dall’interno del
cumulonembo, un furioso temporale con grandine e venti
impetuosi.
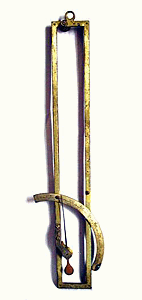
L'igrometro usato da de Saussure |
Tra la strumentazione che Horace-Bénédict
de Saussure portò, o meglio, fece portare, a quelle alte
quote, non poteva mancare l’igrometro a capello, di cui fu
ideatore. Dopo precedenti iniziative nelle quali uomini di
scienza costruirono strumenti capaci di misurare il grado di
umidità presente nell’aria, ossia il suo stato igrometrico,
sfruttando la proprietà che alcune sostanze organiche hanno,
di variare le loro dimensioni (citiamo Santorio che utilizzò
corde di canapa nel 1625, Coniers legno di abete nel 1675,
Molineaux, Lambert e Lana corde di budello animale tra il
1685 e il 1777, De Luc ossi animali nel 1773), nel 1783
Horace-Bénédict de Saussure costruì il primo igrometro
utilizzando capelli umani.
I capelli hanno la caratteristica di
allungarsi o accorciarsi, in funzione della quantità di
vapore acqueo che è presente nell’aria. Questo tipo di
igrometro, detto ad assorbimento e, più comunemente,
conosciuto come “igrometro a capello”, è costituito da un
telaio di metallo sul quale è teso un fascio di capelli
(molto probabilmente si trattava in origine di un solo
capello) trattenuto a un’estremità da una piccola ganascia;
il fascio viene fatto passare su una puleggia e quindi,
all’altra estremità è agganciato a un contrappeso che lo
mantiene in tensione. Un ago mobile con funzione di indice,
fissato alla puleggia, amplifica lo spostamento (provocato
dalla variazione della lunghezza dei capelli) di
quest’ultima su un’opportuna scala graduata da 0 a 100,
restituendo così il valore dell’umidità relativa.
L’igrometro a capello, che ebbe molta più fortuna dei suoi
predecessori e che viene utilizzato ancora oggi, non è
tuttavia uno strumento che fornisce valori della massima
precisione. Per una lettura più raffinata dell’umidità,
infatti, si fa riferimento, normalmente, allo psicrometro.
Da “Avvisi Patrii” n° 5 del
primo febbraio 1794
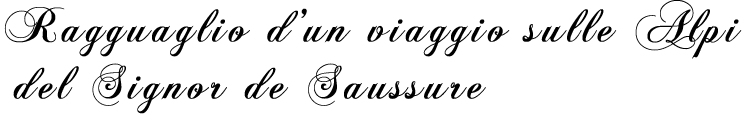
Seconda parte

De Saussure durante l'ascensione al Monte Bianco |
Quei che portavano il nostro bagaglio e gli stromenti
ripartiron tosto alla volta di Chamouni; ma oltre al mio
servitore trattenni con noi quattro delle migliori guide,
affine di potermi prevaler del loro ajuto nelle nostre
operazioni, e per mandarli alternativamente a fare le
provvisioni a Cormayeur.
Quando si furono riposati e ristorati chiesi che si dessero
le necessarie disposizioni pel mio stabilimento; ma un resto
di stanchezza, e la prospettiva degl’incomodi che
s’aspettavano in questo soggiorno, abbattevano le loro forze
e’l loro coraggio. Nulladimeno quando cominciarono a sentire
il freddo della sera, viddero anch’essi che facea d’uopo
pensare a prepararsi un asilo per la notte. Cominciaron
allora a disporre in qualche modo i grossi massi staccati di
granito, che formavano il piano della nostra cresta, e
quindi a spiegarvi le tende per passarvi la notte; poiché la
capanna era inabitabile sin a tanto che non si fosse
disfatto, e portato via uno strato di neve che v’era
penetrata.
Quanto a me, io avea tosto cominciato a visitare i miei
stromenti, ad a mettere in opera quelli che non avean
bisogno d’alcun preparativo, e trovai con mio dispiacere i
miei due barometri guasti: la gran siccità che dominato avea
dopo la nostra partenza da Chamouni avea sminuito il
diametro del sughero collocato nell’anima dei robinetti che
debbon contener il mercurio, il quale usciane come a fili;
l’aria però non eravi entrata, e giunsi a riparare ad uno di
essi adoprando un rimedio indicatomi dall’istessa cagion del
male. Lo tenni continuamente involto in un pannolino
bagnato, il che rigonfiò il sughero, e questo tenne allora
il mercurio.
Benché assai mal coricati, pure dormimmo saporitamente, e
riprendemmo così le nostre forze e la nostra attività. Al
mattino ci occupammo con tutto l’ardore a sgombrare dal
ghiaccio la nostra capanna, e ad alzarla per potervi star in
piedi; formammo de’ piedistalli per magnetometro. Per la
bussola di variazione, pel piano che serve a delinear la
meridiana, e cominciammo che a fare qualche osservazione. Le
nostre guide, che prevedevano un cangiamento di tempo,
travagliarono principalmente ad assicurare sul terreno le
nostre tende; operazion ben difficile su quella cresta più
angusta delle tende istesse, ineguale, e composta di enormi
masse incoerenti.
Ci
trovammo ben contenti di aver prese tali precauzioni; perché
nella notte seguente, dai quattro ai cinque di luglio, fummo
sorpresi dal più orribile temporale che veduto mi abbia
giammai. Un’ora dopo il mezzodì sollevossi un vento
sud-ouest con tal violenza e fragore, che ad ogni istante
credeami che ne portasse la nostra capanna in pietre ove
stavami coricato con mio figlio. Quel vento avea
particolare, che venia periodicamente interrotto da alcuni
intervalli della più perfetta calma- Nel tempo di questi
intervalli sentivasi fischiar il vento sotto di noi nel
fondo della valle dell’Allee Blanche, mentre la massima
tranquillità regnava all’intorno della nostra capanna. Ma
questi momenti di calma eran seguiti da soffi di una
indicibil violenza, che sembravano colpi raddoppiati, simili
a scariche di artiglieria; sentivamo il monte istesso
scuotersi sotto i nostri materazzi; il vento entrava per le
fessure de’ sassi della capanna, ed una volta sollevommi
anche le lenzuola, e le coperte agghiacciandomi da capo a
piedi. Sull’alba del giorno calmossi alquanto; ma sollevossi
di nuovo, e venne accompagnato da neve, che penetrava nella
capanna da ogni parte. Ci rifugiammo in una delle tende, ove
stavamo alquanto meglio riparati. Vi trovammo le guide
costrette a sostener di continuo gli alberi, per paura che
la violenza del vento non li rovesciasse, e non li portasse
via insieme con le tende. Verso le sette del mattino
accoppiaronsi al vento la grandine, e i tuoni, e i fulmini
che succedeansi senza interruzione; uno di questi cadde a
noi sì vicino, che indistintamente sentimmo una scintilla,
che ne era porzione, scorrere crepitando nella tela bagnata
della tenda, appunto dietro al luogo ove trovavasi mio
figlio. L’aria era talmente carica d’elettricità, che appena
io cacciava fuori della tenda la punta sola del conduttore
del mio elettrometro, le pallottole scostavansi quanto
poteano, e quasi ad ogni scoppio di tuono, l’elettricità
divenia di positiva negativa, o reciprocamente. Per aver
un’idea della forza di quel vento, dirò solo, che ben due
volte volendo le nostre guide andar a ricercare delle
provvisioni ch’erano nell’altra tenda, scelsero uno degli
intervalli, in cui parea che il vento si rallentasse, ed a
mezza strada, benché non vi fosser che sedici a diciassette
passi di distanza da una tenda all’altra, vennero assaliti
da un tal colpo di vento, che per non essere balzati nel
precipizio, furon costretti ad attaccarsi ad uno scoglio,
che fortunatamente colà trovavasi, e per due o tre minuti là
si stettero fortemente stretti, mentre il vento impetuoso
sollevava loro sulla testa gli abiti, e si lasciavano
flagellare dalla grandine, piuttosto che avere il coraggio
di continuare il cammino.
Verso il mezzo giorno rasserenossi il cielo, e’l Sig.
Exchaquet ch’era venuto il giorno innanzi con quattro guide
a farci una visita, ed avea avuta la sventura di divider con
noi gl’incomodi ed il timore di quella orribil notte, e di
quella procellosa mattina, al cessare del cattivo tempo,
ritornossene a casa, discendendo per Courmayeur.
Noi fummo ben contenti, veggendo che nei nostri poveri
ripari, avevam potuto resistere agli elementi congiurati e
pensando ch’era quasi impossibile di aver di nuovo sì
cattivo tempo, ci trovammo assicurati contro il timor de’
temporali ch’eranci stati dipinti come assai perigliosi su
queste alture. Proseguimmo perciò con ardore le necessarie
disposizioni per le nostre osservazioni; le quali
cominciarono l’indomani a formare una serie regolare e non
interrotta. Quando il tempo non era troppo cattivo, mio
figlio alzavasi alle quattro del mattino per incominciare le
osservazioni meteorologiche; io non mi alzava che verso le
sette; ma vegliava sino a mezza notte, mentre mio figlio
coricavasi verso le dieci. Durante il giorno ciascun di noi
avea le sue occupazioni particolari.
Da “Avvisi Patrii” n° 7 del 17 febbraio
1794
Fine del Viaggio sull’Alpi di M.r de Saussure

Horace-Bénédicte de Saussure |
Una sì attiva faceane passar il tempo con un’estrema
rapidità; ma soffrivamo un orrido freddo durante il cattivo
tempo, e nella maggior parte delle sere, ancorché precedute
da giorni sereni. Quansi tutte le sere verso le cinque
cominciava a soffiar un vento che veniva dalle balze nevose,
che ci dominavano dalla parte del nord e all’ouest, e che
sovente accompagnato da neve, o da grandine, era di un
freddo estremo. Le più calde vesti, le pellicce istesse non
ci potean difendere; non potevamo accendere il fuoco nelle
nostre piccole tende di tela, e la misera nostra capanna;
traforata per tutti i lati non venia punto intiepidita dai
nostri piccoli scaldatoj; il carbone istesso non accendevasi
in quell’aria, sì rarefatta se non assai languidamente, ed a
forza di mantice; e se giungevamo a riscaldar alquanto i
nostri piedi, e le nostre gambe, il rimanente della persona
era sempre agghiacciato dal vento che attraversava la
capanna. In tai momenti ci doleva meno di non essere che
all’altezza di mille settecento sessanta tese
[3.430 metri, N.d.R.]
sopra il livello del mare, perché più in alto il freddo
sarebbe stato ancor più sensibile; e ci consolavamo altronde
pensando che in quel luogo eravamo circa cento ottanta tese
[350 metri, N.d.R.]
più alti, che la cima del Buet, il quale pochi anni fa
passava per la sommità, fra le accessibili, la più alta
dell’alpi.
Verso le dieci della sera il vento si calmava; quest’era
l’ora in cui lasciava mio figlio coricarsi nella capanna, ed
io andavami nella tenda della bussola a invilupparmi nella
mia pellicia con una pietra calda sotto i piedi, e a mettere
in netto le annotazioni di quanto erasi fatto tra il giorno.
Sortiva di quando in quando per osservare i miei strumenti
e’l cielo; che quasi sempre era allora del più bel sereno.
Queste due ore di ritiro e di contemplazione pareami
estremamente dolci; indi andava a coricarmi nella capanna
sul mio materazzo steso a terra allato a quel del mio
figlio, e là gustava un più dolce sonno che nel letto della
pianura.
La
sedicesima ed ultima sera che passammo al Colle del Gigante
fu d’una sorprendente bellezza. Pareaci che quelle alte
vette c’invitassero a trattenerci colà, e volesser da noi
almeno che non le lasciassimo senza dispiacere. Il freddo
vento, che averci rendute sì incomode per la maggior parte
le altre notti, non spirò punto in quella sera; le
soprastanti vette che ci dominavano, e le nevi che le
dividono, vestivano il più vago color di rosa e di carmino,
tutto l’orizzonte dell’Italia era cinto da una larga fascia
di porpora, e la luna nella sua pienezza alzavasi con regia
maestà sopra questa rosseggiante zona tinta del più vago
vermiglio. L’aria all’intorno avea quella perfetta purezza,
e limpidità, che Omero attribuisce all’aere dell’Olimpo, nel
tempo che le profonde valli ripiene di condensati vapori,
presentavamo un soggiorno d’oscurità e di tenebre.
Ma
come poss’io dipingere la notte che a sì bella sera
successe, allorché dopo il crepuscolo, la luna brillante
sola nel cielo, spandea i suoi argentei raggi sulla vasta
estension delle nevi e delle rocce che facean corona alla
nostra capanna? Quelle nevi, e que’ ghiacci al cui diurno
splendore non può regger lo sguardo, formavano un
sorprendente e delizioso spettacolo al dolce taciturno lume
della face notturna! Quale magnifico contrasto formavano in
mezzo colle lucidi nevi que’ massi oscuri tagliati sì
arditamente, e d’un sì netto contorno? Qual momento per la
meditazione? Di quante pene, e disagi non c’indennizzan’eglino
sì deliziosi istanti? L’anima si solleva, le idee
s’ingrandiscono, e din mezzo di quel maestoso silenzio par
d’ascoltare la voce natura, e di divenire il confidente
delle sue più segrete operazioni.
All’indomani 19 luglio, avendo noi di già compiute le nostre
osservazioni, e esperienze che ci avevamo proposte,
abbandonammo il nostro soggiorno, e scendemmo a Courmayeur.
La prima parte della discesa che fassi su massi mal fermi, è
ripida e faticosa, ma senza il menomo perilio, e perciò ella
non rassomiglia in verun modo a l’Aigiulle di Gouté, cui
erasi paragonata. Tutta questa strada non presenta alcuna
difficoltà. Nulladimeno vi soffrimmo non poco. A principio
il caldo, uscendo noi da un clima freddo; a cui eravamci già
abituati, ci parve insopportabile; ma più di tutto soffrimmo
per la fame. Avevamo riserbate alcune poche provvisioni per
questo breve viaggio; ma esse scomparvero nella notte
antecedente. Sospettammo che qualcheduno degli uomini che ci
serviano di guida ce le avesse involate, non tanto per
approfittarne, quanto per metterci nell’assoluta necessità
di partire; poiché annojavansi tutti all’estremo sul Colle
del Gigante, e la nostra estasi, dirò così, per la bellezza
dell’ultima sera, avendo mio figlio dimostrato qualche
rincrescimento a partire da quel luogo, avea lor data
occasione di temere che non prolungassimo colà il nostro
soggiorno. Il caldo, e l’inanizione mi toglievano le forze,
mi cagionavano una specie di deliquio, e di debolezza di
testa a segno che non trovava più le parole necessarie per
esprimere i miei sentimenti. Mio figlio e’l mio servitore
sen risentirono anch’essi, ma molto meno di me. La debolezza
mia rallentava il nostro cammino, e ne rendea più lontano
perciò il rimedio. Non giungemmo che alle sette della sera
al villaggio d’Entréve, ov’erano le prime case da potervi
ritrovar qualche reficiamento. Ma un giorno di riposo a
Courmayeur bastò a perfettamente ristabilirci. Di là venimmo
scendendo per Colle Terret a Martigny, e quindi a Chamouni,
ove passammo ancora tre giorni per farvi alcune esperienze
da confrontare con quelle che avevamo fatte sul Colle del
Gigante; e ritornammo a Ginevra alla fine di luglio.
|