|

di Roberto Pedemonte
Nel secolo dei “Lumi e della Ragione” ci
fu un proliferare di invenzioni e scoperte. Gli uomini di
scienza misero a disposizione della comunità tutta la loro
conoscenza e fantasia per ideare e costruire, o far
costruire, strumenti nuovi onde poter indagare, con metodo
scientifico, la natura. Molte di quelle apparecchiature,
benché affinate e tecnologicamente evolute, sono oggigiorno
ancora utilizzate, altre dimenticate.

Marsilio Landriani 1751-1815 |
Ci è parso interessante rievocare in
questo numero, sempre dal periodico genovese “Avvisi Patrii”,
la descrizione dettagliata di una nuova “Macchina”,
realizzata intorno al 1780 dal lombardo Marsilio Mandriani,
per misurare, oltre la quantità della pioggia caduta, la
durata della precipitazione liquida: il Cronyometro. Sarà
forse per il nome poco comprensibile e/o facilmente
confondibile con altri strumenti uno dei motivi per cui
questa “Macchina” non ebbe la fortuna sperata dall’inventore
e dai redattori dell’articolo dell’epoca, ma sicuramente si
noterà la genialità del suo creatore.
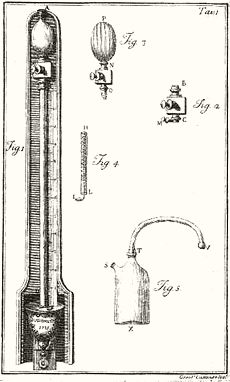
L'Eudiometro inventato da Landriani |
Marsilio Landriani, nacque a Milano il 1°
ottobre 1751 da nobile famiglia e intraprese gli studi scientifici. Nel 1775, pubblicò le
“Ricerche fisiche intorno alla salubrità dell'aria”,
(ristampato per i tipi di Giunti nel 1995) che
rappresentarono il suo primo lavoro scientifico. In quell’opera
descrisse un nuovo strumento, l'eudiometro, neologismo da
lui ideato per definire lo strumento che era in grado di
misurare la salubrità dell’aria; in altre parole la quantità
di ossigeno, cioè della parte “più respirabile,
salubre e pura”, presente nell'aria. Nel 1776 Landriani fu
chiamato a ricoprire la cattedra di fisica sperimentale nel
Ginnasio di Brera e nominato socio della Società
Patriottica, appena fondata, prima istituzione scientifica
milanese divenendone, sei anni dopo, conservatore anziano.
Dopo il 1790 Marsilio Landriani si occupò delle possibili
applicazioni della chimica rivolta alla spiegazione dei
fenomeni elettrici e al perfezionamento di strumenti
meteorologici. Tra il 1790 e il 1794 si trasferì a Dresda in
missione diplomatica. Morì a Vienna nel 1815, riparatovi a
seguito dell'invasione napoleonica dell'Italia
settentrionale.
Sebbene il lavoro di Marsilio Landriani
sia stato superato dalle nuove tecnologie, ci illustra
emblematicamente la grande genialità che contraddistinse gli
uomini di scienza di quel secolo e benché lo scienziato sia
oggi tra i grandi nomi meno noti del suo secolo, forse anche
perché molte delle spiegazioni date sull’analisi chimica
dell'aria atmosferica si rivelarono successivamente
approssimative o addirittura errate, il suo eudiometro e i
suoi strumenti furono usati in tutta Europa da altri
studiosi tra i quali il chimico-fisico e filosofo inglese
Joseph Priestley e Antoine-Laurent Lavoisier, uno dei padri
della chimica moderna.
Da “Avvisi Patrii” n° 21 del
25 maggio 1793

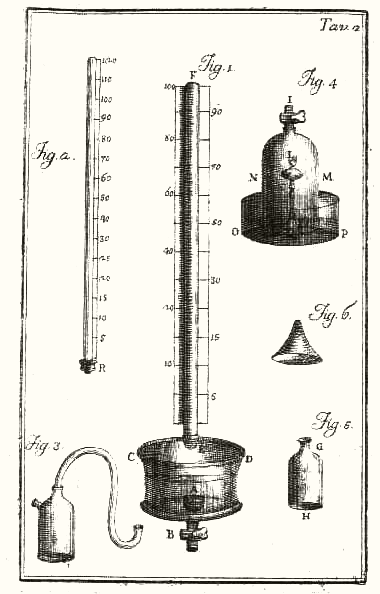
Il Cronyometro inventato da Marsilio Mandriani. |
Il
Cav. Marsilio Mandriani ben noto per le sue speculazioni e
talenti dimostrati nelle cose fisiche ha inventato una
Macchina, che, come leggesi negli Opuscoli di Milano,
potrebbe chiamarsi Cronyometro, ossia Misura-tempo della
pioggia. Può essa servire altresì a misurarne la quantità;
mediante una piccola variazione. Ognun sa che l’aria
insalubre, ed irrespirabile è migliorata, e resa respirabile
dalle piogge; essendo universale l’osservazione, che l’aria
stessa delle paludi, e de’ luoghi più insalubri dopo una
dirotta pioggia si può respirare senza timore e pericolo di
contrarre una delle malattie conosciute sotto il nome di
morbi d’aria cattiva. Nè men l’aria delle risaje ne’ tempi
di primavera e d’autunno è perniciosa per la stessa regione.
Lo stesso effetto benefico producesi dalle piogge nelle
Paludi Pontine, nelle Maremme di Siena ec. E se accada, che
passi molto tempo senza piovere le malattie suddette si
fanno frequenti: così che per viaggiare a quelle parti
convien aspettare, che siano cadute piogge dirotte. Prova di
ciò evidentissima, dice l’Autore, io ebbi in una piccola
scorsa che io feci nelle Maremme Senesi. Non ebbi prima
d’intraprendere un tal viaggio l’avvertenza di domandare se
era molto tempo, che in quelle Maremme non era piovuto:
trovai l’aria molto viziata ed insalubre. Le malattie
putride fatte frequenti, la respirazione poco libera, un
certo calor cutaneo, ed un abbattimento straordinario delle
forze unito ad un certo senso di peso universale a tutti i
muscoli, mi rendevano bastevolmente avvertito
dell’insalubrità di quell’aria. Ciò nonostante m’indussi a
respirarla percorrendo quelle vallate bonificate dalla
Sovrana Munificenza. Quando ecco inaspettato insorge un
minaccioso temporale che si scioglie in una dirottissima e
rovinosa pioggia; la quale, sebbene non durasse che per
brevissim’ora, pure talmente fu sensibile l’effetto della di
lei benefica influenza, che dissipato il calor cutaneo, resa
libera e facile la respirazione, e ritornato il vigore ai
muscoli, mi trovai come rinnovato; e l’eudiometro che aveva
meco dimostrommi che quella pioggia era bastata a migliorare
l’aria di quelle vallate.
Posto ciò non deve sembrar cotanto irragionevole la nostra
consuetudine di scegliere il piovoso autunno a preferenza
d’ogni altra più amena stagione per villeggiare; perché se
le nostre case di campagna fossero tutte in luoghi di aria
costantemente in ogni stagione salubre, saremmo ben poco
avveduti se all’amenità delle altre stagioni preferissimo
l’incostanza dell’autunno, ma siccome buona parte delle
nostre villeggiature sono situate in luoghi, ne’ quali nella
state ed anche nella primavera, per le particolari
circostanze delle acque e pel genere della coltivazione,
l’aria non è molto sana, si è convenuto di passare nelle
campagne quella stagione in cui l’aria per la frequenza
delle piogge è dappertutto di un’uniforme salubrità.

Manifesto sulle: Ricerche fisiche intorno alla
salubrità dell'aria.
Biblioteca Lazzerini - Prato |
Avendo dunque le piogge una tanto diretta influenza sulla
salubrità dell’aria, nessuna vi sarà, che giudicar possa
come sterile ed inutile curiosità il determinare la durata
delle piogge per mezzo di una macchina ben fatta: giacchè,
se non è impossibile, è almeno sommamente incomodo e
difficile il tener conto, massima di notte, della durata
della pioggia per mezzo dell’orologio.
Se
la pioggia fosse sempre uniforme, la quantità dell’acqua
piovuta darebbe la quantità del tempo in cui è durata la
pioggia; ma siccome la pioggia ora è placida, ora è dirotta
e rovinosa, per estimare la durata della medesima è
necessario di fare in modo che in un luogo dato, tanto
quando piove adagio, come quando piove fortemente, la
pioggia sia sempre uniforme ed eguale. Ciò si ottiene
situando sul colmo di un tetto un ampio vaso di rame,
terminante in un cono acciocché l’acqua tutta si raccolga
nel fondo. Questo vaso è sostenuto da quattro grossi bastoni
di ferro che lo tengono sollevato dal tetto. Nel fondo
conico di questo vaso è situato un sifone di rame, la
curvatura del quale si solleva dal fondo del vaso di circa
otto in dieci linee. Il braccio più lungo di questo sifone
passa pel tetto, e per la soffitta, o volta nella sottoposta
stanza, ed entra in un vaso, ove l’acqua si raccoglie.
Lateralmente a questo sifone sono saldati due tubi aperti di
rame, il lembo de’ quali, per la parte per cui entrano nel
vaso sopravanza di circa due linee la curvatura del sifone.
Il diametro di questi due tubi è di circa un pollice e
mezzo. L’offizio di questi è di non permettere mai che
l’acque nel fondo del vaso s’innalzi più di due linee circa
al disopra della curvatura del sifone, perché arrivata al
disopra del livello del lembo delle aperture di questi due
tubi, per quelli esce e si scarica sul tetto in modo che,
tanto quando piove placidamente, come quando la pioggia è
dirotta e rovinosa, il flusso del sifone è sempre equanime e
uniforme; poiché l’acqua nel fondo conico del vaso è in ogni
circostanza di pioggia ad un’altezza sempre costante, per
cui il flusso del sifone deve necessariamente essere
uniforme ed equabile. Perlocchè determinando una volta per
sempre la quantità dell’acqua efflussa dal sifone, per es.
nello spazio di un’ora, si può facilmente dalla quantità
cadutane nel vaso entro la stanza, col quale come dicemmo,
comunica il sifone, trovare la durata della pioggia. Se
questo vaso sarà di una figura cilindrica, o quadrata si
potrà facilmente per mezzo di una scala annessavi misurare
la quantità dell’acqua cadutavi, e da questa la durata della
pioggia, dividendo l’altezza del vaso in varie parti eguali,
ciascuna delle quali equivalga all’acqua che cade in un’ora;
e suddividendo ciascuno di questi spazj rappresentanti
un’ora, in un dato numero di parti eguali le quali
rappresenteranno le divisioni di un’ora ecc.
Il
vaso di cui mi servo è un cilindro cavo di latta
inverniciata, lateralmente al quale evvi saldato un tubolo
di latta, in cui è inserita una canna comunicante di
cristallo parallela al vaso stesso acciò si possa conoscere
l’elevazione dell’acqua caduta nel vaso e da questa il tempo
della durata della pioggia.
|