|

di Roberto Pedemonte

Benjamin Franklin.
Dipinto di: Jean-Baptiste Greuze, 1777 |
Dallo scritto degli “Avvisi Patrii”
genovesi del 1780 che pubblichiamo in questo numero della
Rivista, si comprende quale fosse la capacità espositiva di
Benjamin Franklin. I primi capoversi trattano con semplicità
e chiarezza, forse inaspettate per l’epoca, la circolazione
generale dell’atmosfera, che viene ricondotta in termini
illuminanti, considerato che le teorie del matematico
francese Gaspard Gustave de Coriolis, riguardo l’influenza
della rotazione della Terra sulla circolazione atmosferica
(vedi Rivista Ligure di Meteorologia numeri 18, 19, 20 e
22), dovevano ancora essere formulate. Benjamin Franklin
(nato a Boston il 17 gennaio 1706 e morto a Philadelphia il
17 aprile 1990), diplomatico, inventore, filantropo,
giornalista, scienziato, ebbe modo di occuparsi anche delle
Aurore Boreali, fenomeno fantastico che ha, da sempre,
affascinato e ammaliato il genere umano. Sua fu la prima
osservazione sul fatto che si presentavano più
frequentemente quanto più si procedeva verso i poli.
La sua penna sciolta ci permette di
comprendere quali fossero i pensieri e le deduzioni e le
ipotesi sulle aurore boreali degli uomini di scienza del
XVIII secolo. Leggendo con interesse quanto espone nella sua
memoria il “Sig. Francklin”, avremo modo di confrontarlo con
quelle che sono le attuali conoscenze sul fenomeno delle
Aurore Boreali, scorrendo l’articolo redatto da Diego Rosa
in questo stesso numero, corredato dalle fotografie scattate
da Massimo Riso nel ventoso inverno islandese.
Buona lettura.
Da “Avvisi Patrii” n° III
del 22 Gennaio 1780
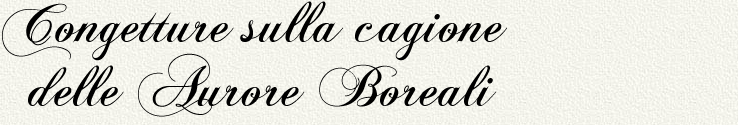

Il Ministro Colbert e Luigi XIV visitano l'Academie
Royale des Sciences.
Incisione di S. Le Clerc del 1671 |
Il Sig. Francklin
anche in mezzo agli affari più seri non lascia di essere un
gran filosofo, ed un attento osservatore. Secondando egli il
suo naturale trasporto per la Fisica, che ha saputo così
bene illustrare con nuovi ingegnosi sistemi, ha dato luogo
ultimamente al Sig. Le Roy di leggere alla R. Accademia
delle scienze di Parigi una sua Memoria, che contiene alcune
Congetture sulla cagione delle Aurore Boreali. Eccole:
L’aria riscaldata
divien più leggera, che quella, ch’è d’una tempra più
fredda. Fatta più leggera si alza, e il luogo da essa già
occupato, si rimpiazza tosto dall’aria vicina più fredda, e
più pesante.
Essendo riscaldata in
mezzo di una Camera con un fornello, o con una stuffa, si
solleva, e distendesi sulla più fredda, fino a che tocchi le
pareti, che essendo più fredde la condensano. Allora fatta
più pesante torna a discendere, e prende il luogo di quella,
che si è frattanto avvicinata al fuoco per fare lo stesso
giro.
Così per mezzo del
fuoco si fa una circolazione continua dell’aria, ch’è nella
camera; circolazione, che può rendersi visibile facendo un
po’ di fumo, il quale prenderà le medesime direzioni. Per
meglio convincervene aprite alquanto una porta fra due
stanze, delle quali l’una sia riscaldata, e l’altra no:
presentate successivamente una candela accesa all’alto, al
basso, e alla metà di questa porta: voi riconoscerete alle
differenti direzioni della fiamma, che una corrente d’aria
riscaldata esce continuamente dalla camera per la parte
superiore, un’altra d’aria fredda n’entra pel basso, e
pochissimo movimento v’è al luogo di mezzo.
La natura produce un
simil effetto sull’aria del nostro Globo. L’aria riscaldata
fra i Tropici tende perpetuamente a sollevarsi, e il luogo,
che abbandona, vien occupato dai venti del Nord, e del Sud
provenienti da regioni più fredde.
L’aria fatta più
leggera per il riscaldamento, galleggiando su un’altra più
fredda e più densa dee spargersi verso il Nord, e verso il
Sud, e discendere presso i due Poli per sostituirsi a
quella, che si è portata verso l’Equatore. Così si fa nella
nostra Atmosfera una circolazione d’aria come nella
mentovata stanza.
Infatti le direzioni
differenti ed opposte delle nuvole dimostrano le direzioni
dell’arie di peso diverso, come quelle del fumo, e della
fiamma nella esperienza della camera, e della porta.
La gran quantità di
vapori, che s’innalza fra i Tropici, forma delle nuvole, che
hanno molta elettricità: alcune cadono in pioggia prima di
giungere alle regioni polari, ed altre vi arrivano.
Se si raccolga della
pioggia in un vaso isolato, o posato sopra di un vetro,
questo vaso sarà elettrizzato, perché ogni goccia vi apporta
un po’ di elettricità. Lo stesso succederà se si usi l’istessa
cautela nel raccogliere della neve, o della grandine.
L’elettricità, che
così discende ne’ climi temperati vien ricevuta e assorbita
dalla terra.
Quando le nubi non si
scaricano sufficientemente per mezzo di quella operazione
graduale, scaricansi talora subitamente scagliando fulmini
sulla terra, che trovasi in istato di ricevere la loro
elettricità.
La terra ne’ climi
temperati, e caldi è generalmente propria a riceverla,
perché è propria a trasmetterla.
Un certo grado di
calore rende atti a trasmettere l’elettricità alcuni corpi,
che senza tal grado atti a ciò non sarebbero. Così la cera
nello stato di fluidità, e vetro ammollito dal calore
possono amendue trasmettere, e condurre l’elettricità.
L’acqua ha la
proprietà di trasmettere l’elettricità essendo gelata,
quantunque ad un freddo mediocre, la perde in parte; se il
freddo è estremo, la perde totalmente.
La neve, cadendo
sulla terra gelata, ritiene la sua elettricità; e la
comunica di fatti ai corpi isolati, se dopo di esser caduta
sia trasportata altrove dal vento.
L’umidità contenuta
nelle nuvole, che si alzano all’Equatore, arrivando alle
regioni polari, dev’esservi condensata, e cadere in neve.
La gran crosta di
ghiaccio, che copre stabilmente quelle regioni, può essere
sì fortemente gelata da impedire che l’elettricità portata
dalla neve penetri nella terra.
Tal elettricità
adunque può essere accumulata su quella crosta di ghiaccio.
L’Atmosfera, che ha
forse tre, o quattro leghe
[15/20 km N.d.R.] d’altezza,
essendo più pesante nelle regioni polari, che fra i Tropici, dev’essere colà men elevata; e men alta vi dev’essere
ancora, perché essendo presso i poli minore la forza
centrifuga, dee trovarvisi minore quantità d’aria, e per
conseguenza men alta ne sarà la colonna. Pertanto vi dee
essere minor distanza dalla terra al vuoto, ch’è sopra
l’atmosfera nelle regioni polari, che fra i Tropici. Quindi
il fluido elettrico accumulato sulla crosta di ghiaccio
presso il polo penetrerà più facilmente l’atmosfera nelle
direzione perpendicolare, che nell’orizzontale: tanto più,
che la resistenza dell’aria diminuisce gradatamente come la
sua densità a misura che s’innalza; laddove nella direzione
orizzontale, e presso la superficie della terra è sempre la
medesima.
Poiché il vuoto
artificiale trasmette bene l’elettricità, quello ch’è sopra
l’atmosfera lo trasmetterà ugualmente.
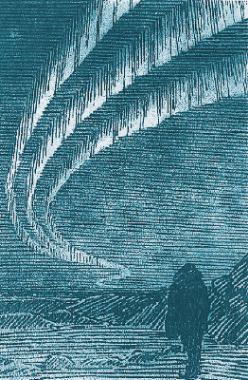
Xilografia di Frigjof Nansen basata su schizzo
del 1883 |
Supposti tali
Principj, passa il Signor Francklin a spiegare congetturando
la formazione delle Aurore Boreali ne’ seguenti termini.
Non è egli possibile,
che la quantità grande di elettricità portata nelle regioni
polari dalle nuvole, che seguendo la direzione de’ meridiani
vanno a radunarvisi, ivi si condensi, e vi cada colla neve?
Non è egli possibile, che l’elettricità, tendendo allora a
penetrar nella terra, e non potendolo a cagione del
ghiaccio, che vi s’oppone, risalga in alto come in una
troppo carica boccia di Leyden, si apra una strada a
traverso la poco elevata atmosfera di quelle regioni, corra
nel vuoto sopra dell’aria, e dirigasi verso l’Equatore
divergendo come i meridiani? L’elettricità non sarà ella
allora molto visibile ne’ luoghi, ove diverrà più densa? E
non diverrà ella men densa a misura che crescerà la sua
divergenza, fino a che trovi un passaggio per portarsi sulla
terra ne’ climi più temperati, o ivi si frammischi coll’aria
superiore? E se così opera la natura, non dovranno elleno
risultarne tutte le apparenze delle Aurore Boreali?
Questi si vedranno
più frequenti nell’autunno, all’avvicinarsi dell’inverno;
non solo perché in quella stagione le notti sono più lunghe;
ma eziandio perché nella state la quasi continua presenza
del sole può ammollire alquanto la superficie della gran
crosta di ghiaccio delle regioni polari, e renderla così più
propria a condurre l’elettricità, onde allora se ne potrà
ivi accumulare in minor copia.
Divenendo pel freddo
eccessivo più densa l’atmosfera delle regioni polari, ed
essendo gelata l’umidità, di cui si carica, non potrebbe
ella essere renduta visibile a chi vive in un’aria più
rarefatta, e men presso il polo per mezzo di una qualche
gran luce? In tal caso sebbene l’atmosfera sia un intero
circolo, che stendesi a 10. gradi di latitudine intorno al
polo, non dee ella mostrarsi agli spettatori, posti in luogo
da non vederne che una porzione, sotto la forma di un
segmento? Restandone la corda sotto l’orizzonte, ed
alzandosene l’arco sopra di esso più, o meno
proporzionatamente alla latitudine, in cui uno si trova, non
dee quello comparire di un colore alquanto oscuro, ma
trasparente abbastanza, perché possiamo vedervi a traverso
alcune stelle?
I raggi elettrici
divergono tra di loro per una mutua ripulsione, a meno che
non siavi qualche altro corpo conduttore, abbastanza vicino
pere riceverli. Quando tal corpo è più distante, i raggi
divergono a principio, ma convergono poi per entrarvi.

L'aurora boreale intorno al Polo Sud vista dallo
Space Shuttle.
Foto: NASA |
Gli effetti del
fluido elettrico non possono eglino spiegare alcune di
quelle varietà, che osservansi ne’ movimenti, e nelle
figure, che prende la materia immensa delle Aurore Boreali?
Basta considerare, che passando queste sopra l’atmosfera, o
andando dai poli all’Equatore sulla direzione dei meridiani,
i raggi di tal materia possono in molti luoghi del loro
passaggio trovare sotto di se delle regioni nebulose, e
dell’aria umida, le quali essenso nello stato naturale
dell’elettricità, e nello stato negativo, possono riceverli,
o farli convergere verso di se. Che se quelle regioni sono
già impregnate d’elettricità, i raggi luminosi possono
divergere dalle nubi ivi accolte, verso altri luoghi
egualmente umidi, e formar così quelle figure, chiamate
corone, e le altre apparenze, delle quali si fa sovente
menzione nelle descrizioni delle Aurore Boreali.
|