|

| |
 |
di Roberto
Pedemonte |
Con la terza e ultima parte concludiamo
la presentazione del lavoro di Pietro Maria Garibaldi sulla
climatologia genovese. In particolare, dopo aver illustrato
la nascita dell’osservatorio e la strumentazione acquisita,
spiega quali siano le grandezze meteorologiche misurate e
documenta, mediante tabelle, i valori dei vari elementi
misurati nei due decenni considerati, fornendo alcune
considerazioni.
Qui riportiamo le tabelle di confronto e
alcune note, tralasciando la descrizione dettagliata per
ogni elemento preso in considerazione e la parte relativa ai
dati sulle variazioni del magnetismo terrestre.
Si è provveduto a convertire in hPa i
valori della pressione atmosferica che, in origine, era
misurata in mm, ridotta a 0 °C ma non al livello medio del
mare.
Si noterà come i giorni di nebbia siano
numerosissimi. La climatologia attuale riferisce mediamente
di un solo giorno di nebbia, ovvero con visibilità inferiore
a 1 km, per la città. Tale raro fenomeno nel capoluogo
ligure avviene unicamente per avvezione, quando correnti
umide e calde provenienti dai quadranti meridionali,
particolarmente nei mesi primaverili, scorrono sopra la
superficie marina che conserva ancora temperatura piuttosto
bassa (12°/15°). Evidentemente è stato indicato il fenomeno
della nebbia in caso di riduzione orizzontale della
visibilità anche al di sopra degli standard attuali. Presso
l’aeroporto genovese il numero medio annuo di giorni con
foschia (periodo 1996-2008), ovvero visibilità orizzontale
maggiore di 1 km e inferiore a 10 km, è di 21.
Nelle tabelle, a puro titolo indicativo,
sono state aggiunte in colore rosso le medie dell’ultimo
decennio (1999-2008), estrapolate dalla stazione automatica
del Dipartimento di Ingegneria Ambientale dell’Università di
Genova, ubicata in Albaro, per temperatura e precipitazioni
e dall’osservatorio dell’aeroporto, ubicato a Sestri
Ponente, per il vento, lo stato del cielo e i fenomeni
atmosferici. La pressione, non essendo stata ridotta al
livello del mare nelle misurazioni ottocentesche, non è
stata presa in considerazione. I differenti siti,
strumentazione e modalità di valutazione dei fenomeni non
consentono, ovviamente, di raffrontare con metodo
scientifico i dati, tuttavia ci sembrava interessante
sottoporre ai lettori questo confronto, anche solo per
spirito di curiosità.
Da Pietro Maria Garibaldi,
Osservatorio della R. Università di Genova – Climatologia di
Genova desunta dai decenni meteorologici 1833-42 e 1871-80,
Tipografia del R. Istituto Sordo-Muti, Genova, 1884
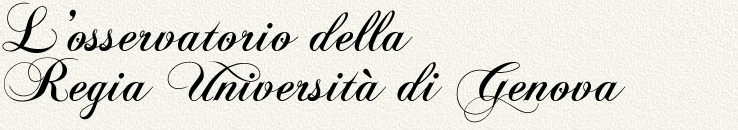
Parte
terza
Climatologia di
Genova
Il decennio
meteorologico 1833-42 fu studiato e disposto nei suoi
risultati dalla Direzione che impiantava l’osservatorio nel
1833. – I dati sono esposti e discussi in una bella
relazione che si trova nella guida di Genova (1) più volte
ricordata nelle attuali note: i dati principali sono
compendiati in tavole numeriche che mettono in evidenza le
condizioni climatologiche della Città durante il decennio.
Il decennio
meteorologico 1871-80 fu studiato e ordinato dalla Direzione
attuale: in altra parte delle presenti note sono esposti i
cangiamenti introdotti nella sala di osservazione, i
miglioramenti degli apparati a tutte le circostanze di fatto
che per avventura avessero potuto esercitare influenza sopra
i risultati finali.
(1) Guida di Genova, tipografia Ferrando
1846, pag. 143 e seg.
PARALLELO
DEI PERIODI METEORICI 1833-42 E 1871-80
I principali elementi
meteorologici dei due periodi decennali sono raccolti e
ordinati nel quadro seguente; così possono essere facilmente
confrontati e rilevarsene le armonie e le discrepanze
Temperatura
|
TEMPERATURA CENTIGRADA |
|
Periodi |
Media
normale |
Medie dei |
Medie delle estreme decennali |
Estremi assoluti |
Epoche degli assoluti |
|
Mass. assol. |
Min. assol. |
Mass. assol. |
Min. assol. |
Mass. |
Min. |
Massimi |
Minimi |
|
1833-42
|
16°,17
|
18°,13 |
13°,05 |
31°,67 |
-1°,23 |
32°,5 |
-3°,1 |
{ |
2 Agosto 1839
13 id. 1842 |
2 Genn. 1836 |
|
1871-80 |
16,16 |
18,87 |
12,97 |
33,18 |
-0,88 |
34,7 |
-4,8 |
{ |
3 Agosto 1873
9 Luglio 1874
7 Agosto 1876 |
10 Dic. 1879 |
|
1999-2008 |
15,80 |
19,02 |
12,58 |
33,43 |
-0,90 |
36,8 |
-3,8 |
|
5 Agosto 2003 |
2 Mar. 2005 |
|
|
1833-42 |
1871-80 |
|
Temperatura media annua max |
16,8 (1834) |
17,0 (1873) |
|
Temperatura media annua min |
14,6 (1838) |
14,6 (1879) |
|
Temperatura estrema max |
32,5 (1839) |
34,7 (1873-74-76) |
|
Temperatura estrema min |
-3,1 (1836) |
-4,8 (1879) |
|
PRESSIONE ATMOSFERICA RIDOTTA A
0° |
|
Periodi |
Media
normale |
Medie delle pressioni |
Estreme pressioni |
Differenza |
Epoche della |
|
Mass. |
Min. |
Mass. |
Min. |
Mass. pressione |
Min. pressione |
|
1833-42 |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
|
|
|
1008,8 |
1020,1 |
993,6 |
1034,2 |
972,0 |
62,3 |
27 Febbraio 1834
a 9 mattina |
26 Febbraio 1838
a 8 mattina |
|
1871-80 |
1009,3 |
1020,0 |
994,2 |
1033,3 |
971,7 |
61,5 |
24 Febbraio 1876
a 9 mattina |
23 Febbraio 1879
a 9 mattina |
|
|
1833-42 |
1871-80 |
|
Pressione media annua max |
1012,2 (1834) |
1010,3 (1870) |
|
Pressione media annua min |
1006,8 (1838) |
1007,8 (1879) |
Meteore acquee
|
METEORE ACQUEE |
|
Periodi |
Pioggia media decennale in mm |
Media decennale dei giorni piovosi |
Rapporto della pioggia ai giorni piovosi |
Giorni |
Stato del cielo
giorni |
|
di
neve |
di
nebbia |
di
gelo |
di
grandine |
di
temporale |
di
sereno |
di
variabile |
di
nuvolo |
|
1833-42 |
1345,92 |
131 |
10,27 |
6,3 |
42,5 |
8,4 |
6,5 |
31,8 |
118 |
160 |
87 |
|
1871-80 |
1359,23 |
123 |
11,05 |
5,3 |
68,2 |
6,7 |
4,4 |
30,9 |
143 |
101 |
121 |
|
1999-2008 |
1221,53 |
111 |
11,00 |
1,7 |
0,5 |
2,7 |
1,9 |
38,2 |
154 |
122 |
89 |
Frequenza dei venti
|
FREQUENZA DE VENTI in % |
|
Periodi |
N |
NE |
E |
SE |
S |
SO |
O |
NO |
Direzione media normale |
|
1833-42 |
29,0 |
15,9 |
6,0 |
18,7 |
10,6 |
15,7 |
2,1 |
2,0 |
N
84° E |
|
1871-80 |
22,0 |
23,4 |
5,2 |
19,7 |
6,7 |
17,0 |
1,7 |
4,3 |
N
76 E |
|
1999-2008 |
15,3 |
38,5 |
8,5 |
15,8 |
12,0 |
5,3 |
3,1 |
1,5 |
|
L’esame delle cifre suddette conduce alle seguenti
conclusioni:
1.° La temperatura media di ciascun decennio è perfettamente
eguale; sono vicinissimi fra loro le medie dei massimi e
minimi assoluti di temperatura; concordano le medie delle
estreme decennali e gli estremi assoluti. Del pari
corrispondono le epoche degli assoluti massimi e minimi,
così che per ciò che riguarda la temperatura la climatologia
di Genova può ritenersi come esattamente definita dalle
risultanze dei decenni in discussione.
2.° Per ciò che riguarda la pressione atmosferica i due
decenni sono del pari in perfetta concordanza; nelle medie
normali, nelle medie delle pressioni massime e minime, nei
valori delle pressioni estreme e nelle loro differenze:
anche le epoche delle pressioni massime e minime
corrispondono perfettamente per mese e quasi per giorno.
3.° La quantità media di pioggia caduta nei decenni è
uguale: il periodo 1871-80 ne ebbe millimetri 13,31 in più
dell’altro 1833-42: il rapporto delle pioggie ai giorni
piovosi è del pari corrispondente. La media decennale dei
giorni di neve, gelo, grandine del primo decennio supera
alquanto quella del secondo, il quale a sua volta supera il
primo per i giorni di nebbia: i periodi corrispondono per i
giorni temporaleschi.
Nei giorni d sereno, di nuvolo e di variabile vi è
differenza; ma di questa se ne ha la ragione nel metodo
tenuto nei computi decennali nel periodo 1871-80. In questo
decennio le modalità dello stato del cielo furono registrate
in numero maggiore e con maggiori dettagli così che doveva
aumentare il numero dei giorni sereni e nuvolosi e diminuire
quello dei variabili come si verifica nel decennio ultimo.
4.° Le differenze parziali che si riscontrano in alcune
meniere di vento nei due decenni si deve ripetere da che in
quello del 1833 al 42 i venti erano osservati sono quattro
volte al giorno, mentre nel periodo 1871-80 il numero delle
registrazioni è orario cioè di ventiquattro nella giornata:
ciò spiega la differenza delle cifre correlative dei due
decenni e assicura che i dati dell’ultimo sono più vicini al
vero.
CONCLUSIONE
Da tutto quanto precede se ne possono dedurre le seguenti
conclusioni generali:
1.° Che il clima di Genova non è sensibilmente variato in
quest’ultimo mezzo secolo; ciò era presunto da molti criteri
ed indizii attendibilissimi: attualmente questa costanza è
fisicamente accertata da misure meteorologiche dirette.
2.° Le condizioni termiche, barometriche; la quantità
assoluta e la distribuzione della pioggia; il numero dei
giorni sereni, nuvoli, variabili; i giorni di gelo,
grandine, tempesta; la sistemazione dei venti in Città e nel
Porto, sono quantità fisicamente definite, e i loro valori –
rappresentati da cifre frutto di osservazioni diligenti e
coscenziose – devono essere considerate come la vera
espressione delle leggi fisiche che governano la
climatologia di Genova e tolte come sicuro fondamento nello
studio e soluzione dei problemi igienici, commerciali e
tecnici che nell’interesse della Città potranno presentarsi
in avvenire.
|