|

| |
 |
di Roberto
Pedemonte |
Nella relazione del prof. Pietro Maria
Garibaldi del 1884 presentata negli ultimi numeri della
rivista, si faceva riferimento alle notizie meteorologiche
contenute nella Guida di Genova pubblicata per i tipi
Ferrando nel 1846, nella quale era contenuto un compendio
meteorologico riferito al primo decennio di funzionamento
dell’Osservatorio della Regia Università di Genova, cioè dal
1833 al 1842. Benché alcuni dati sommari erano già contenuti
nella predetta relazione (vedasi Rivista Ligure di
Meteorologia n. 32) qui proponiamo, in forma
particolareggiata, le tabelle e le annotazioni riportati
nella Guida, opera di Lorenzo Pareto, uomo di scienza
dedicatosi principalmente allo studio della geologia ma che
ha anche avuto vita politica attiva sia come deputato che
promotore dei moti insurrezionali di Genova del 1849.
L’analisi è molto dettagliata e verrà
presentata su queste pagine divisa in capitoli, ciascuno
dedicato a un elemento del clima. Iniziamo con la
temperatura, la cui analisi, per ragioni di lunghezza, viene
divisa in due parti: la prima presenta una disamina e un
commento dei dati rilevati mentre la seconda, che
pubblicheremo sul prossimo numero, riporterà quattro tabelle
contenenti i valori medi ed estremi.
Da Descrizione di Genova e del
Genovesato – Volume I, Tipografia Ferrando, Genova, 1846
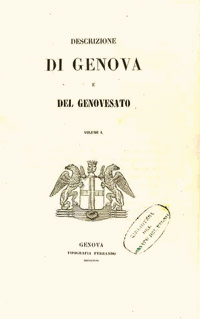
Copertina originale del volume: Descrizione
di Genova e del Genovesato
(Cliccare sull'immagine per ingrandirla) |
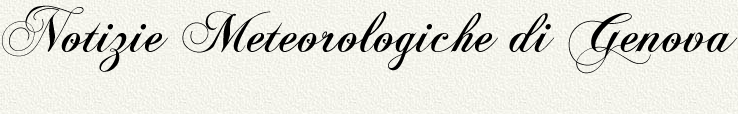
Parte
prima
Al Lettore
|

Lorenzo N.
Pareto |
Il lavoro che
presentiamo ai lettori della Guida sulla meteorologia della
Liguria, o,più esattamente parlando della città di Genova, è
opera del chiarissimo professore D. Giacomo Garibaldi che la
morte ha da poco rapito alle scienze all’affetto ed
all’ammirazione di quelli cui era dato di conoscerlo
intimamente. Caldo egli dell’amore della sua patria cercò
sempre per quanto era da lu, promuoverne il decoro ed il
lustro, ed infatti a lui si deve primieramente lo
stabilimento dell’osservatorio meteorologico della nostra
Università, e per mezzo di questo gli fu dato di constatare
fatti molteplici circa la nostra meteorologia, che dapprima
soltanto sospettavansi, ma de’ quali non eravi alcuna
certezza e con le osservazioni eseguite in
quest’osservatorio durante un decennio, e con tanta
accuratezza, se non possono uguagliare la certezza e
l’ampiezza de’ fatti, che per la meteorologia di altri
paesi, ne’ quali da più lungo tempo furono stabiliti
osservatorii è stato dato raggiungere, presentano nondimeno
indizii sufficienti a farci concepire un’idea esatta di
quanto concerne la meteorologia d’un punto, che per la sua
situazione è interessantissimo e che dai più dotti è stato
indicato come uno di quelli che può somministrare
osservazioni più pregevoli ed atte a far progredire una
scienza che puossi dire ancora sul nascere.
Situati noi nel punto più settentrionale del mediterraneo, e
ove quasi si congiungono due grandi catene di montagne, era
facile il sospettare che qualche particolare fenomeno
dovesse presentare la nostra meteorologia. Dall’esatto ed
accurato lavoro del professor Garibaldi si può riconoscere
che questo sospetto aveva stabile fondamento; straordinaria
infatti tra noi la quantità della pioggia, speciali le
direzioni de’ venti; e quanto alle temperature, certamente
Genova è uno de’ punti in cui a più settentrionale
latitudine corrisponde più mite clima. Tutte queste cose nel
dotto lavoro dell’egregio, che noi piangiamo, appariscono,
siccome vi appariscono nuove osservazioni sull’abbassamento
o rialzamento del livello delle acque del nostro mare a
seconda dell’aumento o diminuzione delle pressioni
barometriche.
Avrebbe bramato quell’esimio poter dare per complemento al
suo lavoro sulla meteorologia un dato delle sue osservazioni
sulla declinazione e inclinazione dell’ago magnetico in un
punto sì notevole della periferia del mediterraneo qual è
Genova, ma la morte lo rapì mentre queste osservazioni stava
portando al termine. Non mancò però un dotto sacerdote, D.
Fortunato Ciocca, che ne istituì altre le quali infine
dell’articolo sulla meteorologia noi presentiamo in
supplemento di quanto il professor Garibaldi stava
preparando, e per far conoscere esattamente la quantità di
deviazione dell’ago magnetico su queste nostre sponde, e in
una città in cui tutto ciò che concerne gli studi nautici
deve avere sulle altre scienze il primato, perché questi
soli possono fornire un tal quale compenso alle passate
grandezze e ancor farci gloriosi percorrere quell’elemento
di cui un Nostro misurò primo la più ampia estensione e aprì
la strada a tutto precorrerlo per quanto esso cerchia la
stabile terra.
Io ho ardito, o cortese lettore, anticipare al tuo giudizio
e fare un elogio del lavoro che ti presento, il quale è
opera di un egregio di cui la nostra città rimpiange la
perdita. Tu confermerai senza dubbio quanto ne ho accennato,
perché nel giudicare non fui guidato da spirito prevenuto e
perché mi stava davanti la massima che ai morti devesi tutta
la verità. Avrei dovuto, lo so, astenermi dal pronunciare
alcun giudizio, ma mi doleva di lasciar trascorrere
l’occasione di tributare alla memoria di un amico e di un
dotto cultore delle scienze, quell’omaggio che la città
nostra e quelli tutti che conoscevano l’alto sapere di lui
congiunto ad estrema modestia, si compiacevano di
proferirgli durante la vita.
Vivi felice.
LORENZO N. PARETO
Temperatura
|

Atrio della
Regia Università di Genova |
Per dare un’idea del
clima di Genova e del posto che gli compete fra i varii
climi della nostra penisola presentiamo in diversi quadri il
sunto delle osservazioni termometriche del decennio,
ordinate nel modo da noi stimato più acconcio a far
conoscere la media temperatura del luogo, le principali
modificazioni di essa cagionate dalle varie posizioni del
sole nell’eclittica e rispetto al meridiano, ed ancora le
massime e le minime temperature dei mesi, delle stagioni e
degli anni.
Il primo quadro presenta i medii annuali delle temperature
orarie, delle massime e minime temperature diurne, e le
semisomme di questi ultimi medii, le quali, come è ben noto,
corrispondono assai prossimamente ai medii annui delle medie
temperature giornaliere.
Il secondo contiene le medie decennali delle temperature
orarie, nonché delle massime, minime e medie temperature
corrispondenti ai diversi mesi e stagioni; considerando le
stagioni non astronomicamente, ma giusta la consuetudine de’
meteorologisti, cioè prendendo per l’inverno i mesi di
dicembre, gennaio e febbraio; per l’estate i mesi di giugno,
luglio ed agosto; e gli altri mesi per le stagioni
intermedie.
Nel terzo son riferiti i medii decennali delle estreme
temperature osservate nei periodi dei mesi e delle stagioni,
ed i medii consimili delle massime oscillazioni
termometriche avute ne’ suddetti periodi e nei periodi
diurni.
Finalmente nell’ultimo si sono riferite le massime e minime
temperature assolute d’ogni anno coll’indicazione delle
epoche ad esse corrispondenti.
Dalla discussione delle cifre di questi quadri deduconsi
diverse generalità, riguardo all’andamento delle temperature
in Genova, che passiamo ora ad esporre.
In primo luogo vediamo che la media delle temperature,
osservate alle 9 del mattino, è presso a poco eguale alla
media temperatura dell’anno, la quale, calcolata
sull’insieme di tutte le osservazioni, ascende a 15.° 58. 1.
Questa è ben poco diversa dalla media temperatura di Nizza,
Firenze e Roma, ed è notabilmente maggiore di quella che si
dovrebbe aspettare, avendo soltanto riguardo alla latitudine
di Genova, e non considerando tutte quelle circostanze
particolari del suolo, che influiscono nella distribuzione
delle temperature alla superficie del globo, tra le quali
sono primarie la vicinanza del mare ed il riparo de’ monti
2.
Le medie temperature annuali variano assai da un anno
all’altro, la maggiore di quelle del decennio fu di 16.° 83
nell’anno 1834, e la minima di 14.° 62 nel 1838; alle quali
corrisponde una oscillazione di 2.° 21. La grandezza di
questa oscillazione ci avverte, che per avere la media
temperatura assoluta del luogo indipendente dalle cause
accidentali che possono modificarla, si richiederebbero
osservazioni prolungate ad un maggior numero d’anni.
La media temperatura annuale sarebbe insufficiente a
caratterizzare il clima di Genova, quando non si avesse
riguardo alle variazioni cui son soggette le temperature dei
giorni, de’ mesi e delle stagioni.
L’andamento medio della temperatura durante il periodo
diurno si rileva prossimamente dal modo in cui si succedono
i valori orarii della medesima. In generale il termometro
alle 9 del mattino segna una temperatura pressoché eguale
alla media diurna, di poi con progressione alquanto diversa
nei varii mesi e stagini, sale gradatamente sino ad un
massimo, che raggiunge intorno alle 3 pomeridiane nella
primavera e enll’autunno, verso le 2 nell’inverno, e presso
le 4 in estate; quindi esso discende verso un secondo medio
che raggiunge prima delle 9 di sera, e così continua fino ad
un minimo che tocca alla mattina prima del levar del sole.
L’oscillazione media, compresa fra le 9 di mattina e le 3
pomeridiane, non arriva a 2 gradi, mentre la media
oscillazione, compresa fra il massimo e minimo giornale,
oltrepassa i 5 gradi.
L’andamento medio delle temperature nel corso dell’anno si
rileva similmente dal modo in cui succedono le cifre dei
medii mensuali e dei medii delle stagioni 3.
Si vede che la media temperatura, ridotta al suo minimo
grado in gennaio, ascende, durante sette mesi, verso un
valore massimo che raggiunge in sul finire di luglio, ed
oltrepassato questo, essa, durante gli altri cinque mesi,
discende per ricondursi al minimo. Avendo le epoche delle
estreme temperature d’ogni anno si potevano calcolare le
epoche medie della minima e della massima temperatura
annuale, e si è trovato che la prima corrisponde ai 13 di
gennaio e la seconda ai 27 di luglio. Variando fra questi
estremi la temperatura passa due volte pel suo valor medio,
e ciò avviene il 14 aprile ed il 21 di ottobre. Queste
epoche medie determinano i limiti veri delle diverse
stagioni in Genova.
La differenza fra la minima e la massima delle medie
mensuali è di 17 gradi, i quali sono inegualmente
distribuiti nei diversi mesi: infatti paragonando le
differenze successive delle temperature dei singoli mesi si
trova che dopo il minimo di gennaio le stesse temperature
ascendono lentamente nei primi quattro mesi, poscia assai
più rapidamente nel quinto e sesto, e di nuovo lentamente
nel mese adiacente all’epoca del massimo; oltrepassato
questo, le temperature mensuali discendono verso il minimo;
lentamente assai sul principio, ma ben tosto con corso molto
veloce, che diviene velocissimo in novembre.
Paragonando le medie delle stagioni colla media annuale, si
rileva che quest’ultima supera di 1°, 7 la media di
primavera, ed è superata di 1° dalla media autunnale; che
inoltre la temperatura dell’inverno discende di 7°, 2 al
disotto della media annuale, mentre quella d’estate ascende
a 7°, 9 al disopra.
Il clima di Genova è rinomato per l’incostanza delle
temperature: infatti la colonna termometrica vi è soggetta a
frequenti oscillazioni, talvolta assai estese anche nel
breve periodo d’una giornata. Il medio valore delle massime
digressioni giornali del termometro ascende a 8°, 5 nei
periodi mensuali, ed a 9, 5 nei periodi delle stagioni: le
maggiori di queste digressioni si trovano nella primavera e
nell’estate, le minori nell’inverno e nell’autunno 4.
Dal confronto della media annuale con i medii delle massime
e minime temperature dei mesi e delle stagioni, si desume
che il termometro, nelle sue maggiori rilevazioni, rimane in
gennaio un grado circa al disotto della suddetta media
annuale, che tocca la stessa media in febbraio, e che la
sorpassa in tutti gli altri mesi sino a discostarsene di 15
gradi, il che succede nei mesi di luglio e di agosto, ne’
quali la massima temperatura supera di poco i 30°½. Invece
nelle sue maggiori depressioni è nei soli mesi di luglio e
d’agosto che si sostiene di 2 circa gradi al disopra della
media annuale, mentre in tutti gli altri scende al disotto
della medesima, e se ne allontana sino a 16 gradi, il che
avviene nel mese di gennaio in cui la minima temperatura è
0°, 4.
Ricercando le massime oscillazioni mensuali del termometro
le troviamo tutte comprese fra 12°, ¾ e 16°, ¾. Maggiori di
queste e più divergenti tra loro sono le massime
oscillazioni delle stagioni: quelle della primavera e
dell’autunno si estendono a 24°, la invernale è limitata a
18°, e l’estiva, che è la minore di tutte, arriva a soli
17°; la media di tutte queste rinviene 20°, 8.
Da quel che abbiamo detto disopra intorno alle massime
oscillazioni diurne possiamo concludere che nella primavera
queste concorrono colle massime oscillazioni delle stagioni,
mentre nell’estate le massime oscillazioni giornali
s’incontrano colle minime delle stagioni.
Rispetto in ultimo alle estreme temperature annuali,
troviamo che in questi dieci anni la massima oscillò fra
30°,5 e 35°,5, e la minima fra 1° sopra lo zero e 3°,1 al
disotto, onde l’oscillazione del massimo freddo fu doppia di
quella del massimo caldo 5. I medii valori di queste massime
o minime assolute li troviamo eguali a 31°,67 sopra, ed
1°,23 sotto lo zero, dimodochè il movimento della colonna
termometrica, dal massimo caldo estivo al massimo freddo
invernale, può dirsi in Genova di 33 gradi. Questa massima
digressione, che risulta dal concorso simultaneo delle cause
che producono le variazioni annue e diurne del termometro,
ha un valore quadruplo quasi di quella sopra notata,
compresa nei soli periodi diurni.
La massima di tutte le temperature osservate nel decennio,
ascese a 32°,3 il 13 agosto 1842, e la minima fra le
medesime discese 3°,1 sotto lo zero il 2 gennaio 1836;
quindi la massima digressione assoluta in questo periodo fu
di 35°,6.
Il massimo caldo estivo fu sempre in luglio od agosto,
tranne una volta in giugno. Il massimo freddo invernale fu
generalmente in gennaio; due volte soltanto sui primi di
febbraio, ed una sola volta in dicembre. Le epoche medie del
massimo caldo e del massimo freddo, dedotte da quelle
osservate nei singoli anni, corrispondono, come già dicemmo,
al 26, 6 di luglio ed al 12, 5 di gennaio.
In due soli anni la minima temperatura annuale si sostenne
al disopra dello zero, negli altri scese al disotto, meno
una volta che si fermò a zero. Durante il decennio si ebbero
in tutto 84 giorni di gelo, cioè una media di giorni 8 ogni
anno, de’ quali la metà cadde in gennaio 6.
NOTE
1
Vedasi il prospetto n.° 1.
2 Che
il riparo de’ monti influisca moltissimo sulla media
temperatura, ne fanno fede diverse località delle nostre
riviere, le quali, perché difese in questo modo più
immediatamente dai venti settentrionali, godono d’un
clima anche più mite del nostro; tali sono Portofino,
Camogli, Nervi, Pegli, S. Remo e Bordighera.
3
Vedasi il prospetto n.° 2.
4
Vedasi il prospetto n.° 3.
5
Vedasi il prospetto n.° 4.
6 Il
Giustiniani nel quinto libro de’ suoi annali fa menzione
di un freddo quali incredibile per queste parti, che
oppresse Genova nell’anno 1493, e tale che congelassi il
mare attorno ai ponti ed agli scali del porto, di
maniera che i barcaroli non potevano allargar le loro
barchette dalla terra, né navigare. Il Casoni ricorda un
freddo pure assai rigido avvenuto in febbraio del 1621,
per cui essendo nei giorni 8 e 9 piovuto, rimasero le
strade coperte da una lastra di ghiaccio che fu duopo
rompere a forza di picconi: videsi in allora pure
agghiacciato il mare in alcune parti della Darsena (Cas.
Ann. Lib. 2). I freddi memorabili che si fecero sentire
in Genova nel nostro secolo furono nel 1814 il 22
febbraio, nel 1816 il 31 gennaio, e nel 1830 il 2
febbraio: in questi il gelo fu assai intenso per tutta
la città ed anche in alcuni luoghi interni del porto.
|