|

| |
 |
di Roberto
Pedemonte |
In questo numero proseguiamo la
pubblicazione della parte climatologica della Guida di
Genova, presentando le tabelle che concludono l’analisi
della pressione atmosferica del primo decennio di
misurazioni presso l’Osservatorio della Regia Università di
Genova.
Nei prossimi numeri proporremo la parte dello studio del
Marchese Lorenzo Pareto, che ebbe quali collaboratori il
Prof. Cav. Sac, Giacomo Garibaldi e, dopo la morte di
questo, del D. Sac. Fortunato Ciocca, inerente l’effetto
degli altri elementi del clima sulla città di Genova
Da Descrizione di Genova e del
Genovesato – Volume I, Tipografia Ferrando, Genova, 1846
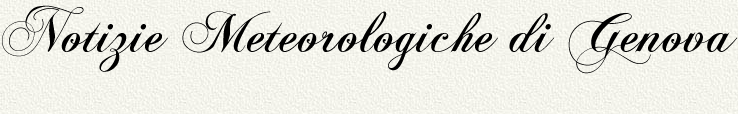
Parte
terza
Pressioni
Barometriche
Per far conoscere le
condizioni più generali della pressione atmosferica in
Genova, e le principali modificazioni ch’essa subisce nei
periodi dei giorni, dei mesi, delle stagioni e degli anni,
presentiamo in compendio i medii delle altezze barometriche,
osservate ne decennio, ordinati in diversi quadri
somiglianti a quelli già descritti trattando delle
temperature.
’ noto che nei nostri
climi le pressioni barometriche, come nelle regioni
equatoriali, sono soggette ad una doppia oscillazione
periodica, diurna, che si manifesta nelle osservazioni;
quando essendo fatte in ore opportunamente scelte, sono
anche in quel numero che si richiede perché vengano
compensati nei loro medii gli effetti delle cause
perturbatrici accidentali. Quale sia l’andamento di questa
oscillazione in Genova lo mostrano le cifre de’ nostri
quadri,
Si scorge
primieramente che la pressione atmosferica in tutti i mesi
dell’anno, verso le 9 del mattino, acquista un massimo
valore, dal quale discende poi, gradatamente dirigendosi ad
un minimo che più generalmente tocca intorno le 3 di sera, e
fra le 3 e 6 nei mesi caldi d’estate: oltrepassato questo
minimo, essa rimonta verso un secondo massimo, alquanto
minore del primo, che raggiunge intorno alle 9 di sera nei
mesi d’inverno, e posteriormente negli altri.
Il valore medio della
oscillazione o periodo discendente, compreso fra le 9 di
mattina e le 3 di sera, è uguale a 0mm, 692
[0.923 hPa], e quello del periodo ascendente, compreso fra
le 3 e le 9 di sera, è uguale a 0mm, 449 [0.599
hPa]: quest’ultimo corrisponde ai due terzi circa del primo
1.
Prendendo i medii
diurni di altre osservazioni barometriche eseguite pure in
Genova nella R. Scuola di Marina, ma ripetute di ora in ora
durante le 24 ore del giorno, abbiamo riconosciuto un
sufficiente accordo fra questi medii ed i valori che si
ottengono facendo la semisomma delle altezze massima e
minima osservate alle ore 9 di mattino e 3 di sera. A
seconda di cotesta relazione si son dedotte da quelle
estreme orarie le medie giornali, e da queste le medie
mensuali ed annuali, nonché la media assoluta di tutte le
pressioni barometriche osservate nel decennio.
Questa media
pressione assoluta, ossia decennale, si è trovata di 756mm,619
[1008.825 hPa]: notabili sono le differenze che s’incontrano
nelle medie dei singoli anni; la massima fra queste ascese
nel 1834 (che fu pur l’anno della massima temperatura) a
759, 139 [1012.185 hPa], e la minima rimase a 755, 079
[1006.772 hPa] nel 1838, anno in cui si ebbe la temperatura
minima; quindi le massime lor digressioni, rispetto alla
media assoluta, furono di 2mm,52 [3.36 hPa] al
disopra, e di 1mm,54 [2.05 hPa] al disotto.
L’ampiezza di queste
digressioni, che superano unite 4mm [5 hPa],
lascia sul vero valore della media pressione assoluta una
leggera incertezza, la quale cesserà quando possa dedursi da
un maggior numero di osservazioni.
La media pressione
assoluta, eguale a 756mm,619 [1008.825 hPa], si
riferisce alla temperatura 0 del mercurio barometrico, alla
temperatura media dell’aria di 15, 6, ed all’altezza di
metri 48 sul livello medio del mare. Riducendo la stessa a
quest’ultimo livello l’abbiamo trovata eguale a 761mm,268
[1015.024 hPa] conservate le sopraddette condizioni relative
alle temperature, corrette la capillarità, e fatta la
riduzione al barometro normale dell’osservatorio di Parigi.
Considerando
l’andamento delle pressioni nei loro medii mensuali, si
scorge ch’esse nei mesi di dicembre e gennaio ascendono ad
un massimo che sorpassa il medio annuale di 1mm,9
[2.5 hPa], che in aprile discendono ad un minimo inferiore
al suddetto medio di 2mm,6 [3.7 hPa]; vediamo
anche che l’intera oscillazione, compresa fra queste estreme
pressioni, è circa 4mm,5 [6.0 hPa] 2.
Considerate nelle
diverse stagioni le medie pressioni, si trovano al massimo
nell’inverno, al minimo nella primavera; mentre assumono
nell’estate e nell’autunno un medio valore assai prossimo
alla media assoluta dell’anno.
Dall’esame dei medii
valori delle massime e minime pressioni corrispondenti ai
mesi e stagioni, e dall’andamento delle differenze tra
questi e la media annuale, rileviamo che la colonna
barometrica nelle sue maggiori elevazioni si discosta dalla
media annuale assi meno che nelle maggiori sue depressioni;
infatti mentre la media escursione si limita ad 8mm,4
[11.2 hPa], la media inferiore arriva ad 11mm,4
[15.2 hPa] 3. Vediamo altresì che ai mesi di gennaio e
febbraio, di minima temperatura, corrispondono ad un tempo
le più alte pressioni e le più grandi oscillazioni
barometriche; laddove a luglio ed agosto, mesi di massima
temperatura, vi corrispondono bensì le minime oscillazioni,
ma non le minime pressioni che troviamo invece nei mesi di
novembre, gennaio e febbraio. La massima di queste
oscillazioni mensuali scende a 27mm,38 [36.51 hPa],
e la minima rimane ad 11mm,47 [15.29 hPa].
Riguardo alle
stagioni è nell’inverno che troviamo riunite le più alte e
le più basse pressioni, accompagnate dalla più estesa
oscillazione che monta quasi a 34mm [46 hPa]:
minima è l’oscillazione estiva ed eguale alla metà circa
della invernale, cioè a 17mm [23 hPa] quella di
primavera è la media aritmetica delle precedenti, cioè 25mm
½ [34 hPa] circa, e quella d’autunno supera quest’ultima di
quasi tre millimetri [4 hPa].
Nel quadro n.° 8
abbiamo raccolte le massime e minime pressioni annuali, e le
epoche corrispondenti alle medesime. La media delle massime
supera di poco 773mm [1030 hPa],e corrisponde
all’epoca media dei 27 gennaio, e la media fra le minime è
prossima a 736mm [981 hPa], e corrisponde
all’epoca dei 9 dicembre, cosicchè l’oscillazione media
annuale del barometro si estende a 37mm [49 hPa],
ed è compresa nel breve intervallo di 49 giorni.
La massima assoluta
di tutte le pressioni osservate nel decennio fu 775mm,66
[1034.21 hPa] il 27 febbraio 1834 alle 9 di mattina, con
calma perfetta di vento e di mare e con cielo sereno: la
minima assoluta fu di 727mm,28 [969.71 hPa] il 26
febbraio 1838 alle 8 antimeridiane, essendo il cielo
piovigginoso, con venticello E., e con mare
straordinariamente grosso. L’intervallo, compreso fra queste
estreme pressioni decennali, ascende a 48mm,38
[64.51 hPa], cioè alla sedicesima parte circa della media
pressione annuale. Gli anni in cui furono osservate queste
estreme pressioni sono gli stessi nei quali trovammo la
massima e la minima delle medie pressioni annuali e delle
medie temperature. Nell’anno 1805 e nei giorni 21 e 22
gennaio si ebbe in Genova una pressione del barometro anche
maggiore di quella sopra notata, essendo lo stesso disceso a
724mm [965 hPa]; questa pure fu accompagnata da
una furiosissima tempesta di mare.
Note:
1. Vedasi il prospetto n.° 5.
2. Vedasi il prospetto n.° 6.
3. Vedasi il prospetto n.° 7.
|