

Numero 70, anno XXIII
Marzo 2023

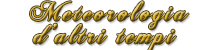
Numero 70, anno XXIII
Marzo 2023
Google Bing
Google Bing

|
di: Massimo Riso |

|
e: Andrea del Ponte |
Lucrezio e i fulmini
Nel libro VI si dilunga nella spiegazione delle tempeste e dei fulmini.
Proponiamo un estratto del libro VI nella versione in latino con traduzione in italiano, con alla fine un commento che confronta ciò che descrive Lucrezio con la meteorologia moderna.
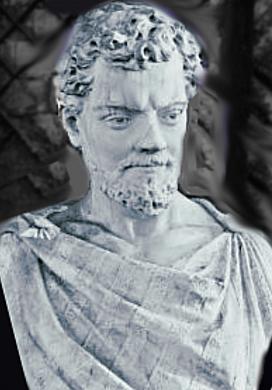 Fig. 1 – Busto ottocentesco di Lucrezio al colle Pincio, Roma. |
Lucrèzio Caro, Tito
Poeta latino del 1° sec. a. C. La tradizione antica non è concorde sulle date di nascita e di morte, che si possono collocare rispettivamente nel primo decennio del sec. 1° a. C. e intorno al 55 (secondo una notizia, sarebbe morto il giorno stesso in cui Virgilio prese la toga virile, il 15 ott. del 53). Non è noto il luogo di nascita: elementi di onomastica locale e generici riferimenti contenuti nell'opera hanno fatto pensare a Pompei, ma senza prove sicure.
Lucrèzio è autore del De rerum natura, a noi giunto nella forma che, a quanto pare, gli dette Cicerone quando alla morte del poeta ebbe tra le mani il manoscritto (compiuto ma non limato) e lo rivide rapidamente per la pubblicazione.
Il poema si divide in 6 libri, a ognuno dei quali è premesso un proemio. La filologia moderna si è affaticata a ricostruire il testo, che per molti riguardi appare non definitivo, con soppressioni e spostamenti di versi e di interi passi, secondo criteri di ragionevolezza e di concordanza con i programmi che lo stesso Lucrèzio enuncia circa l'ordine di trattazione della materia. Tuttavia, nessuna delle ricostruzioni complessive ha interamente soddisfatto, e si tende a tornare a considerare l'ordine tradizionale (salvo particolari) come l'unico su cui sia legittimo fondarsi.
Da: Enciclopedia Treccani.
Lucrezio, De rerum natura: Libro 06 Parte 02
ergo fervidus hic nubem cum perscidit atram, dissipat ardoris quasi per vim expressa repente semina, quae faciunt nictantia fulgura flammae; inde sonus sequitur, qui tardius adlicit auris quam quae perveniunt oculorum ad lumina nostra
Così il vento infocato, quando ha squarciato la nuvola nera, d'un tratto scaccia, per così dire, a forza e sparge qua e là quei semi di fuoco che fanno i guizzanti lampi di fiamma; viene poi il suono, che colpisce gli orecchi più lento delle immagini che arrivano alla vista dei nostri occhi.
scilicet hoc densis fit nubibus et simul alte extructis aliis alias super impete miro ne tibi sit frudi quod nos inferne videmus quam sint lata magis quam sursum extructa quid extent
Ciò avviene, s'intende, quando le nuvole son dense e, insieme, accumulate in alto le une sulle altre, con slancio meraviglioso; non t’inganni il fatto che noi guardando dal basso le nubi vediamo la loro ampiezza più che la loro altezza.
contemplator enim, cum montibus adsimulata nubila portabunt venti transversa per auras, aut ubi per magnos montis cumulata videbis insuper esse aliis alia atque urguere superna in statione locata sepultis undique ventis
Osservale bene, quando somiglianti a montagne i venti le porteranno di traverso per l’aria, o quando ammucchiate su grandi dorsali stanno una sull’altra e premono dall’alto come ancorate in totale calma di venti.
tum poteris magnas moles cognoscere eorum speluncasque vel ut saxis pendentibus structas cernere, quas venti cum tempestate coorta conplerunt, magno indignantur murmure clausi nubibus in caveisque ferarum more minantur
Allora potrai conoscere l’enorme grandezza e distinguervi come grotte formate da rocce sospese: quando i venti, scoppiata la tempesta, le colmano chiusi dentro le nubi urlano con grande strepito e ruggiscono minacciosi come belve chiuse in gabbia
nunc hinc nunc illinc fremitus per nubila mittunt, quaerentesque viam circum versantur et ignis semina convolvunt [e] nubibus atque ita cogunt multa rotantque cavis flammam fornacibus intus, donec divolsa fulserunt nube corusci
ora di qua ora di là fischiano attraverso le nuvole, s’aggirano creando una via, trascinando con sé i semi di fuoco, molti ne raccolgono e fanno girare la fiamma in quella cave fornaci, finché, squarciata la nube, brillanti lampeggiano.
Lucrezio da una spiegazione tragica e poetica di una tempesta. Ma è proprio ciò che suscita in tutti noi quando la osserviamo: tragica per la drammaticità dei fenomeni, ma anche poetica; l’intensità e la potenza delle energie messe in gioco ha sempre meravigliato l’uomo.
Soffermiamoci un attimo su questa frase: “quei semi di fuoco che fanno i guizzanti lampi di fiamma” Lucrezio nomina spesso questi “semi di fuoco” come l’origine dei fulmini.
Certo, 2000 anni fa non conoscevano l’elettricità e l’elettrostatica ma con la sola osservazione Lucrezio si è avvicinato molto alla esatta formazione di una nube temporalesca e del fulmine.
All’interno di una nube temporalesca, termine scientifico: Cumulonimbus, si formano minutissimi cristalli di ghiaccio e piccole palline di grandine soffice. I cristalli di ghiaccio più leggeri sono trascinati verso l’alto dalle correnti ascensionali, le palline di grandine morbida, più pesanti, cadono verso il basso. Questi due diversi movimenti provocano collisioni fra i cristalli e le palline, durante queste collisioni i cristalli si caricano negativamente e le palline positivamente, “fanno i guizzanti lampi di fiamma”, di conseguenza la nube si carica come un enorme condensatore.
Ed ecco i “semi di fuoco” di Lucrezio.
Le collisioni all’interno della nube non sono provocate soltanto dai diversi movimenti ma anche dai venti. All’interno di un cumulonembo ci sono correnti ascendenti, discendenti, ma anche venti che ruotano. Queste correnti possono superare anche i 150 Km/h.
Lucrezio: “quando i venti, scoppiata la tempesta, le colmano chiusi dentro le nubi urlano con grande strepito e ruggiscono minacciosi come belve chiuse in gabbia; ora di qua ora di là fischiano attraverso le nuvole, s’aggirano creando una via, trascinando con sé i semi di fuoco”.