|
Martedì 12 novembre 2019 l'intensa
depressione battezzata "Detlef" dall'Istituto di Meteorologia
dell'Università di Berlino, in lenta risalita dalla Sicilia verso il
Tirreno con un minimo barico inferiore a 990 hPa, ha determinato
sull'Italia tempeste di vento, piogge alluvionali al Sud (urban-flood
a Matera), rabbiose mareggiate soprattutto sulle coste ioniche
e salentine, e un eccezionale episodio di acqua alta a Venezia.

Venezia, martedì 12
novembre 2019: la cripta della Basilica di San Marco inondata (f.
AGF,
Agenzia Giornalistica Fotografica).
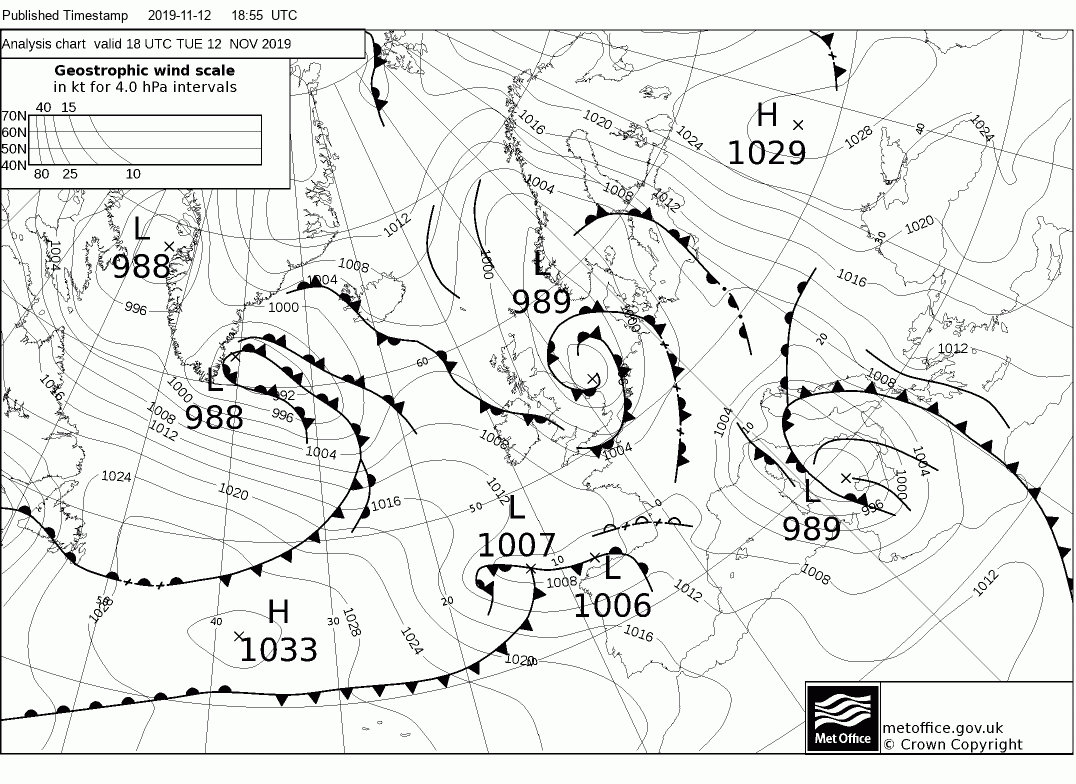
Carta di analisi della pressione e dei
fronti al suolo, ore 18 UTC del 12 novembre 2019 (fonte:
MetOffice).
Il minimo barico di 989 hPa poco a Nord della Sicilia pilota furiosi
venti di scirocco soprattutto tra lo Ionio e l'Adriatico, scatenando
violente mareggiate e sollevando una straordinaria marea sulla laguna
veneta (ma in generale su tutto l'alto Adriatico).
Tale ciclone mediterraneo è evoluto in maniera distinta rispetto a un
precedente vortice che lunedì 11 novembre si è posizionato a ridosso
delle coste algerine con caratteristiche di
TLC = Tropical Like Cyclone ("cuore" caldo anziché freddo come
solitamente avviene nelle normali depressioni extra-tropicali).
VENTI IMPETUOSI E MAREGGIATE: 188 KM/H IN SICILIA
Primo effetto delle due intense
ciclogenesi ravvicinate è stato l'insorgere di impetuosi venti
meridionali, da libeccio in Sicilia e da scirocco tra lo Ionio e
l'Adriatico (in rotazione a maestrale in Sardegna il 12
novembre), con raffiche massime a 85 km/h a Venezia-Ist. Cavanis (ARPA
Veneto), 91 a Reggio Calabria, 94 a Grottaglie (Taranto), 104 a Pantelleria e Capo Carbonara
(Aeronautica Militare),
ma fino a ben 188 km/h a Novara di Sicilia, sulle alture di
Messina tra i Monti Nebrodi e Peloritani (valore più elevato mai
registrato dalle stazioni della rete
SIAS
Sicilia installate nel 2002).
Rovinose mareggiate hanno
colpito le coste con disagi e danni alla viabilità litoranea e a
edifici e stabilimenti turistici in varie località, tra cui Agrigento,
Messina, Metaponto,
Gallipoli, Leuca, Porto Cesareo.

Adelfia (Bari): luminarie della festa patronale abbattute dal vento il
12 novembre 2019 (via pagina FB
MeteOne Puglia e Basilicata).
PIOGGE INTENSE E PIENE FLUVIALI AL SUD ITALIA
Piogge estese e intense, ulteriormente
esaltate da nuclei convettivi (temporali) e dallo sbarramento
orografico a ridosso delle montagne hanno scaricato importanti
quantità d'acqua in particolare sulla Sicilia e sui versanti ionici
del Sud peninsulare: in due giorni (11-12 novembre), totali di 72 mm a
Matera, 102 a Montescaglioso (MT), 117 a
Caltanissetta, 119 a Gela (CL), 153 a Petronà (CZ), 155 a Petilia
Policastro-Pagliarelle (KR), 164 a Caltagirone (CT), 315 a
Linguaglossa-Etna Nord (CT) (Fonti: CFR regioni
Calabria e
Basilicata,
SIAS
Sicilia).
Piene fluviali e straripamenti hanno interessato svariati bacini
idrografici, dalla Sicilia (esondazione del Platani a Ribera,
Agrigento) alla Basilicata, dove si sono concentrati i danni più
rilevanti.
Un'impetuosa urban-flood ha colpito il centro storico di
Matera al mattino del 12 novembre, a seguito di una precipitazione
non particolarmente abbondante, ma concentrata in breve tempo (36 mm/1
h secondo il pluviometro della
Centro Funzionale Regione Basilicata).
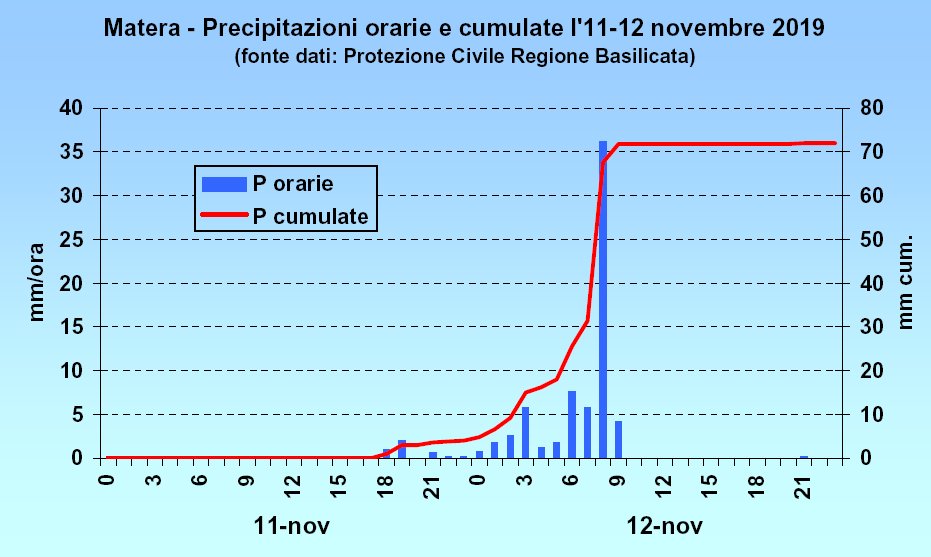
Precipitazioni orarie
e cumulate l'11-12 novembre 2019 a Matera: totale di 72 mm (quantità
non eccezionale) ma in gran parte concentrati al primo mattino del 12
con massimo orario di 36 mm tra le h 07 e le 08 (fonte:
Centro Funzionale e Protezione Civile Regione Basilicata).
VENEZIA: LA SECONDA PEGGIORE ACQUA ALTA
IN OLTRE UN SECOLO, DOPO L'EVENTO DEL 1966
L'effetto più appariscente
dell'episodio perturbato è stata la straordinaria onda di marea che ha
colpito Venezia e tutto l'alto Adriatico.
Dopo un primo picco al mattino del 12 (127 cm sullo zero
mareografico di Punta della Salute alle h 10:20, fonte
Centro Previsioni e Segnalazioni Maree), che già ha determinato
l'allagamento di parte della città e l'insolita inondazione della
Basilica di San Marco, in serata la marea astronomica si è
sfavorevolmente combinata con le forzanti meteorologiche (forte vento
e passaggio del pronunciato minimo di pressione) nel determinare
una seconda onda di marea, eccezionale e più elevata delle attese, con
187 cm registrati alle h 22:50.
Si tratta del secondo valore più elevato nella serie
mareografica veneziana iniziata nel 1872, dopo la disastrosa "aqua
granda" da 194 cm del 4 novembre 1966 (approfondimento su
Nimbus 77).
All'intensità dell'episodio di marea
ha contribuito la convergenza tra il forte scirocco in risalita
dall'Adriatico e il vento in rotazione da Nord-Est sulle coste
venete, fenomeno detto
"scontratura".


Venezia durante e
dopo l'eccezionale acqua alta e mareggiata
del 12 novembre 2019 (immagini da
www.tviweb.it,
e
pagina FB
Comune di Venezia).
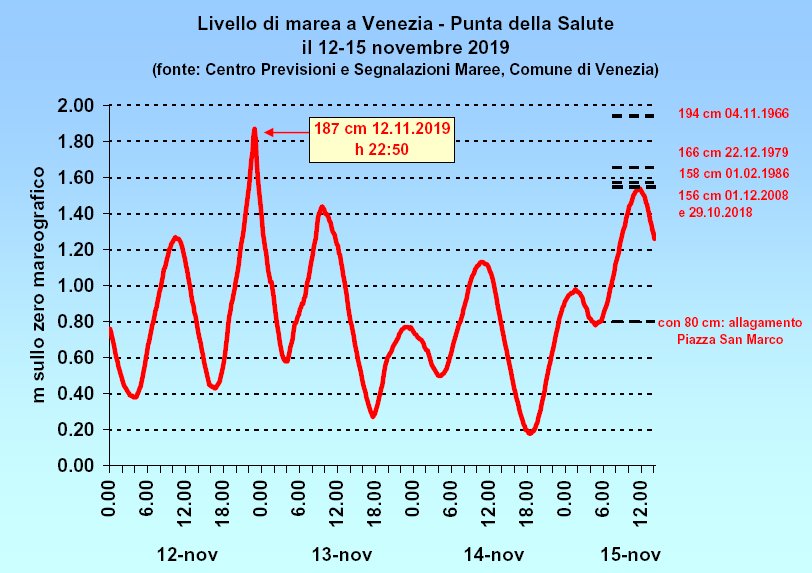
Andamento del livello di marea a Venezia - Punta della Salute dal 12
al 15 novembre 2019. Oltre al picco straordinario della sera di
martedì 12, alte maree sostenute si ripetono pure nei giorni seguenti
a causa del persistente scirocco. Notevoli, infatti, anche i 154 cm
delle h 11:40 del 15 novembre,
al 7° posto tra gli episodi più rilevanti in oltre un secolo
(Fonte dati:
Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, Comune di Venezia).
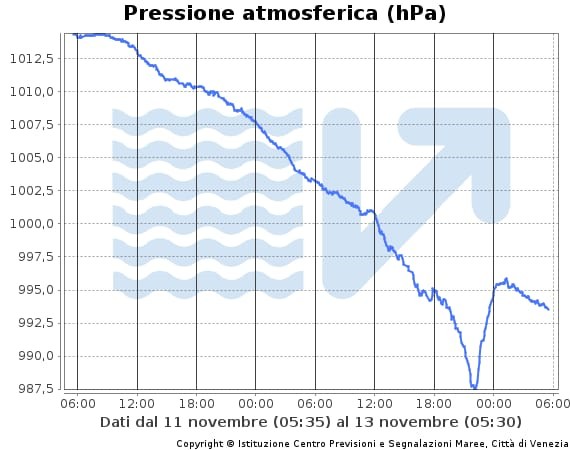
Il transito di un
pronunciato minimo di pressione di 987,5 hPa attorno alle h 22 del 12
novembre 2019 ha contribuito alla straordinaria marea di tempesta (storm
surge) a Venezia, in fase con il forzante astronomico
(Fonte:
Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, Comune di Venezia).
Non ci dilunghiamo nel commento dei
gravissimi danni (oltre alle due vittime, a Pellestrina, VE) che
la mareggiata e l'inondazione ha determinato al patrimonio edilizio,
storico e culturale della città, colpendo anche le limitrofe zone
litoranee e lagunari, da Rimini, a Chioggia, a Lignano, fino a
Trieste, dove al mattino di mercoledì 13 novembre è stata
parzialmente invasa Piazza Unità d'Italia, ma facciamo qualche
riflessione sul contributo dell'aumento del livello marino medio
a episodi di questo tipo.

13 novembre 2019: devastazione di capanni di pescatori nella Sacca
degli Scardovari (Delta del Po) dopo la mareggiata e l'alta marea
eccezionale della sera precedente (Fonte:
Rovigo in
diretta).

Piazza Unità d'Italia a Trieste, inondata il 13 novembre 2019 (Fonte:
Il Piccolo).
CAMBIAMENTI CLIMATICI E SUBSIDENZA DEL SUOLO
RENDONO PIU' PROBABILI MAREE ECCEZIONALI
(aggiornamento al 28 novembre 2019)
L'acqua alta è un fenomeno normale e
naturale per Venezia, tuttavia la sua frequenza sta rapidamente
aumentando, mettendo a rischio la vita quotidiana, le strutture e
l'economia della città.
Considerando i casi con livello >=110 cm, ovvero quelli che
determinano l'allagamento del 12% della città, si è passati da
2-8 episodi al decennio tra fine Ottocento e la prima metà del
Novecento, fino ad arrivare a oltre 50 casi al decennio dagli Anni
Duemila! In particolare, il decennio 2010-19, ancora incompleto,
ne ha contati ben 86, includendo i 17 episodi registrati nel
2019 fino al 28 novembre (il record annuale è di 18 episodi nel 2010).
Come ben visibile nel grafico sotto, l'infittirsi degli eventi di
acqua alta (colonne azzurre) procede parallelamente all'aumento del
livello marino medio (linea rossa), determinato dalla somma di due
fattori:
- incremento delle acque marine dovuto
ai cambiamenti climatici (eustatismo), tramite la
fusione dei ghiacciai e la dilatazione termica dell'acqua divenuta più
calda (di circa 1 °C nell'ultimo secolo nell'alto Adriatico, secondo
un
recente studio di Fabio Raicich e Renato R. Colucci del CNR-ISMAR
di Trieste);
- subsidenza (abbassamento) del
suolo lagunare per cause naturali (lenta compattazione di
sedimenti) e antropiche (forte emungimento di acqua dalle falde
per scopi industriali nella zona di Marghera, fenomeno culminato negli
anni Cinquanta-Sessanta del Novecento).
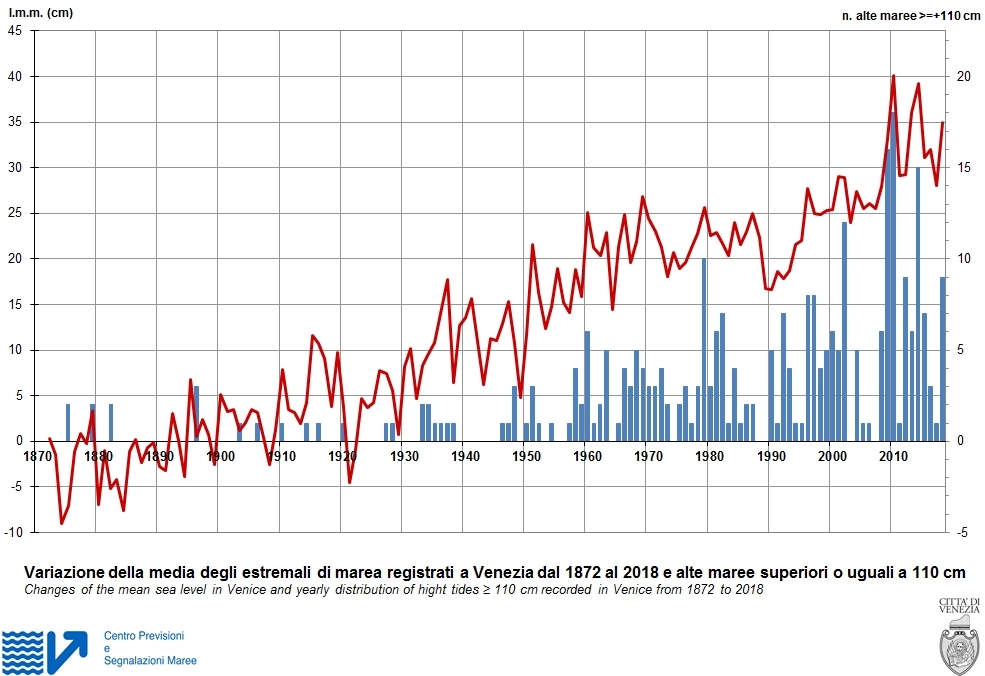
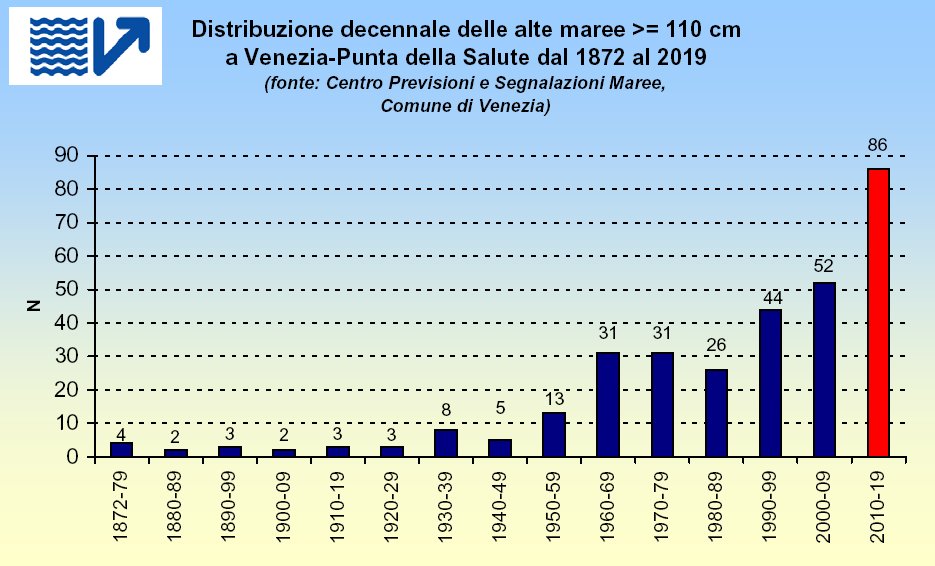
Conteggio annuo e
decennale dei casi di acqua alta >=110 cm a Venezia - Punta della
Salute dal 1872, e confronto con l'aumento del livello marino medio
(linea rossa nel grafico più in alto) dovuto al riscaldamento globale
e alla subsidenza del suolo. Il conteggio annuo nel primo grafico si
ferma al 2018, quello decennale nel secondo include i 17 episodi
finora registrati nel 2019
(Fonte:
Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, Comune di Venezia).
Quanta parte hanno giocato i due
fattori nel far perdere quota alla superficie di Venezia rispetto
al livello dell'Adriatico?
Secondo le misure mareografiche (oggi
coordinate da
ISPRA - Area Maree e Laguna) dal 1900 a Venezia il mare ha
guadagnato circa 35 cm in altezza, aumento attribuibile per
circa il 60% all'abbassamento del suolo (cause naturali + antropiche)
e per il rimanente 40% circa al contributo climatico.
Seppure attenuato rispetto ai decenni centrali del Novecento, la
subsidenza del suolo è tuttora un fattore importante, quantificato
con misure GPS in 3,3 mm/anno nella zona di Venezia (vedi
Vecchio et al., 2019, sulla rivista "Water").
A ciò va aggiunto un incremento eustatico (cause climatiche)
dell'ordine di 4,5 mm/anno nell'alto Adriatico (Trieste, media
periodo 1992-2016 secondo lo "Studio
conoscitivo dei cambiamenti climatici e di alcuni loro impatti in
Friuli Venezia Giulia").
Nell'ultimo mezzo secolo il livello
marino medio a Venezia è aumentato di oltre 10 cm, per cui se oggi
dovesse ripetersi l'eccezionale concorso di fattori astronomici e
meteorologici che si ebbe il 4 novembre 1966 si avrebbe una marea ben
superiore a 2 metri (rispetto ai 194 cm misurati all'epoca),
con effetti ancora più drammatici.
Si tratta di scenari che si
avvereranno nel corso di questo secolo con l'inesorabile aumento
dei livelli oceanici dovuto al riscaldamento globale (grafico qui
sotto).
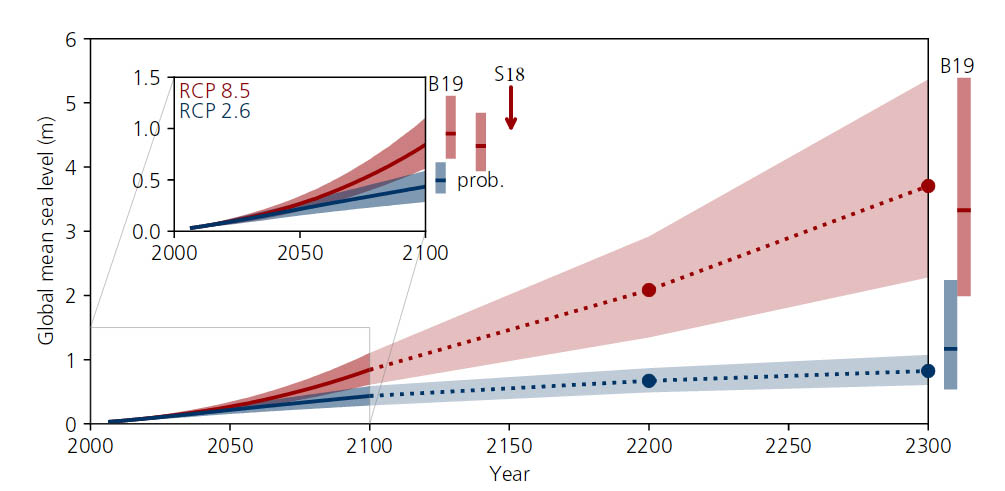
Previsioni di aumento del livello marino
medio globale fino al 2300,
dal
rapporto speciale IPCC
su oceani e criosfera (settembre
2019).
In azzurro lo scenario auspicabile di decarbonizzazione (RCP 2.6), in
rosso lo scenario peggiore, senza riduzione delle emissioni serra (RCP
8.5), e relative bande di probabilità intorno alla media degli scenari
(linee spesse). Le linee tratteggiate dopo il 2100 indicano il minore
livello di affidabilità della previsione.
In assenza di politiche climatiche (rosso) si avrebbero incrementi di
livello prossimi o anche superiori a 1 m nel 2100, a 2 m nel 2200 e 3
m nel 2300.
Un'evoluzione che ridisegnerebbe la geografia delle zone costiere di
tutto il mondo, costringendo all'emigrazione centinaia di milioni di
persone con enormi ripercussioni sociali, sanitarie e geopolitiche.
Verso il 2100, maree come quella del 12 novembre 2019 a Venezia
potranno verificarsi decine di volte all'anno, fino a divenire la
normalità, il nuovo livello marino medio, inondando in maniera
pressoché permanente le zone abitate da centinaia di migliaia di
persone lungo l'alto Adriatico. Il problema è peraltro globale...
NEL MONDO, MEZZO MILIARDO DI PERSONE
ESPOSTE ALL'AUMENTO DEI LIVELLI MARINI
ENTRO FINE SECOLO
Nuove simulazioni, eseguite grazie a
un più accurato modello altimetrico digitale, triplicano le precedenti
stime della popolazione esposta all’aumento dei livelli marini in
questo secolo: anche in uno scenario a basse emissioni, e senza
considerare il futuro aumento demografico, nel 2100 circa 190
milioni di persone nel mondo potranno essere soggette a inondazione
permanente dal mare, e 350 milioni almeno una volta all’anno in caso
di alte maree straordinarie; numeri che salirebbero a 340 e 500
milioni se non limiteremo i gas serra. Come indicano Scott Kulp e
Benjamin Strauss, autori di questo studio sulla rivista Nature (New
elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level
rise and coastal flooding), le comunità costiere “devono
prepararsi a un futuro molto più difficile di quanto noto finora”.
Devolvi il 5 per mille alla SMI!
Sosterrai
le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,
e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|