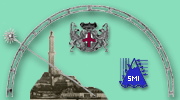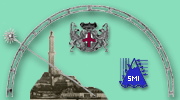di Diego Rosa |
Versione stampabile  |
Temperatura, temperature, température, Temperatur
(seconda parte)
Strumenti di misura della temperatura
Cenno storico
Il primo strumento scientifico di misura (almeno
qualitativa) della temperatura è attribuito a Galileo.
Nel 1575 era stata pubblicata a stampa la “ Pneumatica” di Erone di
Alessandria, il più grande ingegnere e costruttore di meccanismi
dell’antichità. In essa si trattava, tra l’altro, della dilatazione
dell’aria sottoposta a riscaldamento. Forse inspirandosi a questo testo,
Galileo, come afferma il biografo Viviani nella sua “Vita di Galileo”,
ideò e costruì nel
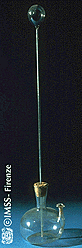 1597, a Padova, uno strumento (in figura a lato un
modello dello strumento esistente presso il museo delle scienze di
Firenze) che più che termometro si dovrebbe chiamare “termobaroscopio”,
capace sì di indicare una variazione di temperatura, ma essendo assai
influenzato dalla pressione atmosferica variabile nel corso del tempo.
Benedetto Castelli, allievo e collaboratore di Galileo, in una lettera del
1638 indirizzata al poeta Cesarini, descrive lo strumento che aveva visto
lui stesso nelle mani dello scienziato, nel 1603 (ma già prima, lo storico
Biancani ne aveva data un descrizione nella sua “Sphaera Mundi” edita in
Bologna nel 1620). Questo era costituito da una caraffa di vetro della
grandezza di un uovo dotata di un lungo collo (circa 40 cm) pure di vetro.
La caraffa vuota,veniva scaldata con le mani ed il collo veniva poi
immerso in un vaso sottostante contenente dell’acqua colorata o forse del
vino. Liberata la caraffa dal calore delle mani, dopo un po’ l’acqua
saliva nel collo di vetro superando il livello dell’acqua rimanente nel
vaso; ciò a causa della contrazione dell’aria dovuta al suo raffreddamento
(diversa da quella della craffa). Il dislivello ottenuto era legato al
grado di riscaldamento iniziale dell’aria nella caraffa ma anche alla
pressione atmosferica esistente.Ogni successiva variazione della
temperatura della caraffa o meglio dell’aria in essa contenuta,
determinava una variazione del livello della colonna liquida innescata con
la prima manovra. 1597, a Padova, uno strumento (in figura a lato un
modello dello strumento esistente presso il museo delle scienze di
Firenze) che più che termometro si dovrebbe chiamare “termobaroscopio”,
capace sì di indicare una variazione di temperatura, ma essendo assai
influenzato dalla pressione atmosferica variabile nel corso del tempo.
Benedetto Castelli, allievo e collaboratore di Galileo, in una lettera del
1638 indirizzata al poeta Cesarini, descrive lo strumento che aveva visto
lui stesso nelle mani dello scienziato, nel 1603 (ma già prima, lo storico
Biancani ne aveva data un descrizione nella sua “Sphaera Mundi” edita in
Bologna nel 1620). Questo era costituito da una caraffa di vetro della
grandezza di un uovo dotata di un lungo collo (circa 40 cm) pure di vetro.
La caraffa vuota,veniva scaldata con le mani ed il collo veniva poi
immerso in un vaso sottostante contenente dell’acqua colorata o forse del
vino. Liberata la caraffa dal calore delle mani, dopo un po’ l’acqua
saliva nel collo di vetro superando il livello dell’acqua rimanente nel
vaso; ciò a causa della contrazione dell’aria dovuta al suo raffreddamento
(diversa da quella della craffa). Il dislivello ottenuto era legato al
grado di riscaldamento iniziale dell’aria nella caraffa ma anche alla
pressione atmosferica esistente.Ogni successiva variazione della
temperatura della caraffa o meglio dell’aria in essa contenuta,
determinava una variazione del livello della colonna liquida innescata con
la prima manovra.
Questo strumento fu perfezionato dal medico veneziano Santorio, dallo
scienziato dilettante e amico di Galileo Sagredo e da Galileo stesso
includendovi delle scale numeriche.
Nel 1630 apparvero a Firenze i primi termometri a liquido, prototipi dei
famosi termometri “fiorentini” alcuni dei quali sono descritti da Lorenzo
Margotti, segretario dell’Accademia del Cimento, nei famosi “Saggi di
naturali esperienze
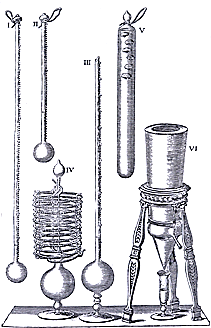 fatte nell’Accademia del Cimento ” pubblicati nel 1667.Tali
termometri usavano un solo punto di riferimento per la graduazione: la
temperatura del ghiaccio fondente che era segnata gradi 13,5 nella scala
di 50° sul termometro adottato per le osservazioni meteorologiche, a
partire dal 1654. Fu lo stesso Granduca Ferdinando, protettore
dell’Accademia, a suggerire di sigillarne le estremità. Nella figura a
lato, tratta dall’opera del Margotti, sono riprodotti quattro termometri a
liquido (spirito di vino o “acquarzente”) di cui uno a forma di spirale
(IV) che grazie a un grande rapporto tra la sezione del capillare ed il volume
del bulbo consentiva un movimento molto accentuato della colonna di
liquido lungo le volute con il cambiamento anche piccolo della temperatura
ed un curioso termoscopio (V) costituito da un serbatoio pieno di alcol nel
quale erano immerse palline cave di vetro aventi densità apparente
diversa. Ogni pallina galleggiava o scendeva nel fondo per una temperatura
determinata dalla sua densità apparente. Il disegno VI rappresenta un
igrometro a condensazione concepito dallo stesso gran duca Ferdinando. fatte nell’Accademia del Cimento ” pubblicati nel 1667.Tali
termometri usavano un solo punto di riferimento per la graduazione: la
temperatura del ghiaccio fondente che era segnata gradi 13,5 nella scala
di 50° sul termometro adottato per le osservazioni meteorologiche, a
partire dal 1654. Fu lo stesso Granduca Ferdinando, protettore
dell’Accademia, a suggerire di sigillarne le estremità. Nella figura a
lato, tratta dall’opera del Margotti, sono riprodotti quattro termometri a
liquido (spirito di vino o “acquarzente”) di cui uno a forma di spirale
(IV) che grazie a un grande rapporto tra la sezione del capillare ed il volume
del bulbo consentiva un movimento molto accentuato della colonna di
liquido lungo le volute con il cambiamento anche piccolo della temperatura
ed un curioso termoscopio (V) costituito da un serbatoio pieno di alcol nel
quale erano immerse palline cave di vetro aventi densità apparente
diversa. Ogni pallina galleggiava o scendeva nel fondo per una temperatura
determinata dalla sua densità apparente. Il disegno VI rappresenta un
igrometro a condensazione concepito dallo stesso gran duca Ferdinando.
I termometri fiorentini dal 1648 cominciarono a essere conosciuti e
riprodotti in tutta Europa, però non essendo fissata in modo univoco una
scala comune (non solo un riferimento per la temperatura minima ma anche
uno per la temperatura massima) né potendo avere le esatte stesse
proporzioni tra le dimensioni del bulbo e quelle del capillare, non erano
utilizzabili per determinare delle temperature che fossero univocamente
confortabili .
Finalmente Fahrenheit (Danzica, 1715), Réamur (Parigi, 1731) e Celsius (Upsala,
1742) proposero delle scale razionali aventi due punti di riferimento(ma
prima di loro anche l’astronomo Ole Roemer a Copenhagen dal 1708 al 1709
aveva utilizzato un termometro con due punti di riferimento: ghiaccio
fondente ed acqua bollente).
La scala Fahrenheit che segnava 0° alla temperatura del ghiaccio fondente
mescolato con sale da cucina e circa 96 ° alla temperatura del corpo umano
in salute dando così 32° al punto del giaccio fondente ed 212 al punto di
ebollizione, la scala Réamur che segnava rispettivamente 0° ed 80° alla
temperatura del ghiaccio fondente e dell’acqua bollente alla pressione
atmosferica, la scala centigrada che segnava a questi fenomeni 0° e 100°.
Quest’ultima ridefinita nel 1948 come scala Celsius ponendo il punto
triplo dell’acqua pari a 0,01 °C ed il suo punto di ebollizione alla
pressione atmosferica standard pari a 99,975 °C, è quella ufficialmente
adottata nel Sistema Internazionale SI, ormai obbligatorio nella Comunità
Europea. La scala Fahrenheit, come è noto, è ancora largamente usata negli
Stati Uniti.
In fisica come già visto, è di fondamentale importanza la temperatura
assoluta che ha il punto zero a – 273,15 gradi Celsius (°C). In onore a
lord Kelvin si usa K per indicare tale temperatura.
Tipi di termometro
Si hanno tre principali tipologie di termometri:
- termometri a liquido
- termometri metallici
- termometri elettrici
I termometri a liquido utilizzano la differente
espansione termica fra un liquido ed il suo contenitore in vetro. Il
mercurio è solitamente utilizzato come liquido al di sopra dei – 38 °C.
I termometri metallici sfruttano o la variazione di
curvatura di una lamina bimetallica con un estremo fisso al telaio e
l’altro collegato a un trasduttore, o la variazione di curvatura di un
elemento curvato di tubo metallico a sezione elittica cava e riempito di
alcool.
I termometri elettrici appartengono soprattutto alle
seguenti tipologie:
- termocoppie
- termoresistenze
- sensori di temperatura a semiconduttore
La termocoppie sono realizzate mediante la giunzione di
due conduttori costituiti da metalli diversi. Al variare della temperatura
della giunzione, che costituisce il sensore, varia la differenza di
potenziale alle due estremità libere qualora mantenute ad una temperatura
di riferimento nota (ad esempio quella del ghiaccio fondente). Tale
tensione è misurabile ad es. con un galvanometro.
Le termoresistenze sono resistenze elettriche realizzate in materiali la
cui resistenza elettrica varia in maniera nota e significativa al variare
della temperatura. Per misure meteorologiche si usa generalmente una
resistenza di platino da 100 Ώ a 0 °C.
I sensori a semiconduttore consistono di solito in circuiti integrati con
uscita in corrente direttamente proporzionale alla temperatura assoluta (i
più diffusi hanno un’uscita di 1 μA per K). Parte integrante del sensore
sono i circuiti elettronici per la normalizzazione del segnale in uscita
sul campo di misura.
In campo meteorologico si usano di solito termometri a liquido, termometri
metallici, termoresistenze e termometri a semiconduttore.
I termometri a liquido e quelli metallici secondo le prescrizioni del CNR
e della WMO (World Meteorological Organization) dovrebbero essere posti in
un apposita capannina meteorologica con doppio tetto che permetta la
circolazione dell’aria (e doppio fondo nei luoghi con prolungata presenza
di neve al suolo), verniciata internamente ed esternamente di bianco e
posta ad un’altezza tale che la misura avvenga ad un’altezza compresa tra
1,25 e 2 m dal suolo. Il sito migliore per la collocazione della stazione
è un luogo pianeggiante, esposto al sole ed al vento, in assenza di
edifici od alberi; poco adatta la collocazione sul tetto degli edifici.
I termometri elettrici non necessittano di essere tenuti in una capannina
meteorologica in quanto sono dotati di schermi protettivi bianchi contro
la radiazione solare; è comunque raccomandabile la ventilazione forzata.
Registrazione della temperatura
Termometri a minima e massima
Più che i termometri a massima (es. i classici
termometri da febbre) ed i termometri a minima sono usati in meteorologia
i termometri a massima e minima. Questi sono costituiti da un bulbo pieno
di alcool che costituisce il sensore, un capillare ad “U” riempito di
mercurio e di alcool con un’espansione superiore contenente aria
compressa. Sui due peli liberi del mercurio sono appoggiati due
cilindretti di ferro portanti alle estremità sferette di vetro scorrevoli
con lieve attrito all’interno dei tratti di capillare riempiti di alcool.
Aumentando o diminuendo la temperatura per l’espansione o contrazione
dell’alcool nel bulbo e dell’aria nella polla, i cilindretti si spostano
seguendo i peli liberi del mercurio. Quando il pelo libero del mercurio si
allontana da una posizione estrema il cilindretto rimane nella posizione
raggiunta indicando così la temperatura minima o massima. Mediante un
piccolo magnete i cilindretti possono essere riportati a contatto con la
colonna di mercurio
Termografi
I termografi sono apparecchi che trasmettono ad un
pennino scrivente su un rullo ruotante con regolarità su cui è avvolta una
carta riportante un griglia di misura, la deformazione di un termometro
metallico (in genere un tubo metallico curvo riempito di alcool, come
nella forma classica dei fratelli Richard).
Registratori digitali
Le uscite di un termometro elettrico, in genere a
semiconduttore, sono inviate ad una unità di registrazione digitale o
direttamente ad un computer dove possono essere memorizzate ed elaborate
Temperatura dei corpi celesti
Le stelle
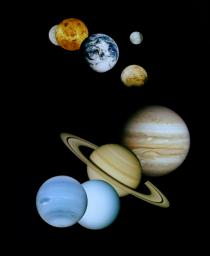 I colore delle stelle indica la loro temperatura
superficiale secondo la legge di Wien (si veda l’articolo precedente) che
indica come la lunghezza d’onda corrispondente alla massima energia
irraggiata sia inversamente proporzionale alla temperatura assoluta della
superficie, ed il colore dominante sia legato alla lunghezza d’onda
prevalente di irraggiamento. I colore delle stelle indica la loro temperatura
superficiale secondo la legge di Wien (si veda l’articolo precedente) che
indica come la lunghezza d’onda corrispondente alla massima energia
irraggiata sia inversamente proporzionale alla temperatura assoluta della
superficie, ed il colore dominante sia legato alla lunghezza d’onda
prevalente di irraggiamento.
Lo spettro di emissione delle stelle, si può inscrivere con una certa
corrispondenza in quello del corpo nero avente quella temperatura.
Dal rosso al blu questo con continuità sono i colori che caratterizzano
l’immagine delle stelle.
L’analisi delle immagini di gran parte delle stelle evidenzia una
relazione stretta tra la loro luminosità assoluta (cioè indipendente dalla
distanza dalla terra) ed il colore dominante del loro spettro o meglio del
loro tipo spettrale. Riportando in un grafico (digramma di
Hertzsprung-Russel) tale relazione con le ascisse il colore o tipo
spettrale ed in ordinate la luminosità, i punti rappresentativi si
collocano in maggioranza attorno una retta che parte dalle stelle più
calde e luminose verso le più fredde e deboli. Tale fascia si chiama
sequenza principale. Esistono inoltre altre tre aree del diagramma,
esterne alla fascia, occupate da delle stelle: l’area delle nane bianche,
poco luminose e di colore bianco, e le aree delle giganti e delle
supergiganti di colore da bianco al rosso e di grande luminosità. La
temperatura corrispondente della superficie stellare dal rosso al blu
varia da circa 3000 K a 40000 K.
Il sole
Collocato nella parte destra della sequenza principale,
il nostro astro ha un “colore” giallo-verde cui corrisponde una
temperatura della superficie (fotosfera) di circa 6000 K. La rarefatta
corona solare d’altro canto, costituita da protoni ed elettroni (corona
interna, K) e particelle solide di qualche micron (corona esterna, F),
presenta temperature di alcuni milioni di gradi K, mentre il centro
dell’astro avrebbe una temperatura di circa 15 milioni di gradi.
Mercurio
Il più prossimo al Sole, questo pianeta è pressoché
privo di atmosfera. Si può però dire che il terreno esposto ai raggi
solari all’equatore supera mediamente i 400 °C, la parte oscurata scende
sotto i –150 °C, durante il periodo notturno che dura circa 29 giorni
terrestri.
Venere
Con periodo di rotazione di 243 gg. ed uno di
rivoluzione di 224 gg., il giorno solare su Venere dura 116 giorni
terrestri. Ciò nonostante a causa dell’alta densità dell’atmosfera (al
suolo la pressione è di 92 atmosfere) composta essenzialmente di anidride
carbonica con una piccola percentuale di azoto, la temperatura è quasi
costante tra giorno e notte, variando tra 460 e 480 °C.
Luna
Come su Mercurio, sulla Luna l’atmosfera è pressoché
assente (solo tracce di ioni di sodio provenienti dalle rocce della
superficie). Il giorno lunare dura circa 29 giorni terrestri quanto dura
la rivoluzione attorno alla terra.
La temperatura che assumono le rocce illuminate dal sole raggiunge
mediamente 107°C, le rocce in ombra restano a circa -50 °C. La notte esse
si raffreddano per irraggiamento verso la volta celeste mediamente fino a
-153 °C con un minimo di -233 °C.
Marte
L’atmosfera di Marte ha una pressione al suolo
variabile tra 6 e 10 millibars ed è composta in gran parte di anidride
carbonica. La temperatura media al suolo è di -55 °C, con estremi di 27 °C
all’equatore, a mezzogiorno e –133 °C ai poli, in inverno (estremi
accentuati dalla forte variazione
dell’irraggiamento solare dovuta alla notevole eccentricità dell’orbita).
Giove
Il pianeta gigante ha un’atmosfera enormemente spessa
composta in gran parte di idrogeno ed elio. Non esiste una superficie
solida propriamente definita. La temperatura alla base delle nuvole è di
circa –140 °C; alla pressione di 1 bar –108 °C (NASA)
Saturno
Atmosfera comparabile a quella di Giove ma con meno
elio; temperatura media alla sommità delle nuvole: -228 °C; alla pressione
di 1 bar = -139 °C (NASA).
Urano e Nettuno
Pianeti dotati anch’essi di atmosfere molto spesse
formate in gran parte di idrogeno, elio e metano. Temperatura media alla
superficie –215 °C; alla pressione di 1 atmosfera rispettivamente -197 °C
e -201 °C (NASA).
Plutone
Il più lontano dei pianeti scoperto nel 1930 con un
satellite scoperto solo nel 1978. Ha un’atmosfera tenuissima costituita
quasi esclusivamente di metano. Temperatura media al suolo :-223 °C
Prossimamente
Temperatura dell’atmosfera terrestre, temperature termodinamiche
|