|
|
|
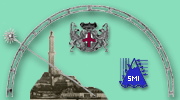 |
 |
 |
|
|
L'arcobaleno Uno dei più suggestivi spettacoli della natura è senza dubbio
l’arcobaleno. Così Dante: “..rimanea distinto di sette liste, tutte in quei colori (Purg. XXIX, 76) ed ancora: “…e come l’aere, quand’è ben piorno, (Purg. XV, 91) Cenno storico Il primo a descrivere l’arcobaleno sembra essere stato
Aristotele. Egli credeva che si originasse per riflessione della luce del
sole sulle nuvole, riflessione che doveva avveniva sotto un certo angolo
fisso rispetto alla direzione dei raggi solari determinandone così la
forma circolare. Il fenomeno della riflessione fu trattato già da
Euclide nella sua “Ottica” ove evidenziava come il raggio incidente ed il
raggio riflesso siano complanari e simmetrici rispetto alla normale alla
superficie riflettente. Nel 1266 il filosofo Ruggero Bacone misurò, forse per primo,
l’apertura angolare
dell’arcobaleno, meglio degli arcobaleni: primario e secondario Nel 1611 viene pubblicato a Venezia il libro dell’arcivescovo di Spalato Antonius de Dominis, dal titolo “De radiis visus et lucis”, in cui è esposta una teoria dell’arcobaleno simile a quella di Teodorico, con la descrizione di una serie di esperimenti di diffrazione e dispersione della luce attuati ancora con brocche di vetro piene di acqua. De Dominis non era probabilmente al corrente dei lavori di Teodorico e degli Arabi. Agli inizi del XVII secolo il fisico olandese Dutchman Willibrord Snell scopre, ma non pubblica, la legge matematica della rifrazione, riportata da Descartes (Cartesio) nel 1637 nella sua “Ottica”: Questa legge stbilisce che: sen (i1)/sen (i2)= n1/n2 dove i1 è l’angolo del raggio luminoso incidente, i2 è quello del raggio rifratto, n1 ed n2 sono i rispettivi indici di rifrazione dipendenti dai mezzi indici in seguito si è scoperto essere pari i al rapporto tra la velocità della luce nel vuoto e nel mezzo in questione.
Fig.1 Rifrazione della luce bianca n2 medio = 1,333 all'interfaccia aria-acqua Lo stesso Descartes nelle “Meteore” appendice al celebre “ Discorso sul metodo” pubblicato a Leida nel 1637, dava una spiegazione molto soddisfacente dal punto di vista dell’ottica geometrica, ma incompleta sopratutto per quanto concerneva la generazione dei vari colori dell’arcobaleno, (si vedano le figure qui sotto tratte dall’edizione di Amsterdam del 1644).
Fig. 2. Descartes: Spiegazione degli arcobaleni primario e secondario da “Le Meteore”. Amsterdam 1644
Fig 3. Descartes:Arcobaleno rovesciato per riflessione della luce in uno specchio d’acqua. Da un suo disegno originale Nel biennio 1665-1667 Newton nel suo ritiro di
Wollsthorpe, suo paese natale, oltre a gettare le basi dell’analisi
infinitesimale ed a meditare sulla forza che trattiene assieme i corpi
celesti, fece i primi esperimenti sulla dispersione della luce. In occasione delle lezioni di ottica che diede a Cambridge nel 1669-71, in base a questi esperimenti espose la propria teoria dell’arcobaleno che veniva (almeno in parte) a completare quella di Descartes. All’interno dell’arcobaleno primario si possono notare
talvolta degli archi di colore sbiadito porpora pastello o verde, detti
archi soprannumerari non spiegabili con la teoria di Newton- Descartes. Il
fisico Thomas Young nel 1803 scoprì l’interferenza della luce per cui due
raggi luminosi coerenti (monocromatici ed in fase) possono interferire tra di loro producendo in uno
schermo che li raccolga bande oscure (interferenza negativa) e luminose
(interferenza positiva) alternate.Questo fenomeno, rimise in auge la
teoria ondulatoria della luce (di Huygens che si contrapponeva a Newton
fautore di quella crepuscolare) e consentì allo stesso Young di dare una
spiegazione degli archi soprannumerari e dell’arcobaleno nel suo
complesso. Uno, due tre, più arcobaleni La teoria e l’osservazione diretta dimostrano la possibile esistenza di più arcobaleni. Essi si possono formare non solo nel cielo, ma anche in prossimità di una cascata o presso lo zampillo d’acqua della fontana del nostro giardino.
Fig. 4 Disposizione schematica dell’arcobaleno primario rispetto l’osservatore L’arcobaleno primario (Fig. 4)è quello consueto, ben più brillante degli altri. Appare sotto forma di archi colorati circolari aventi per centro l’antisole, cioè un punto opposto alla direzione del centro del sole al di sotto della linea dell’orizzonte. L’arco rosso è il più esterno e forma un angolo costante di 42,22° rispetto al suo asse. Gli altri colori: arancio, giallo, verde, blu (o talvolta cyan) si succedono all’interno sino al violetto (40,36°). Il centro dell’arco è al più tangente alla linea dell’orizzonte, con il sole giusto al tramonto. In questo caso avremo un arco a semicerchio (spesso però incompleto).Con altezze del sole superiori a 42 ° non è possibile vedere alcun arco, a meno di non trovarsi in posizione elevata rispetto al luogo dove le gocce d’acqua sono illuminate dal sole; in questo caso l’arco può avere una dimensione maggiore del semicerchio. I raggi di luce colorata che provengono dalla sua immagine formano un angolo costante con quelli dei raggi solari diretti così che come il nostro astro, anch’egli pare spostarsi con noi( in effetti spostandosi si vedono raggi che provengono da gocce diverse e quindi un variabile arcobaleno che può infine annullarsi parzialmente o totalmente se esse mancano nella traiettoria dei raggi visuali ), non si deforma, né può essere visto di traverso né può essere avvicinato (si può dire che otticamente è un’immagine all’infinito) e per ragioni ovvie di simmetria ha una forma assialsimmetrica, circolare. Anche se le dimensioni angolari sono rigorosamente le stesse, effetti prospettici ci fanno ritenere più grandi gli arcobaleni prodotti da gocce lontane. L’arcobaleno secondario molto meno brillante e non sempre visibile, è concentrico ed esterno al primario. Presenta dei colori disposti in ordine opposto con il rosso che corrisponde ad un angolo di circa 51° posto all’interno, il violetto all’esterno. Tra l’arcobaleno primario e secondario si può notare una fascia scura la così detta fascia scura di Alessandro, dal filosofo greco Alessandro di Afrodisia che per primo la descrisse. Un terzo arco, detto terziario, ha dimensioni (angolari) e colori uguali a quelle dell’arco primario ma è posto tra il sole e l’osservatore. Esso ha una luminosità così bassa da essere difficilmente visibile. Altri archi, i già citati archi sopranumerari dovuti all’interferenza della luce nelle gocce, giacciono all’interno dell’arco primario e sono egualmente poco visibili, in genere solo presso la sua parte più alta. Alle nostre latitudini gli arcobaleni appaiono in primavera-estate piuttosto che in inverno per la più facile presenza di gocce cadenti irraggiate da un sole collocato alle spalle dell’osservatore (ad es. dopo un temporale pomeridiano che era pervenuto da W). L’immagine del sole riflessa da una superficie d’acqua può produrre un arcobaleno. In questo caso i raggi emergendo dal basso danno origine ad archi che si proiettano alti nel cielo i quali possono sovrapporsi agli archi dovuti alla luce diretta ed assumere forma di archi interi. Se la parte alta viene offuscata, si ha il fenomeno dell’arco rovesciato (si veda la Fig. 3). Esistono infine arcobaleni prodotti da nebbie piovigginose o dalle stesse nuvole (cloudbows e fogbows in lingua inglese). Si presentano anch’essi dalla parte opposta del sole, hanno dimensioni angolari più ridotte (circa 2° in meno), spessore maggiore, ed i colori sono grigi-biancastri e poco luminosi. I “cloudbows” sono visibili soprattutto dagli aerei e vengono anche chiamati “pilot’s bows”. |
|||