|
|
|
|
|
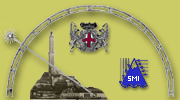 |
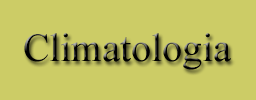 |
 |
|
||
|
|
1. Parte
Introduzione La geografia gioca un ruolo di primaria importanza nel condizionare la circolazione a grande scala in particolare nell’area Mediterranea, che ci appare come un enorme ‘catino’ circondato da una prevalenza di terre emerse con rilievi più o meno importanti quali ad esempio le Alpi, i Pirenei, l’Atlante,l’Appennino, i balcani, ecc...
Tali catene montuose spesso fanno da spartiacque tra masse d’aria significative
e di diversa origine: spesso quella più fredda d’origine continentale
(proveniente dall’Europa Orientale) viene a trovarsi contrapposta ad un flusso
Sud-occidentale d’origine subtropicale che è in grado di pescare masse d’aria
dal Nord-Africa, subendo un processo d’umidificazione nel cuore del Mare
Nostrum. Basti pensare che il Mediterraneo occidentale (bacino che si estende in
longitudine dalla Spagna alle coste tirreniche e in latitudine dal Golfo del
Leone fino al Maghreb) presenta un superficie di ben 820.000 km2 ed è circondato
da una serie di catene montuose di un certo rilievo, quali i Pirenei, il
Massiccio Centrale, le Alpi, gli Appennini e più a Sud l’Atlante (oltre a essere
caratterizzato da una serie d’isole con rilievi significativi). Le masse d’aria tendono così a seguire vie preferenziali indotte dall’orografia (valli, catene montuose, coste alte ecc) aggirando gli ostacoli o assecondando un percorso più naturale.
Ritorno continentale dai quadranti orientali In particolari condizioni sinottiche caratterizzate:
tende ad instaurarsi un significativo gradiente barico, associato ad un regime di Maestrale e Tramontana sui settori occidentali del Mediterraneo (ed in particolare sul golfo del Leone). Sulle regioni adriatiche e la Pianura padana invece s’innesca un regime più continentale di origine balcanica (dal 2° e 3° quadrante, come indicato dalle frecce blu), che converge con una risalita d’aria relativamente più umida attraverso l’Adriatico centro-settentrionale (come indicato dalle frecce arancio).
Con il passaggio alla stagione fredda, l’anticiclone continentale (che si può presentare come una propaggine orientale dell’anticlone Russo) risulta caratterizzato dalla permanenza ed estensione verso occidente di un promontorio presente solo sui Balcani e/o l’Europa Orientale (anticiclone Balcanico). Questa vasta struttura che si rinforza su gran parte dell’Europa continentale, tende via via a rinvigorirsi in particolare nella stagione invernale e/o inizio primaverile, risultando associata ad un importante produzione ed accumulo di aria fredda (in prossimità delle aree continentali dell’Europa orientale e della Siberia): i valori di pressione così tendono ad aumentare con il sopraggiungere della stagione fredda, passando da 1025 -1030 hPa di fine estate (evento di Settembre 2005) ad oltre 1040 hPa (già nel Dicembre 2005) nel cuore del continente europeo (fig. 4).
In mancanza di nuvolosità, il raffreddamento del suolo innevato tende a produrre, nei primi 2000-3000 m, importanti strati d’aria fredda (nelle ore notturne) in assottigliamento ed espansione verso occidente lungo il bordo meridionale dell’anticiclone. Queste masse d’aria sono associate ad un tempo molto rigido e freddo anche alle latitudini mediterranee. Tale configurazione (vedi figura 4 e 6) può causare un tempo moderatamente perturbato sulle regioni adriatiche ed i versanti padani delle Alpi occidentali, sul basso Piemonte e l’Appennino Ligure (figura 5): inoltre presenta un’evoluzione poco dinamica (persistenza della fase di maltempo per almeno 36 –72h), associata a venti di caduta dagli Appennini verso il mare, con vistosi fenomeni di turbolenza in prossimità dei versanti marittimi.
L’interazione tra regime da Est Nord-Est e l’orografia appenninica
Questo regime risulta associato ad una circolazione in quota quasi stazionaria sulle regioni tirreniche (cut-off), che in precendenza si era formata sul Nord-Ovest italiano; ecco che assistiamo in Liguria ad un tempo a tratti ventoso e ‘chiuso’, almeno nelle prime 36-48 ore, accompagnato da nuvolosità diffusa ed occasionali precipitazioni (in particolare sui rilievi e i versanti padani) che nel periodo più freddo possono trasformarsi in insidiose bufere di neve in grado di raggiungere quote relativamente basse.
La presente configurazione tende a differenziarsi da un flusso più ‘secco e chiaro’ da Nord (spesso caratterizzato da vistosi episodi di Foehn sul Piemonte, e venti forti da N, NW in particolare tra il Savovese e Capo Mele). Ecco alcune caratteristiche legate al ritorno dal I quadrante (dalla mesoscala alla scala locale):
Nuvolosità: A ridosso del Golfo Ligure segnaliamo:
*Il Bolam è un modello ad area limitata, i cui run sono resi possibili grazie
alla collaborazione tra l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima
(ISAC-CNR) di Bologna, il Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova
(DIFI) e il Centro Meteo-Idrologico della Regione Liguria (ARPAL-CMIRL). |
||||||||||||||||||||||||||||||||