|
Violenti nubifragi hanno colpito con effetti alluvionali diverse zone
della Sardegna, ma in particolare i settori nord-orientali (dall'Ogliastra
alla Costa Smeralda) nella giornata di lunedì 18 novembre 2013.
Per quanto responsabile di eventi estremi, si è trattato di una
situazione
relativamente
comune in autunno nel Mediterraneo: una depressione sulle Baleari
(battezzata "Ruven" dall'Istituto
di Meteorologia dell'Università di Berlino; "Cleopatra" è una
denominazione non ufficiale) ha convogliato verso la Sardegna aria
caldo-umida da Sud-Sud-Est che, insieme all’instabilità dovuta ad aria
più fredda in alta quota, e all’apporto di abbondante energia e vapore
acqueo dal mare ancora tiepido dopo l’estate (27-28 °C in superficie
sul Tirreno centrale, 2-3 °C sopra media), ha alimentato per diverse
ore imponenti celle temporalesche rigeneranti, visibili nelle
immagini satellitari qui sotto.
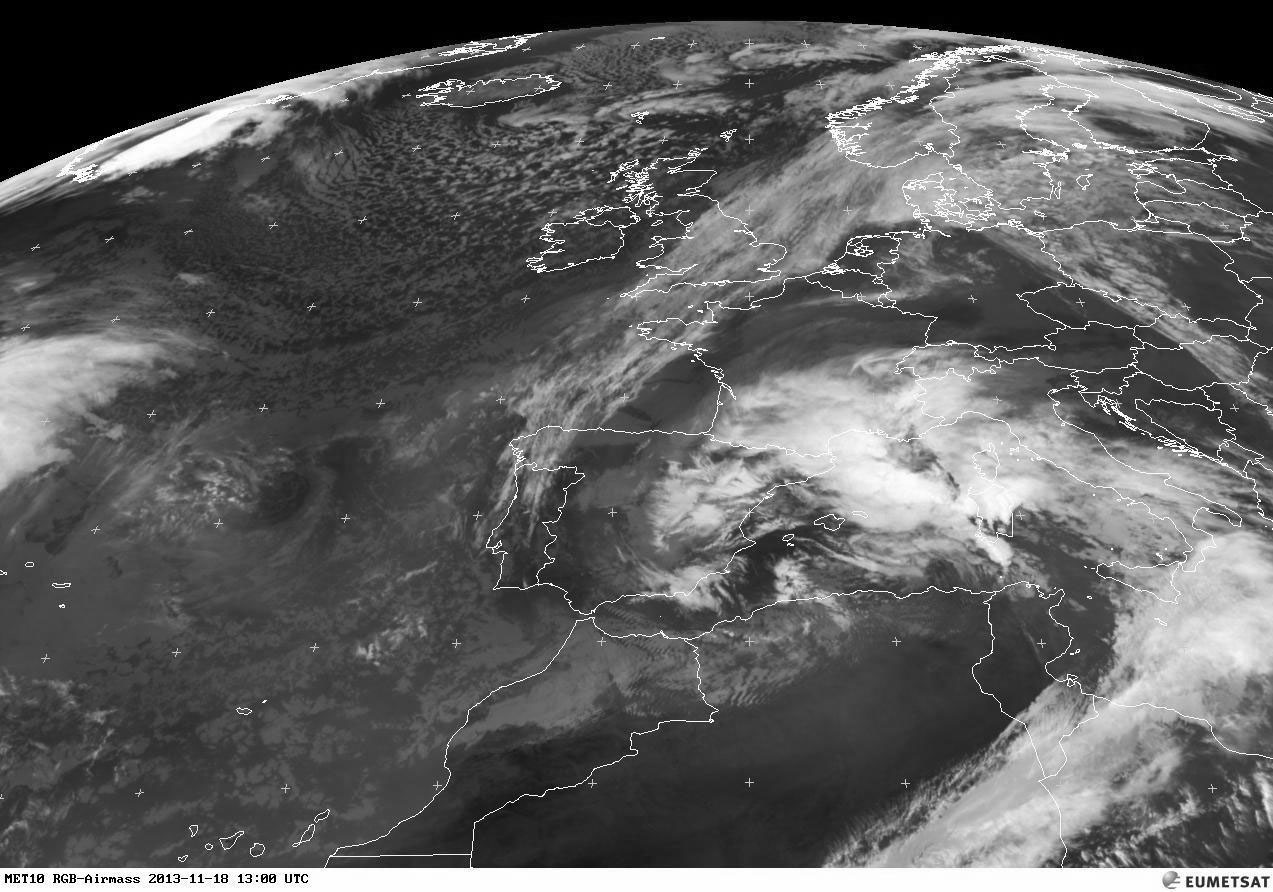
Immagine Meteosat10 nel canale
infrarosso di lunedì 18 novembre 2013 - ore 13 UTC
(ore 14 italiane). Due nuclei temporaleschi interessano la Sardegna
nord-orientale,
ed è possibile riconoscere la caratteristica forma a "V" delle
formazioni nuvolose,
indizio di sistemi convettivi rigeneranti. Fonte:
Eumetsat.
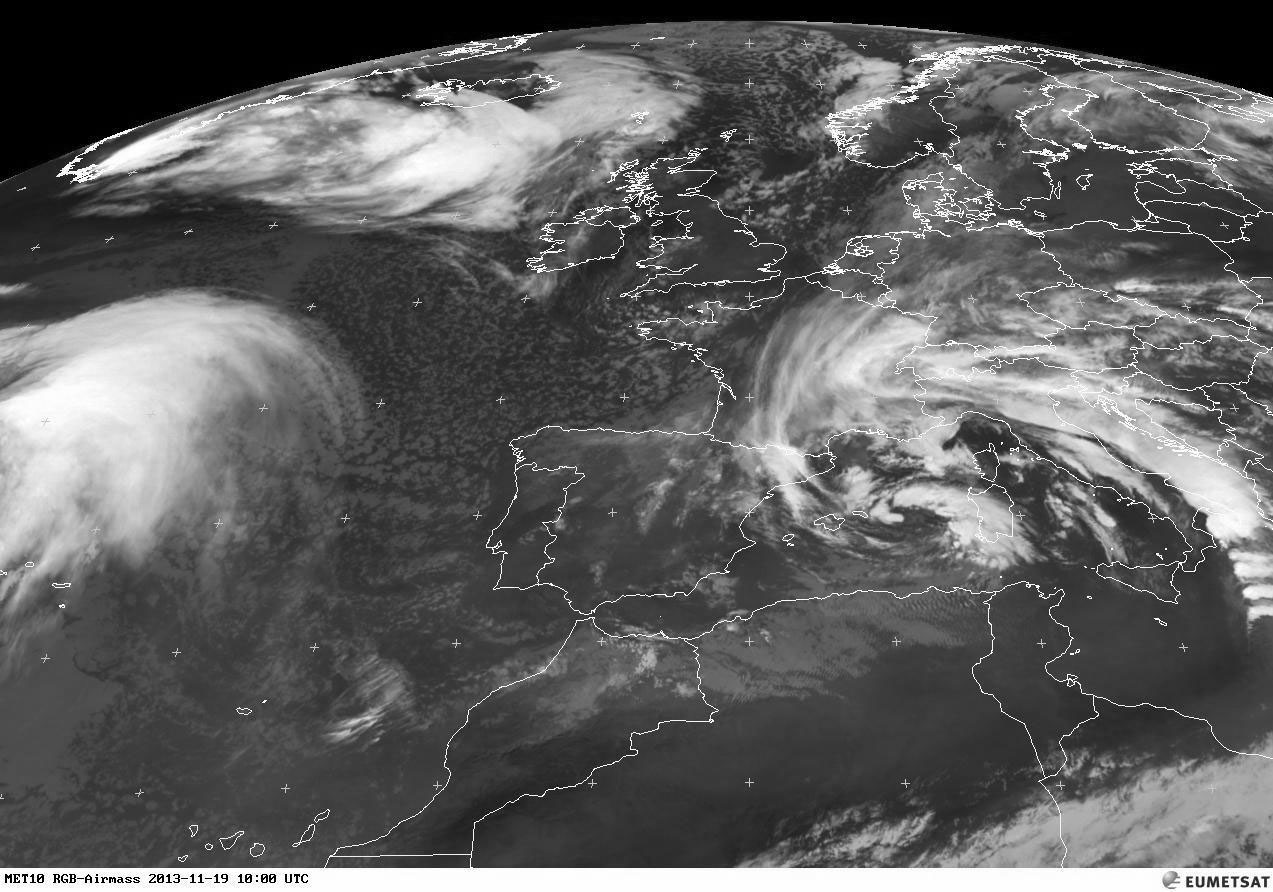
Immagine Meteosat10 nel canale
infrarosso di martedì 19 novembre 2013 - ore 10 UTC
(ore 11 italiane). Le precipitazioni più violente sulla Sardegna sono
terminate, mentre una linea temporalesca - dopo aver interessato la
Calabria - si estende dalle regioni ioniche al basso Adriatico,
colpendo in particolare il Salento (tromba d'aria su Gallipoli,
Lecce).
E' riconoscibile inoltre la struttura spiraleggiante delle nubi
intorno al minimo di pressione in superficie tra le Baleari e la
Sardegna. Fonte:
Eumetsat.
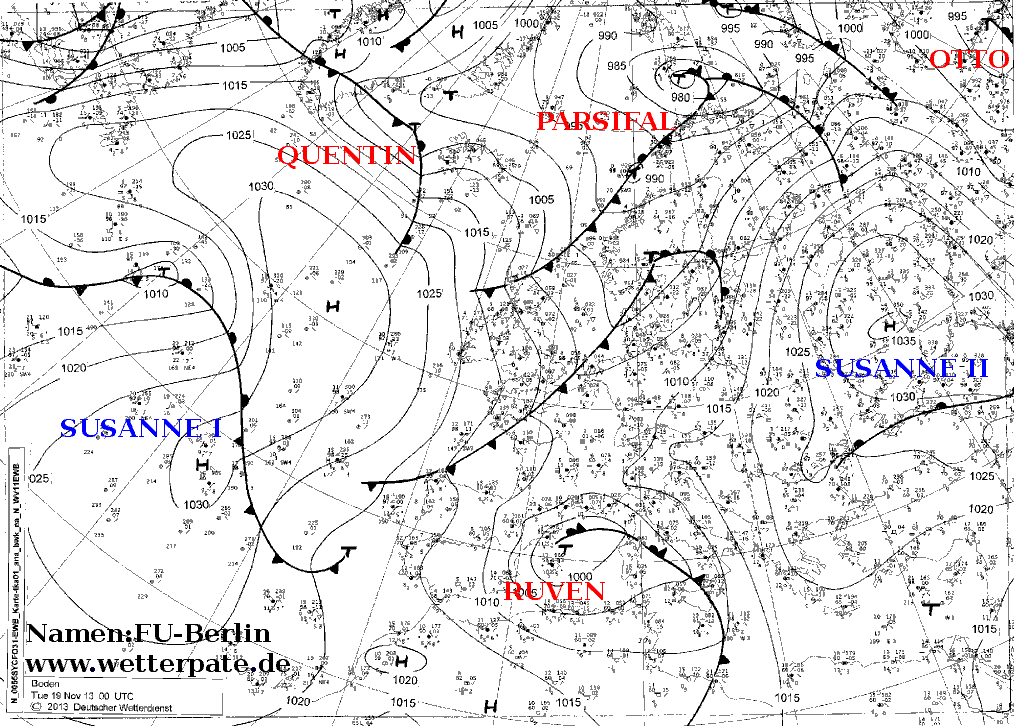
Analisi
al suolo, h 00 UTC del 19.11.2013: la depressione "Ruven" (minimo
inferiore a 1000 hPa) è collocata poco a Est delle Baleari, e investe
la Sardegna con un flusso caldo-umido sud-orientale che alimenta la
formazione di celle temporalesche
(Institut
für Meteorologie, Berlin).
Secondo
la rete di pluviometri del
Servizio
Agrometeorologico Regionale (SAR) della Sardegna i massimi di
precipitazione si sono collocati nell'immediato entroterra del Golfo
di Orosei (Nuoro), con valori, nella sola giornata del 18 novembre, di
385.6 mm a Dorgali-Filitta e 378.2 mm a Oliena. Notevolissimi
gli apporti piovosi anche un po' più a Sud, in Ogliastra, con 316.4
mm a Villanova Strisaili, zona tuttavia non nuova a violenti
nubifragi con precipitazioni incentivate dal sollevamento orografico
delle masse d'aria umida in arrivo dal Tirreno sui fianchi orientali
del Gennargentu.
Assai anomala, benché inferiore, la quantità di 151.6 mm rilevata a
Palmas Arborea, alle porte di Oristano, zona solitamente molto
asciutta (media di circa 600 mm/anno) il cui reticolo idrografico non
è dimensionato per smaltire senza gravi effetti simili quantità di
pioggia.
Al di là dei singoli dati pluviometrici, straordinari ma di cui
esistono riscontri storici passati (vedi le descrizioni più avanti),
colpisce l'elevata estensione dei territori colpiti, dall'Oristanese,
all'Ogliastra, alla Gallura. Particolarmente funestata dalle
esondazioni e dalle alluvioni-lampo ("flash-flood") l'area di Olbia
e quella del bacino del Fiume Cedrino (entroterra tra Nuoro e
Orosei).
Alla
gravità del bilancio (attualmente di 16 vittime e un disperso, 2300
sfollati e 43 feriti) ha contribuito l'interessamento di zone ad
elevata densità abitativa e di infrastrutture (in particolare Olbia e
dintorni).
Qui la crescente occupazione e artificializzazione del territorio
- senza tenere presente l'insegnamento di episodi alluvionali passati
- negli ultimi decenni spesso ha interferito con il reticolo di
deflusso naturale delle acque, che in una regione come la
Sardegna rimane asciutto per lunghi periodi dell'anno.
Una situazione che peraltro accomuna molte regioni d'Italia. Per
questo, a parità di grandezza meteorologica dell'evento, questa
alluvione ha prodotto effetti particolarmente importanti, di cui si
sono occupate ampiamente le cronache giornalistiche nazionali e
locali.

Durante l'impetuosa esondazione del Fiume
Cedrino il rilevato di accesso al ponte sulla strada provinciale 46
presso Dorgali (Nuoro) è parzialmente crollato,
causando una delle 16 vittime dell'alluvione (fonte: "La
Nuova Sardegna").
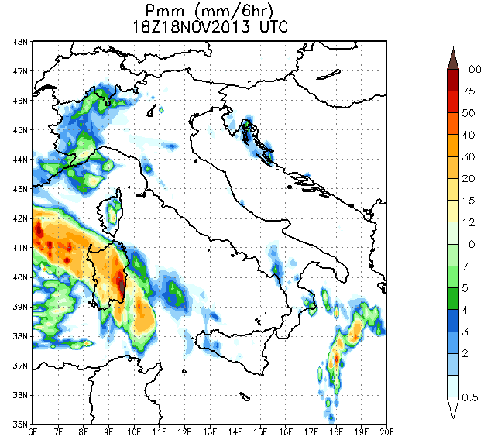
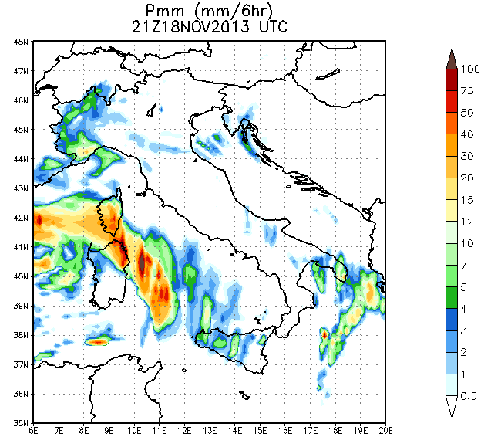
L'episodio di violente piogge è stato ben delineato dai modelli
numerici di previsione con 24-48 ore di anticipo. Qui sopra, carte di
previsione delle precipitazioni in Italia, rispettivamente intervalli
h 12-18 e h 15-21 UTC di lunedì 18 novembre 2013, emesse domenica 17
novembre: ben visibile un nucleo di particolare intensità (>100 mm in
6 ore, fondo scala del modello) risalire da Sud
il versante orientale della Sardegna verso l'Ogliastra e la Gallura
(fonte: MetOffice).
Per quanto violento e responsabile di vittime e danni estesi e gravi,
questo episodio alluvionale non è da considerarsi una novità assoluta
per la Sardegna, poiché esistono riscontri di altri casi analoghi in
passato, in particolare, negli ultimi 15 anni:
1999, 12-13 novembre: grave
alluvione per un nubifragio rigenerante sul Cagliaritano; a cavallo
dei 2 giorni cadono 462 mm a Uta e 443 a Decimomannu (quasi pari
all'apporto medio annuo!), 2 vittime.
2004,
6 dicembre: colpita l’Ogliastra, 517 mm in 24 ore a Villanova
Strisaili, strade cancellate e ponti crollati, 2 vittime.
2008,
22 ottobre: nubifragio alluvionale sul Campidano di Cagliari, 372
mm in poche ore a Capoterra, 5 vittime, inondazioni su 40 chilometri
quadrati di territorio con altezze d'acqua fino a 2 metri.
Più indietro nel tempo si ricordano inoltre:
1940, 18-20 ottobre: 700 mm ad Arzana (Ogliastra), storica piena
del Flumendosa (sud-est della regione).
1946, 26-27 ottobre: flash-flood notturna nel Cagliaritano con
effetti peggiori a Sestu ed Elmas (esondazione Rio Matzeu), altezze
d'acqua fino a 4 m, una quarantina di vittime.
1951,
metà ottobre: in 4 giorni, fino a 1400 mm di pioggia sull’Ogliastra,
5 vittime, distruzioni diffuse, due paesi (Gairo e Osini) furono
abbandonati.
Elenco alluvioni storiche in Sardegna meridionale
Tanta
pioggia e così concentrata, è colpa del riscaldamento globale?
Non si può
dare una risposta univoca a questa domanda. Gli effetti del
riscaldamento globale si sovrappongono agli eventi estremi naturali
accrescendone eventualmente frequenza e intensità. Ma non è possibile
distinguere quanta parte è dovuta alla normale variabilità naturale e
quanta alle nuove condizioni indotte dall’attività antropica, tra cui
l’aumento della temperatura del mare che è uno degli ingredienti che
alimentano i nubifragi. L’unica certezza è che gli estremi
meteorologici non potranno che intensificarsi in futuro via via che
cresce la temperatura globale e quindi per un Paese già così fragile
come l’Italia è fondamentale investire sulla manutenzione del
territorio e la protezione civile.
A tal proposito, si legga questo
articolo curato dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti
Climatici.
|