|
Dopo una primavera fresca e tardiva - in
Italia e su gran parte d'Europa
- giugno 2021 si sta mostrando decisamente caldo per
effetto di anticicloni subtropicali allungati dal Nord Africa talora
fino all'Europa nord-orientale. Le anomalie di temperatura media del
periodo 1-22 giugno variano da circa +2,5 °C sulle Alpi a circa +1
°C in zona ionica, dove ora però si sta concentrando l'intensa
ondata di calore che in questi giorni scorsi (22-24 giugno) ha portato
estremi inconsueti fino a:
44,4 °C a Enna (superato il precedente record di 42,9 °C del 24
luglio 2009);
44,5 °C a Comiso (precedente: 43,5 °C il 12 luglio 2012) e
Augusta (sfiorati i 45,1 °C del 24 luglio 2002);
44,6 °C a Caltagirone (precedente: 44,3 °C il 25 luglio 2009)
(fonte: stazioni rete
SIAS
con serie dal 2002).
Tuttavia il mese, come spesso avviene, sta trascorrendo
anche frequentemente temporalesco sulle regioni del Nord,
lambite da impulsi di aria più umida e instabile da Sud-Ovest sul
bordo dell'anticiclone attualmente disteso con asse tra Centro-Sud
Italia e Balcani.
In questo contesto spicca, tra gli altri, lo straordinario
nubifragio che nel tardo pomeriggio di martedì 22 giugno ha
investito Torino.

L'impressionante "colonna"
di precipitazioni rovesciata dal cumulonembo sui quartieri
centro-orientali di Torino ripresa dal grattacielo Sanpaolo in Corso
Inghilterra, in direzione Nord-Est. Al centro, Piazza XVIII Dicembre
(stazione di Porta Susa), all'estrema destra la Mole Antonelliana.
Si noti, proprio dietro la Mole, il ricciolo creato dall'impatto al
suolo della colonna di pioggia e correnti fredde discendenti (microburst),
che tendono ad estendersi e irradiarsi in maniera concentrica in tutte
le intorno al centro di scroscio (foto Franco Vinetti, via pagina FB
Tornado in Italia).

Un dettaglio colto in direzione
Nord-Est dal palazzo della Città Metropolitana, sempre in Corso
Inghilterra (foto Emanuela Sarzotti).
Il temporale, rigenerante per circa tre ore con nuclei
in moto da SW a NE, ha scaricato sulla
stazione ARPA Piemonte di Via della Consolata - riferimento per la
prosecuzione della serie meteorologica storica del centro città - ben
75,0 mm in un'ora e 94,2 mm in 3 ore.
Valori molto simili al pluviometro, sempre ARPA, dei Giardini Reali, e perfino superiori alla stazione
del gruppo
TorinoMeteo in Corso Regio Parco, ben 105 mm in 3 ore.
Inevitabili, con tali intensità di scroscio,
inondazioni di strade e sottopassi (urban flood) e forti disagi
al traffico, anche per schianti di rami dalle alberate, peraltro
in ora di punta pre-serale.

L'immagine satellitare nel canale
visibile (fonte: Eumetsat, via
Sat24) alle ore
18:15 locali mostra il vasto sistema temporalesco a multicella che si
estende da Torino fino ai laghi prealpini.
A Sud del Po prevalgono il sereno e il caldo intenso, con punte di
quasi 45 °C in Sicilia!
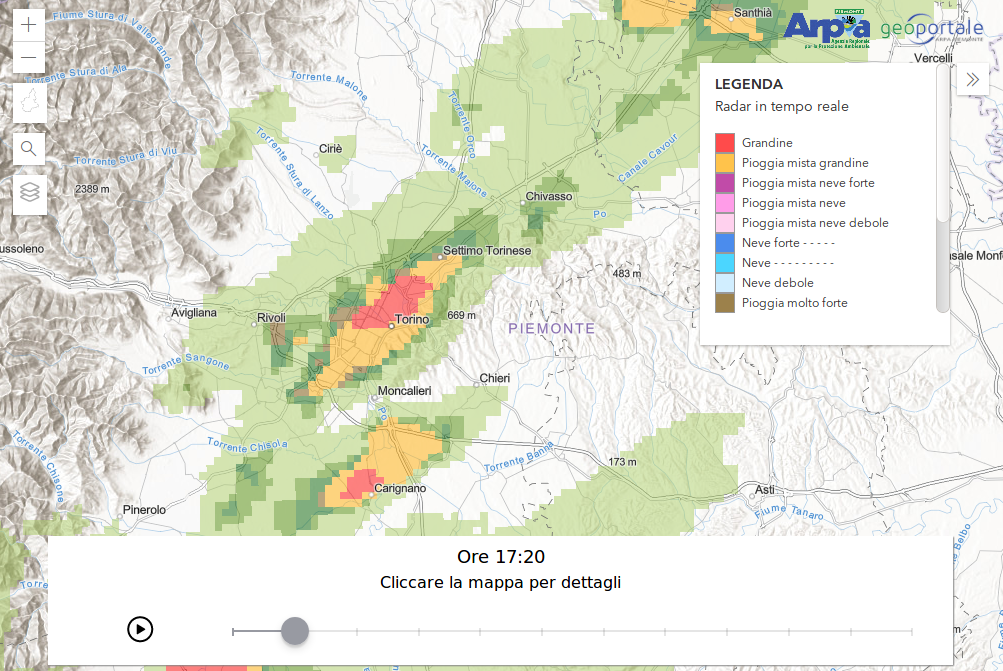
Frame del
radar ARPA Piemonte (basato al Bric della Croce sulla collina
torinese), ore 17:20 locali: i colori gialli e rossi indicano i
settori più attivi del sistema temporalesco, disposto con asse SW-NE,
su Torino centro, con elevata probabilità di grandine frammista alla
pioggia. Un secondo nucleo intenso è presente in cintura Sud, intorno
a Carignano.
Concentrandosi sul dato della Consolata, questo risulta
il massimo rilevato in tre ore dal 1928, anno in cui a
Torino-centro si avviò la registrazione continua delle precipitazioni
con apparecchi a bascula, ovvero pluviografi meccanici (sedi Ufficio
Idrografico di via Gropello e Corso Inghilterra) oppure pluviometri
automatici (rete ARPA Piemonte da fine Anni Ottanta).
Dalle informazioni in nostro possesso, su nessun pluviometro della
città era mai caduta tanta pioggia in così poco tempo.
Seguono in classifica, con un certo distacco rispetto
all'episodio recente, questi eventi, tutti degli ultimi anni (quantità
cadute sempre in 3 ore e alla Consolata):
- 11 agosto 2010, 86,6 mm (83,9 mm ai Giardini Reali)
- 9 luglio 2011, 80,8 mm
- 17 agosto 2020, 81,8 mm
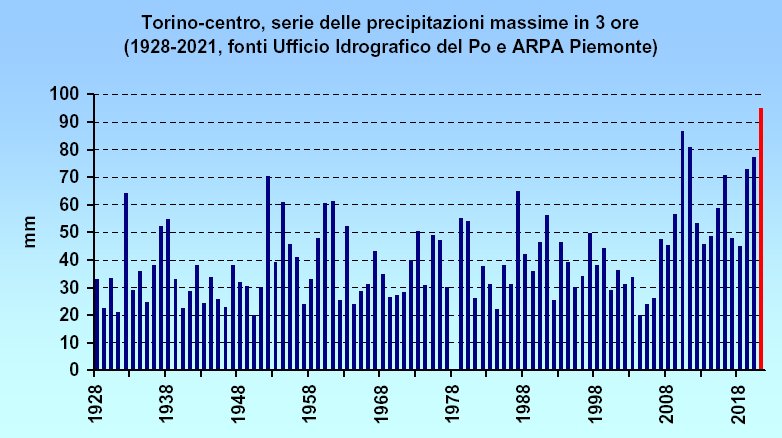
Serie annua delle massime
precipitazioni in 3 ore a Torino-centro (1928-2006 stazioni UIPO,
2007-2021 stazione ARPA Piemonte di Via della Consolata).
Il metodo di valutazione degli estremi è invariato nel tempo
(precipitazioni cadute in sequenze qualsiasi di 180 minuti, e non per
"blocchi" fissi di tre ore) e - assumendo che l'affidabilità degli
apparecchi impiegati sia rimasta costante, e che lo spostamento delle
stazioni di riferimento dai pressi di Porta Susa alla Consolata (circa
1,5 km a Est) non abbia comportato rilevanti variazioni nel
comportamento delle piogge - risulterebbe evidente un incremento
delle intensità dei massimi annuali dagli Anni Duemiladieci, con
al vertice l'evento del 22 giugno 2021.
L'aumento di intensità e frequenza dei rovesci
violenti per effetto del riscaldamento di atmosfera e oceani è ben
noto a livello teorico e nei modelli di previsione del clima futuro in
quanto in un pianeta più caldo:
1) l'evaporazione da suoli, foreste e mari avviene più rapidamente;
2) l'atmosfera può contenere più vapore acqueo (+7% per ogni grado °C
di incremento termico secondo l'equazione di Clausius-Clapeyron, vedi
qui), ingrediente fondamentale delle precipitazioni.
A differenza dell'aumento delle temperature, evidente pressoché in
tutto il mondo (ad eccezione di una ristretta zona del Nord Atlantico
intorno all'Islanda), la maggiore intensità e concentrazione delle
precipitazioni per il momento emerge in maniera irregolare sul
territorio, Italia inclusa, dove regioni limitrofe mostrano
andamenti contrastanti, come indica
questo articolo pubblicato nel 2019 su Geophysical Research
Letters.
Tuttavia a scala globale gli aumenti di frequenza e intensità degli
episodi sembrano prevalere sulle diminuzioni, secondo
questo studio apparso sempre nel 2019 su Water Resources
Research, in linea con quanto previsto per il futuro dai modelli
di simulazione del clima.
Inoltre, l'artificializzazione del suolo - che
pare purtroppo inarrestabile... - contribuisce ad aumentare la
vulnerabilità dei territori a parità di magnitudine degli episodi
pluviometrici, tramite il rapido ruscellamento delle acque
meteoriche sui terreni resi impermeabili, e l'aumento dei beni
sottoposti a danno.
Per approfondire la storia della meteorologia
torinese,consigliamo il volume
"Il clima di Torino" di Gennaro Di Napoli e Luca Mercalli
(2008, ed. SMS),
acquistabile sul Meteoshop SMI.
Vedi anche l'approfondimento
di ARPA Piemonte sul nubifragio torinese del 22 giugno 2021.
GRAZIE A...
ARPA Piemonte,
per la capillare misura dei parametri meteorologici che consentono di
proseguire la lunga serie di dati torinesi cominciata nel 1753 (1802
per le precipitazioni).
Gennaro Di Napoli, storico socio e collaboratore
SMI, che insieme a Luca Mercalli ha recuperato e analizzato con
grande accuratezza l'enormità di informazioni riguardanti tre secoli
di clima torinese.
Devolvi il 5 per mille alla SMI!
Sosterrai
le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,
e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|