|
Dalle Alpi, alla Scandinavia, alla
Russia, con anomalie termiche medie da +2 °C a oltre +6 °C, l'inverno
2019-20 si è chiuso in molte località come il più caldo mai registrato
nelle lunghe serie di osservazioni meteorologiche, cominciate tra
Settecento e Ottocento.
A livello italiano si è trattato del secondo inverno più caldo dal
1800 dopo quello del 2006-07, secondo il
CNR-ISAC.

Torino - Cavoretto,
24 febbraio 2020: magnolia precocemente fiorita in una delle numerose
giornate di tepore fuori dal comune in questo inverno, con temperature
massime di 22-23 °C sulla pianura torinese (f. Domenico Rosso).
Responsabile di tale anomalia climatica è
stata una situazione atmosferica di blocco con persistenti
anticicloni caratterizzati da aria calda subtropicale sull'Europa
meridionale, in contrasto con profondissime depressioni atlantiche che
incessantemente hanno sfilato sul Nord del continente causando
peraltro ripetute tempeste.
Tra queste ricordiamo in particolare "Ciara" (secondo la nuova
nomenclatura dello
Storm Centre del Met Office) o "Sabine" (secondo l'Istituto
di Meteorologia dell'Università di Berlino), violenta burrasca che
dal Regno Unito alla Slovenia ha causato 8 vittime il 9-11 febbraio
2020.
Tra i due campi di pressione prevalenti
si sono dunque incanalati da Ovest a Est continui flussi di aria
oceanica mite che sono penetrati fin nel cuore del continente (a
Mosca, nella serie dal 1821, si è registrato per la prima volta un
inverno con temperatura media sopra zero, 0,2 °C), mentre nessuna
rilevante irruzione fredda è riuscita a scendere a latitudini
italiane.
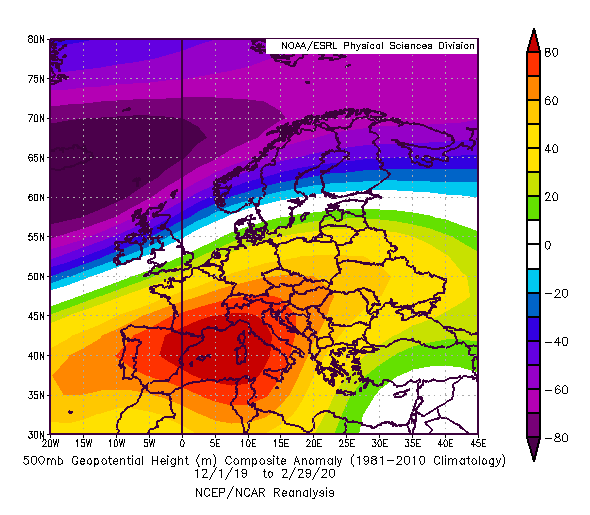
Anomalie del
geopotenziale alla superficie isobarica di 500 hPa
(circa 5500 m di quota) nel trimestre dicembre 2019 - febbraio 2020 in
Europa.
Come evidenziato dai colori arancio-rosso, gli anticicloni (caldi)
hanno insistito ben più del consueto, soprattutto tra la penisola
iberica e l'Italia, in netto contrasto con la fascia compresa tra
Islanda, Regno Unito e Scandinavia, soggetta a condizioni intensamente
depressionarie. Una configurazione ricondubicile alla fase positiva
dell'Oscillazione
Nord Atlantica (NAO+) e a un vortice polare molto più vigoroso del
solito intorno al Polo Nord (Fonte:
ESRL-NOAA).
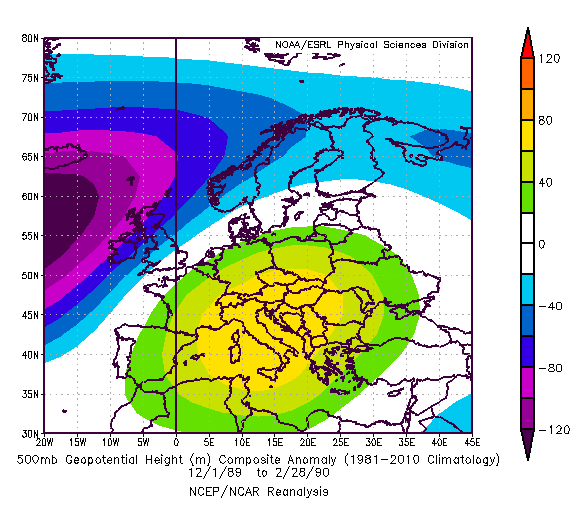
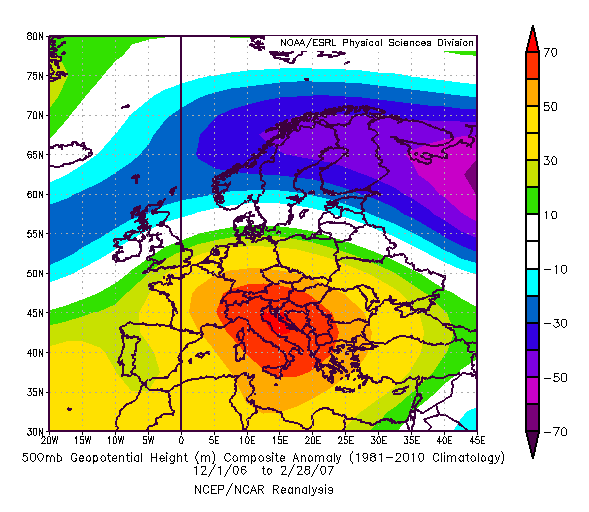
Una tale
distribuzione delle anomalie di pressione in quota sull'Europa aveva
caratterizzato anche altri inverni miti del passato, come il 1989-90
(a sinistra) e il 2006-07 (a destra), tuttavia con deviazioni dalla
norma meno spiccate rispetto al 2019-20 (Fonte:
ESRL-NOAA).
Ecco in tabella una sintesi delle anomalie di temperatura nel
trimestre dicembre-gennaio e di precipitazioni nel bimestre
gennaio-febbraio 2020 in alcuni osservatori del Nord Italia, i
confronti con la norma e i precedenti record (cliccare sulla tabella
per ingrandirla).
Per quanto riguarda le precipitazioni si
è concentrata l'attenzione su gennaio-febbraio 2020 per mettere in
evidenza la marcata siccità, che a livello trimestrale risulterebbe
invece mascherata dal dicembre 2019, piuttosto piovoso.
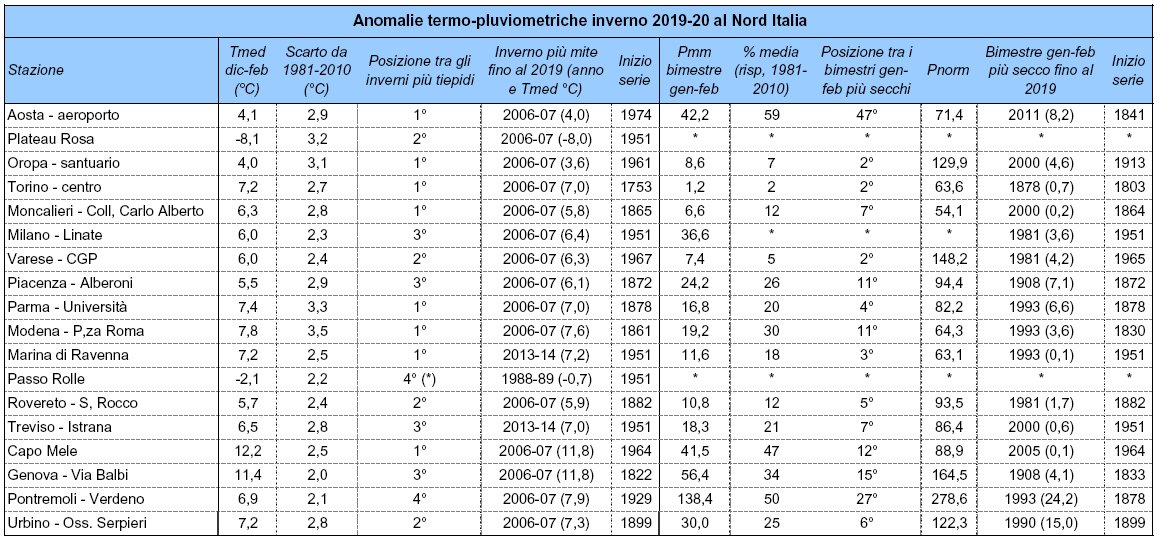
(*) serie
lacunosa, posizione in classifica indicativa
TEMPERATURE: CIRCA 3 °C SOPRA MEDIA AL
NORD, BATTUTO QUASI OVUNQUE IL RECORD DELL'INVERNO 2006-07
Le temperature medie del trimestre
dicembre-febbraio hanno superato i valori normali del periodo
1981-2010 piuttosto omogeneamente di 2,5-3,5 °C tra le Alpi e le
pianure del Nord, e di circa 2 °C in Liguria e alta Toscana.
Il precedente record di inverno
più tiepido, quasi ovunque stabilito nel 2006-07 tra le Alpi e
la Valpadana, è stato superato in varie località, da Aosta, a
Torino, a Capo Mele, a Modena... mentre è rimasto imbattuto, seppure
di pochissimi decimi di grado °C, alla stazione d'alta quota di
Plateau Rosa (3488 m), così come a Varese, Milano-Linate e Rovereto.
A Marina di Ravenna è stato eguagliato il precedente primato del
2013-14, caso che invece alla stazione di Treviso è rimasto in testa
tra i più miti con un distacco di mezzo grado °C.
Ma la sostanza non cambia: come
inequivocabile effetto del riscaldamento globale, gli inverni
italiani, ma anche tutte le altre stagioni, stanno diventando
sempre più tiepidi (+0,33 °C/decennio a livello nazionale in
inverno, nel periodo 1980-2018, secondo il
CNR-ISAC).
Ridicole le temperature minime
assolute raggiunte durante l'inverno 2019-20 nelle pianure del
Nord, a stento prossime a -5 °C nelle zone extraurbane più
fredde. Nell'ampio (e solitamente freddo) parco del Collegio Alberoni,
alla periferia di Piacenza, non si è scesi sotto i -3,6 °C del 13
gennaio 2020, mai accaduto dalla collocazione della capannina
meteorologica su prato nel 1962.
All'eccezionalità dell'inverno 2019-20 ha
contribuito la costanza delle temperature nettamente sopra media in
tutti e tre i mesi, ma in particolare in febbraio, quando
l'anomalia termica è stata ulteriormente accentuata - soprattutto al
Nord-Ovest - da frequenti episodi di foehn caldissimo. Storico
l'evento del 3 febbraio 2020 in Piemonte (27 °C nel Torinese!), ma
punte di tepore esagerato si sono avute anche il 10-11 e 24 febbraio.
All'osservatorio di Moncalieri in
febbraio l'anomalia è stata di +2,3 °C sulla media delle minime e di
ben +5,9 °C sulla media delle massime, ed è risultato nel complesso il
febbraio più caldo nella serie dal 1865 (Tmed 9,0 °C) superando
il caso del 1990 (Tmed 8,5 °C).
I numerosi rinforzi di vento di caduta da
Alpi e Appennini hanno accentuato l'effetto disseccante della carenza
di precipitazioni (vedi paragrafo successivo), ma per lo meno hanno
aiutato a rimescolare l'aria e a ridurre i livelli di polveri
sottili e ossidi di azoto che a metà gennaio, sotto tenaci alte
pressioni, avevano toccato il culmine.
Dettagli sulla situazione a
Milano-centro (a cura della Fondazione Milano Duomo) e a
Parma (Ass. MeteoParma).
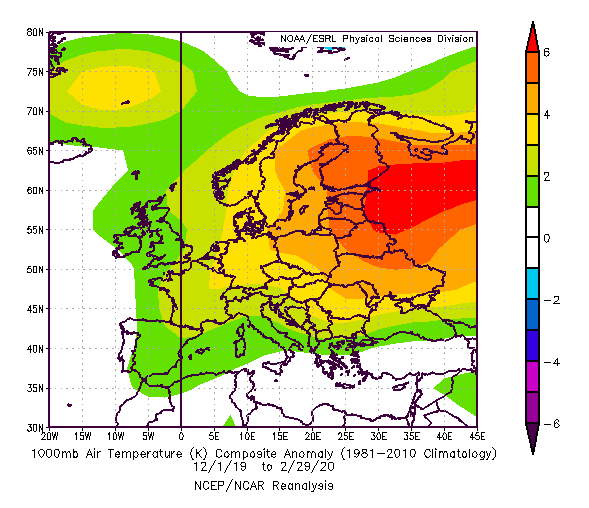
Anomalie di
temperatura in prossimità del suolo nel trimestre dicembre 2019 -
febbraio 2020 in Europa, rispetto al trentennio 1981-2010. L'inverno è
stato più tiepido del dovuto in tutto il continente, ma soprattutto
tra Finlandia, Baltico e Russia nord-occidentale, con scarti
stagionali dalla norma fin oltre +6 °C
(Fonte:
ESRL-NOAA).
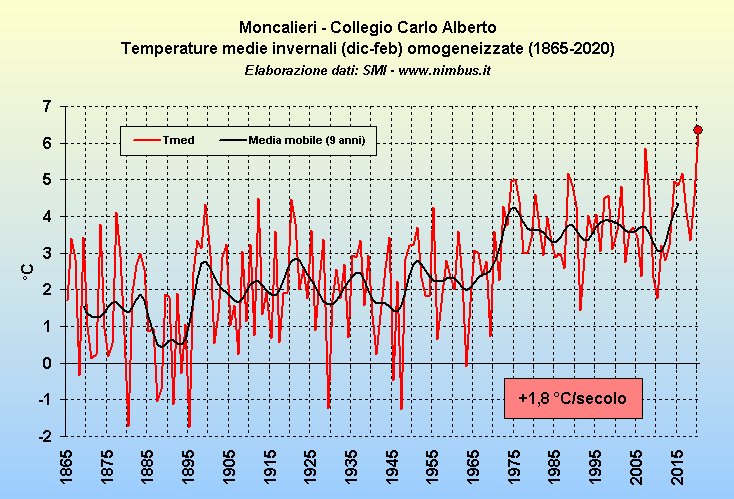
Serie delle
temperature medie invernali a
Moncalieri - Collegio Carlo Alberto:
inverno più mite dal 1865, con media di 6,3 °C, e scarto di +2,8 °C
rispetto al trentennio 1981-2010.
Evidente la tendenza al riscaldamento,
pari a +1,8 °C/secolo.
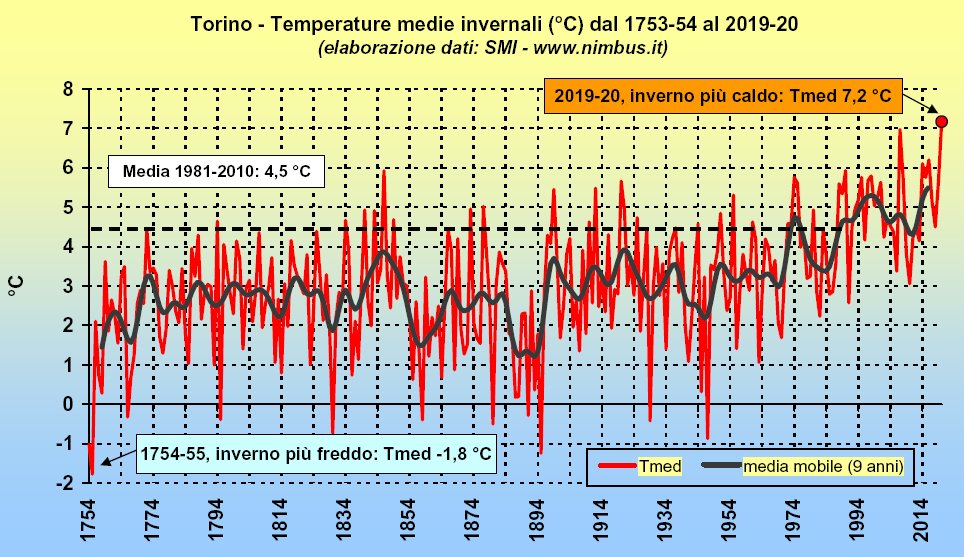
Nelle immediate
vicinanze, Torino conferma il primato di caldo, con media stagionale
di 7,2 °C che supera il precedente del 2006-07 (7,0 °C). La linea
grigia rappresenta la media mobile calcolata su un periodo di 9 anni.
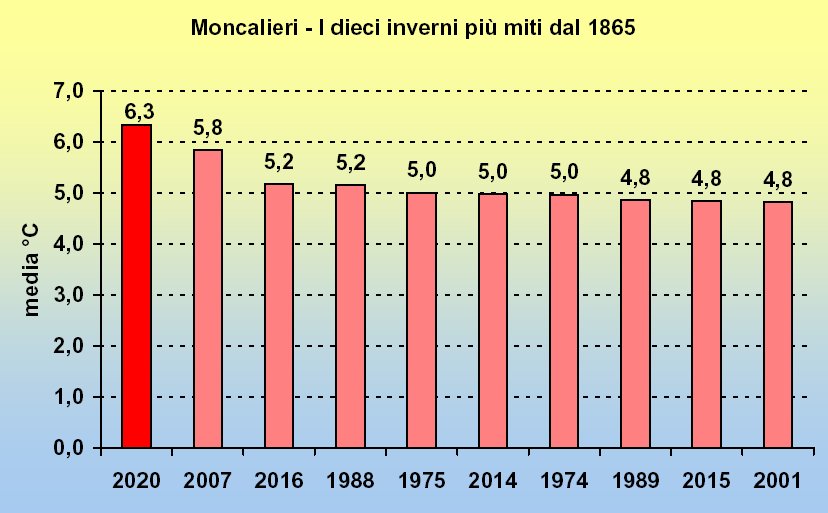
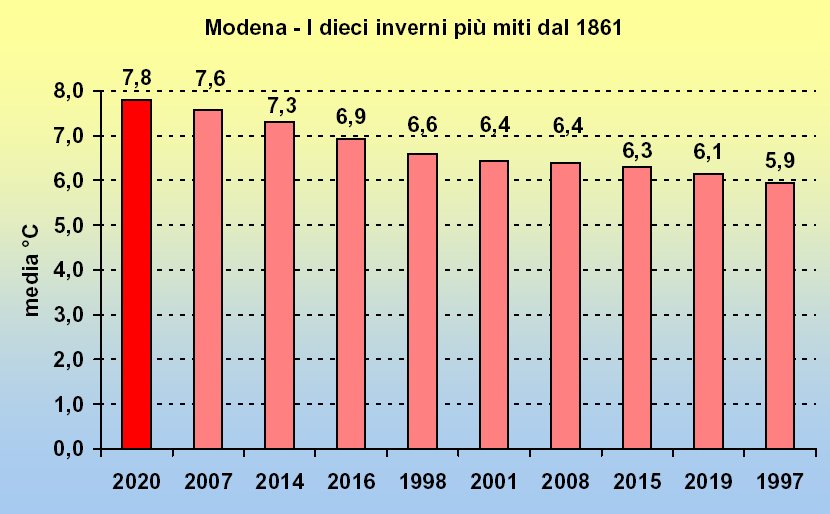
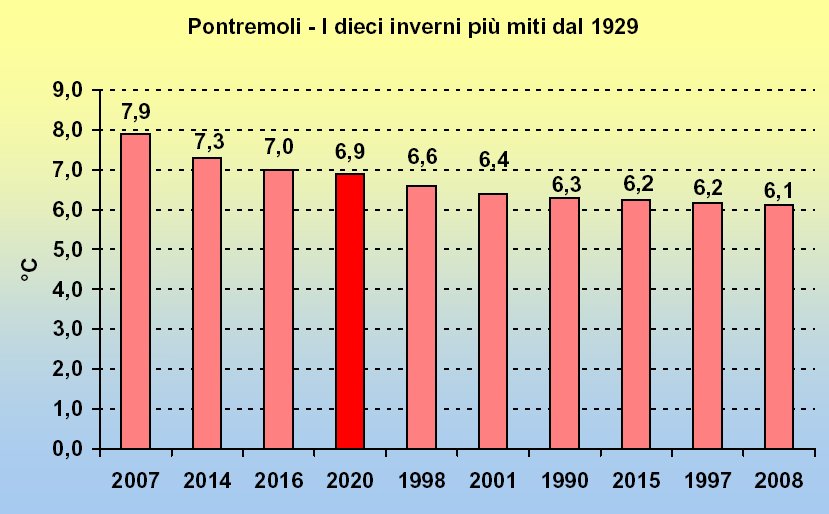
Elenco dei dieci
inverni più miti agli osservatori di
Moncalieri,
Modena e
Pontremoli: al di là del superamento o meno del record precedente,
colpisce la concentrazione dopo la fine degli Anni Ottanta della quasi
totalità degli inverni più
miti
in un secolo o più.


Precoci fioriture di albicocchi, quasi un mese in anticipo, a La
Morra, sulle Langhe (16 febbraio 2020, f. Daniele Marco) e sulle
colline di Castellamonte, Alto Canavese (23 febbraio 2020, f. Marco
Fornengo).
PRECIPITAZIONI: BIMESTRE
GENNAIO-FEBBRAIO 2020,
TRA I PIU' SECCHI AL NORD-OVEST
Da Natale 2019 fino alla fine di febbraio
2020 alte pressioni ed episodi di foehn da Ovest o Nord-Ovest
si sono spartiti il predominio sul Nord Italia, e l'assenza di
rilevanti apporti d'aria umida al Sud delle Alpi ha determinato
una prolungata carenza di precipitazioni.
Il deficit pluviometrico di inizio
anno ha colpito in particolare il Piemonte, rimasto sempre
sottovento (1,2 mm nel bimestre a Torino, valore prossimo ai minimi in
gennaio-febbraio nella serie dal 1803 insieme al lontano caso del
1878, con 0,7 mm), un po' meno la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il
Nord-Est grazie alle fugaci piogge di alcune perturbazioni occidentali
(17-18 e 28 gennaio, 4, 10 e 26 febbraio), ma con totali bimestrali
comunque inferiori a 20-40 mm.
Questi stessi fronti atlantici invece
hanno scaricato rovesci talora importanti tra il Levante ligure, la
Lunigiana e le Alpi Apuane, zone soggette ai flussi umidi da
Ponente e libeccio: ben 627 mm caduti in 21 giorni piovosi a
Campagrina (Lucca).
VALPADANA:
EFFIMERE NEVICATE SOLO IL 12-13 DICEMBRE 2019.
MA, A DIFFERENZA DEL 2006-07, MOLTA NEVE IN QUOTA SULLE ALPI
Temperature elevate e scarse
precipitazioni hanno concorso a rendere marginale la nevosità della
stagione a bassa quota al Nord Italia, dove le uniche apparizioni
della neve in pianura sono avvenute il 12-13 dicembre 2019
(1-3 cm il giorno 12 dal Piacentino, al Bergamasco, al Delta del Po e
ai litorali romagnoli; fugaci fioccate si sono ripetute il giorno
seguente, anche in Piemonte, con 2 cm a Torino).
Unica differenza con il mitissimo e secco
2006-07, l'abbondante coltre nevosa rimasta in eredità sulle
Alpi oltre i 1500 m da un
tardo autunno di precipitazioni straordinarie, manto che ha
resistito nonostante i tepori invernali e l'assenza di nuovi apporti
rilevanti, mentre nel caso di tredici anni fa l'arco alpino era
privo di neve in pieno inverno talora a 2000-2500 m.
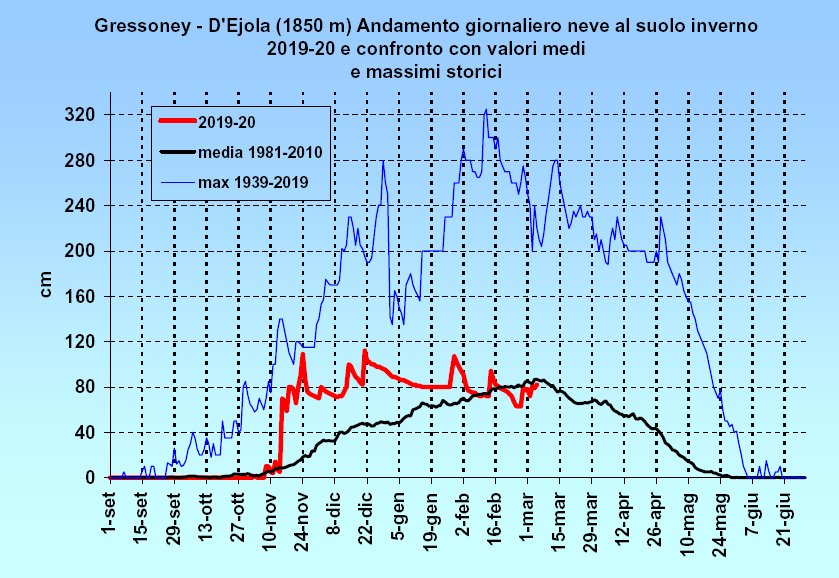
Andamento dello
spessore nevoso al suolo a Gressoney-D'Ejola (1850 m, Monte Rosa)
nell'inverno 2019-20 e confronto con la media 1981-2010 e i massimi
della serie dal 1939. Grazie alle copiose nevicate di novembre 2019,
per gran parte della stagione l'altezza del manto nevoso è stata
superiore alla norma (massimo di 112 cm il 21 dicembre 2019),
nonostante le temperature miti e la scarsità di nuove precipitazioni.
Tuttavia, con i regimi da Ovest/Nord-Ovest, alcune nevicate hanno
imbiancato le zone di confine con Francia e Svizzera tra gennaio e
febbraio 2020.
Fino al 5 marzo 2020 si sono totalizzati, nella stagione, 301 cm di
neve fresca (normale a questa data: 272 cm, +11%).

Immagine della
webcam di Gressoney-D'Ejola puntata verso l'asta nivometrica in
teleosservazione, che indica - alle ore 14 del 29 gennaio 2020 - uno
spessore nevoso totale di 107 cm (27 cm di neve fresca dal giorno
precedente).
Una perturbazione accompagnata da forti venti da Ovest scarica copiose
nevicate sulle Alpi occidentali di confine sopra i 1400 m, mentre a
fondovalle e su parte della Pianura Padana soffia il foehn e prosegue
il tempo ostinatamente asciutto.
IN ITALIA: SECONDO INVERNO PIU' CALDO E OTTAVO PIU' SECCO
DAL 1800
Riportiamo parte del comunicato stampa
emesso dal
CNR-ISAC
di Bologna:
"L’inverno meteorologico (che per convenzione si fa coincidere con il
trimestre gennaio-dicembre-febbraio) ha fatto registrare per l’Italia
un’anomalia di +2,03 °C rispetto alla media del trentennio di
riferimento 1981-2010, secondo solo all’inverno 2006-07
(anomalia di +2,13°C).
Nello specifico il mese di dicembre ha fatto registrare un’anomalia di
+1,91 °C, il secondo più caldo dal 1800 ad oggi, e febbraio è
risultato il più caldo da quando abbiamo a disposizione misure di
temperatura, con un’anomalia di +2,76 °C. Gennaio, invece,
chiude “solamente” al nono posto con un’anomalia di 1.42°C.
Accanto alle temperature insolitamente alte, l’inverno 2019-20 è stato
caratterizzato da precipitazioni pesantemente sotto media:
infatti, dopo un mese di dicembre nella media, le precipitazioni di
gennaio e febbraio sono state piuttosto scarse (-68% a gennaio e -80%
a febbraio) tanto che la cumulata sul trimestre invernale è risultata
di poco al di sopra della metà di quello che piove di solito, facendo
segnare un deficit del 43% rispetto alla precipitazione
invernale media del trentennio di riferimento 1981-2010, chiudendo
come l’ottavo inverno più secco dal 1800 ad oggi. Il deficit
risulta più contenuto al nord (-25%) grazie alle precipitazioni delle
prime decadi di dicembre, mentre sale a -55% al sud dove
l’inverno appena concluso risulta il più secco da quando
abbiamo a disposizione le misure."
L'INVERNO PIU' MITE NELL'INSIEME D'EUROPA
Secondo il servizio europeo di
monitoraggio satellitare
Copernicus
l'inverno 2019-20 è stato il più mite nell'insieme del continente:
scarto +3,4 °C rispetto al 1981-2010, ben oltre i +2,0 °C del
precedente record dell'inverno 2015-16. Anomalie termiche
sbalorditive, 5-6 °C sopra media, soprattutto nel settore Nord-Est,
tra Scandinavia e Russia.
Report completo qui.
Inoltre, inverno più mite nelle serie
nazionali di
Francia,
Svizzera,
Svezia, al secondo posto in
Austria e
Germania.
Frequenti, profonde e intense burrasche atlantiche hanno determinato
piogge alluvionali in Inghilterra nord-occidentale e Galles, e
nell'insieme del Regno Unito febbraio 2020 è stato il più piovoso
in oltre un secolo
secondo il Met Office.
RINGRAZIAMENTI
Grazie a Giulio Contri (Centro
Funzionale Regione Autonoma Valle d'Aosta), Paolo Valisa (Centro
Geofisico Prealpino, Varese), Paolo Fantini (Osservatorio
Università di Parma), Luca Lombroso (Osservatorio
Università di
Modena e Reggio Emilia), Alessio Bozzo e Filippo Orlando
(Osservatorio
Museo Civico di Rovereto), Luciano Grinza (SMI, Torino), Roberto Pedemonte (SMI, Genova) e
Maurizio Ratti (SMI,
Osservatorio di Pontremoli), Piero Paolucci (Osservatorio
Serpieri - Università di Urbino) per la condivisione di dati. Inoltre,
Gennaro di Napoli (SMI) per i contributi statistici;
il CNR-ISAC, il Servizio
Meteorologico dell'Aeronautica Militare,
ARPA Piemonte,
l'Osservatorio
del Santuario di Oropa.
Devolvi il 5 per mille alla SMI!
Sosterrai
le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,
e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|