|
Estate 2025 al Nord-Ovest italiano:
quarta o quinta più calda a seconda delle località;
precipitazioni complessivamente nella norma,
ma in deficit sulle Alpi occidentali
5 settembre 2025
Daniele Cat Berro, SMI / Redazione Nimbus
Giugno tra i più caldi (secondo solo a quello del 2003), luglio
termicamente nella norma con un episodio fresco sul finale, agosto di
nuovo canicolare nei primi venti giorni.
Ecco in poche parole l'andamento dell'estate meteorologica 2025 al
Nord Italia e sulle Alpi, che - come da convenzione - è terminata il
31 agosto (quella astronomica invece si chiuderà il 22 settembre con
l'equinozio d'autunno). Vediamo allora più in dettaglio come è andata
al Nord-Ovest aiutandoci con i dati registrati dalle stazioni
meteorologiche, indispensabili per avere un quadro oggettivo e non
basato su (spesso fallaci) impressioni individuali.

Veduta
aerea del fondovalle di Aosta e delle Alpi tra i massicci del Rutor (a
sinistra, innevato) e del Mont Fallère (a destra) al mattino del 28
giugno 2025, giornata tra le più calde di cui ci sia documentazione
storica sulla regione alpina, con livello degli 0 °C intorno a 5100 m
(f. SMI).
Caldo estremo in giugno e parte di agosto,
luglio nella norma (fresco alla fine)
Gli anticicloni nord-africani hanno dominato all'inizio
e alla fine della stagione, proponendo tre fasi calde straordinarie
per combinazione di intensità e durata: a metà giugno, a
fine giugno-inizio luglio, e intorno alla metà di agosto, periodi
che hanno visto lo zero termico sfiorare o talora superare i 5000
metri sui cieli delle Alpi, e le temperature massime raggiungere i
35-38 °C per intere settimane nelle località di pianura e fondovalle.
Per lo meno è stata provvidenziale per il benessere - soprattutto di
chi vive in città - la pausa di temperature più normali che si
è dipanata nel corso di luglio, quando a dirigere il tempo
atmosferico sulla regione alpina è stato il più tranquillo anticiclone
delle Azzorre alternato a qualche fronte temporalesco; a fine mese,
poi, depressioni sull'Europa centrale associate a correnti fresche
nord-atlantiche e variabilità hanno ricordato per qualche giorno
le estati Anni Ottanta... Ma, appunto, è durato poco, perché la
calura nord-africana è tornata a prevalere dall'8 al 18 agosto. La
“rottura” dell'estate è giunta poi nella terza decade con temporali
(anche rovinosi) e temperature rientrate intorno alla norma.
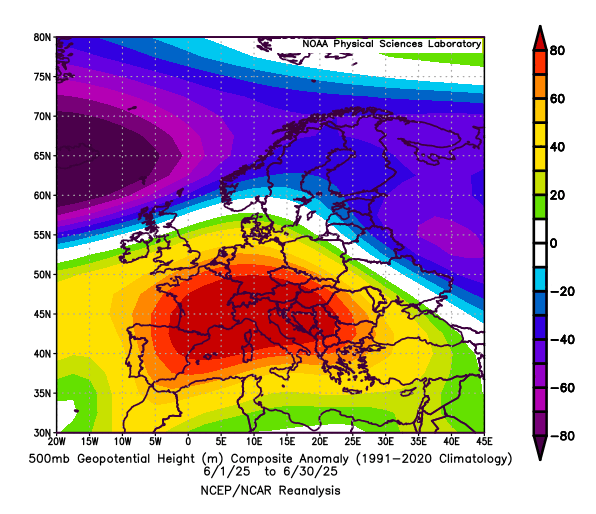
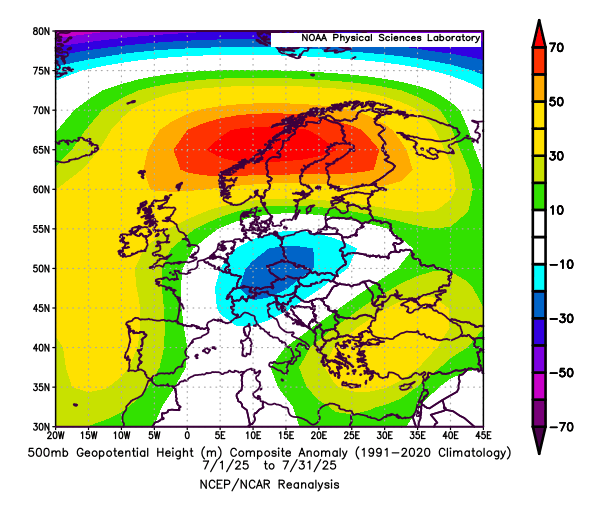
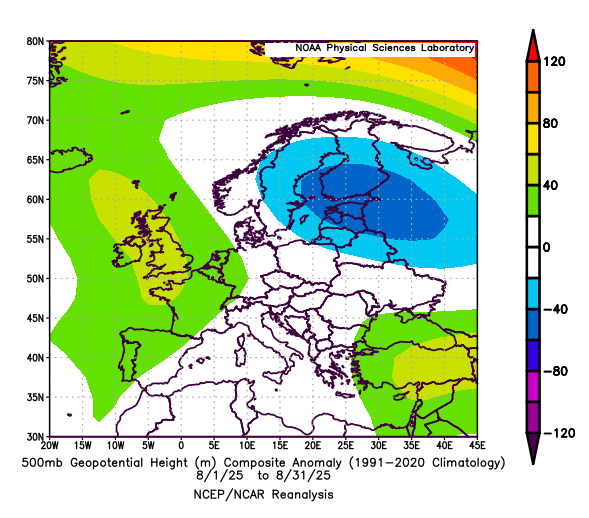
Anomalie medie dell'altezza di geopotenziale alla superficie isobarica
di 500 hPa (circa 5500-5800 m di quota alle medie latitudini), nei
mesi di giugno, luglio e agosto 2025 (cliccare sulle immagini per
ingrandirle).
Balza all'attenzione, in colori arancio-rossi, il robusto blocco
anticiclonico che ha caratterizzato giugno su tutta l'Europa
centro-meridionale, contrapposto a situazioni estesamente
depressionarie nel Nord del continente. La situazione, seppure con
anomalie minori, si è ribaltata in luglio, quando la Fenno-scandinavia
ha vissuto ondate di caldo eccezionalmente lunghe e intense, mentre
l'Europa centrale e la regione alpina, specie nella terza decade, sono
rimaste sotto l'influenza di depressioni con aria fresca. Minori
segnali di anomalia di geopotenziale (potremmo dire, per semplificare,
di pressione atmosferica nella media troposfera) hanno caratterizzato
agosto: al Nord Italia il dominio dell'anticiclone nord-africano della
seconda decade è stato evidentemente bilanciato da condizioni più
depressionarie a inizio e fine mese (Fonte:
Physical Science Laboratory - NOAA).
Quinta estate più calda a Torino, quarta ad Aosta
L'analisi
climatica di Arpa Piemonte segnala che nell'insieme della regione
l'estate 2025 si è collocata quinta nella classifica delle più
calde con anomalia di +1,4 °C rispetto alla norma del trentennio
di riferimento 1991-2020, piazzandosi (in ordine di temperatura media
decrescente) dopo i casi del 2003, 2022, 2017 e 2015 nella serie
termometrica regionalizzata a partire dal 1958. Identica situazione a
Torino-città: alla stazione di misura di via della Consolata
media termica trimestrale di 25,3 °C, anche qui in esubero di 1,4 °C,
con la stessa graduatoria riscontrata a scala regionale (quinto posto,
peraltro condiviso con l'estate 2018). Le misure nel capoluogo
iniziarono ben più indietro nel tempo, nel 1753, ma in ogni caso le
stagioni più roventi sono tutte concentrate negli ultimi tre decenni,
con le prime dieci estati che si affollano dal 2003 in poi
testimoniando l'incalzante riscaldamento in atto.
Ampliando lo sguardo alla Valpadana centrale, l'osservatorio
Alberoni di Piacenza (di cui SMI cura la gestione
tecnico-scientifica in collaborazione con l'Opera
Pia Alberoni) conferma la quinta posizione tra le estati
più calde come a Torino e in Piemonte (in questo caso pari merito, sul
filo dei centesimi di grado °C, con le estati 2012, 2018, 2019 e
2023), con un eccesso di 1,3 °C rispetto alla media 1991-2020.
Ma, sul versante Sud dell'Appennino, è al quinto
posto tra le più calde anche l'estate di Pontremoli (Massa-Carrara),
dove l'osservatorio SMI ha rilevato un'anomalia di +1,5 °C,
evidenziando una buona omogeneità territoriale del segnale termico
della stagione.
L'esubero di caldo è stato un po' più marcato sulle Alpi: all'aeroporto
di Aosta (545 m) e all'osservatorio del Gran San Bernardo
(2472 m) l'estate è risultata quarta tra le più calde, con anomalie
rispettivamente di +2,0 °C e +1,8 °C (dati
Centro Funzionale
Regione Autonoma Valle d'Aosta e
MeteoSvizzera).
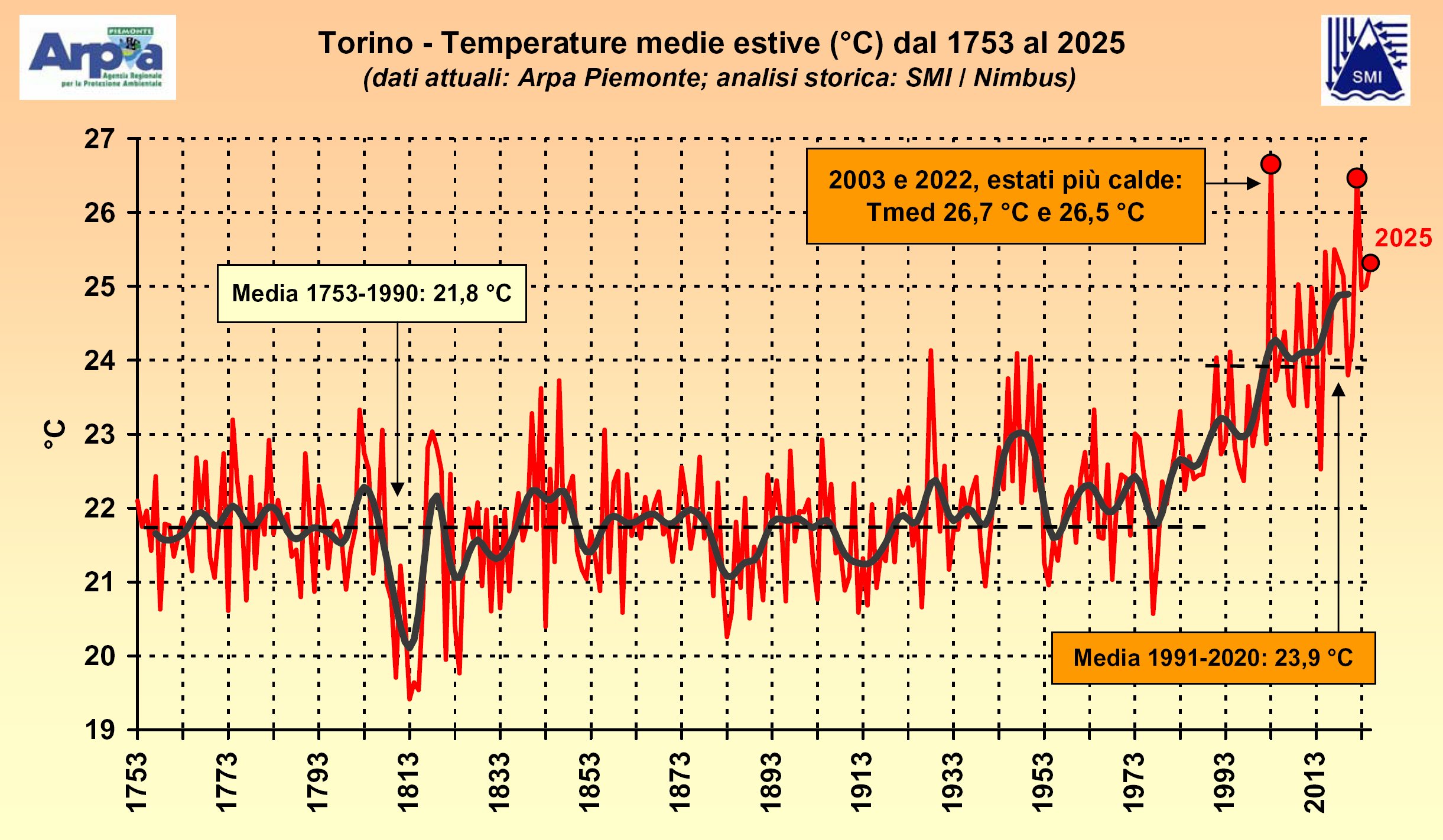
Serie delle temperature medie estive dal 1753 a Torino. Il trentennio
1991-2020 è risultato 2,1 °C più caldo rispetto al precedente periodo
storico di misura 1753-1989, e a sua volta l'estate 2025 (con media
trimestrale di 25,3 °C) è stata 1,4 °C più calda rispetto alla media
1991-2020.
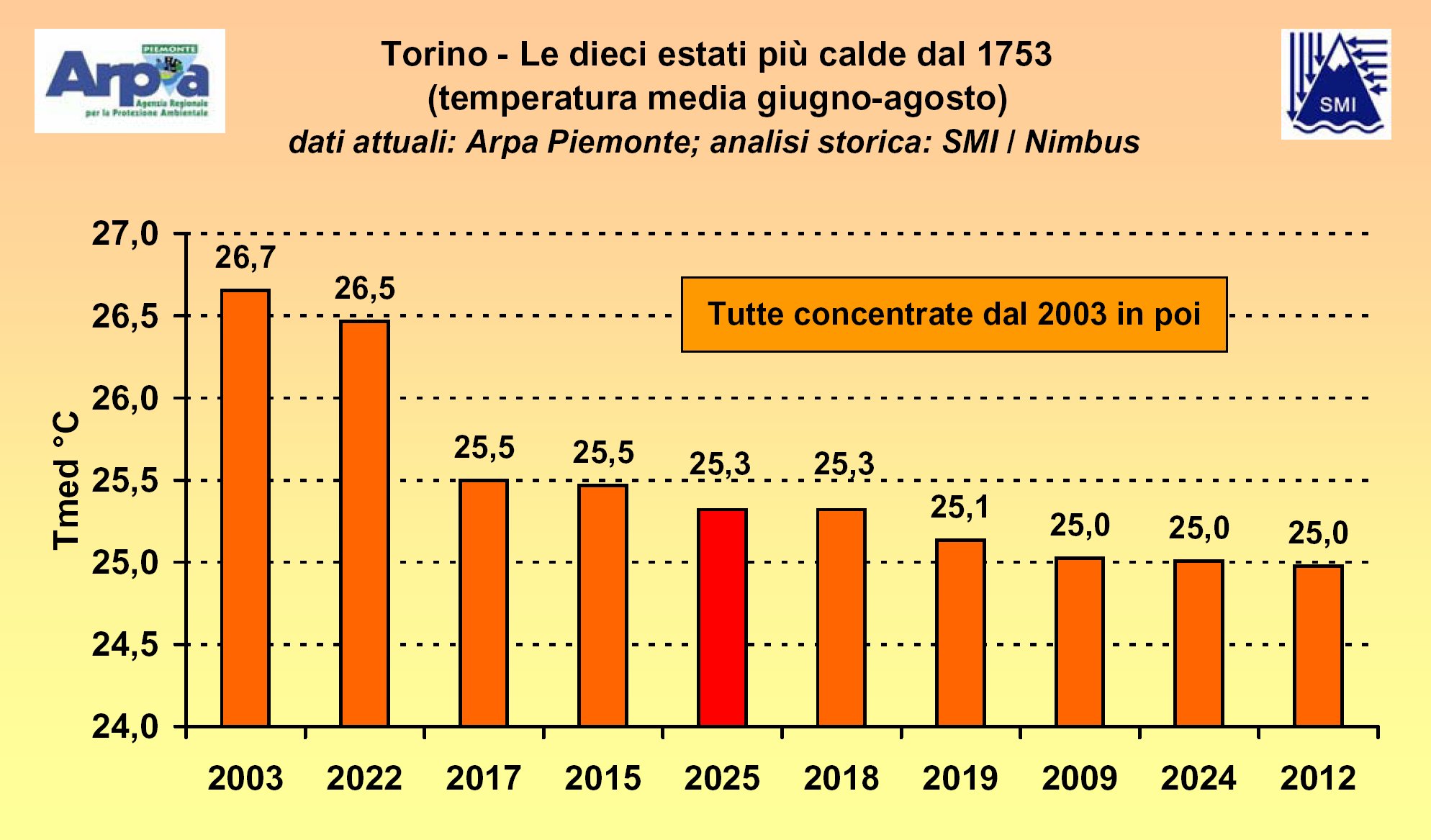
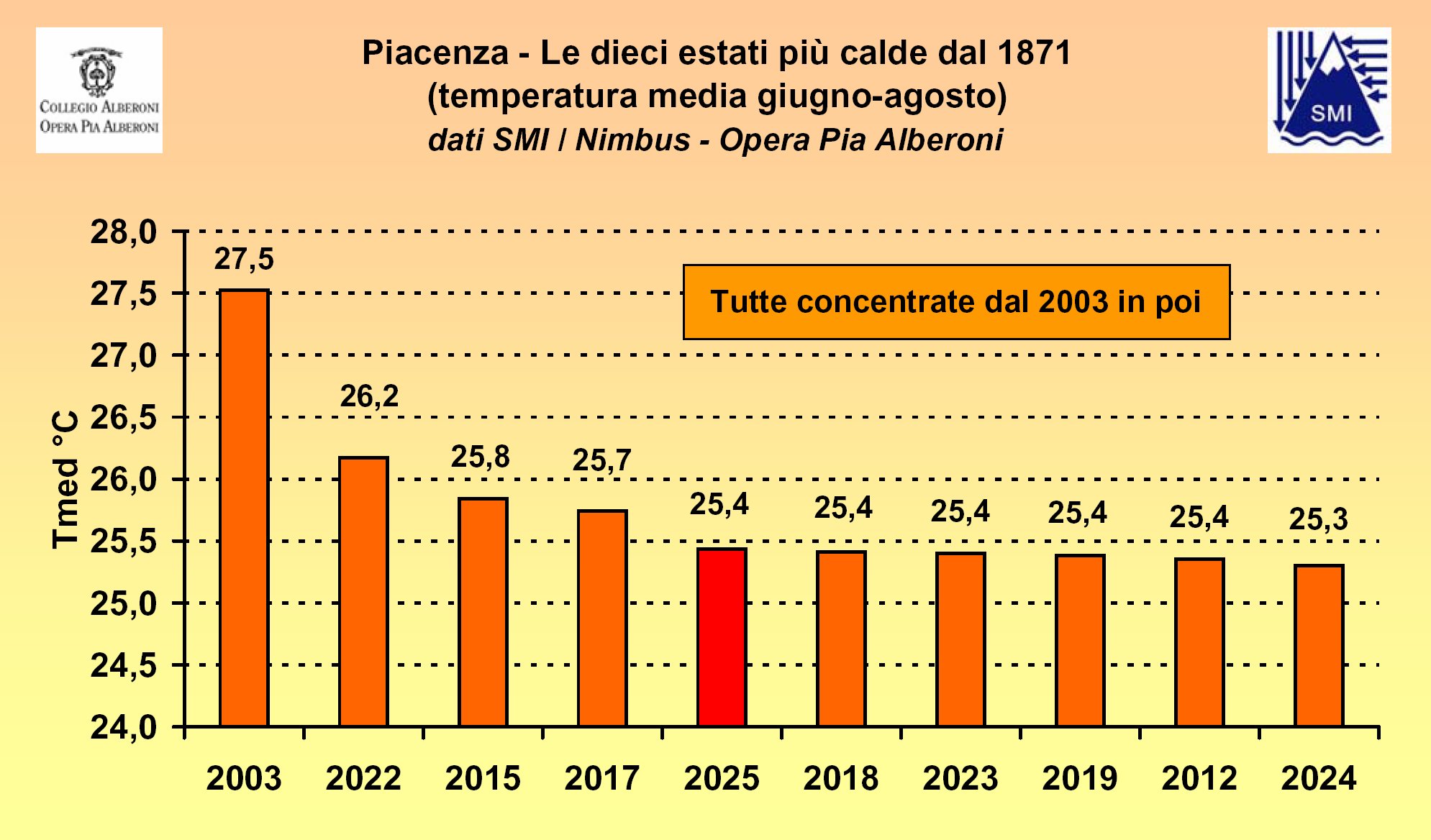
Classifiche delle dieci estati più calde nelle serie storiche di
Torino-centro (dati attuali della stazione Arpa Piemonte di via della
Consolata) e di Piacenza - Collegio Alberoni: in entrambi i casi
l'estate 2025 è al quinto posto, e tutti i casi in elenco sono
concentrati dal 2003 in poi. Inoltre, rispettivamente 6 e 7 su dieci
appartengono all'ultimo decennio.
Precipitazioni nel complesso normali, ma più copiose
sul Piemonte settentrionale e in deficit sulle Alpi occidentali
Secondo i
bollettini idrologici Arpa Piemonte sull'alto bacino del Po
chiuso alla confluenza con il Ticino (area comprendente dunque
Piemonte, Valle d'Aosta, Ticino svizzero e parte dell'entroterra delle
province di Savona e Genova) il trimestre ha raccolto 243 mm
d'acqua come media regionalizzata: un valore pressoché nella norma,
esito del bilanciamento tra un giugno anticiclonico e decisamente
secco su tutto il territorio, in cui era caduta metà della pioggia
consueta (52 mm), e un bimestre luglio-agosto più bagnato
(rispettivamente 78 e 113 mm nei due mesi).
Tuttavia questa estate dalle precipitazioni complessivamente normali a
scala regionale nasconde al suo interno non solo marcate differenze
tra ciascuno dei tre mesi, ma anche tra una zona e l'altra:
guardando alle diverse aree, scopriamo infatti che (a parte giugno) la
stagione è stata generosa d'acqua dal Verbano-Cusio-Ossola al Biellese,
Vercellese e Novarese (circa +9% rispetto alla media nel trimestre),
mentre è trascorsa decisamente più siccitosa del solito sul
Piemonte occidentale, dal Gran Paradiso al Monviso (ma anche fin
verso le Alpi Marittime), con un deficit di piovosità del 27%.
Ecco che a metà agosto, complice anche la lunga e intensa ondata di
calore che ha amplificato l'evaporazione, in quelle valli alpine
boschi e praterie ingiallivano paventando per gli allevatori una
demonticazione anzitempo dagli alpeggi, tra sorgenti in magra e
carenza d'erba per il bestiame nonostante l'iniziale buona
dotazione idrica lasciata in eredità dalla primavera.
La penuria d'acqua ha messo in difficoltà pure alcuni rifugi d'alta
quota come il Remondino e il Morelli in Valle Gesso (Cuneo).
Nel corso della stagione non sono mancati i
temporali violenti, come quelli associati a vento tempestoso (downburst)
della sera del 21 giugno in più località dal Lario, al Biellese, al
Cuneese, quello che il 30 giugno ha innescato una violenta colata
detritica lungo il T. Frejus a Bardonecchia (una vittima), e la
grandinata distruttiva del 29 agosto a Ivrea e dintorni, con chicchi
fino a 8 cm di diametro che hanno devastato tetti, pannelli
fotovoltaici, coltivazioni e vetture. Torino, città assai soggetta ai
nubifragi estivi, quest'anno è stata invece pressoché risparmiata da
eventi dannosi.
Sul versante ligure, è il caso di segnalare i nubifragi
che a ripetizione hanno accumulato ingenti quantità di pioggia, con
rapide piene torrentizie e allagamenti, ad esempio: il 12 luglio
nell'entroterra tra Genova e Savona (202 mm in poco meno di sei ore a
Campo Ligure) e, appena una settimana dopo, il 19 luglio a Savona e
dintorni (83 mm nel capoluogo, all'Istituto Nautico).

26 agosto 2025: segni della siccità estiva nei boschi
a monte di San Giorio di Susa (Torino). Nelle valli tra il Gran
Paradiso e il Monviso le precipitazioni del trimestre sono state sotto
media del 27%
(f. D. Cat Berro).

La grandine rovinosa, con diametro fino a 7-8 cm, caduta la sera del
29 agosto a Ivrea, Torino (f. Marco Franchino,
via
pagina FB Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte).
Ghiacciai di nuovo in sofferenza
nonostante l'abbondante neve di primavera
L'ennesima estate calda si è ripercossa negativamente
sulla conservazione della neve in alta quota: particolarmente
abbondante fino a inizio giugno, è stata poi rapidamente fusa
dalle ripetute ondate di calore (nonostante il temporaneo episodio
fresco di fine luglio), lasciando i ghiacciai di nuovo in gran
parte spogli di neve con evidenti perdite di massa, che verranno
valutate a breve nel quadro delle campagne annuali di monitoraggio
della Fondazione
Glaciologica Italiana cui collabora anche la SMI in particolare
con i rilievi al Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso).

Il
Ghiacciaio Basei (Gran Paradiso) il 31 luglio 2025, durante la fase
fresca che ha caratterizzato i giorni centrali dell'estate: circa due
terzi della superficie glaciale sono ancora coperti dalla neve
invernale, tuttavia la lunga e intensa ondata di caldo della seconda
metà di agosto determinerà una più estesa scomparsa del manto nevoso e
l'affioramento del ghiaccio sottostante
(f. D. Cat Berro).

Il
ghiacciaio del Teodulo (in basso) e il plateau glaciale del Colle del
Breithorn (in alto, a fil di cielo) ripresi il
19 agosto 2025 dalla
webcam Panomax di Plateau Rosa/Testa Grigia
(3480 m), a monte di Cervinia. Al termine della lunga ondata di calore
di metà mese si notano, in colore più scuro/grigiastro, le ampie
superfici di ghiaccio crepacciato e ormai privo di neve invernale,
nonostante la quota prossima a 3500 m.
Devolvi il 5 per mille alla SMI!
Sosterrai
le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,
e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|