|
L'avvicinamento e il transito della
depressione atlantica "Christian" ha determinato, tra domenica 3 e
martedì 5 ottobre 2021, una fase di tempo intensamente perturbato al
Nord Italia.
I fenomeni più rilevanti hanno investito i rilievi
appenninici a ridosso del Mar Ligure, con nubifragi autorigeneranti
di eccezionale violenza e persistenza lunedì 4 ottobre tra le
province di Savona, Genova e Alessandria, e conseguenti impetuose
piene torrentizie-fluviali e frane.

Una delle frane che lunedì 4 ottobre
2021 hanno interrotto la A26 Voltri-Gravellona Toce nel tratto
appenninico, qui tra Ovada e Masone
(autore sconosciuto, via
LiguriaOggi).
Già tra notte e mattino di domenica 3 ottobre intensi
rovesci e allagamenti avevano colpito il Ponente genovese, ma in
particolare il giorno 4 due imponenti sistemi temporaleschi
stazionari hanno infierito per diverse ore rispettivamente sui
rilievi dall'entroterra di Finale verso Nord-Est fino al lato
padano del Turchino in mattinata, e poi - dopo una relativa
attenuazione - ancora sull'asse Turchino-Stura di Ovada nel
pomeriggio, stavolta però con direzione di sviluppo Sud-Nord.
Ecco alcuni impressionanti dati di precipitazione
rilevati dalla rete di stazioni meteorologiche
ARPA Liguria
(info sulle statistiche delle massime precipitazioni in Italia a cura
del
CNR-IRPI di Torino, cortesia Fabio Luino):
* 178,2 mm in un'ora a Urbe-Vara Superiore (SV),
a un soffio dai 181 mm/1 h del 4 novembre 2011 a Vicomorasso (GE);
* 377,8 mm in 3 ore, sempre a Urbe;
* 496 mm in 6 ore a Montenotte Inferiore
(Cairo Montenotte, SV), nuovo primato italiano su questo
intervallo di tempo;
* 740,6 mm in 12 ore a Rossiglione (GE),
anche questo un nuovo primato nazionale su tale intervallo
(superati i 717,8 mm/12 h del 7-8 ottobre 1970 a Bolzaneto, sul
versante marittimo del Turchino alla periferia di Genova, episodio che
causò
devastazioni e almeno 35 vittime nel capoluogo);
* 883,8 mm in 24 ore sempre a Rossiglione,
non lontano dal record storico nazionale di 948,4 mm del 7-8 ottobre
1970 a Bolzaneto;
* 927,0 mm di totale evento a Rossiglione (3-5
ottobre).
Si tratta di quantità e intensità tra le più elevate
al mondo nelle zone extra-tropicali (si veda a tal proposito
l'interessante grafico pubblicato in
questo articolo di Arpa Liguria).
Tutte e tre le località ricadono nel territorio d'oltregiogo,
amministrativamente in Liguria ma facente parte del bacino idrografico
padano, a nord dello spartiacque, e tali rovesci hanno innescato
importanti piene e straripamenti lungo i due rami del Bormida
e degli affluenti destri Erro e Stura di Ovada/Orba.
Tuttavia anche il Letimbro, sul versante marittimo, ha causato
danni e interruzioni di viabilità fin verso la foce a Savona.
L'impatto sul territorio è stato gravoso, anche a carico del
violento ruscellamento di acque selvagge lungo i versanti, oltre
che per le esondazioni, frane e colate di fango, ma quanto meno
non si sono sofferte vittime, elemento per nulla scontato con
fenomeni di tale entità.
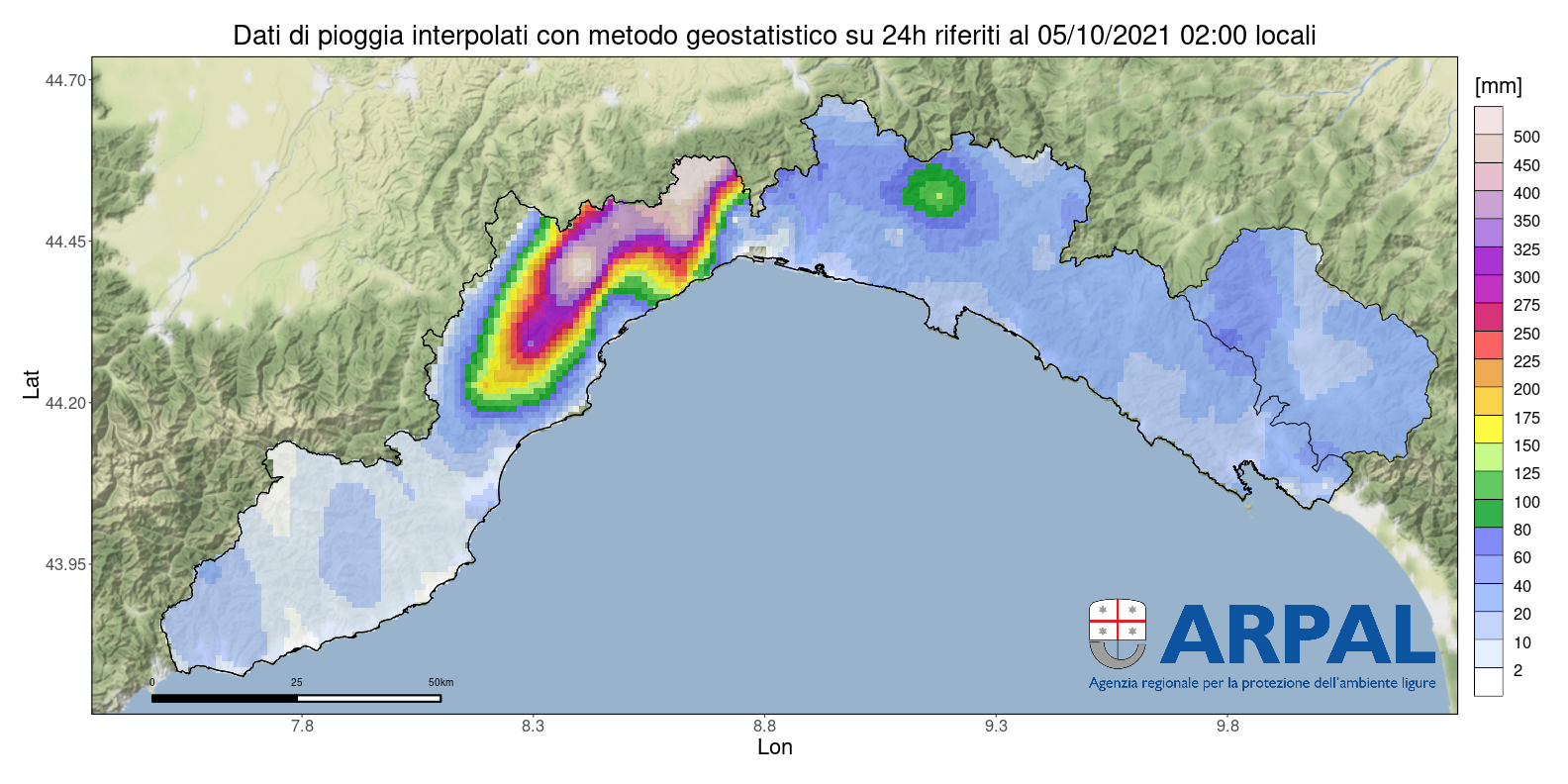
La carta delle isoiete realizzata
dall'ARPA
Liguria dà un'idea immediata delle aree più interessate dai
nubifragi di lunedì 4 ottobre 2021, nel settore tra il Colle di
Cadibona e il Passo del Turchino, con totali giornalieri estesamente
oltre 200 mm, fino ai quasi 900 mm di Rossiglione. Il resto della
regione ha ricevuto apporti per lo più inferiori a 60 mm, e parte
della Riviera di Ponente è rimasta pressoché all'asciutto.
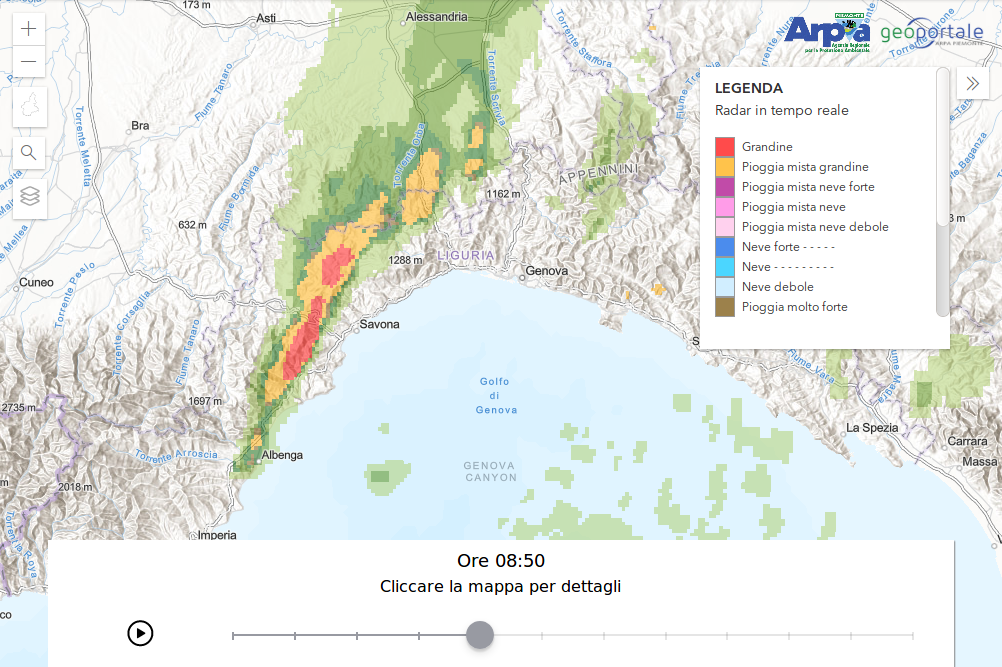
Scansione radar delle h 8:50 locali
del 4 ottobre (Torino-Bric della Croce e Monte Settepani, fonte ARPA
Piemonte - ARPA Liguria): in giallo-rosso è rappresentato il
pennacchio di violente precipitazioni (anche con probabile presenza di
grandine) associate al nubifragio autorigenerante che dall'entroterra
di Finale Ligure si estende verso Nord-Est fino alle valli
appenniniche a Nord del Monte Beigua e del Passo del Turchino.
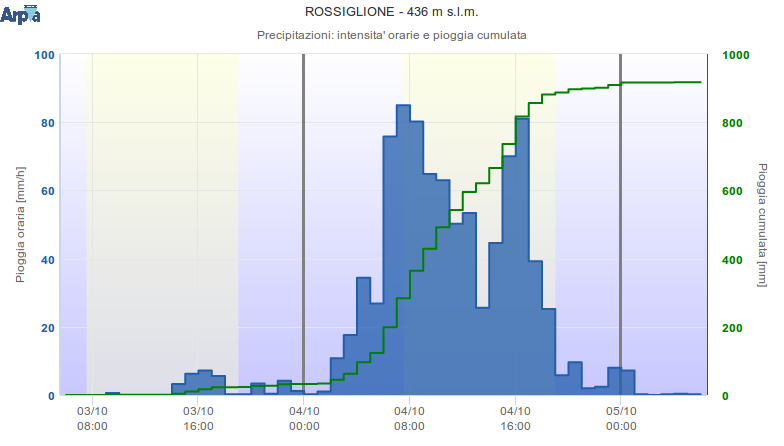
Precipitazioni orarie e cumulate del
3-5 ottobre 2021 a Rossiglione (GE). L'incredibile totale in 24 ore di
883,8 mm si è generato in due principali e violente fasi
temporalesche, al mattino e poi nel pomeriggio (grafico tratto da
ARPA Piemonte,
che condivide con
ARPA Liguria
il monitoraggio del territorio ligure d'oltregiogo, di pertinenza del
bacino padano).
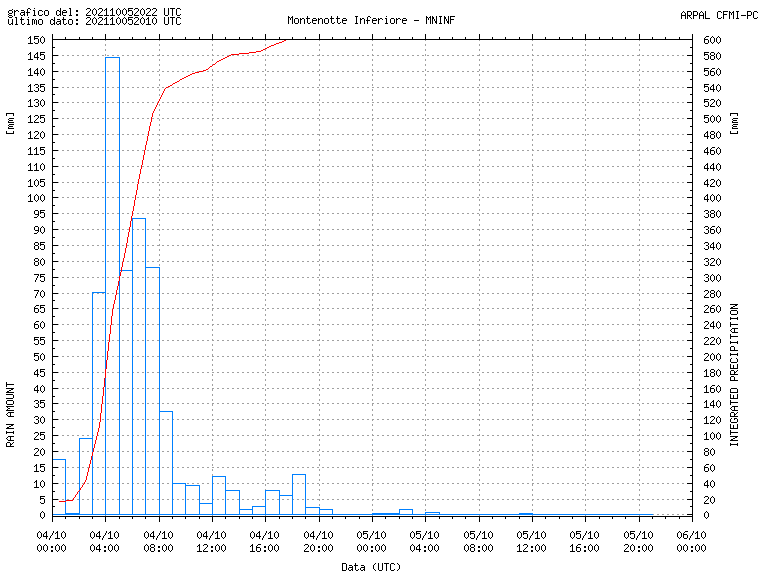
Precipitazioni orarie e cumulate del
4-5 ottobre 2021 a Montenotte Inferiore (SV). Qui gli apporti si sono
concentrati tra notte e mattino del 4, risultando nel nuovo record
italiano in 6 ore di 496 mm (fonte:
ARPAL).

4 ottobre 2021, il Bormida di Spigno
straripa nell'area urbana di Cairo Montenotte (SV), ricordando quanto
avvenuto solo due anni prima durante l'alluvione
del 23-24 novembre 2019.

Edificio investito da una
frana a Rossiglione, località centro di scroscio dell'evento e
penalizzata da gravi alluvionamenti e dissesti
(f. Claudio Angeleri, via
pagina FB Comune di Rossiglione).

La furiosa piena del Torrente
Gargassa a Rossiglione, superiore al già gravoso evento del 6-8
ottobre 1977 (frame da video di Roberto Boccone,
via
pagina FB Comune di Rossiglione).
PIEMONTE:
RECORD DI PIOGGIA IN 12 ORE
CONCENTRATI NEGLI ULTIMI TRE ANNI
Anche in territorio piemontese,
ARPA Piemonte
ha rilevato esorbitanti quantità totali (3-5 ottobre) di 363,0 mm a
Ovada e 555,0 mm a Ponzone-Bric Berton, ed è
impressionante notare come nel periodo 2019-2021 si siano concentrate
- in eventi accomunati da dinamiche meteorologiche molto simili -
le tre più intense piogge note in un periodo di 12 ore nella banca
dati meteo regionale, di lunghezza più che trentennale:
-
21 ottobre 2019: 428 mm/12 h a Gavi (AL)
-
2 ottobre 2020: 515 mm/12 h a Limone Piemonte - Pancani (CN)
- 4 ottobre 2021: 454 mm/12 h a Ponzone - Bric Berton (AL)
Riesce difficile pensare che si tratti solamente di
casualità data dalla normale variabilità climatica... mentre, mano
a mano che si accumulano fenomeni di tale portata, cresce l'evidenza
che vi sia anche un contributo da parte dei cambiamenti climatici
antropogenici, come peraltro ormai noto in molte zone del mondo,
Europa inclusa (leggi il
report del gruppo di ricerca World Weather Attribution sulle
alluvioni di luglio 2021 in Germania, Francia e Benelux).
A livello idrometrico, sempre grazie alle rilevazioni
ARPA Piemonte, segnaliamo che il colmo di piena del Bormida ad
Alessandria, pari a 9,41 m alle h 22 UTC del 4 ottobre,
ha superato seppure di soli 2 cm il già straordinario
evento del 24 novembre 2019, stabilendo dunque un nuovo
massimo nella serie dell'idrometro automatico attivo dal 2000, ma
ponendosi anche come una delle piene più gravose in un secolo dopo
quella del 7-8 ottobre 1977.
Interruzioni di viabilità, danni a strade e ponti,
inondazione di edifici ed evacuazioni di abitanti si sono
susseguiti in svariate località del bacino del Bormida, dal Cadibona,
a Cairo Montenotte, Pontinvrea, Sassello, Cartosio, Rossiglione, Ovada...
per citarne solo alcune, e giù fino alla foce in Tanaro ad
Alessandria.
L'evento appare ancora più stupefacente se si considera
che è sopraggiunto come prima intensa perturbazione autunnale dopo
quattro mesi di marcata siccità: dal 1° giugno al 30 settembre
2021 a Ovada (AL) erano caduti appena 48 mm di pioggia, meno di un
terzo del normale.
SITUAZIONE METEO CLASSICA,
MA PIOGGE ECCEZIONALI CHE AVREBBERO MANDATO
IN CRISI QUALUNQUE BACINO IDROGRAFICO
E ANCHE LA MONTAGNA PIU' CURATA
1) Per quanto nubifragi di questo genere all'inizio
dell'autunno siano frequenti alle spalle del Mar Ligure, inseriti
all'interno di vigorosi flussi di scirocco che precedono l'ingresso di
un fronte freddo atlantico, le quantità e intensità di
precipitazione rilevate il 4 ottobre 2021 sull'Appennino tra Piemonte
e Liguria sono estremamente rare.
2) E' possibile che il riscaldamento globale abbia
contribuito a incrementare la violenza dell'evento attraverso la
maggiore disponibilità di vapore acqueo ed energia nel mare e
nell'atmosfera, più caldi del consueto (anomalia termica delle
acque superficiali superiore a +3 °C tra Corsica, Liguria e
Golfo del Leone!).
3) Con tali quantità di pioggia (fino a 884 mm =
884 litri per metro quadrato, in 24 ore) qualunque territorio va in
crisi ed è soggetto a disastri (affermazioni del tipo "è
bastato un temporale" o "come è possibile, con due ore di
pioggia?"... non hanno alcun fondamento) indipendentemente dalle
caratteristiche e gestione del bacino idrografico (si veda il caso
dell'efficiente Germania, luglio 2021), fermo restando che gli
effetti dei nubifragi risultano aggravati proporzionalmente al livello
di antropizzazione, soprattutto se non rispettosa delle fasce di
pertinenza fluviale.
4) L'elevato grado di naturalità e forestazione e la
modesta densità abitativa delle zone colpite il 4 ottobre hanno
scongiurato perdite economiche e umane catastrofiche (per quanto
già gli effetti siano stati gravi per molti), quali si sarebbero
senz'altro verificate se gli stessi temporali avessero infierito poche
decine di chilometri più a Sud-Est, sull'area metropolitana di Genova
(città tra le più critiche del Mediterraneo per interferenza umana su
un territorio per natura soggetto a nubifragi) come peraltro avvenuto
nell'ottobre 1970, settembre 1993, novembre 2011, ottobre 2014...
4) Ci sono mille sacrosanti motivi - sociali,
economici, paesaggistici... - per cui il territorio montano debba
essere oggetto di attenzioni, curato, manutenuto, abitato (purché il
più possibile in equilibrio con gli ecosistemi naturali), ma è
illusorio pensare che il recupero delle aree marginali e abbandonate
dall'uomo nella seconda metà del Novecento possa scongiurare gravi
effetti alluvionali in situazioni come queste.
Affermazioni come "già, non ci sono più i muretti a secco"...
manifestano una certa ingenuità.
Più importanti sono l'adattamento delle infrastrutture soprattutto in
zona urbana, la ri-naturalizzazione dei corsi d'acqua e la tempestiva
previsione degli eventi.
5) Le previsioni meteorologiche sono preziose e
determinanti per identificare in tempo le aree maggiormente esposte al
rischio alluvionale, e le allerte - per quanto elaborate e
diramate da efficienti enti locali come le ARPA (leggi il
comunicato ARPAL del 3 ottobre 2021) - sono
necessariamente riferite a territori più ampi rispetto ai piccoli
bacini idrografici su cui spesso si concentrano nubifragi
autorigeneranti, per loro natura molto localizzati (larghezza del
"pennacchio" di pioggia violenta anche inferiore a 10 km) e
impossibili da prevedere con precisione chilometrica!
Altra affermazione da evitare è dunque: "c'era l'allerta
arancione/rossa ma da me ha fatto due gocce!"... mentre a pochi
chilometri di distanza si scatenava il finimondo. E' sempre importante
fare lo sforzo di valutare le situazioni al di là del proprio cortile.
GRAZIE A...
Fabio Luino (CNR
IRPI, Torino) e ai membri della gruppo facebook "Memoria
Storica del Processi Geo-Idrologici" per il costante scambio e
aggiornamento di informazioni in tempo reale.
Devolvi il 5 per mille alla SMI!
Sosterrai
le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,
e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|