|
Dopo un lungo periodo con prevalenza di
tempo anticiclonico, asciutto e caldo, a metà ottobre 2019 la
configurazione meteorologica cambia radicalmente sul Nord-Ovest
italiano: le depressioni atlantiche tornano a prevalere sull'Ovest
europeo pilotando intensi flussi d'aria umida marittima (libeccio,
scirocco) verso le Alpi e l'Appennino settentrionale, responsabili
delle prime diffuse (e dannose) piogge autunnali.

Capriata d'Orba (AL):
ponte della SS155 abbattuto la sera del 21 ottobre 2019 dalla piena
del T. Albedosa, tributario destro dell'Orba (f. La Repubblica).
Una rapida ma vigorosa perturbazione transita già martedì 15
ottobre 2019 con effetti più appariscenti sul versante ligure,
dove
temporali autorigeneranti scaricano fino a 481 mm in gran parte
in una dozzina d'ore a Mele (GE), presso il Passo del Turchino (fonte:
ARPA Liguria),
con grande piena dei torrenti Leira e Cerusa, allagamenti a Voltri e
Sestri Ponente, e disagi sulle linee ferroviarie.
Alle schiarite anche
ampie del 16-17 ottobre segue una più prolungata sequenza di
perturbazioni, nel quadro di una situazione di blocco con
continua risalita di venti umidi meridionali tra le depressioni a
Ovest e un anticiclone a Est, sui Balcani. Si tratta di una classica
configurazione responsabile di eventi alluvionali al Nord Italia.
Dal 18 al 20 ottobre
violenti rovesci temporaleschi battono a più riprese l'entroterra
tra Savona e Genova (nel pomeriggio del 19 anche l'Imperiese),
attivando dissesti e piene dei corsi d'acqua non solo sul lato
marittimo (evacuazione di 15 abitanti per una frana a Pigna, Val
Nervia, IM), ma anche su quello padano, con un'importante piena del
Bormida e problemi alla viabilità nel pomeriggio-sera del 20
ottobre a seguito di scrosci torrenziali intorno al Colle del
Melogno (243 mm in 24 ore sul Monte Settepani, fonte:
ARPA Piemonte).
Il tempo perturbato
prosegue lunedì 21 ottobre 2019 sotto un intenso flusso da
Sud-SudOvest che produce i rovesci più intensi tra la Liguria centrale
e le alte valli del corrispettivo versante padano.
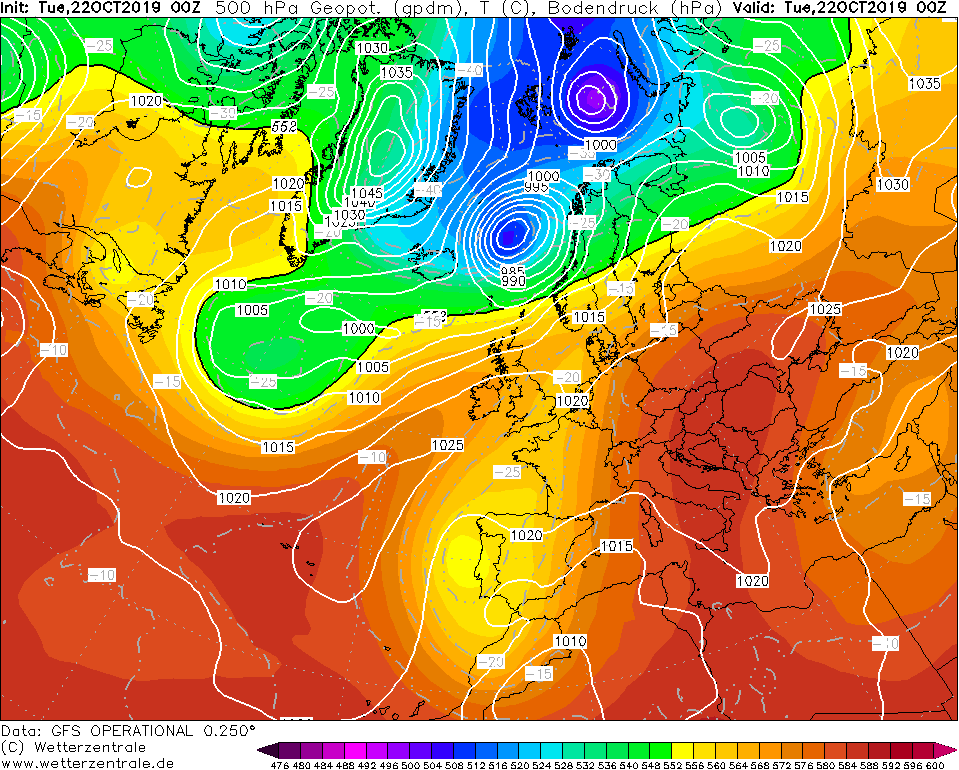
Carta dell'altezza di
geopotenziale a 500 hPa (colore) e delle isobare al suolo (linee
bianche) alle h 00 UTC del 22 ottobre 2019, orario corrispondente alle
fasi finali dell'evento a Gavi e dintorni. Si nota in
particolare la depressione in quota sulla penisola iberica (giallo)
che - sul suo fianco orientale - pilota intense correnti caldo-umide
meridionali verso il Nord-Ovest italiano
(reanalisi GFS, via
wetterzentrale).
In particolare, nuclei
temporaleschi autorigeneranti di rara violenza colpiscono tra
pomeriggio e sera del 21, insistendo per 8-12 ore, gli alti bacini dei
torrenti Scrivia e Orba (e in particolare del Lemme e
del Piota, tributari destri dell'Orba), attivando impetuose piene,
straripamenti e frane sui versanti, con sconvolgimento di centri
abitati e della viabilità stradale e ferroviaria, e una vittima
(un tassista travolto con la sua auto di servizio a Capriata d'Orba).
Come già osservato in altre occasioni
(ad esempio le
alluvioni di metà ottobre 2014 tra Genovesato e Alessandrino),
nell'innesco e nel mantenimento per diverse ore di tali celle
temporalesche gioca un ruolo primario la convergenza tra i
forti venti di scirocco da Sud-Est e correnti settentrionali
traboccanti dal bacino padano verso il Mar Ligure.
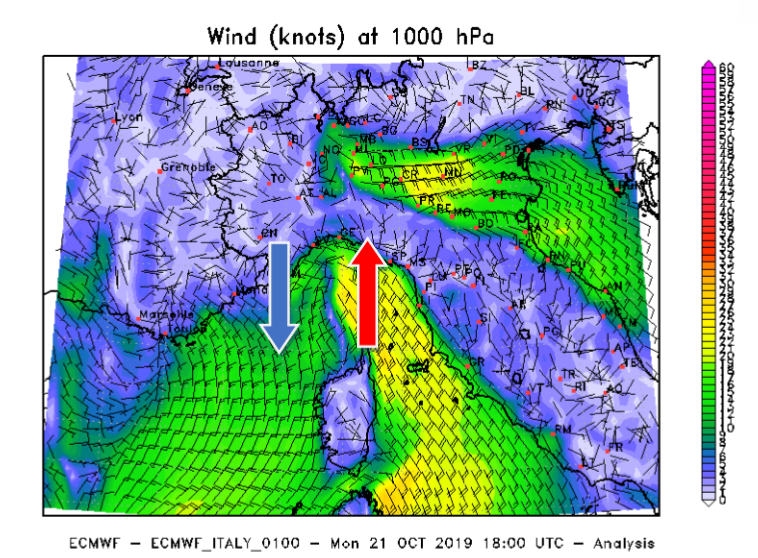
Carta con i vettori di velocità (scala a colori) e direzione del vento
a 1000 hPa, ovvero praticamente al livello del mare, alle h 18 UTC del
21 ottobre 2019: di fronte alle coste genovesi si realizza la
convergenza tra lo scirocco caldo-umido in risalita dal Tirreno e
correnti settentrionali, elemento che favorisce l'innesco di intensi
moti verticali dell'aria e la genesi di celle temporalesche
autorigeneranti che dalla Liguria si protendono per diverse ore sul
versante alessandrino dell'Appennino (dal
rapporto d'evento di ARPA Piemonte).
Centro di
scroscio dell'evento è il paese di Gavi (AL), che in 12 ore
riceve ben 428 mm di pioggia, un primato di intensità per
l'intera
rete di stazioni meteorologiche in telemisura del Piemonte (oggi
gestita da ARPA),
attive in molti casi dalla fine degli Anni Ottanta (si veda tuttavia,
più avanti, il confronto con l'episodio del 13 agosto 1935).
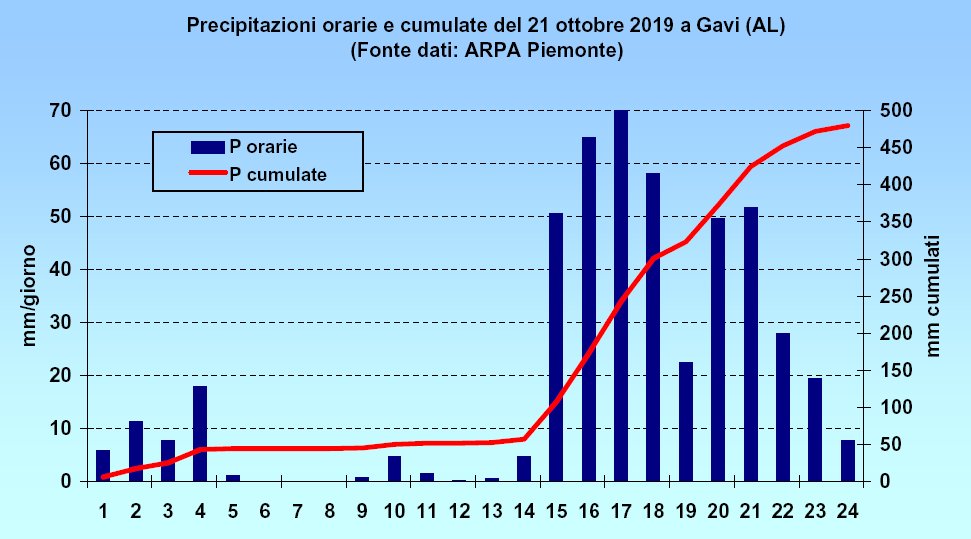
Precipitazioni orarie
e cumulate del 21 ottobre 2019 a Gavi (AL): il nubifragio,
di estrema violenza, si accanisce tra pomeriggio e sera scaricando
fino a 70 mm d'acqua in un'ora, 193 mm in 3 ore, 317 mm in 6 ore e 428
mm in 12 ore.
In 12 ore è l'intensità più elevata nella banca dati delle stazioni
automatiche installate in Piemonte a partire dal 1988 (precisiamo
tuttavia che la stazione ARPA Piemonte di Gavi è attiva dal 2001).
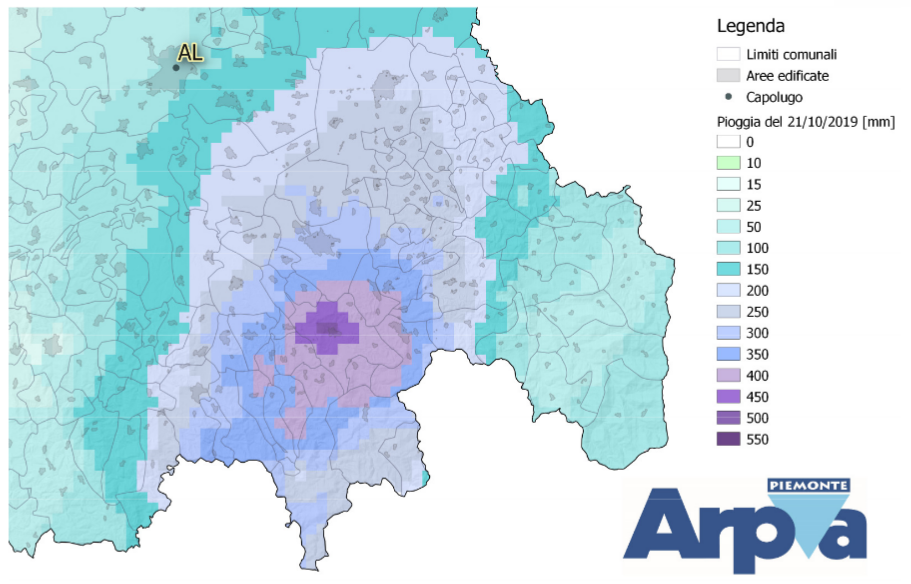
Carta delle
precipitazioni (isoiete) del 21 ottobre 2019 nell'Alessandrino: si
nota il nucleo di particolare intensità (oltre 400 mm) su Gavi e
dintorni
(dal
rapporto d'evento di ARPA Piemonte).
.
Anche nell'intera sequenza di giorni dal 18 al 22 ottobre 2019 Gavi
mantiene il primato di quantità, con totale di 571 mm d'acqua,
seguito da:
Rossiglione (GE)
551 mm
Lago di Lavagnina (AL) 517 mm
Arquata Scrivia (AL)
472 mm
Bosio-Bric Castellaro (AL) 439 mm
Piampaludo (SV)
426 mm
L'evento, descritto anche in un
rapporto preliminare di ARPA Piemonte, colpisce con modalità
analoghe, ma con intensità ancora superiore, le stesse zone già
funestate dal nubifragio del
13 ottobre 2014, spingendosi in
entrambi i casi verso Nord fin sulle colline del Tortonese.
Lungo il corso dell'Orba si
propaga una piena straordinaria, con deflusso massimo al colmo
valutato in 2700-2800 m3/s a Casal Cermelli, che a sua
volta alimenta l'ingrossamento del Bormida fino a 3000 m3/s
ad Alessandria, valori più elevati nelle rispettive serie dal 2003 e
dal 2000 (idrometri automatici con misure di livello e relative scale
delle portate), con diffusi straripamenti e inondazioni.


Due immagini del
ponte sul Rio Arbaro a Castelletto d'Orba, a seguito dell'imponente
piena del 21 ottobre 2019 (in alto) e durante l'analogo episodio del 13 ottobre
2014 (qui sopra): in entrambi i casi il ponte ha rappresentato un ostacolo al
deflusso, favorendo l'accumulo di detriti (tronchi e vetture) che
hanno amplificato la gravità dell'esondazione nel centro abitato.
EVENTO ROVINOSO, MA ANDO' ANCORA PEGGIO NEL 1977 E NEL 1935
Per quanto dannoso, complessivamente
l'evento del 2019 lascia insuperato, per gravità degli effetti e
numero di vittime (15 tra basso Piemonte e Liguria), l'episodio del
7 ottobre 1977, tra i più gravosi in un secolo e mezzo nel bacino
dell'Orba.
L'alluvione del 1977 fu scatenata da piogge in 24 ore fino a 396 mm a
Ortiglieto (all'epoca la rete pluviometrica dell'Ufficio
Idrografico del Po, seppur fitta, era meno capillare di quella odierna
dell'ARPA, la stazione di Gavi in quell'anno non era operativa, e
valori di precipitazione superiori potrebbero essere stati raggiunti
localmente).

Colamenti
superficiali di fango (soil slip) sotto il forte di Gavi a seguito dei
violenti rovesci del 21 ottobre 2019: i fenomeni si sono riproposti in
numero e distribuzione analoga nelle stesse zone già interessate il 7
ottobre 1977, sebbene con distruzioni stavolta più contenute
nell'abitato, e senza vittime
(foto scattata il 22 ottobre 2019 da Matteo Gastaldo, uno dei tre
vigili del fuoco rimasti uccisi pochi giorni dopo, il 5 novembre,
nell'esplosione
di un edificio incendiato a Quargnento, Alessandria).

Vigneto travolto da
un soil slip a Gavi il 21 ottobre 2019 (da pagina FB
Gavi972).
Merita citazione anche la catastrofica alluvione dell'Orba del 13
agosto 1935, cui contribuì in gran parte il
crollo della diga di
Molare durante uno storico nubifragio da 554 mm in 8 ore
alla centrale idroelettrica di Lavagnina. Si trattò della più violenta
pioggia mai registrata in Piemonte comprendendo anche le serie
pluviometriche storiche antecedenti l'introduzione delle recenti
stazioni automatiche, e probabilmente la sola, tra quelle note, ad
aver superato l'episodio del 21 ottobre 2019 a Gavi.
Le vittime del disastro, accuratamente ricostruito e descritto
nel libro
"Storia della diga di Molare", furono 111, di cui 97 nel
solo comune di Ovada.
ALTRE PIOGGE STRAORDINARIE NEL NOVEMBRE 2019:
OLTRE 1000 MM IN POCO PIU' DI UN MESE,
UN RECORD DA OLTRE UN SECOLO
Tempo frequentemente piovoso ha
caratterizzato anche il
successivo mese di novembre 2019, in cui hanno spiccato in
particolare le piogge intense del giorno 19 e del 22-24 (nuova
alluvione nel bacino del Bormida).
Gli episodi piovosi dell'autunno 2019
sull'Appennino al confine tra Alessandrino, Savonese e Genovesato
assumono caratteristiche record a scala secolare soprattutto su un
lungo intervallo di giorni.
Infatti, analizzando tutte le
possibili sequenze di 40 giorni consecutivi nelle serie
pluviometriche di Gavi, Lago Lavagnina e Piampaludo (tutte con inizio
nel 1914, anche se purtroppo con varie lacune), i totali del
periodo 15 ottobre - 23 novembre 2019 sono i più elevati, superando
anche i casi degli autunni 1926 e 1951, pure responsabili di gravi
alluvioni nel bacino del Po.
Ecco in tabella le prime 4 posizioni con le quantità cumulate e il
giorno di fine sequenza.
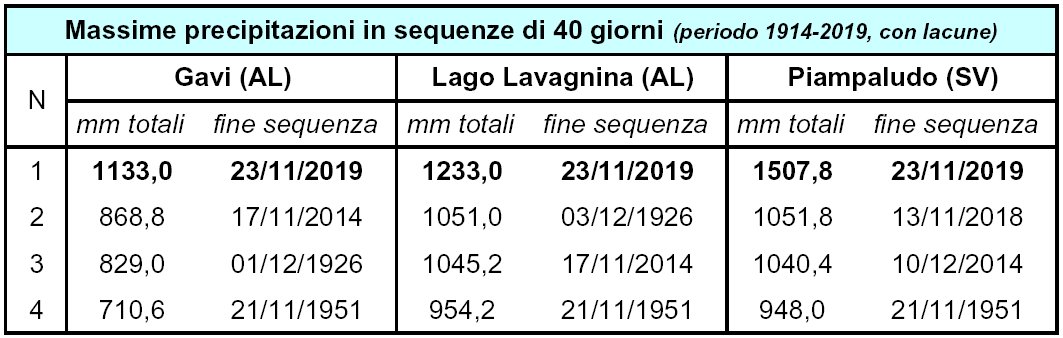
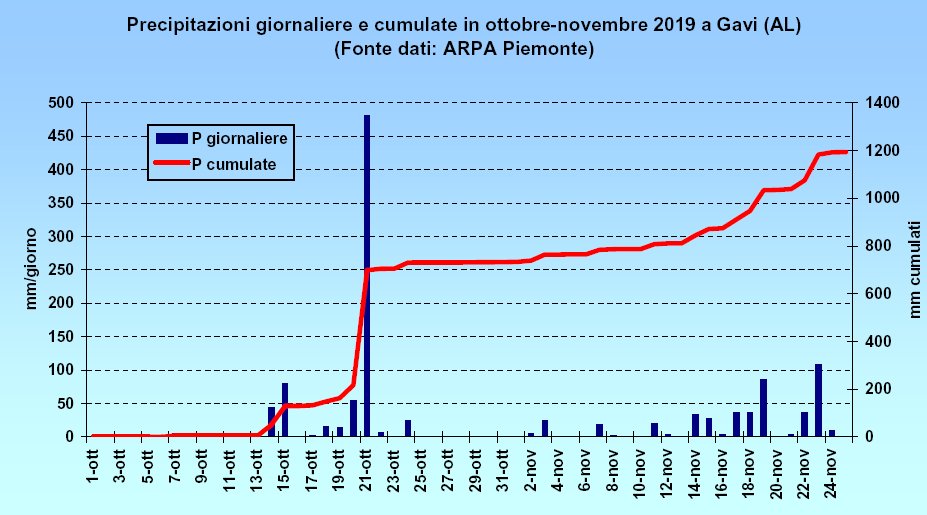
Precipitazioni
giornaliere e cumulate a Gavi (AL) dal 1° ottobre al 25 novembre 2019:
spicca il valore eccezionale di 481,4 mm del 21 ottobre, ma
straordinario è pure il totale di 1187 mm registrato in poco più di un
mese (tra il 14 ottobre e il 24 novembre, 26 giorni con almeno 1 mm di
precipitazione su 42).
Devolvi il 5 per mille alla SMI!
Sosterrai
le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,
e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|