|
A metà aprile 2025 l'Italia è stata interessata da un intenso
episodio sciroccale - legato all'approfondirsi della depressione "Hans"
sul Golfo Ligure - che tra la sera di martedì 15 e giovedì 17 ha
prodotto le precipitazioni più copiose al Nord-Ovest e in particolare
a ridosso dei rilievi dal Torinese all'Ossola, dove hanno
assunto carattere eccezionale soprattutto per il mese di aprile,
determinando notevoli piene fluviali, inondazioni e dissesti.

17 aprile 2025: estese inondazioni
dovute allo straripamento del fiume Sesia alla periferia Sud di
Vercelli. Sullo sfondo sono visibili l'autostrada A26
Voltri-Gravellona Toce, e parte della città (ripresa da drone,
cortesia
Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia).
Imponenti quantità d'acqua, fin oltre 400-500 mm sui rilievi tra
alto Canavese, bassa Valle d’Aosta e Biellese-Sesia-Ossola (talora
da record su intervalli di 1-2 giorni) hanno determinato gravosi
effetti sul territorio, con grandi piene dei corsi d'acqua -
soprattutto del Po e suoi affluenti in sinistra da Torino al Casalese
(Dora Riparia, Stura di Lanzo, Malone, Orco, Dora Baltea, Cervo-Sesia),
ma in parte anche del Belbo e dei due rami del Bormida; diffusi
straripamenti e inondazioni, frane e colate detritiche su viabilità e
abitati di collina e montagna, delineando un evento di alluvioni e
dissesti tra i più notevoli per entità ed estensione in queste zone
nel periodo successivo alla storica alluvione dell'ottobre 2000.
A valle dell'Alessandrino e del Pavese la piena del Po, pur
laminandosi grazie ai minori contributi degli affluenti nel basso
corso del fiume, ha mantenuto pur sempre caratteri di tutto rispetto,
inondando le zone golenali nei giorni intorno alla Pasqua.
Il pericolo di grandi piene fluviali e dissesti era
stato correttamente segnalato 24-48 ore prima dai centri
funzionali di
Piemonte e
Valle d'Aosta tramite un'allerta arancione su gran parte
del territorio,
evoluta a rossa per fenomeni idrogeologici per il giorno 17
aprile nei settori montani piemontesi dalla Val Sangone alla Val
Sesia (consulta la
piattaforma Meteo3R di allertamento comune per le regioni Valle
d'Aosta, Piemonte e Liguria).
Analisi meteorologica: sbarramento orografico da scirocco,
intensificato dalla depressione "Hans" sul Golfo Ligure
L'intenso
episodio perturbato
che ha raggiunto il suo apice al Nord-Ovest italiano tra il 16 e il 17
aprile 2025 ha avuto una fase preparatoria nei giorni
precedenti, dapprima con una matrice prevalentemente atlantica e
fenomeni modesti, in seguito con una componente mediterranea che ha
acuito l’apporto di aria umida verso il Sud delle Alpi con
l’attivazione di fenomeni molto intensi.
Dopo una parentesi anticiclonica che il 10-11 aprile 2025 aveva
portato tempo in gran parte soleggiate e temperature in aumento fin
oltre 20 °C in Valpadana, una struttura depressionaria si estende
gradualmente a tutto l'Ovest europeo indirizzando anche verso le
regioni nord-occidentali italiane un flusso di aria più umida da
Sud-Ovest. I primi annuvolamenti irregolari interessano la giornata di
sabato 12 aprile con alcuni piovaschi in transito. Anche
domenica 13 aprile la nuvolosità è estesa, ma le precipitazioni
si presentano ancora discontinue, e concentrate per lo più sul Nord
del Piemonte.
Solo da lunedì 14 aprile prende il via l’estensione delle
piogge, con l’inizio della fase mediterranea dell’evento
perturbato. Con l’ampliarsi del sistema depressionario e
l’approfondimento della saccatura dall’Islanda al Mediterraneo
occidentale comincia infatti ad accentuarsi il richiamo umido
meridionale verso il Sud delle Alpi, e un primo sistema frontale si
sviluppa dal Nord dell’Algeria alle Alpi occidentali, preceduto da una
risalita di polvere sahariana che invade gradualmente i cieli
soprattutto del Centro-Sud Italia, in associazione a una massa d’aria
caldo-umida. Questo primo passaggio frontale è seguito da alcune
schiarite martedì 15 aprile, ma l’intervallo è poco duraturo.
La discesa della massa d’aria fredda in seno alla saccatura protesa
dal Nord Atlantico al Mediterraneo occidentale continua infatti ad
alimentare l’avvezione umida verso le regioni alpine con correnti in
quota dapprima da Sud, poi da Sud-Est, e nel contempo contribuisce ad
alimentare il calo della pressione atmosferica in superficie tra le
Baleari, la Sardegna e il Mar Ligure.
Da questa ciclogenesi secondaria si formerà il minimo di pressione
denominato “Hans” dal servizio meteorologico nazionale italiano
nell'ambito del nuovo
sistema di nomenclatura delle burrasche Eumetnet (lista di nomi
afferenti ai Paesi del Central Mediterranean Group), vortice
responsabile della fase più acuta delle precipitazioni.
Nel corso di 24 ore, tra mercoledì 16 e giovedì 17 aprile,
la pressione al suolo tra le coste della Liguria di Ponente e la Costa
Azzurra scende da 1008-1010 hPa a 991 hPa, con una ciclogenesi
quasi “esplosiva” che attiverà forti venti orientali dall’alto
Adriatico verso il Piemonte occidentale. Il profondo minimo di
pressione del ciclone “Hans” si posiziona tra la Costa Azzurra, il
Mar Ligure e la Corsica nelle prime ore di giovedì 17 determinando
piogge molto intense sui settori più esposti allo sbarramento
orografico (stau) da Est e da Sud-Est alle quote medio-basse.
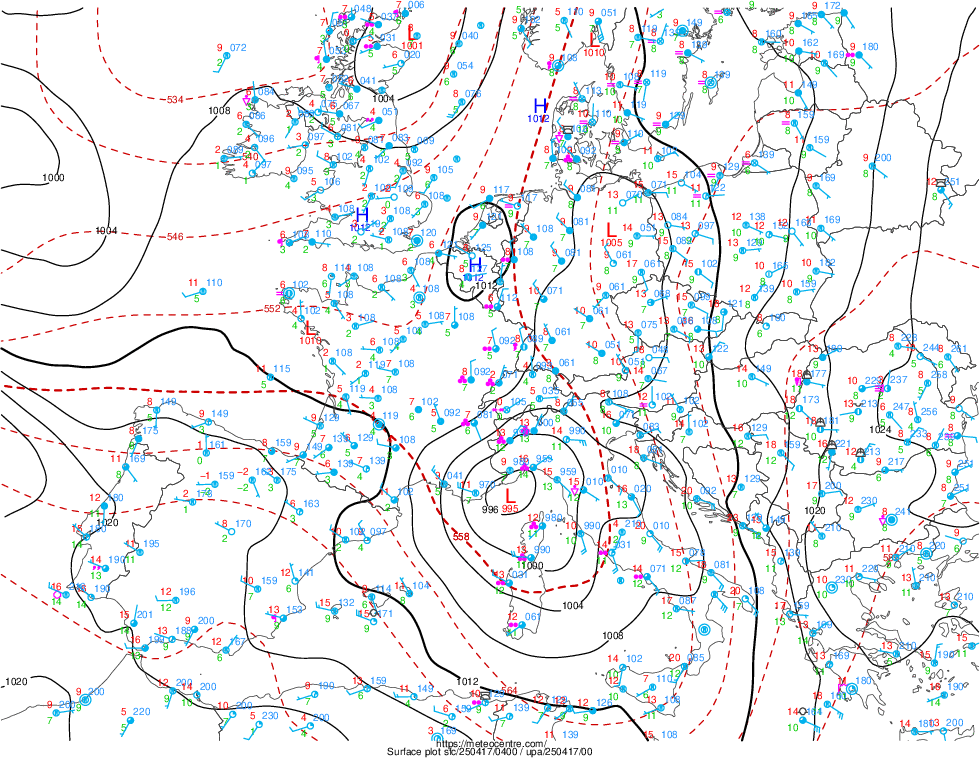
Carta di analisi della pressione
atmosferica (linee isobare nere) e del tempo osservato in superficie,
e altezza del geopotenziale al livello di 500 hPa (tratteggi rossi),
ore 04 UTC del 17 aprile 2025 (le 6 locali in Italia). Si nota la
marcata saccatura in quota e, in superficie, la vigorosa depressione "Hans"
localizzata sul mare di fronte alla Costa Azzurra e alla Riviera
ligure di Ponente (fonte:
MétéoCentre).
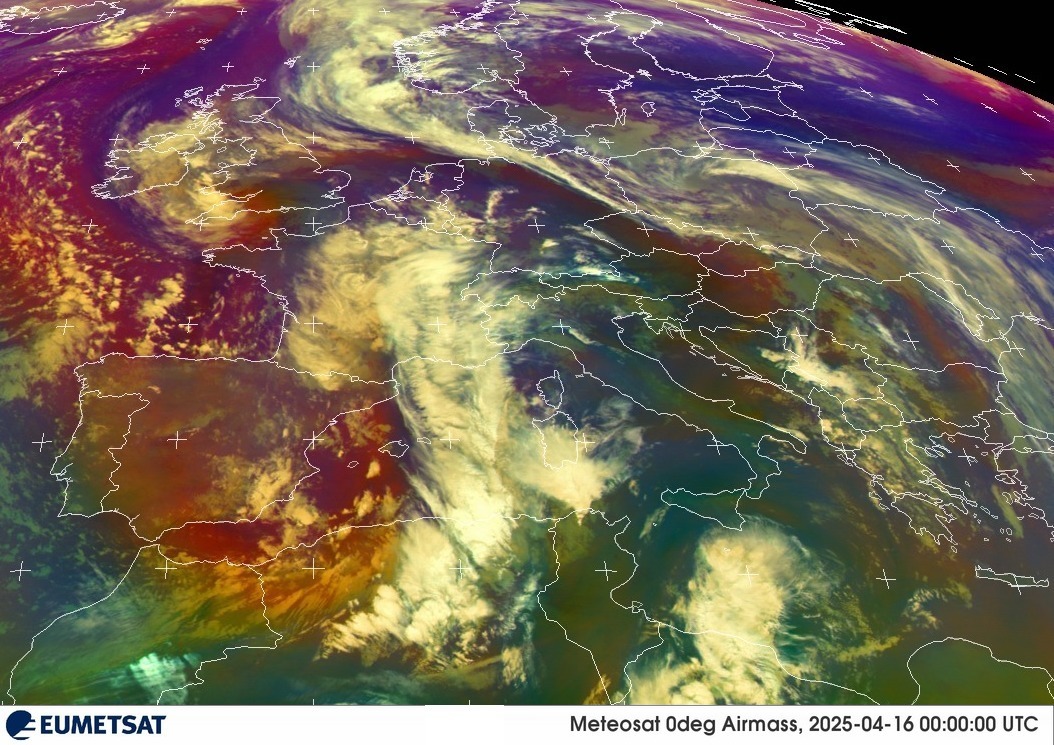
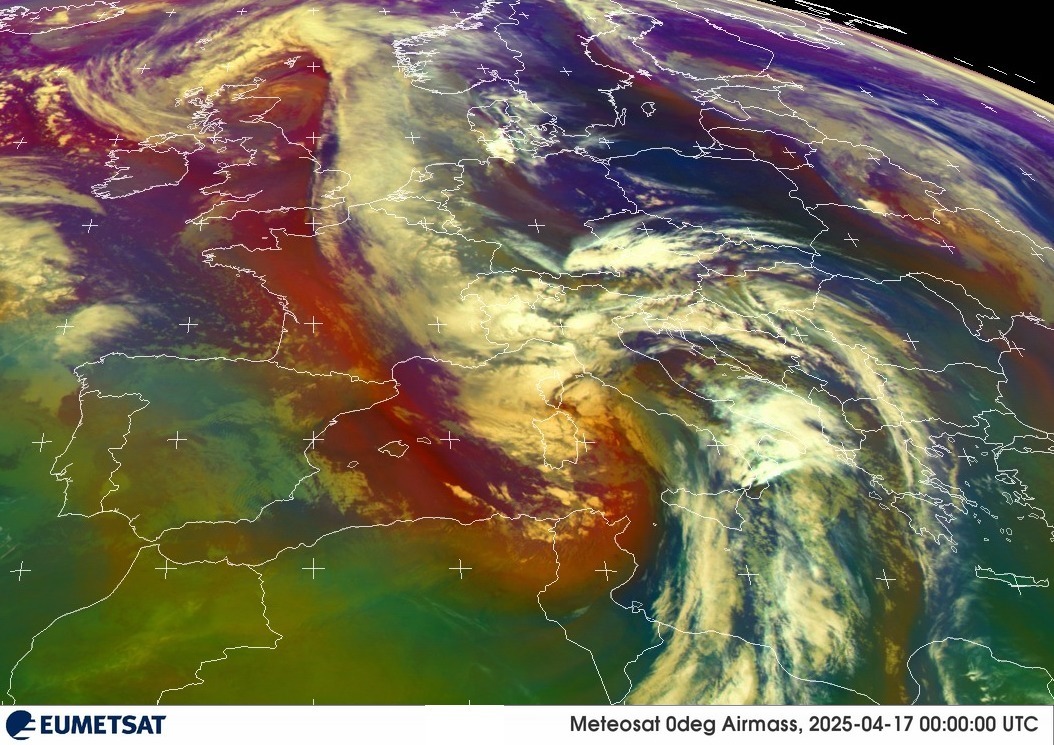
Nell'immagine satellitare MSG
(canale Airmass) delle h 00 UTC del 16 aprile 2025, nella fase
iniziale dell'evento perturbato, si notano i corpi nuvolosi estendersi
dall'Algeria alle Alpi occidentali, sospinti da un flusso di venti da
Sud-Sud-Est. Ventiquattro ore più tardi la depressione "Hans" è in
formazione intorno al Golfo Ligure, le masse nuvolose tendono a
spiraleggiare intorno al suo minimo di pressione, e i venti a
orientarsi da Est-Sud-Est in bassa troposfera, intensificando le
precipitazioni da sbarramento orografico a ridosso dei rilievi tra
Torinese, bassa Valle d'Aosta e Biellese-Sesia (fonte:
Eumetsat).
I nuclei di precipitazioni più intensi interessano
dapprima (16 aprile) i settori più esposti allo sbarramento da Sud e
Sud-Est quindi tutta la fascia alpina e pedemontana dalle Valli di
Lanzo al Verbano, compresi i settori sudalpini svizzeri dal Vallese al
Ticino occidentale, con limite delle nevicate che - per effetto delle
correnti miti - risale oltre i 2000-2200 m (talora 2500 m nella notte
tra il 15 e il 16 aprile).
La formazione di "Hans" accentua poi lo sbarramento delle correnti
in rotazione da Est, con precipitazioni in intensificazione anche
a ridosso dei rilievi più meridionali del Torinese, dal Pinerolese
alla Val Susa; il "retour d'Est" investe con forti precipitazioni
anche le alte vallate francesi e, di nuovo, il Vallese. Oltralpe
l'avvicinamento di un fronte freddo poco strutturato porta un
calo delle temperature in quota, che interessa solo marginalmente i
settori italiani di confine, mentre sul versante italiano prevale
ancora l'afflusso di correnti decisamente miti dal Mediterraneo.
Tuttavia, l'intensità delle precipitazioni è tale da provocare
all'interno delle vallate un deciso raffreddamento tra notte e mattino
del 17 aprile con la formazione di uno strato omotermo spesso
almeno 1000 m (talora fino a 1300-1500 m) al di sotto dello zero
termico: il limite delle nevicate scende a 800-1000 m nelle valli del
Torinese, ma perfino a 500 m in Valle d'Aosta e, oltralpe, tra
Maurienne e Savoia e nel Vallese, delineando un "effetto-valle" da
manuale di meteorologia... (leggi
l'analisi di MeteoSvizzera sul limite delle nevicate di questo
evento). Laddove le precipitazioni si sono presentate meno intense,
per esempio nelle valli del Monviso, il limite pioggia-neve è rimasto
decisamente più elevato, oltre i 1500-1800 m.
L'imponente avvezione di aria umida verso il Nord-Ovest italiano è
evidente dalle carte dell'acqua precipitabile dell'intera
colonna atmosferica, ovvero della quantità di pioggia che si
produrrebbe idealmente se tutto il vapor d'acqua presente condensasse
e precipitasse istantaneamente. Il 16 aprile - quando la vasta e
profonda saccatura raggiunge la sua massima estensione spingendosi dal
Nord Atlantico fino al Nord Africa, e il flusso di Scirocco sul suo
fianco orientale tocca la massima intensità - masse d'aria molto
umida risalgono il Mediterraneo fino alle Alpi. Lungo una fascia
stretta e lunga che si estende
per circa 800 km dalle coste della Tunisia fino al Nord della Sardegna
il contenuto di acqua precipitabile della colonna atmosferica
raggiunge i 30-35 mm, valori non estremi, tuttavia notevoli, in
una configurazione simile a quella di un
atmospheric river di breve
durata. Le masse d'aria estremamente umida confluiscono poi nel minimo
"Hans" e vengono convogliate
con correnti tra Est e Sud-Est dal Mar Ligure e dalla Pianura Padana
verso le regioni nord-occidentali italiane.
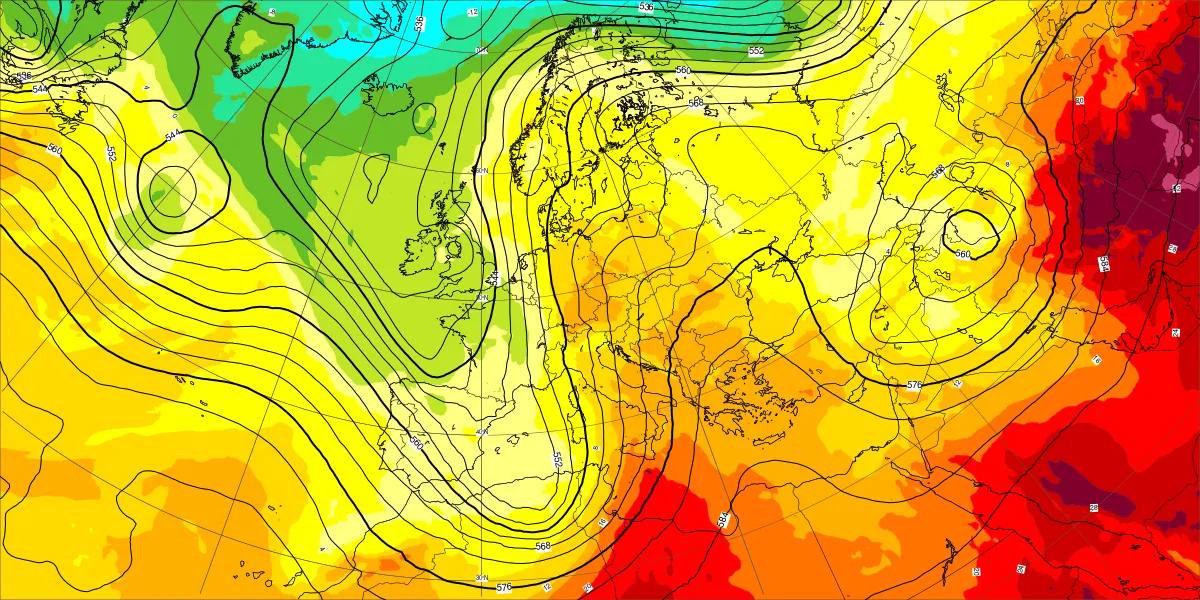
Altezza di geopotenziale (linee
continue) al livello isobarico di 500 hPa e temperatura (ombreggiatura
colorata) al livello isobarico di 850 hPa alle ore 12 UTC del 16
aprile 2025, modello ECMWF-IFS (run h 12 UTC del 16 aprile). Tra la
profonda saccatura che si estende in quota dal Nord Atlantico fin
sulle coste del Nord Africa e un promontorio di alta pressione più a
Est, si instaura un marcato gradiente di pressione con forti correnti
meridionali (tra S e SE) che trasportano aria mite e molto umida lungo
tutto il Tirreno fino al Nord-Ovest italiano.
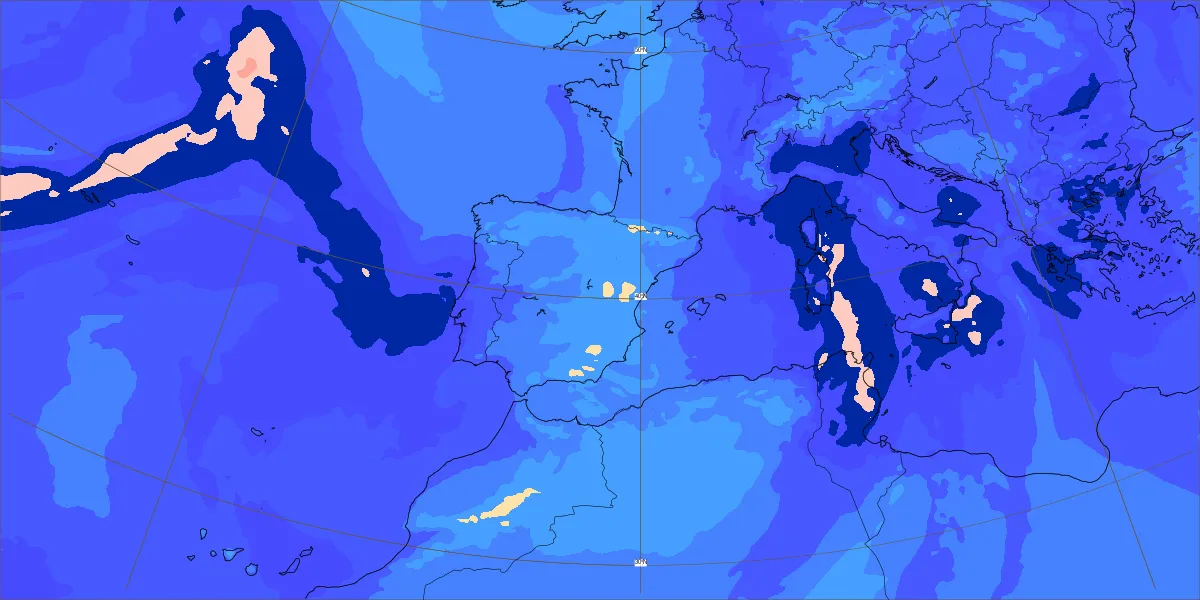
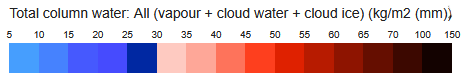
Carta del contenuto di acqua
precipitabile in tutta la colonna atmosferica alle ore 12 UTC del 16
aprile 2025 (modello ECMWF-IFS, run h 12 UTC dello stesso giorno).
La massiccia avvezione di aria molto umida in risalita lungo il
Tirreno, richiamata dalla profonda saccatura che dal Nord Atlantico si
spinge fin sul Nord Africa, è evidente da questo parametro che esprime
la quantità di pioggia che si otterrebbe se il contenuto totale di
vapor d'acqua dell'intera colonna atmosferica condensasse e
precipitasse istantaneamente. E' presente una fascia stretta e lunga
che si estende per circa 800 km dalle coste della Tunisia al Nord
della Sardegna con valori di acqua precipitabile di 30-35 mm (nuclei
di colore rosa nella carta), notevoli anche se non estremi, che per
entità e configurazione possono ricordare un atmospheric river, anche
se di breve durata.
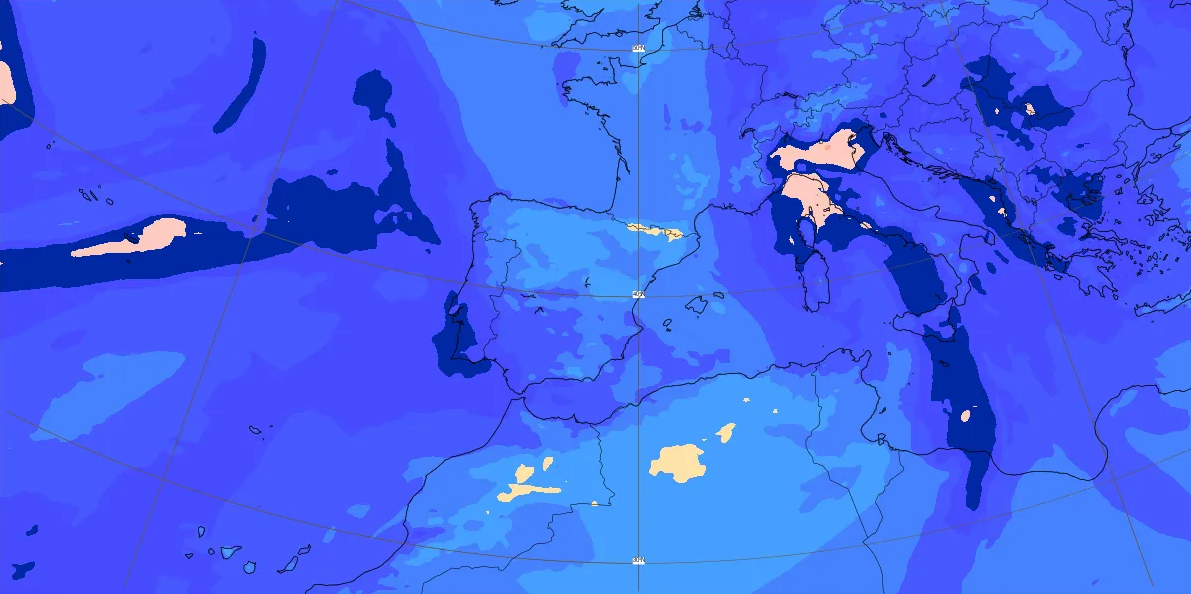
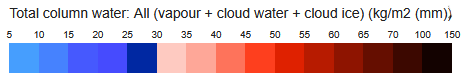
Carta del contenuto di acqua precipitabile in tutta la colonna
atmosferica alle ore 12 UTC del 17 aprile 2025 (modello ECMWF-IFS, run
h 12 UTC dello stesso giorno).
Con la formazione del minimo di pressione "Hans" tra la Liguria e la
Costa Azzurra, l'aria molto umida viene avvettata sul Mar Ligure e,
con correnti da Est lungo la Pianura Padana, fin sull'Italia
nord-occidentale, scaricando ingenti precipitazioni sui settori che
offrono il massimo sbarramento alle correnti tra Sud e Sud-Est
(rilievi dalle Valli di Lanzo al Verbano) ed Est (rilievi dal
Pinerolese alla bassa Valle di Susa).
Precipitazioni eccezionali su 1-2 giorni
soprattutto per il mese di aprile, fin oltre 500 mm
Secondo le reti di misura dei
centri funzionali del
Piemonte e della
Valle d’Aosta, la soglia di 100 mm di precipitazione
in 48 ore (mercoledì 16 e giovedì 17) è stata superata su circa due
terzi del territorio, lasciando fuori solo l’alta Val Susa, la zona
che va da Torino-città verso, Saluzzo Cuneo e le valli tra il Monviso e il Col
di Tenda, nonché l'estremo Piemonte sud-orientale. Le quantità d’acqua più
imponenti, fin oltre 400-500 mm, si sono riversate sui rilievi
tra
l’alto Canavese, la bassa Valle d’Aosta e il Biellese-Sesia-Ossola.
Secondariamente, oltre 150-200 mm si segnalano su alcune località
dell'Appennino Ligure e Alessandrino (Monte Settepani, Ponzone).
Ecco i totali d'evento più significativi su tre giorni
(15-17 aprile), considerando
dunque anche gli apporti non trascurabili di martedì 15 (dati
Arpa Piemonte,
salvo Lillianes, stazione del
Centro
Funzionale Regione Autonoma Valle d'Aosta):
Gressoney-St-Jean - Lago Seebna (Valle del Lys, Aosta): 643,3
mm (*)
Trivero-Camparient (Val Sessera, Biella):
570,6 mm
Lillianes-Granges (Valle del Lys, Aosta): 567,2 mm
Boccioleto (Val Sesia, Vercelli):
565,0 mm
Santuario di Oropa (Biella):
509,5 mm
Carcoforo (Val Sesia, Vercelli): 473,4 mm
Corio-Pian Audi (Val Malone, Torino): 465,9 mm
Valstrona-Sambughetto (VCO): 462,2 mm
Andrate-Alpe Pinalba (rilievi tra Ivrea e Biella): 460,4 mm
Montecrestese-Lago Larecchio (Valle Isorno, VCO):
458,4 mm
(*) dato rilevato da un pluviometro a pesata (OTT) e
preliminarmente validato dal Centro Funzionale della Regione Autonoma
Valle d'Aosta; il totale include anche gli apporti del 18 aprile in
quanto parte delle precipitazioni dell'evento è stata rilevata
dall'apparecchio e pesata con qualche ora di ritardo. Si tratta di uno
strumento più affidabile per la misura delle precipitazioni in alta
montagna (il Lago Seebna si trova a quota 2270 m, in sinistra
orografica della Valle del Lys e a breve distanza dal bacino
piemontese del Sesia), soprattutto quelle invernali, poiché permette
di ovviare alla problematica misura dell'equivalente in acqua delle
nevicate (pesando la precipitazione, non importa se questa sia caduta
allo stato liquido o solido). Tuttavia, agli estremi superiori del
campo di misura come in questo caso, il dato potrebbe aver sofferto di
una moderata sottostima, confermando a maggior ragione le
caratteristiche di eccezionalità dell'evento nella zona.
Si tratta di quantità più che doppie o triple rispetto alla norma di aprile,
concentrate in soli tre giorni,
ed equivalenti a una frazione compresa tra un terzo e un quarto della precipitazione media annua.
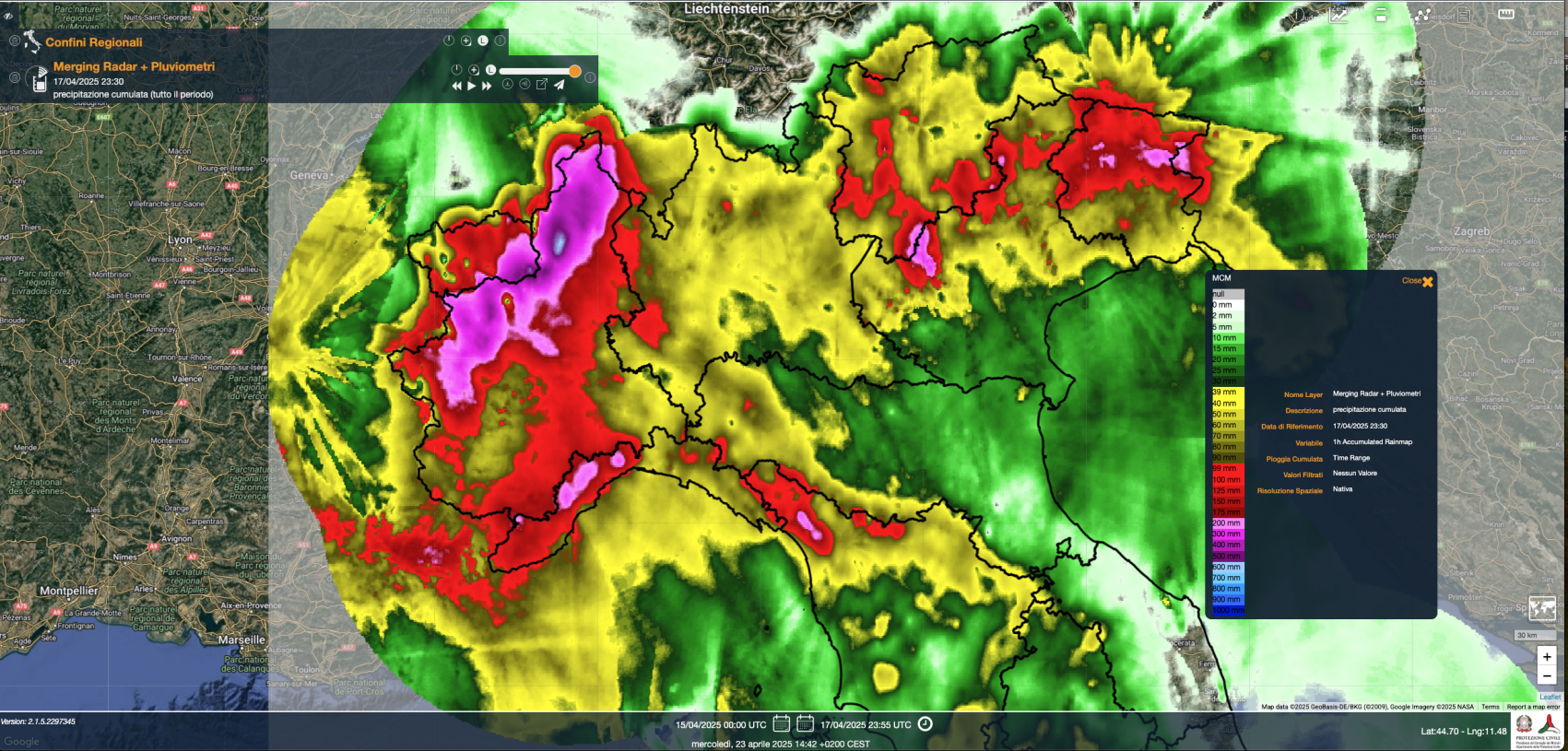
Carta delle precipitazioni (clicca
sopra per ingrandirla) totalizzate nei tre giorni dal 15 al 17 aprile
2025 al Centro-Nord Italia (integrazione tra rete dei pluviometri e
radar). In rosso i valori >100 mm, con varie gradazioni di porpora
quelli a partire da 200 mm. L'area più colpita dall'evento, con
apporti oltre 200 mm, va dalle valli Pinerolesi, alla Valle d'Aosta
sud-orientale, all'Ossola, e in parte coinvolge anche l'Appennino
Ligure nell'entroterra tra Savona e Genova. All'opposto, meno di 70 mm
sono caduti in varie località della pianura cuneese e
dell'Alessandrino sud-orientale. Colpiti, seppure in misura minore per
intensità ed estensione delle piogge, anche i rilievi del Nord-Est;
40-90 mm su gran parte delle restanti Alpi centro-orientali, mentre la
bassa Valpadana e soprattutto la Romagna sono rimaste sotto i 20-30 mm
(immagine tratta dalla piattaforma myDewetra del
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, cortesia
Fondazione
CIMA - Savona).
In
diversi casi - su serie di osservazione di oltre un secolo - non aveva
mai piovuto tanto in 1 e/o 2 giorni ad aprile, o perfino in qualunque mese
dell’anno come nel caso di Domodossola. Riportiamo a titolo di
esempio alcuni record, senza pretesa di esaustività e in attesa di
indagini più estese.
Domodossola - Collegio Rosmini
(dati
CNR-IRSA, Pallanza)
271,0 mm il 16 aprile: primato 1 g per aprile e assoluto, serie
dal 1871
(precedenti 1 giorno: 174,0 mm il 30 aprile 1977 e 247,6 mm il 25
agosto 1987);
367,6 mm il 16-17 aprile: primato 2 gg per aprile e assoluto,
serie dal 1871
(precedenti 2 giorni: 260,0 mm il 29-30 aprile 1977, 343,0 mm il 2-3
novembre 1868).
La stazione
Arpa Piemonte
di Domodossola-Nosere, circa 1,5 km a Sud-Est del Collegio Rosmini, ha registrato valori ancora superiori (317,7 mm
il 16 aprile, 410,5 mm il 16-17 e 440,1 mm il 15-16-17), confermando a
maggior ragione i record secolari.
Il valore misurato dal pluviometro del Collegio Rosmini è d'altronde
pienamente confermato dai volumi d'acqua raccolti dagli adiacenti
rilevatori di deposizione secca e umida e analizzati nei laboratori
del
CNR-IRSA a Verbania-Pallanza.
Oropa - Santuario
(dati Arpa
Piemonte, confronto con serie storica osservatorio)
308,2 mm il 16 aprile: primato 1 g per aprile, serie dal
1913
(precedente 1 giorno: 240,0 mm il 30 aprile 1977);
476,4 mm il 16-17 aprile: primato 2 gg per aprile, serie dal
1913
(precedente 2 giorni: 370,6 mm il 29-30 aprile 1977).
Gressoney-D'Ejola
(dati Centro
Funzionale VdA, confronto con serie osservatorio)
110,2 mm il 16 aprile: primato 1 g per aprile, serie dal
1927
(precedente 1 giorno: 92,7 mm il 13 aprile 1989);
204,0 mm il 16-17 aprile: primato 2 gg per aprile, serie dal
1927
(precedente 2 giorni: 142,7 mm il 16-17 aprile 1948).
Aosta-aeroporto Saint-Christophe
(dati
Centro
Funzionale VdA, confronto con serie storica Aosta-città +
aeroporto)
135,8 mm il 16-17 aprile: primato 2 gg per aprile,
serie dal 1891
(precedente 2 giorni: 133,0 mm il 24-25 aprile 1926).
Dopo che già da domenica 13 aprile 2025 si susseguivano
fasi piovose a intermittenza, soprattutto sull'alto Piemonte le
precipitazioni dell'evento principale si sono mantenute senza
interruzione per circa 48 ore consecutive su gran parte delle
stazioni più colpite - ovvero dalla sera di martedì 15 aprile fino
alla sera del 17 o talora fino alle prime ore di venerdì 18 -
raggiungendo le massime intensità orarie (spesso >20-30 mm/h in
località di montagna) talora già nelle prime ore del 16 sull'alto
Piemonte (45,6 mm tra le h 05 e le 06 locali, UTC+2, a
Valstrona-Sambughetto, a monte di Omegna), più diffusamente tra il
pomeriggio del 16 e il mattino del 17 dall'Ossola al Pinerolese (50,8
mm a Oropa tra le h 18 e 19 locali del 16).
Fanno eccezione le località di collina tra Chivassese e Astigiano
settentrionale, interessate da un violento temporale responsabile di
gravi dissesti intorno al mezzogiorno di giovedì 17 aprile (a
Morasengo-Tonengo, 34,2 mm tra le 12 e le 13, e 51,8 mm tra le 12 e le
14 locali, UTC+2), quando nelle
altre zone l'evento pluviometrico volgeva al declino.
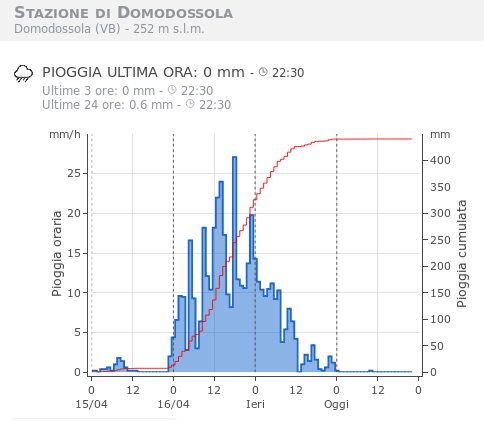
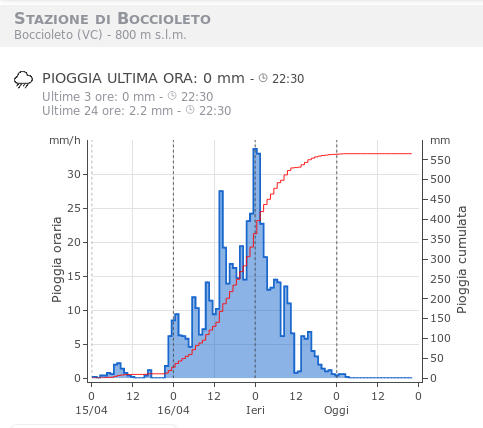
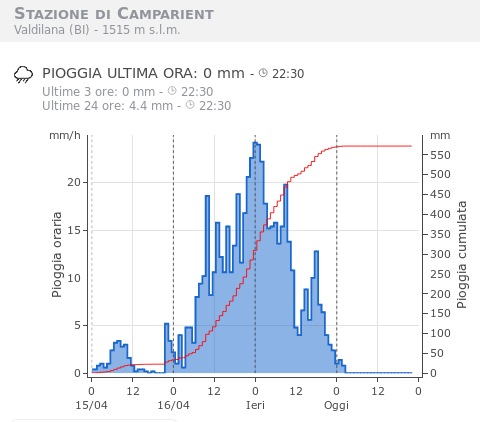
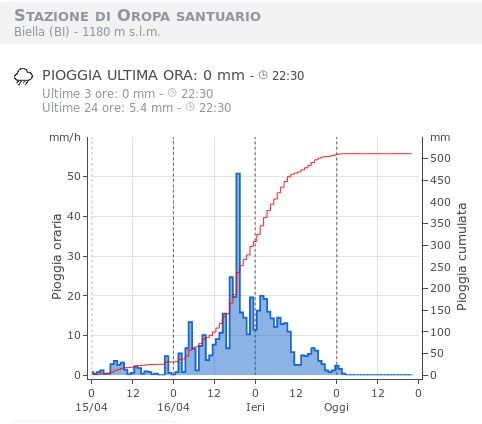
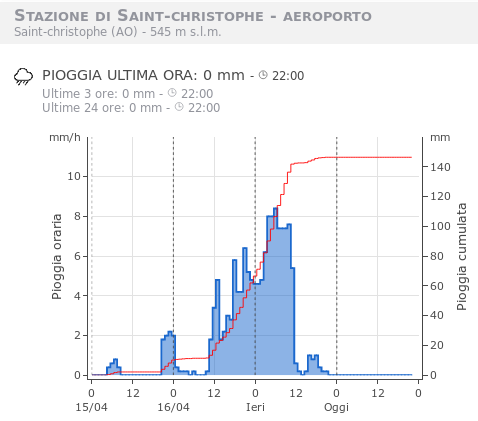
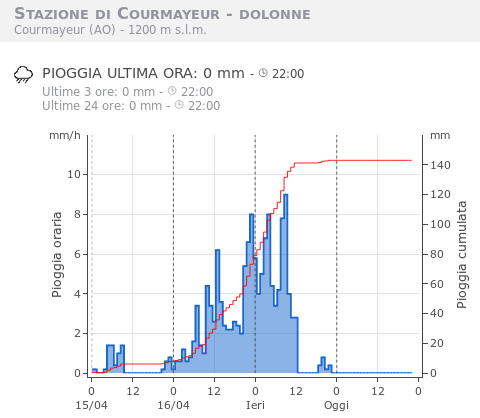
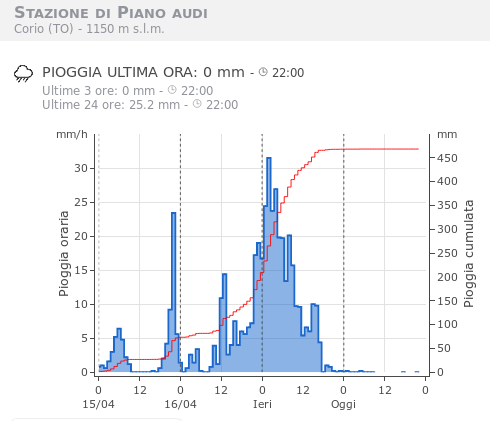
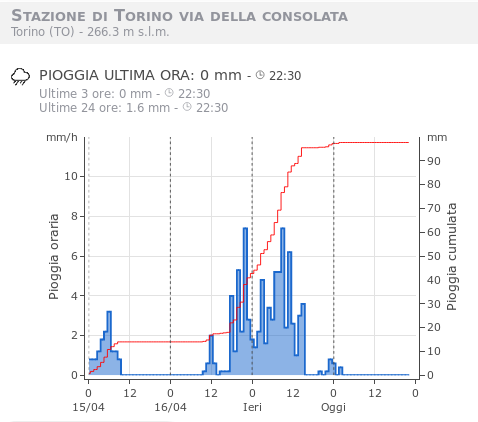
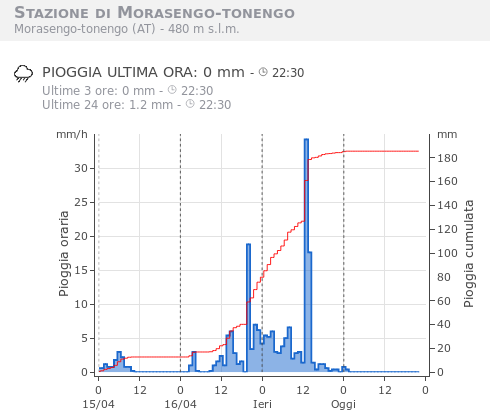
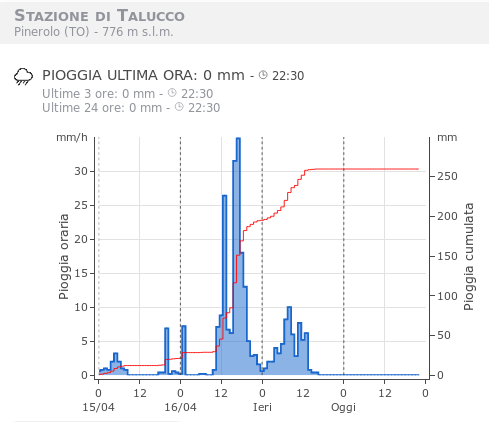
Precipitazioni orarie e cumulate dal
15 al 18 aprile 2025 in alcune località tra Piemonte e Valle d'Aosta
(grafici tratti dalla
app
Meteo3R). Le intensità più elevate (talora superiori a 30-50
mm/ora sulla fascia montana dal Torinese all'alto Piemonte) si sono
generalmente registrate tra il pomeriggio del 16 e il mattino del 17
aprile. Sulle
colline del Po tra Chivassese e Monferrato spiccano invece i violenti
scrosci avvenuti intorno al mezzogiorno del 17 su suoli già saturi
d'acqua per le precipitazioni precedenti, causa del rapido innesco di frane per fluidificazione
superficiale e della piena parossistica del Rio della Valle a Monteu
da Po (una vittima).
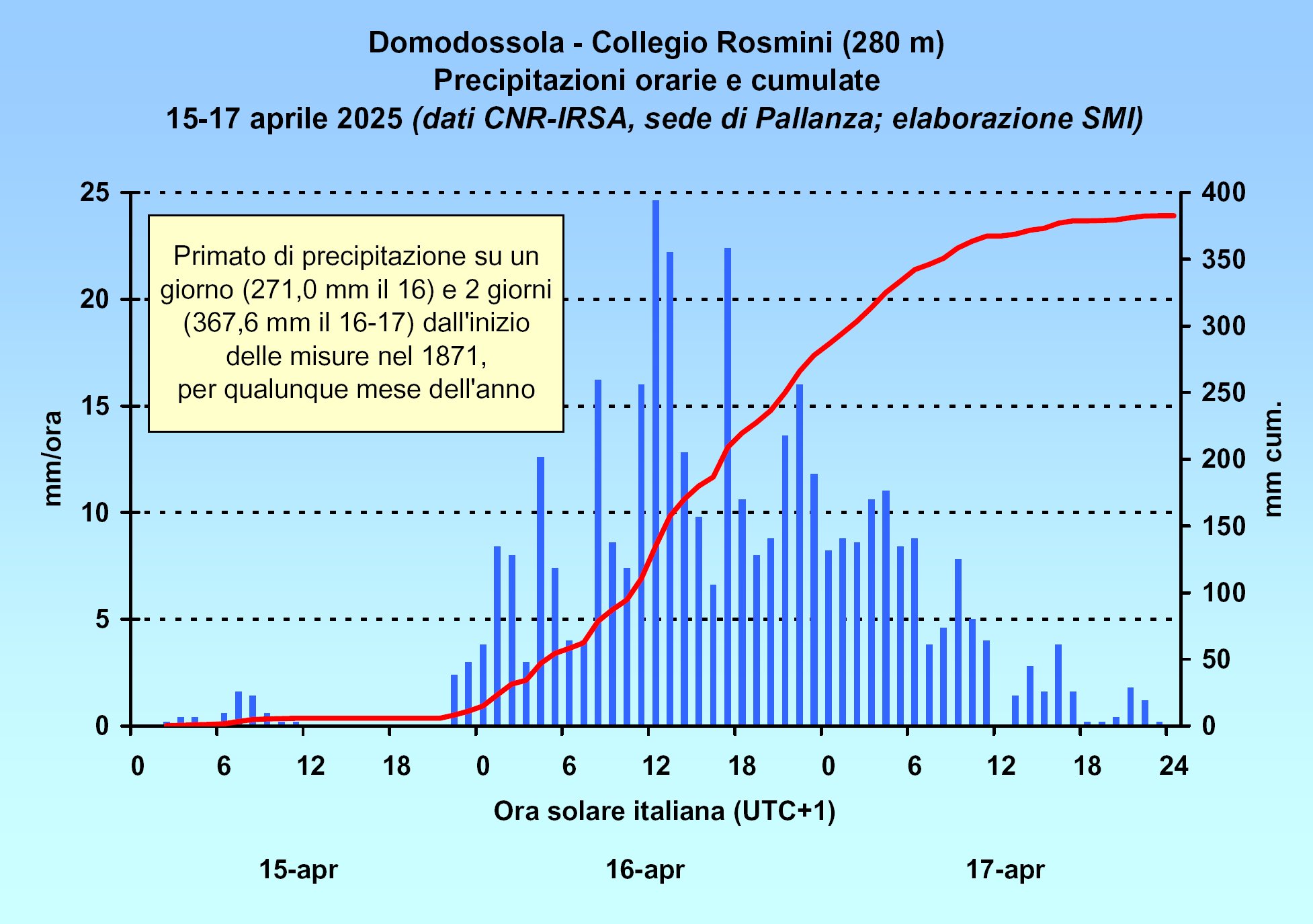
Pur non avendo ricevuto le
precipitazioni in assoluto più elevate dell'evento (spettanti ad altre
località più a Sud, tra Val Sesia, Biellese e bassa Valle del Lys, con
totali superiori a 500 mm in tre giorni), l'osservatorio meteorologico
di Domodossola - Collegio Rosmini,
nominato dalla WMO "stazione centenaria" e gestito dal
CNR-IRSA di Verbania-Pallanza, ha stabilito dei notevoli primati
di piovosità giornaliera non solo per aprile, ma per qualunque mese
dell'anno nella serie storica avviata nel lontano 1871. In 154 anni di
misure non aveva mai piovuto tanto sia in un giorno (271,0 mm il 16
aprile 2025), sia in due giorni (367,6 mm il 16-17), superando
ampiamente i precedenti record assoluti su tali durate
(rispettivamente 247,6 mm il 25 agosto 1987 e 343,0 mm il 2-3 novembre
1968, entrambi in occasione di gravi episodi alluvionali). Invece il
totale su tre giorni (382,6 mm il 15-16-17 aprile 2025) è rimasto
leggermente sotto al record storico di 388,0 mm dell'1-2-3 novembre
1968, superando tuttavia di gran lunga il precedente primato di 3
giorni relativo al solo mese di aprile (287,0 mm il 22-24 aprile
1934).
Secondo
l'analisi pluviometrica aggiornata in tempo reale da Arpa Piemonte,
dal 1° gennaio al 21 aprile 2025, a evento alluvionale
terminato, sull'insieme della regione sono caduti in media 439 mm
di pioggia e neve fusa, pari al doppio della quantità mediamente
attesa. Il 16 e 17 aprile 2025 si collocano inoltre nel gruppo dei
giorni più piovosi registrati in primavera dall'inizio della serie
pluviometrica regionalizzata nel 1958 (grafico qui sotto), simili solo
al caso del 31 marzo-1° aprile 1981.
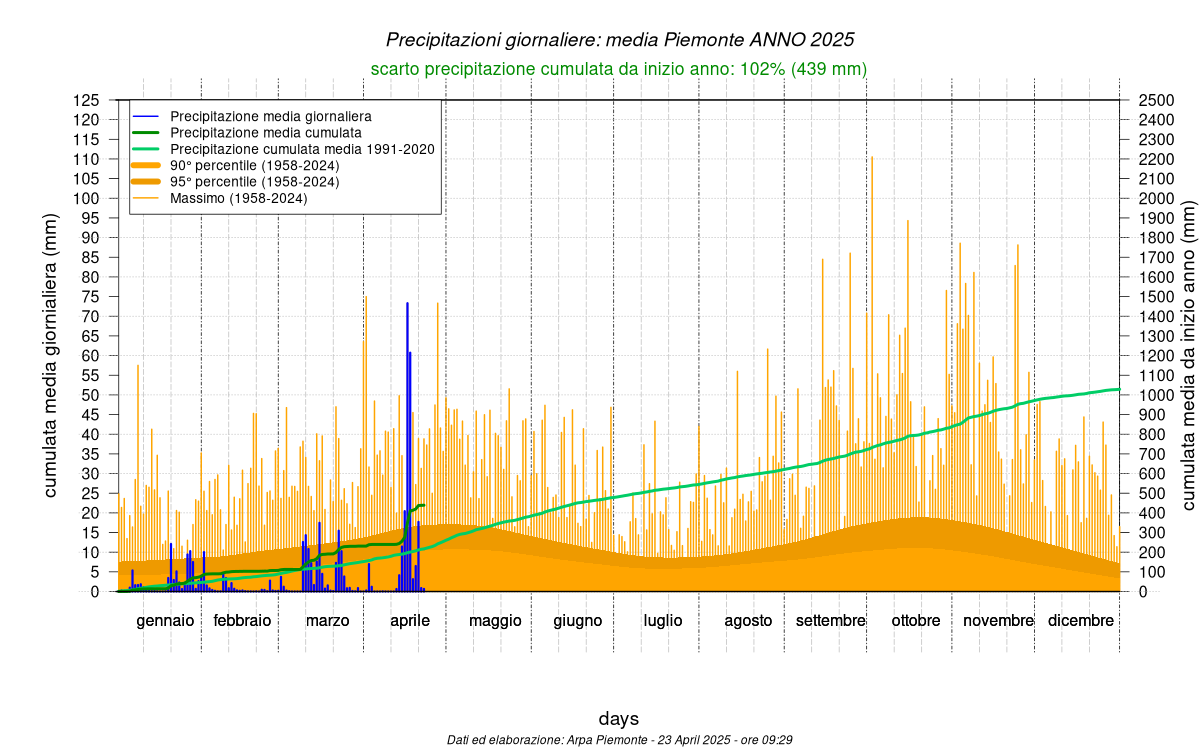
Come anticipato sopra, durante l'evento il limite
pioggia-neve, inizialmente elevato e ben superiore a 2000 m, si è
abbassato in modo più evidente nelle valli alpine interne e soggette a
precipitazioni più intense, come in Valle d'Aosta, arrivando qui a
imbiancare temporaneamente perfino la città di Aosta (580 m) al
mattino di giovedì 17 aprile (6 cm di neve fresca).
La caduta delle precipitazioni parzialmente in forma nevosa ha
limitato i deflussi di piena dalle valli alpine, scongiurando effetti
sul territorio ancora peggiori, che si sarebbero realizzati se la
medesima perturbazione si fosse presentata a fine primavera o a inizio
autunno, stagioni peraltro più propense a sviluppare configurazioni
meteorologiche e rovesci intensi di questo tipo.

Circa 10 cm di neve molto bagnata e
pesante caduti tra notte e mattino di giovedì 17 aprile 2025 a Ceresole
Reale, Parco nazionale Gran Paradiso (foto Pierluigi Cullino), durante
la fase di temporaneo abbassamento del limite pioggia-neve dovuto
all'intensità della precipitazione ("effetto valle", ovvero
progressivo raffreddamento del volume d'aria racchiuso nella vallata a
causa della fusione di miliardi di fiocchi di neve, passaggio di stato
che sottrae calore all'ambiente circostante, ovvero all'aria).

Ceresole Reale, 17 aprile 2025:
valanga di neve umida in località Foiere, il cui deposito è giunto a
pochi metri dalla SP 50 per il Colle del Nivolet (foto
Pierluigi Cullino).

All'interno della Valle d'Aosta (e
in modo ancor più marcato oltralpe, nel Vallese), al mattino del 17
aprile 2025 la neve è scesa fino a fondovalle, imbiancando Aosta con
uno strato di 6 cm (rilievo eseguito da Giancarlo Cesti in periferia
Sud della città). Per trovare un evento nevoso così tardivo nel
capoluogo valdostano occorre tornare ai casi del 19 aprile 2014 (2 cm)
e del 20 aprile 2013 (2 cm). Solo 24-36 ore prima il limite
pioggia-neve si attestava ancora a 2200-2400 m, scendendo poi
rapidamente di quasi 2000 m! La caduta di neve in montagna (sebbene in
una prima fase solo ben al di sopra dei 2000 m) ha limitato un po' i
deflussi dalle valli alpine, scongiurando piene fluviali ancora più
imponenti che si sarebbero invece verificate se le stesse quantità di
precipitazione fossero cadute durante un episodio di inizio autunno,
con temperature più elevate.

Oltre i 2500 m, dove le
precipitazioni sono avvenute in forma nevosa durante tutto l'evento,
dal Gran Paradiso al Monte Rosa e all'Ossola sono caduti diffusamente
almeno 120-150 cm di neve fresca. Nella foto, lo storico
Istituto Scientifico Angelo Mosso, gestito dall'Università di
Torino presso il Col d'Olen (2901 m, alta Val Sesia, Monte Rosa),
appare semisepolto nel manto nevoso al ritorno delle schiarite venerdì
18 aprile 2025: la locale stazione meteorologica del
Servizio
Meteomont/Comando Truppe Alpine rileva 340 cm di neve al suolo, di
cui 140 cm di fresca (fonte immagine:
pagina Facebook Rifugi Monte Rosa).
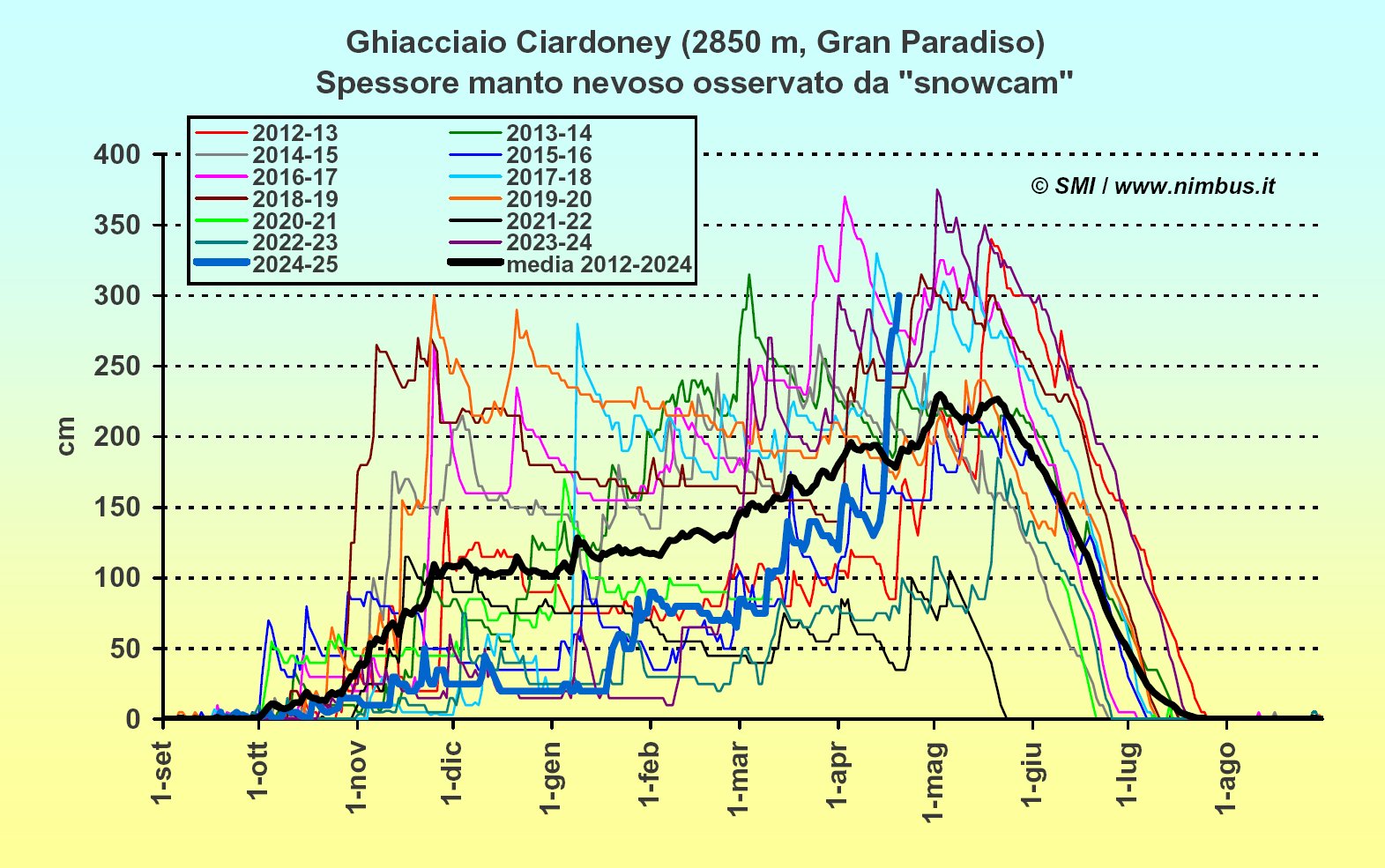
Altezza della neve totale al suolo
alla
stazione meteorologica del Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso)
nelle stagioni nevose dalla 2012-13 all'attuale (linea azzurra
spessa). Dopo un inverno dall'innevamento piuttosto magro, le
precipitazioni di marzo-inizio aprile 2025 hanno riavvicinato lo
spessore nevoso alla media (linea nera spessa), poi ampiamente
superata con l'evento di metà aprile. Al mattino del giorno 18 il
manto era spesso 275 cm (120 cm di neve fresca in tre giorni), ed è
ulteriormente aumentato fino a 300 cm al mattino di Pasqua (20
aprile). Si tratta finora del massimo della stagione 2024-25, valore
che in primavera - nel periodo di osservazione dal 2013 - è stato
raggiunto/superato un anno su due. Dunque la nevicata recente è stata
molto abbondante, ma avere 3 m di neve ad aprile-maggio a queste quote
è del tutto ordinario.
Effetti sul territorio: evento tra i più
rilevanti in 25 anni
in Piemonte e Valle d'Aosta, maggiore piena del Po
del periodo
post-2000 a valle di Torino e fino al Pavese;
disastri e
una vittima sulle colline tra Chivassese e Astigiano;
danni per decine di milioni di euro
Le eccezionali
precipitazioni hanno determinato una gravosa risposta del territorio
in termini sia di deflussi lungo la rete idrografica, sia di
attivazione di fenomeni di versante (frane e colate detritiche o
fangose), soprattutto dalla bassa Val Susa all'alto Canavese, bassa Valle
d'Aosta, Eporediese, Biellese, Sesia e Cusio-Ossola: grandi
piene dei corsi d'acqua in trasferimento alle pianure e
convogliate poi all'asta del Po, diffusi straripamenti, frane e
colate detritiche/fangose su viabilità e abitati di collina e montagna,
evacuazioni e black-out elettrici (giovedì 17 aprile erano senza
elettricità, in parte o totalmente, 37 comuni valdostani su 74), delineando
- pur con sfumature locali - un evento tra i più notevoli per entità ed estensione in
queste zone nel periodo successivo alla storica alluvione dell'ottobre
2000.
Inoltre sono state particolarmente colpite da frane e piene
parossistiche di rii minori le colline tra Chivassese e Astigiano nel
primo pomeriggio del 17 aprile, e - seppure più localmente e in misura
minore - il Pinerolese (Val Lemina) già la sera del 16. La stima dei
danni, ancora incompleta, ammonterà a decine di milioni di euro
(almeno 20 milioni nel solo Piemonte).
L'innesco di
piene e dissesti è stato facilitato da suoli in condizioni
pregresse di umidità elevata dopo le precipitazioni di fine inverno -
inizio primavera (apporti
superiori alla norma del 79% a marzo 2025 nel bacino del Po
sotteso al Ponte della Becca, Pavia). Infatti l'evento
si inquadra in un periodo di abbondante piovosità, talora
straordinaria, che in questi primi mesi del 2025 sta coinvolgendo
l'Europa meridionale e soprattutto la Penisola iberica, mentre una
marcata siccità ha interessato i Paesi dal
Regno Unito all'Europa centrale, fino al versante nordalpino.
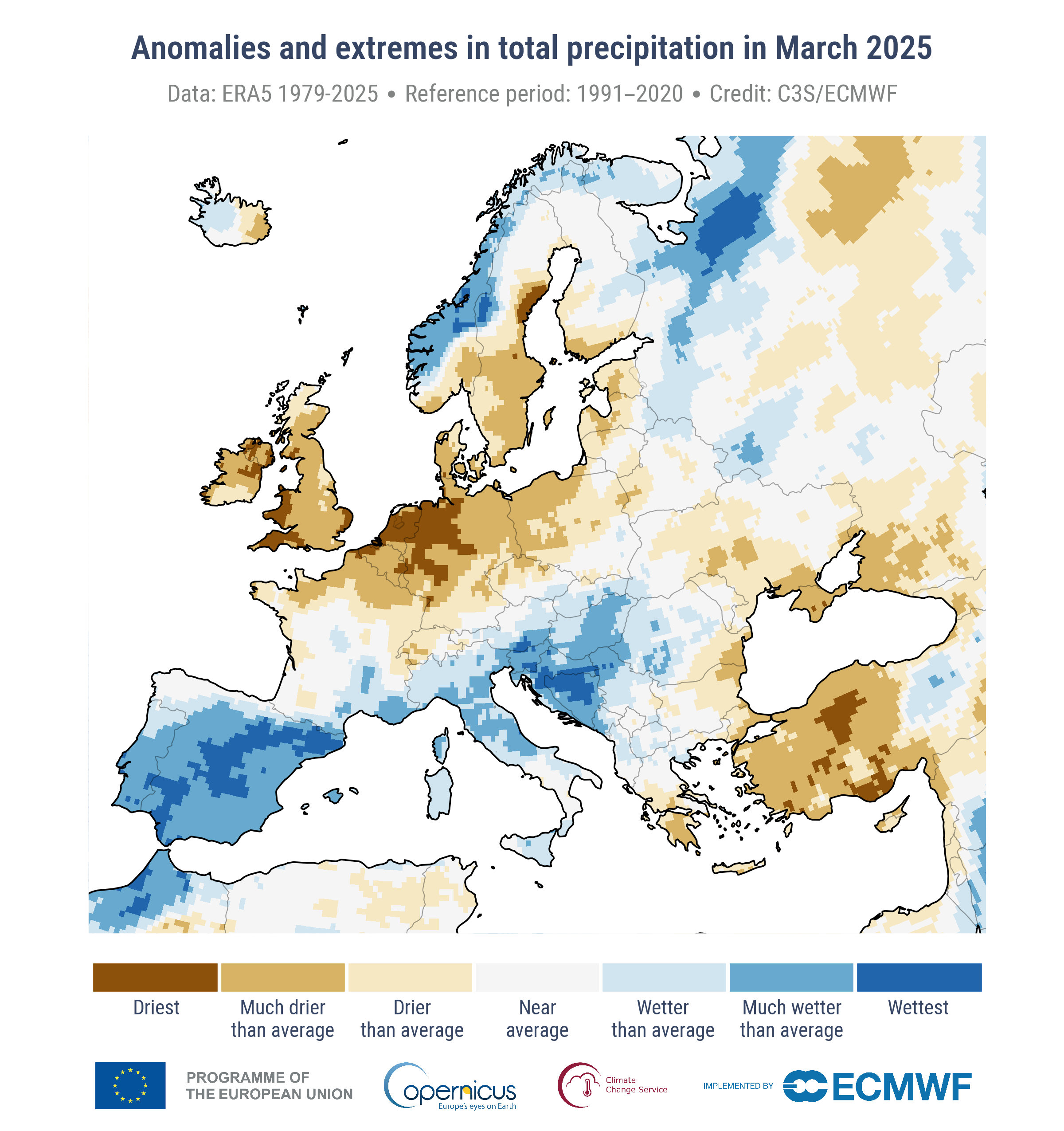
Caratterizzazione statistica delle
precipitazioni di marzo 2025 in Europa, abbondanti nel Sud del
continente, Italia inclusa, e talora eccezionali sulla Penisola
iberica e sui Balcani; nettamente in deficit dalle isole britanniche
all'Europa centrale e all'area baltica. Fonte:
bollettino climatico Copernicus - marzo 2025.
Inoltre ha
contribuito un limite pioggia-neve a
quote elevate per la stagione nelle fasi iniziali dell'evento, quando
talora sotto lo scirocco pioveva fin verso i 2500 m (notte tra
martedì 15 e mercoledì 16).
Tuttavia il successivo rapido abbassamento del limite delle
nevicate
a 1500-1800 m
dalla sera del 16 aprile, e perfino sotto i 1000 m nella Valle d'Aosta
interna al mattino del 17, ha ridotto i deflussi dagli affluenti
alpini proprio nella fase più critica dell'evento alluvionale,
evitando conseguenze ancora peggiori per lo meno lungo i corsi
d'acqua con bacino in prevalenza montuoso.
Danni e
interruzioni di viabilità hanno cominciato a manifestarsi nel corso
del 16 aprile per lo più nell'alto Piemonte (Ossola, Cusio, Val
Sesia), soggetto alle precipitazioni più intense nella prima fase
dell'evento, più localmente anche nel Torinese (Val Lemina, presso
Pinerolo). Poi, la sera, allagamenti si sono moltiplicati nel Canavese,
infine tra notte e mattino del 17 le criticità si sono estese a gran
parte dei settori a Nord di Torino.
Il peggio è toccato a località colpite da
violenti rovesci temporaleschi che hanno infierito su suoli già saturi
d’acqua, come – per citarne solo alcune - Almese e Rubiana in bassa
Val Susa, Fontainemore nella Valle del Lys, e vari paesi delle
colline tra Chivassese e Astigiano, dove viabilità e centri
abitati sono stati sconvolti da frane e piene parossistiche di rii
secondari a seguito del nubifragio avvenuto tra mezzogiorno e il primo
pomeriggio del 17 aprile; a Monteu da Po (Torino) il Rio della Valle ha
invaso con irruenza il paese causando una vittima, e nella
zona, a una settimana dall'evento, la situazione è ancora
estremamente problematica con isolamento di molti centri e assenza
di acqua potabile.
Frane, strade interrotte e allagamenti anche tra alta Langa e valle
Belbo.
Il Po ha
allagato i Murazzi di
Torino con livelli di ricorrenza ordinaria, quasi annuale (colmo
di piena a 3,84 m in tarda sera del 17 aprile; rete idrometrica
Arpa Piemonte), grazie alle
precipitazioni più moderate alla testata del bacino intorno al Monviso. E' soprattutto a valle della città, una volta ricevute le
maestose piene della Dora Riparia, della Stura di Lanzo, del Malone, dell’Orco, della Dora
Baltea e del Sesia, che il fiume si è gonfiato in modo straordinario: a Isola Sant'Antonio (Alessandria) è salito fino a
8,69 m alle h 05:30 locali del 18 aprile 2025 (pari a una
portata di circa 10.300 m3/s; fonte
Arpa Piemonte), ponendosi come la piena più elevata
post-alluvione 2000 (massimo di 9,31 m il
16 ottobre, 10.500 m3/s), superando i colmi delle già ragguardevoli piene del
26 novembre 2016 (8,55 m) e del
24 novembre 2019 (7,97 m). Rispetto a questi due ultimi eventi,
stavolta il contributo del Tanaro è stato minore, e comunque
dovuto per lo più alle piene dei due rami della Bormida (Spigno e
Millesimo), ingrossati fino alla soglia rossa dai forti rovesci
intorno al crinale spartiacque con il Mar Ligure. Ad Alessandria, le
Bormide ormai riunite nel tratto verso la foce in Tanaro hanno
sfiorato un livello di 7,0 m, inferiore di oltre 2 m ai casi
eccezionali e ravvicinati del
21 ottobre 2019 (9,21 m) e
24 novembre 2019 (9,39 m), e a quello del
4 ottobre 2021 (9,41 m).
Il Lago
Maggiore è salito fino a 5,46 m sullo zero idrometrico alle h
03:30 locali di venerdì 18 aprile (ovvero 195,46 m sul livello del
mare), con allagamenti solo di lieve entità sulle rive:
infatti, nonostante le notevolissime precipitazioni nel bacino del
Toce (vedi sopra il caso di Domodossola) la caduta di neve in alta
montagna ha relativamente attenuato i deflussi del principale corso
d'acqua ossolano (7,36 m a Candoglia nelle prime ore di giovedì 17
aprile, due metri sotto il livello dell'evento
storico del 3 ottobre 2020), inoltre nei settori svizzero e
lombardo del bacino imbrifero del Verbano, che pesano per oltre metà
della sua superficie totale, le precipitazioni sono state meno
intense.

Il Po al ponte di Chivasso alle h 17
del 17 aprile 2025: la piena del fiume - di ricorrenza pressoché
annuale a Torino grazie alle precipitazioni relativamente meno intense
alla testata del bacino, a monte della città - si è rapidamente
accresciuta subito a valle del capoluogo ricevendo i poderosi
contributi della Stura di Lanzo, del Malone, dell'Orco e - poco più a
valle di Chivasso - della Dora Baltea. A Crescentino il livello al
colmo di 6,00 m raggiunto a inizio serata del 17 aprile è il più
elevato del periodo successivo alla piena storica dell'ottobre 2000
(6,45 m), superando seppur di poco i 5,86 m del 25 novembre 2016 (f. Daniele Cat Berro).
Traslando verso
valle - ricevuto ancora il significativo contributo del Ticino
che ha allagato il Borgo basso a Pavia (livello al colmo di 4,19 m
intorno alle h 19 del sabato di Pasqua, 19 aprile; fonte
Arpa Lombardia)
- la piena del Po si è mantenuta su livelli elevati nel tratto
lombardo-emiliano, al di sopra delle soglie rosse di pericolo,
sebbene con tendenza a laminarsi e ad assumere connotati via via meno
straordinari a causa degli apporti modesti da parte degli
affluenti alpini e appenninici nel basso corso del fiume.
Qualche
considerazione storica più estesa sulla situazione a Piacenza:
all'idrometro ARPAE
il colmo di piena è transitato alle 8 locali di sabato 19 aprile 2025,
con un'altezza di 8,15 m che lo ha collocato in decima
posizione tra gli eventi più rilevanti dall'inizio del Novecento in
poi. Ecco, in ordine decrescente, gli altri episodi ancora più
notevoli di quello recente, con le relative altezze idrometriche
(fonte: Annali Idrologici, salvo diversa indicazione):
17 ottobre 2000: 10,60 m
13 novembre 1951: 10,25 m
7 novembre 1994: 10,08 m
18 maggio 1926: 9,63 m
1° giugno 1917: 9,00 m
28 ottobre 1907: 8,57 m (quotidiano "Libertà")
3 novembre 1945: 8,38 m (idrometro monumentale di Piacenza)
5 novembre 1968: 8,34 m
26 novembre 2019: 8,21 m (ARPAE)
(si tenga presente che eventuali variazioni nel profilo dell'alveo
intervenute nel tempo - che infatti richiedono periodiche
ridefinizioni delle quote dello zero idrometrico - possono influenzare
in parte i valori registrati)
Si noti come le
piene maggiori appartengano tutte ai mesi di maggio-giugno e
ottobre-novembre: un evento come quello di aprile 2025, per quanto non
eccezionale in generale in questa sezione del fiume, in aprile risulta
anomalo e precoce. E, curiosamente, negli ultimi sei anni si
sono verificate le piene maggiori più tardiva (26 novembre 2019) e più
precoce (19 aprile 2025) in oltre un secolo di osservazioni, elemento
che sembrerebbe indicare un'estensione del periodo in cui le
alluvioni del Po si manifestano durante l'anno, peraltro in
accordo con quanto atteso in futuro per effetto delle temperature di
atmosfera e oceani più elevate.
Procedendo
verso il Delta, il colmo di piena del Po è transitato alle h 18 locali
di domenica 20 aprile (Pasqua) a Boretto (Reggio Emilia),
ancora sopra la soglia rossa (7,04 m), e all'una di notte di martedì
22 aprile alla sezione di chiusura del bacino di Pontelagoscuro
(Ferrara), dove l'onda lunga e lenta, con un livello massimo di 2,37
m, è rimasta sotto la soglia rossa di una quindicina di centimetri.
Nelle zone di
innesco della piena, tra Piemonte e Valle d'Aosta, l'emergenza non è
del tutto finita al defluire delle acque, poiché l'elevata saturazione
d'acqua di suoli e ammassi rocciosi ha continuato a produrre qua e là
frane e crolli, come avvenuto nel pomeriggio di Pasqua (20
aprile) sulla strada provinciale della Valle Strona (Verbania),
interrotta presso Fornero, e - pur senza danni - il giorno di
Pasquetta (21 aprile) a Breno, frazione di Chialamberto (Val Grande di
Lanzo, Torino).
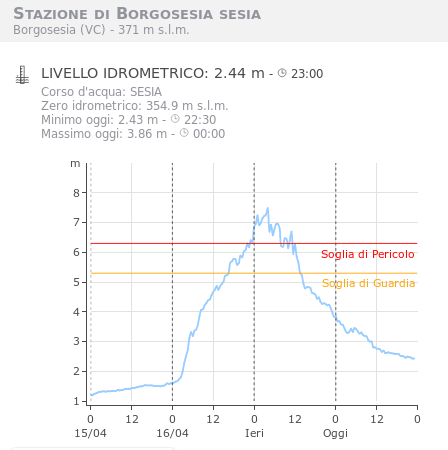
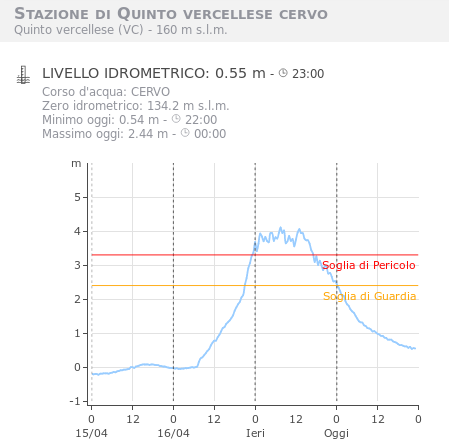
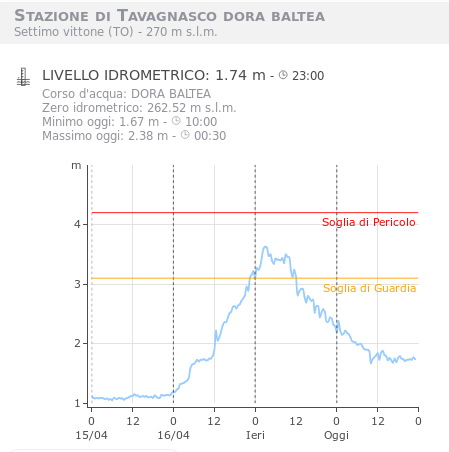

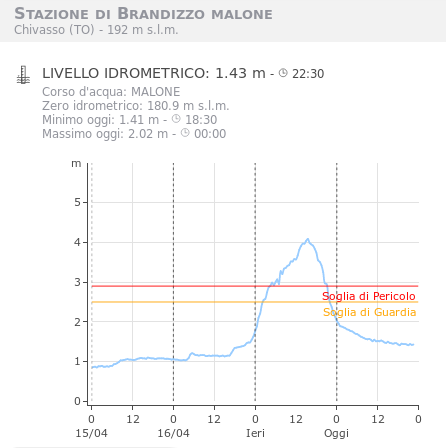

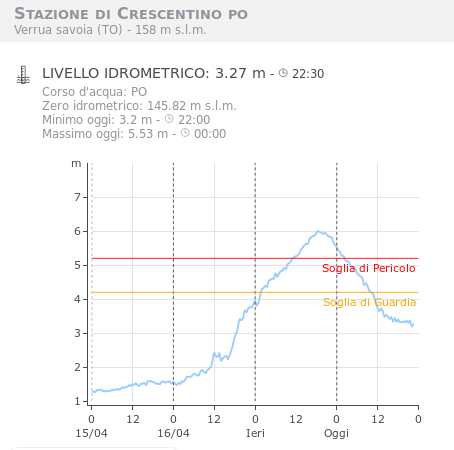

Livelli idrometrici presso alcune
sezioni fluviali rappresentative delle piene che hanno interessato il
Piemonte (grafici tratti dalla
app
Meteo3R). I colmi di piena degli affluenti del Po in sinistra
orografica sono transitati per lo più tra notte e primo pomeriggio del
17 aprile, superando in molti casi (e talora di molto) la soglia rossa
definita di pericolo (Stura di Lanzo, Malone, Orco, Cervo, Sesia...).
L'onda di piena del Po ha assunto caratteri straordinari subito a
valle di Torino, una volta ricevuti i notevoli contributi dai
tributari sopracitati, provenienti dalle Alpi Graie e Pennine. Il
colmo di piena del grande fiume è transitato alle h 05:30 locali del
18 aprile a Isola Sant'Antonio (Alessandria), all'uscita dal
territorio piemontese, alle h 18 del medesimo giorno al Ponte della
Becca (Pavia, alla confluenza con il Ticino), alle h 8 del 19
aprile a Piacenza e intorno alle h 18 del 20 aprile (Pasqua) a Boretto (Reggio Emilia), mantenendosi sempre al di sopra delle soglie
di allarme, benché con livelli di eccezionalità inferiori rispetto a
quelli del tratto tra Torino e l'Alessandrino (qui sotto, grafico
relativo alla sezione di Piacenza, da
Agenzia Interregionale Fiume Po).
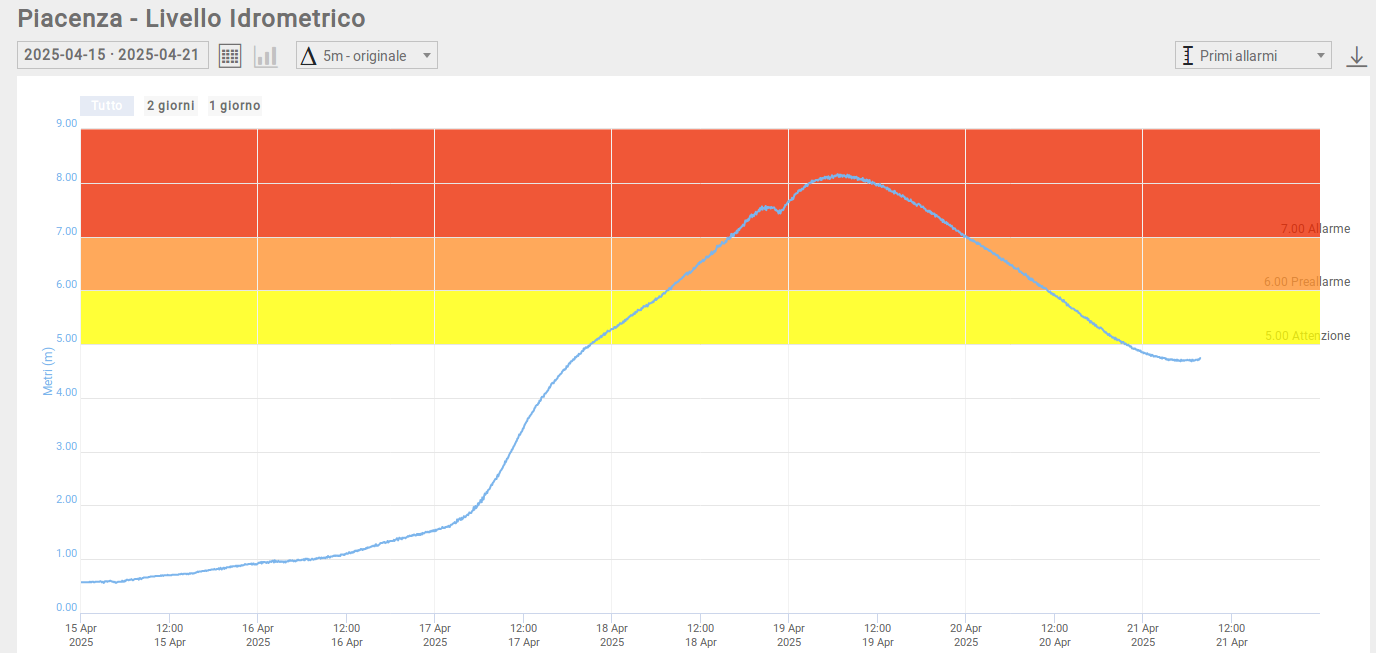
Non ci
dilunghiamo in altri dettagli, di cui le cronache giornalistiche si
sono ampiamente occupate, lasciando ulteriori descrizioni al
fotoracconto che segue.

I primi problemi si sono verificati
già nel corso di mercoledì 16 aprile 2025 sull'alto Piemonte, tra Ossola e
Biellese-Sesia, zone che per prime sono state interessate da
precipitazioni intense. Nella foto, trasporto di detriti sulla strada
di Valpiana, frazione di Villadossola, comune più colpito nella
provincia del Verbano-Cusio-Ossola (foto tratta dal portale
OssolaNews).

17 aprile 2025: un trasporto
torrentizio in massa interrompe la strada della Val Vogna (laterale
destra dell'alta Val Sesia) pochi metri a valle
della frazione Cà di Janzo, in territorio di Riva Valdobbia (foto
tratta dalla
pagina Facebook Comune di Alagna Valsesia - Im Land).

17 aprile 2025: l'autostrada A26
Voltri-Gravellona Toce circondata dalle inondazioni causate dallo
straripamento del fiume Sesia alla periferia Sud di Vercelli. Al vicino idrometro di Palestro (Pavia),
con un colmo di piena di 5,27 m, l'evento si
pone in terza posizione in un trentennio dopo i casi del 15 ottobre
2000 (5,71 m) e 3 ottobre 2020 (6,64 m). La
grande piena del Sesia del 2020 (tempesta Alex) era a sua volta
paragonabile a quella storica di inizio novembre 1968 (ripresa da
drone, cortesia
Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia).

17 aprile 2025: il Sesia straripa
inondando estesamente le campagne tra Prarolo (Vercelli) e Palestro
(Pavia), sommergendo e isolando la Cascina Lupo, in destra del fiume e
ben visibile al centro dell'immagine (ripresa da drone, cortesia
Associazione
d'Irrigazione Ovest Sesia).

La stessa località ripresa il giorno
seguente, 18 aprile 2025, al recedere delle acque: in primo piano si
notano i danni alla strada rurale per Cascina Lupo e la completa
demolizione di un canale irriguo, i cui moduli in cemento sono stati
trascinati anche a svariati metri di distanza (foto
Associazione
d'Irrigazione Ovest Sesia).

18 aprile 2025: come sopra, moduli
di un canale di irrigazione asportati dall'alluvione del Sesia,
straripato in destra lungo la strada rurale Prarolo (Vercelli) -
Pizzarrosto (Pavia) (foto
Associazione
d'Irrigazione Ovest Sesia).
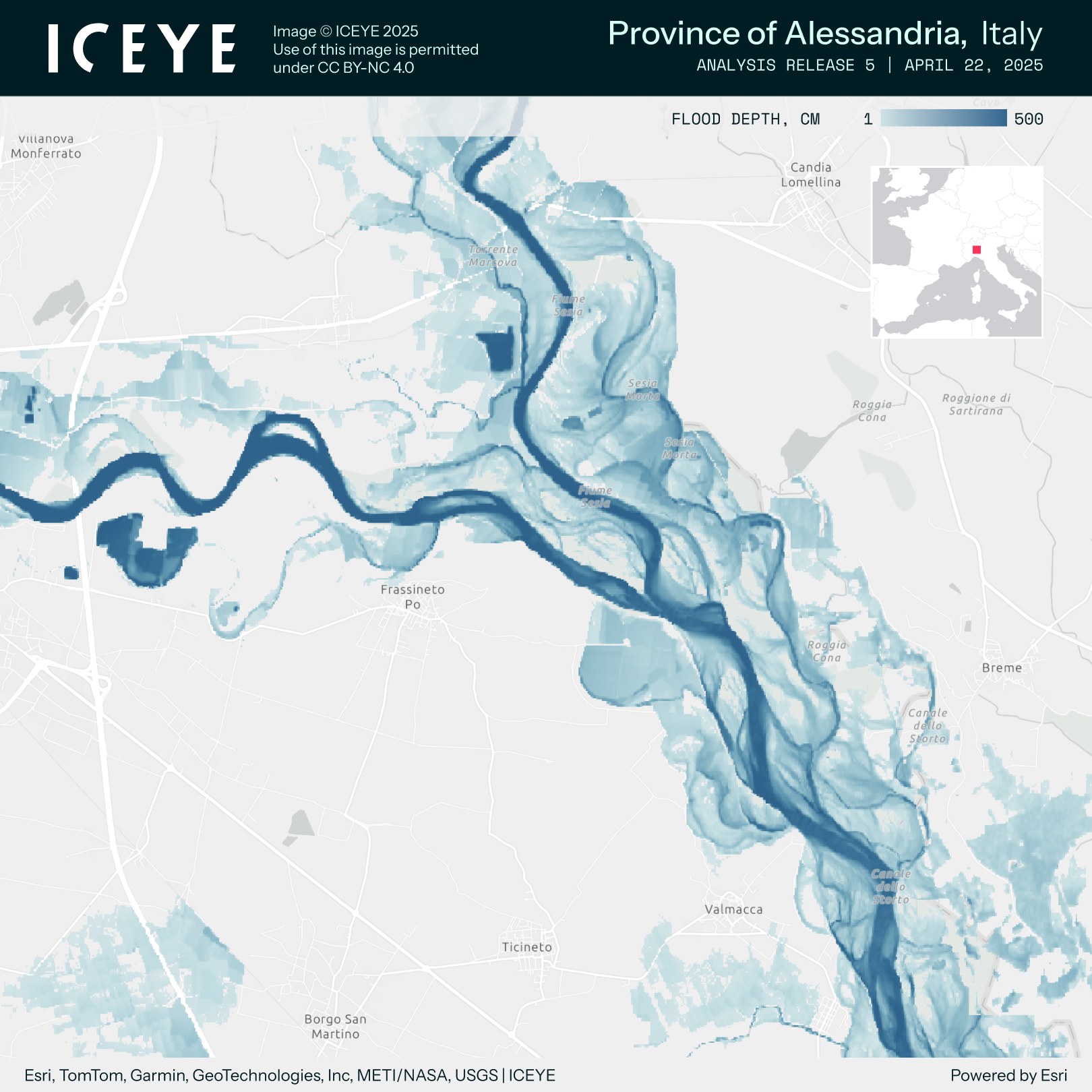
In azzurro, le estese inondazioni
intorno alla confluenza Sesia-Po, tra le province di Alessandria e
Pavia, telerilevate da satellite tramite tecnologia SAR (Synthetic
Aperture Radar). Fonte:
pagina
Facebook dell'azienda aerospaziale ICEYE.

Castelletto Cervo (Biella): la
notevole piena del Torrente Cervo danneggia lo scaricatore del Canale
Vanoni (a sinistra nella foto), a sua volta derivazione del Canale
Depretis completata nel 1958 per distribuire l'acqua della Dora Baltea
nelle risaie della zona (ripresa da drone, cortesia
Associazione
d'Irrigazione Ovest Sesia).

Mongrando (Biella), 17 aprile 2025:
la grande piena del torrente Elvo abbatte il ponte Gilino, sulla
strada per Borriana (f. Michele Teagno, tratta dalla
pagina Facebook Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte).

17 aprile 2025, Casanova Elvo
(Vercelli): lo straripamento del torrente Elvo, che trae origine dalle
montagne biellesi (bacino culminante ai 2600 m del Mont Mars vetta più
elevata della provincia di Biella), inonda campagne, risaie e
cascinali. Il corso del torrente si intravede sullo sfondo a sinistra,
mentre il canale in primo piano è il Canale Cavour, attraversato dalla
SP 53 per Santhià
(foto
Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia).

Il comune di Fontainemore, nella
bassa Valle del Lys, è stato il più gravemente colpito dai dissesti in
territorio valdostano. Alle h 03:30 locali di giovedì 17 aprile una violenta
colata detritica lungo il torrente Bioley, in sinistra Lys, ha
investito alcune abitazioni e ha interrotto la strada regionale 44 per
Gressoney
(foto tratta da un
articolo di Aosta Sera).

L'impetuosa piena della Dora Baltea
al Ponte Vecchio di Ivrea
al mattino del 17 aprile 2025 (f. Emiliano Stabile).

Lo straripamento della Dora Baltea
ha inondato i territori in destra orografica tra Lessolo, Fiorano e
Banchette, lungo l'autostrada Torino-Aosta poco a monte di Ivrea.
Sullo sfondo, a destra, si notano ulteriori inondazioni nella zona tra
Strambino e Vestigné. La piena del fiume è comunque rimasta inferiore
a grandi eventi alluvionali del passato, tra tutti quelli del 24
settembre 1993 e 14-15 ottobre 2000, anche grazie all'abbassamento del
limite pioggia-neve in Valle d'Aosta (foto di Mauro Palomba, ripresa
da Brosso in Val Chiusella nel primo pomeriggio del 17 aprile 2025).

Una grande colata detritica, con
blocchi anche di grande pezzatura, ha interrotto la strada comunale
che da Fondo di Valchiusella (Torino) porta verso l'ex-comprensorio
sciistico del Palit (autore ignoto).

Frana sulla strada provinciale 59 a
Sant'Anna dei Boschi, frazione di Castellamonte. In questa località,
il pluviometro del socio SMI Fulvio Fornengo ha raccolto
292,5 mm di precipitazione in tre giorni (15-16-17 aprile), massimo in
tale intervallo (e considerando non solo aprile, ma qualunque
mese dell'anno) nella pur breve serie di misura dal 2004 (da
pagina
Facebook Città Metropolitana di Torino).

Il torrente Malone a San Benigno
Canavese (Torino) alle h 18 di giovedì 17 aprile 2025, con livello
diminuito di circa mezzo metro rispetto al colmo di piena transitato
nel primo pomeriggio, quando le acque straripate in riva destra hanno
sormontato la strada provinciale 39 per Lombardore (come avviene a
ogni grande piena con tempo di ritorno di 5-10 anni) con battenti
idrici dell'ordine di 20-30 cm. Gli idrometri di Front (più a monte) e
Brandizzo (più a valle) hanno registrato livelli massimi
rispettivamente di 3,3 m e 4,1 m, massimi dei periodi di osservazione
iniziati nel 1995 e 2005. Nell'ultimo trentennio altre notevoli piene
avvennero il 5 ottobre 1992,
5-6 novembre 1994, 15 ottobre 2000, 25 novembre 2016 e 24 novembre
2019 (f. Daniele Cat Berro).

San Benigno Canavese (Torino): le
acque straripate in destra Malone - il cui deflusso è in parte
ostacolato dal rilevato della linea ferroviaria Rivarolo-Chieri -
ristagnano nelle campagne lungo la SP 39 alle h 18 del 17 aprile 2019
(f. Daniele Cat Berro).

San Benigno Canavese (Torino): le
acque straripate in destra Malone - il cui deflusso è in parte
ostacolato dal rilevato della linea ferroviaria Rivarolo-Chieri -
ristagnano nelle campagne lungo la SP 39 alle h 18 del 17 aprile 2019
(f. Daniele Cat Berro).

Brandizzo (Torino): torrente Malone
dal ponte della SP 220, a un chilometro dalla foce nel Po, in
prossimità del colmo di piena alle h 16:30 del 17 aprile 2025. Massimo
livello di circa 4,1 m rilevato dall'idrometro
Arpa Piemonte,
in primo piano nell'immagine (primato nella serie di misura avviata
nel 2005). La località si trova 8 km a valle dei
punti di ripresa delle due immagini precedenti riferite a San Benigno
(f. Daniele Cat Berro).

Appena più a Nord-Est, ecco la
grande piena del T. Orco a Chivasso vista verso valle alle h 16:45 del
17 aprile 2025 dal ponte della SP 11 "Padana Superiore" (f. Daniele Cat Berro). Stando alle
misure dell'idrometro Arpa collocato 8 km a monte, tra San Benigno Canavese e Foglizzo,
con un colmo di 3,87 m intorno a mezzogiorno del 17 si è trattato della piena più importante del
periodo successivo all'evento storico del 14-15 ottobre 2000,
superando i casi del 16 giugno 2010 (3,05 m), 6 novembre 2011 e 25 novembre 2016
(3,10 m), 6 novembre 2018 (3,00 m), 3 ottobre 2020 (3,56 m) e 5
settembre 2024 (2,86 m).

Dallo stesso punto di ripresa,
l'Orco ripreso verso monte con il ponte della ferrovia regionale
Torino-Milano (f. Daniele Cat Berro).

Venaria Reale (Torino): il T.
Ceronda, tributario destro della Stura di Lanzo, alle h 14 del 17
aprile 2025, poco dopo il transito del colmo di piena, visto dal ponte
di Viale Mazzini (f. Daniele Cat Berro).

Torino, Il T. Stura di Lanzo al
ponte Amedeo VIII (Strada Settimo), appena a monte della confluenza
nel Po, alle h 15:20 di giovedì 17 aprile 2025. L'acqua lambisce quasi
l'impalcato del ponte, con un livello al colmo di 3,27 m al vicino
ponte di Corso Giulio Cesare che risulta massimo nel periodo successivo
alla storica alluvione del 14-15 ottobre 2000. Da allora, solo la
piena del 24-25 novembre 2016 si era avvicinata a questa, con un colmo
di 3,09 m (f. Daniele Cat Berro).


Due immagini riprese sempre lungo la
Stura di Lanzo, ma più a monte, a ridosso del ponte della SP 724 a
Villanova Canavese, a evento concluso al mattino di sabato 19 aprile
2025. La piena ha determinato il collasso di opere trasversali (platee
di stabilizzazione del fondo) e la rimozione del materasso detritico
alluvionale, mettendo a nudo il sottostante orizzonte giallastro di
argille del Pliocene. E' il risultato di processi di erosione
rimontante scatenati da prelievi indiscriminati di materiale lapideo
in alveo nella seconda metà del Novecento, che già portarono al crollo
dei ponti di Altessano il 14 luglio 1973 e di Robassomero il 15
ottobre 2000, a conferma dei gravi danni che può innescare
l'escavazione degli alvei, spesso erroneamente invocata come soluzione
alle alluvioni. Ora il punto di maggiore disequilibrio del
profilo fluviale, in progressiva risalita verso monte, si trova
proprio in corrispondenza del ponte di Villanova, tuttora chiuso al
traffico per l'esecuzione di verifiche strutturali (f. Gabriele
Savio).


Le due foto soprastanti
mostrano l'area di innesco, vista da monte e da valle, della colata
detritica che - al mattino di giovedì 17 aprile 2025 - dalla SS 25 del
Moncenisio si è incanalata lungo il Rio Croce fino a raggiungere il
sottostante abitato di Venaus (Val Cenischia - Val Susa). Una profonda
erosione attivata da acque ruscellanti attraverso la sede stradale ha
dato inizio al processo di trasporto torrentizio in massa (f. Gabriele
Savio, 20 aprile 2025).

Venaus (Val Susa), 17 aprile
2025: effetti della colata detritica del Rio Croce
(f. Gabriele Savio).

Sulle Alpi occidentali anche la rete
sentieristica ha subito gravi danni durante l'alluvione del 16-17
aprile 2025: una frana ha cancellato parte del percorso della GTA -
Grande Traversata delle Alpi nel tratto (da poco ripristinato) poco a
monte della frazione San Giuseppe di Mompantero, Val Susa
(f. Marco Caparello).

Caprie, località Giardini (Torino):
deposizione di detriti nei prati a seguito dell'esondazione del Rio
Pra Barbe avvenuta durante il nubifragio che al primo mattino di
giovedì 17 aprile 2025 ha infierito sui territori tra il Monte Musiné
e Rocca Sella, in sinistra orografica della bassa Val Susa, agendo su
suoli già saturi per le precipitazioni delle ore precedenti. Effetti
analoghi, ma con pezzature dei detriti inferiore, si erano verificati
nello stesso punto il 24 novembre 2016 (f. Gabriele Savio).

Lo stesso nubifragio del primo
mattino del 17 aprile 2025 ha determinato numerose frane da
fluidificazione della coltre superficiale e conseguenti colate di
fango, nonché il collasso della rete idrografica minore nella bassa
Val Messa, tra i comuni di Rubiana e Almese (Torino): nell'immagine,
un complesso fenomeno franoso in frazione Tetti di Rubiana ha
intercettato la SP 197 per il Colle del Lis e la diramazione per la
borgata (f. Mirella Chiadò Piat).

Almese (Torino), la straordinaria
piena del T. Messa alle h 11:15 di giovedì 17 aprile 2025, peraltro
già scesa di almeno mezzo metro rispetto al colmo di un paio d'ore
prima. Il corso d'acqua, già ingrossato per le piogge del giorno
precedente e della notte, ha risposto in modo irruente al nubifragio
del primo mattino, toccando un livello che non si era raggiunto
nemmeno durante le alluvioni del 15 ottobre 2000 e del 24 novembre
2016 (f. Luca Mercalli).

Almese (Torino), uno tra i numerosi
episodi di crollo di muri di sostegno di strade e terrapieni, a
seguito del nubifragio mattutino del 17 aprile 2025. Il territorio
della Val Messa (comuni di Almese e Rubiana) è stato tra i più colpiti
dall'evento nelle valli alpine torinesi (f. Luca Mercalli).

Avigliana-Drubiaglio, ore 13:30 del
17 aprile 2025: inondazione di prati a causa dello straripamento in
destra del Torrente Messa (f. Daniele Cat Berro).

Il Po in piena al ponte di Chivasso,
h 17 del 17 aprile 2025: al centro è visibile la traversa di
derivazione del Canale Cavour (f. Daniele Cat Berro).

Chivasso (Torino), h 17 del 17
aprile 2025: allagamenti in riva sinistra del Po in corrispondenza
dell'imbarcadero e del Parco fluviale Sabbiuné (f. Daniele Cat Berro).

Interruzione per frana della SP 9
Chivasso-Castagneto Po. Le colline del Po alle spalle del tratto
Chivasso-Crescentino, al margine settentrionale del Monferrato, sono
state interessate da un violento temporale intorno al mezzogiorno del
17 aprile 2025, i cui rovesci - come accaduto poche ore prima in bassa
Val Susa - hanno mandato in crisi il reticolo idrografico minore e
determinato decine di frane per fluidificazione della coltre
superficiale, sconvolgendo centri abitati e viabilità (foto tratta
dalla
pagina Facebook Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte).

Particolarmente colpito il piccolo
centro pedecollinare di Monteu da Po (Torino), devastato dalla piena
parossistica del modesto Rio della Valle che attraversa l'abitato: un
anziano di 92 anni è morto nell'inondazione della sua casa (foto
tratta da La Stampa).

Lauriano (Torino): Piazza
Risorgimento coperta dal fango lasciato dalla flash-flood delle ore
centrali del 17 aprile 2025 (da
pagina
Facebook Città Metropolitana di Torino).

Una delle numerose frane di
scivolamento planare che hanno compromesso la viabilità sulle colline
tra Asti e Chivasso (fonte:
La Voce di Asti).

La piena del Po trasla lungo il
tratto lombardo-emiliano nei giorni successivi, mantenendosi al di
sopra delle soglie rosse di allarme, e invadendo le zone golenali
racchiuse entro gli argini maestri. All'idrometro di Piacenza il colmo
viene registrato alle h 8 di sabato 19 aprile 2025 con un livello di
8,15 m, inferiore di pochi centimetri al caso del 26 novembre 2016
(8,21 m) e di ben 2,4 metri rispetto all'alluvione secolare del 17
ottobre 2000 (10,60 m). Nella foto, ripresa al mattino del 19 aprile
2025, l'inondazione lungo la riva destra in via del Pontiere, presso
il ponte della strada statale 9, alla periferia Nord di Piacenza
(cortesia della redazione di
PiacenzaSera).

Un'altra immagine
del Po al colmo di piena al mattino del 19 aprile 2025, alla
periferia Nord di Piacenza (cortesia della redazione di
PiacenzaSera).

Il Po a Boretto (Reggio Emilia) alle
h 09 di lunedì 21 aprile (Pasquetta), sceso di circa 30 cm rispetto al
colmo di piena di 7,04 m transitato nel tardo pomeriggio del giorno
precedente (webcam
Comune di
Boretto e
Reggio
Emilia Meteo).
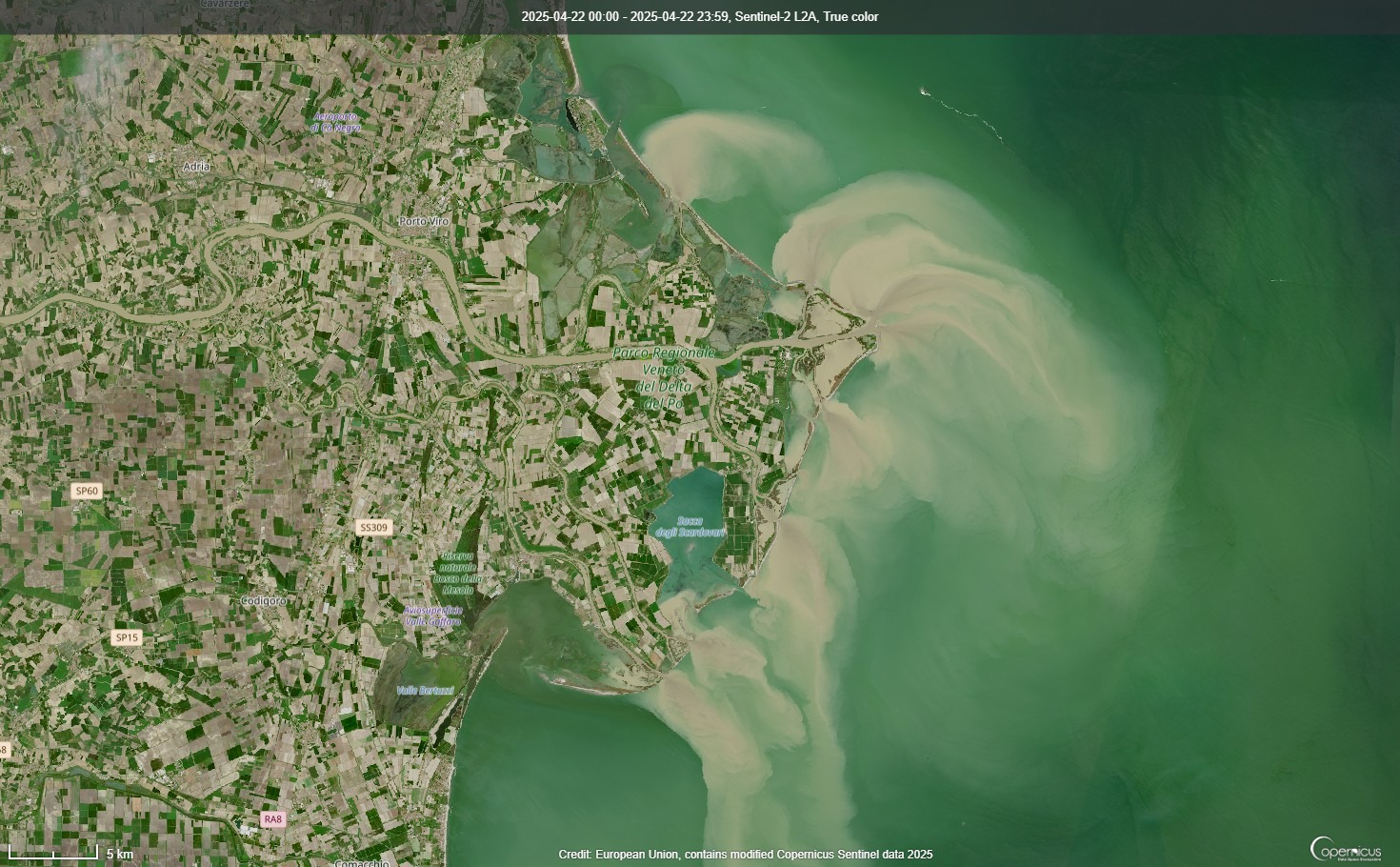
22 aprile 2025: la piena del Po,
giunta al Delta, rilascia in Adriatico grandi pennacchi di materiale
fine in sospensione (sabbie fini, limi, argille). Immagine in veri
colori,
missione Copernicus - Sentinel2 L2A, tramite
Copernicus browser (Credits: European Union, contiene dati
Copernicus Sentinel 2025 modificati).
17 aprile 2025: nubifragi anche al
Nord-Est,
due vittime nel Vicentino
Benché concentrato sugli eventi sofferti dal Nord-Ovest
italiano, questo resoconto non può tralasciare un cenno alle intense
precipitazioni che, nella stessa giornata del 17 aprile 2025, hanno
interessato il Nord-Est e in particolare il Vicentino. Un nubifragio
ha colpito Valdagno e dintorni, dove il pluviometro
Arpa Veneto
ha raccolto 152 mm di pioggia di cui 102 mm in tre ore: nel
cedimento del ponte dei Nori sul torrente Agno in piena (struttura che
era
già crollata durante l'evento del 16 maggio 1905) sono morti un
uomo e suo figlio, cadendovi con l'auto. Inoltre un tornado ha
provocato alcuni danni alla periferia Sud di Verona.

Il Ponte dei Nori crollato a
Valdagno (fonte immagine:
L'Eco Vicentino).
_MilosLago.jpg)
Mattino del 18 aprile 2025: il
Brenta in piena allaga le golene presso Vigodarzere, Padova (f. Milos
Lago).
Conclusioni: piogge, piene fluviali e dissesti
straordinari il mese di aprile
Le precipitazioni e i conseguenti fenomeni di piena
fluviale e dissesto di metà aprile 2025 nell'alto bacino del Po hanno
assunto rilevanza straordinaria, anche (e soprattutto) per la stagione
in cui si sono - precocemente - verificati.
Aprile è di norma un mese tra i più bagnati dell'anno sulle Alpi
occidentali, con precipitazioni frequenti e prolungate ma di intensità
moderata, mentre rovesci violenti e su territori vasti come
sperimentato nell'evento recente sono caratteristici più delle
grandi perturbazioni alluvionali d'autunno (o, al più, della tarda
primavera, tra maggio e metà giugno).
Oltre ai vari record secolari di precipitazione per aprile osservati
su intervalli di 1-2 giorni tra il 16 e il 17 aprile, ne è ulteriore
prova che nessuna delle grandi piene fluviali confrontabili con quelle
attuali - quanto meno negli ultimi decenni - si era verificata nella
prima metà della primavera.
Il ruolo del riscaldamento globale nell'intensificare
l'evento andrebbe accertato con opportuni
studi di attribuzione (weather attribution). Tuttavia riteniamo
probabile che il surplus di vapore acqueo ed energia proveniente dalla
superficie dell’Atlantico e del Mediterraneo prossima ai massimi
storici di temperatura abbia giocato un ruolo nell'eccezionalità
dell'evento. Questo - insieme alla maggiore capacità dell'aria
calda di contenere vapore acqueo e dunque acqua precipitabile -
rappresenta un elemento determinante nel contribuire a fenomeni
meteo-idrologici più estremi, anche in stagioni inconsuete, come
peraltro già attestato per una moltitudine di eventi tra cui, nel
2024, le
alluvioni di metà settembre in Europa centro-orientale e quelle
del
29 ottobre a Valencia e dintorni.
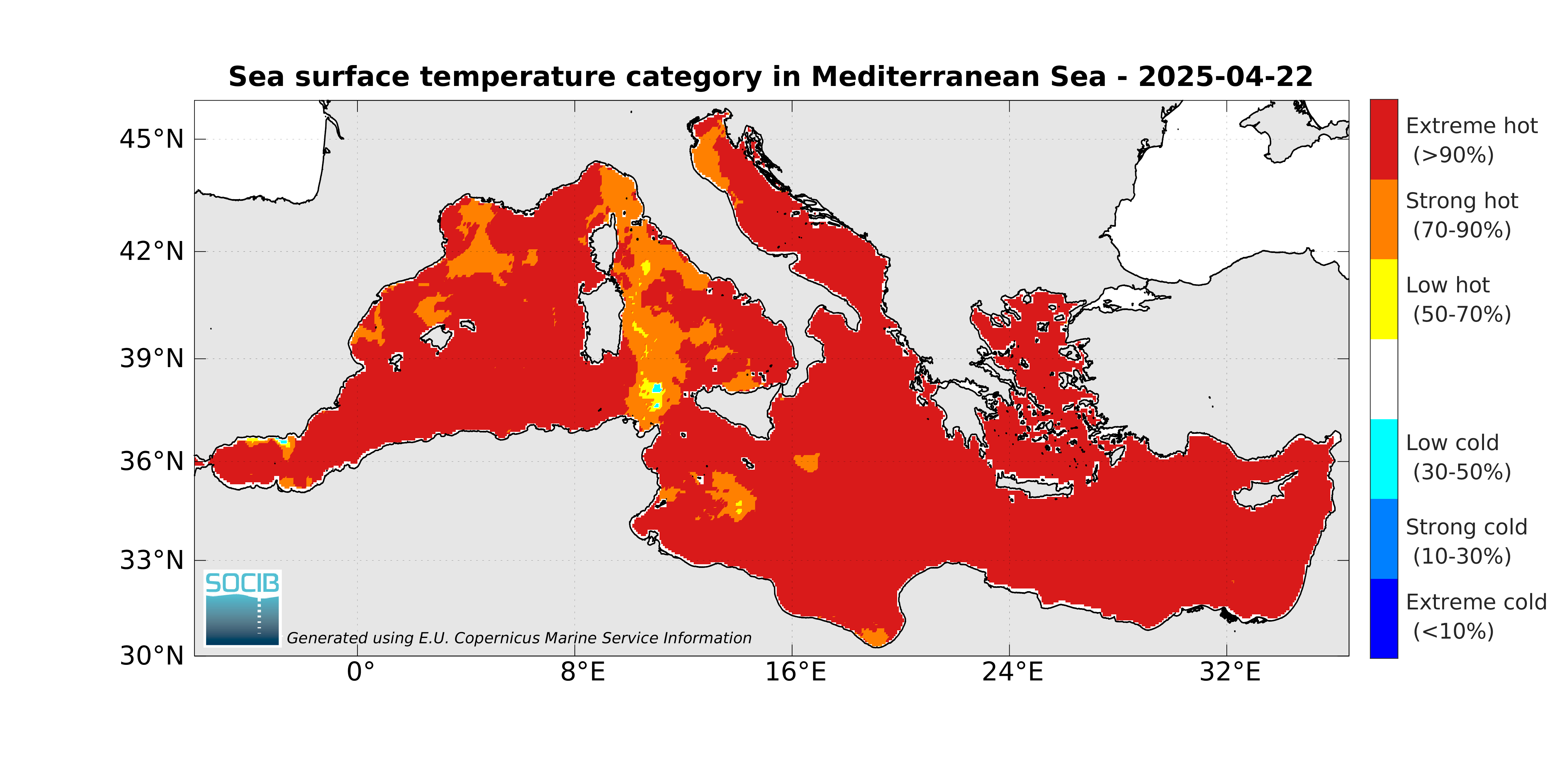
Caratterizzazione statistica delle
temperature delle acque del Mediterraneo in superficie (22 aprile
2025): pressoché tutto il bacino è in condizioni di "caldo estremo" in
rapporto alla media stagionale (>90° percentile della distribuzione
statistica), con anomalia complessiva di +1,44 °C rispetto al periodo
1982-2015, in corrispondenza dei massimi noti per questo periodo
dell'anno in oltre un quarantennio di telerilevamento satellitare
(fonte:
SOCIB - Sistema de Observación Costero de las Illes Balears, su
dati
Copernicus Marine Service).
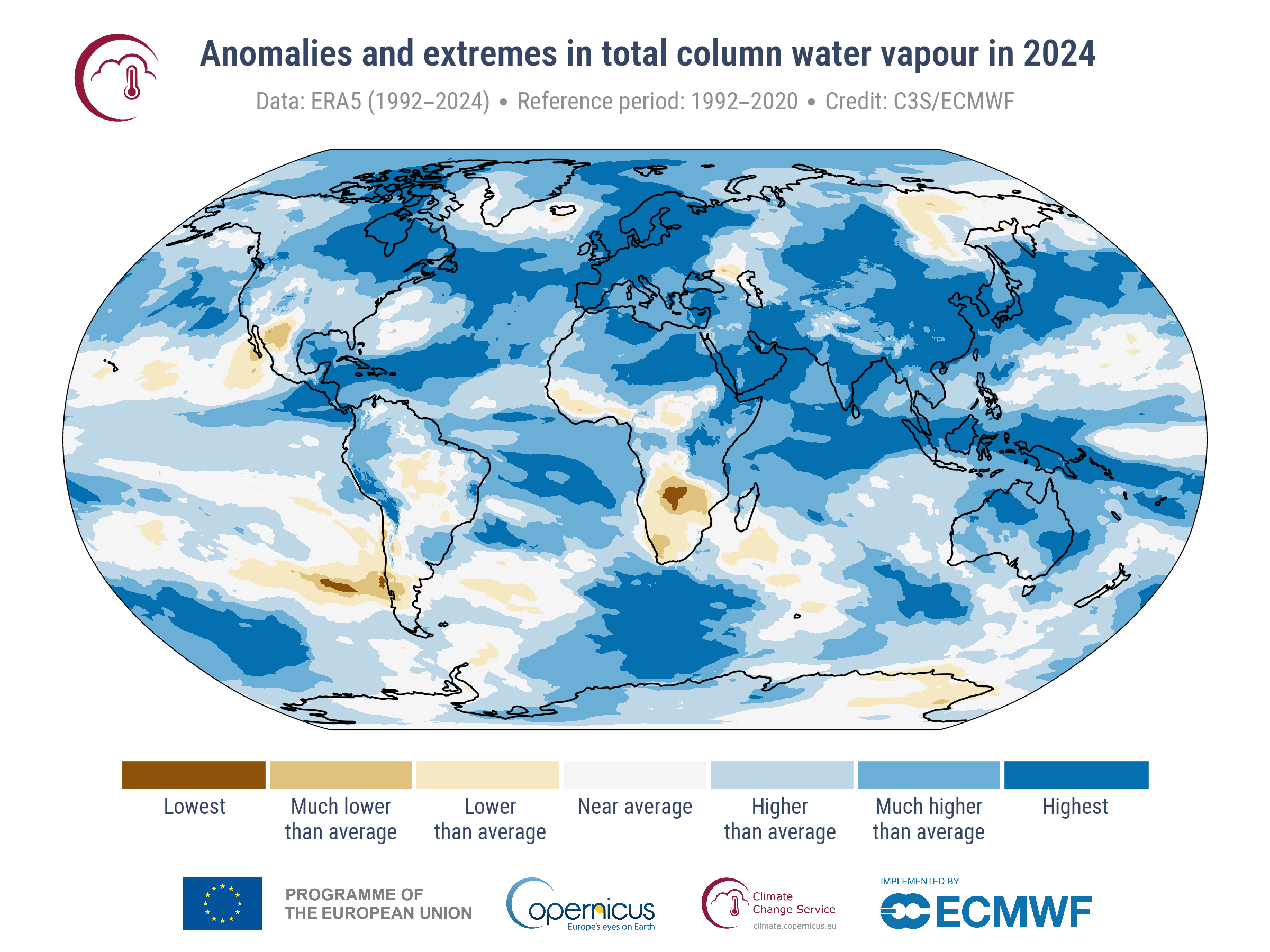
Secondo il
rapporto annuale Copernicus sullo stato del clima globale, il 2024
è stato non solo l'anno più caldo a scala planetaria da quando si
fanno misure meteorologiche, ma anche quello (e di fatto ne è
conseguenza) con il maggiore contenuto di vapore acqueo nell'aria,
dunque acqua precipitabile che può essere "spesa" in eventi
pluviometrici estremi. La causa va ricercata nelle temperature
estremamente elevate sia degli oceani (più evaporazione) sia
dell'atmosfera (maggiore propensione dell'aria a contenere vapore
acqueo, secondo la legge fisica di Clausius-Clapeyron, +7%/°C). Questo
non significa che ovunque piova di più, poiché il surplus di vapore si
distribuisce irregolarmente in base ai campi di pressione e alla
circolazione atmosferica (infatti ci sono state anche molte regioni
soggette a siccità), ma è comunque indice del fatto che nell'atmosfera
c'è più acqua allo stato gassoso disponibile per intensificare gli
eventi di precipitazione estrema, laddove le condizioni al contorno
(dinamica atmosferica, orografia) lo permettano.
Note
Elenco dei rapporti d'evento Arpa Piemonte
consultati per l'inquadramento della piena recente rispetto al passato
(livelli fluviali)
Evento del 14-16 ottobre 2000
Evento del 14-15 settembre 2006
Evento del 28-30 maggio 2008
Evento del 14-17 giugno 2010
Evento del 4-8 novembre 2011
Eventi del
3-6 novembre e
9-17 novembre 2014
Evento del 21-25 novembre 2016
Eventi del 27 ottobre-7 novembre 2018
Eventi del 19-24 ottobre 2019
Evento del 22-25 novembre 2019
Evento del 2-3 ottobre 2020
Evento del 3-5 ottobre 2021
Evento del 4-5 settembre 2024
I livelli
idrometrici riportati in questo articolo (evento recente ed episodi
passati), fanno riferimento alle pubblicazioni ufficiali delle
autorità competenti in materia meteo-idrologica (Annali idrologici del
Servizio Idrografico, rapporti d'evento dei centri funzionali). Si
tenga presente che eventuali variazioni nel profilo degli alvei
intervenute nel tempo a causa della naturale dinamica fluviale o di
interventi antropici (evoluzioni che infatti richiedono periodiche
ridefinizioni delle quote dello zero idrometrico), possono influenzare
in parte la confrontabilità dei valori registrati. Confronti più
robusti si possono eseguire tra i valori di portata (per le sezioni
fluviali in cui sia possibile calcolarli tramite le apposite scale di
deflusso): per questo rimandiamo alle valutazioni contenute nei
rapporti sull'evento di aprile 2025 di Arpa Piemonte e del Centro
Funzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Rapporto preliminare Arpa Piemonte sull'evento del 15-17 aprile
2025, con ulteriori
informazioni di dettaglio sulla rilevanza statistica dell'episodio
pluviometrico e sugli effetti sul territorio.
Ringraziamenti
Prima di tutto esprimiamo un ringraziamento particolare
ai Centri Funzionali del
Piemonte e
della Valle
d'Aosta per l'attività di monitoraggio meteo-idrologico in
tempo reale e per la puntuale emissione di efficaci
allerte alla popolazione, strumento prezioso e indispensabile per
proteggere vite umane e beni materiali.
Inoltre, grazie a tutti coloro che hanno condiviso
materiali e informazioni con la redazione di Nimbus, soprattutto l'Associazione
d'irrigazione Ovest Sesia, Dario Manca e colleghi del
CNR-IRSA di Verbania-Pallanza, Hervé Stevenin (Centro
Funzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), Giancarlo Cesti
(già tecnico incendi boschivi - Regione Autonoma Valle d'Aosta),
Michele Maiorano (Servizio
Meteomont/Comando Truppe Alpine),
Mauro Ferri (redazione
PiacenzaSera),
nonché - tra i tanti - i soci SMI Gabriele Savio
(collaboratore esterno CNR-IRPI, Torino), Andrea Vuolo
(meteorologo RAI), Gianni Castagneri, Raffaella Miravalle,
Pierluigi Cullino, Mauro Palomba, Emiliano
Stabile, Pierfrancesco Currado, Marco e Fulvio
Fornengo, per le frequenti comunicazioni sull'evolversi della
situazione.
Devolvi il 5 per mille alla SMI!
Sosterrai
le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,
e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|