|
|
|
|
|
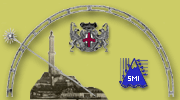 |
 |
 |
|
|||
|
|
INDAGINE PRELIMINARE SUL CAMPO TERMICO DELLA CITTA’ DI GENOVA
R. PEDEMONTE, D. ROSA, M. RISO, Società Meteorologica Italiana, Sezione Ligure, Galleria G. Mazzini 7,
Genova c/o CAI Sez. Ligure -
Prima di scorrere il seguente articolo si rende necessario da parte nostra fare alcune precisazioni. Nei primi numeri della Rivista Ligure di Meteorologia avevamo presentato la fase preparatoria di un progetto che prevedeva, tramite una sonda termica montata su un veicolo, una mappatura della temperatura della città di Genova, lungo la costa e le due valli principali. In effetti, ai tempi alle prime due puntate (anno 2001) erano già stati acquisiti i dati necessari a elaborare una preliminare disamina. Nei mesi successivi gli impegni per gli autori sono stati gravosi e solo in occasione del XVIII Colloquio dell’Associazione Internazionale di Climatologia, tenutosi a Genova tra il 7 e il 10 settembre 2005, si è potuto produrre in modo organico i risultati dell’indagine preliminare pubblicata di seguito.
Sommario Lo studio riporta i risultati di un’indagine preliminare, effettuata sul campo, in relazione alla variazione della temperatura nella città di Genova, in situazioni anticicloniche invernali, per verificare l’influenza dell’orografia locale e l’eventuale esistenza di un’isola di calore urbana. Da questi primi dati si evince che la complessa orografia del territorio influisce in maniera sostanziale sulla distribuzione spaziale della temperatura, mascherando gli effetti dell’isola di calore urbana, in particolar modo lungo la costa. Key-words: Genova, isola di calore, orografia, regime anticiclonico, temperatura, urbanizzazione. 1. L’area di studio Lo studio è stato svolto a Genova, città che conta circa 600 mila abitanti i quali vivono, in gran parte, lungo i 31 km di costa, nei punti più accessibili della retrostante fascia collinare e nelle valli principali, aree che hanno subito un'urbanizzazione marcata, specialmente dopo l’ultimo dopoguerra. La costa si presenta rettilinea con andamento est-ovest ed è intersecata da numerosi solchi vallivi, percorsi da brevi corsi d’acqua a carattere torrentizio. I contrafforti collinari lasciano limitato spazio alle poche e circoscritte piane costiere. Le principali valli sono la Val Polcevera a occidente del centro cittadino, disposta secondo un asse rettilineo nord-sud, e la Val Bisagno a oriente che, prima di giungere al mare, compie una vasta ansa verso sud. L’orografia complessa e il mare, che bagna a mezzogiorno la città per tutta la sua estensione, determinano microclimi particolari, differenti da quelli riscontrabili in altre aree urbane. 2. Metodologia Si è scelto di misurare le temperature lungo i tre seguenti percorsi (Fig. 1):
Figura 1 L’analisi è stata condotta utilizzando un termometro digitale a termocoppia, dotato di sonda aerotermica con risoluzione di 0.1°C e tempo di risposta di 10 sec. La sonda è stata sistemata a bordo di un’autovettura su un apposito supporto isolante in materiale plastico, a 210 cm dal suolo. I tragitti automobilistici sono stati compiuti in ore notturne, a una velocità compatibile con i tempi di risposta della sonda. Lungo ognuno dei tre itinerari sono stati individuati, dopo alcuni sopralluoghi, i siti più rappresentativi, la cui ubicazione è stata memorizzata e informatizzata con apparecchiatura GPS. In considerazione dei tempi di percorrenza dei tragitti, questi sono stati effettuati due volte, un’andata e un ritorno, registrando a ogni transito e in ogni punto prescelto il valore della temperatura. Assumendo una variazione lineare nel tempo delle temperature, dovuta alla naturale escursione termica giornaliera, la media tra i due valori registrati in ogni singolo punto, può essere confrontato con quello analogo degli altri punti. Nei grafici i valori indicati ΔTm rappresentano lo scostamento delle medie, come sopra calcolate nei vari punti, rispetto alla loro media lungo tutto il percorso. 3. Risultati Le campagne di misura sono state condotte durante l’inverno 2000/2001 in due situazioni anticicloniche: Situazione 1: cielo sereno con forti correnti settentrionali al suolo. Situazione 2: cielo sereno con calma o vento leggero. 3.1 Percorso A – Itinerario costiero (Fig. 2) La curva della temperatura nella situazione 1 evidenzia l’effetto dei freddi venti settentrionali convogliati attraverso le valli che intersecano la costa. Procedendo da ovest verso est, subito dopo l’abitato di Arenzano (punto misura 1), si rileva a Vesima (2) il valore più elevato della temperatura a ponente del centro città. Segue quindi una rapida diminuzione riscontrabile a Voltri (4), alle foci del Cerusa e del Leira, con un minimo in corrispondenza dello svincolo autostradale (8). Da questo punto una risalita sino al Lido di Pegli (10), variazione di ΔTm = 1.3 °C in 2.7 km, seguita da una lenta ma costante discesa della temperatura fino a Cornigliano, allo sbocco del Polcevera. Da qui una variazione di ΔTm max = 0.3 °C in 4.3 km, (da1 punto 16 al punto 22) fino a Sampierdarena. Il centro cittadino, in particolare la zona del Porto Antico (24), riparato dal monte Sperone, presenta valori termici simili a quelli di Pegli. Alla foce del Bisagno (26) si ha un raffreddamento che qui raggiunge il valore massimo di tutto il percorso costiero. Oltre, fino a Priaruggia (33), si costata un generale livellamento verso il basso dei valori (variazione di ΔTm max = 0.5 °C in 5.7 km (da (26) a (33)). Avvicinandosi a Nervi la costa diventa ben protetta, a fronte dei venti settentrionali, dal bastione del monte Moro. Tra Priaruggia e la parte più orientale di Quinto (35) è stata registrata una differenza positiva del ΔTm di 2.8 °C in soli 1.9 km. La temperatura poi si mantiene costante fino a Sant’Ilario (38); in seguito subisce una lieve diminuzione, per stabilizzarsi fino a Bogliasco (41). Nella situazione 2 il ponente cittadino è caratterizzato da una sensibile differenza tra le aree riparate dai rilievi e quelle situate allo sbocco delle vallate. La variazione di ΔTm tra Pegli (11) e il ponte sul Polcevera (19) è = -3.1 °C in 6.4 km. La temperatura quindi risale rapidamente per raggiungere il terzo massimo, dopo Pegli e Vesima, in corrispondenza della Stazione Marittima (23), nel centro città. Appare invece molto uniforme, a differenza della situazione 1, la distribuzione termica tra la zona Foce (25) e Bogliasco (41), variazione max di ΔTm = 0.7 °C in 12.9 km, con lievi picchi negativi in corrispondenza dello sbocco delle valli minori: valle del torrente Sturla (31), del rio Castagna (34) e del torrente Nervi (37). In conclusione, lungo tutto il percorso costiero, l’influenza dell’isola di calore urbana risulta poco evidente poiché sembra avere preminenza, sul campo termico, l’influenza della posizione geografica. 3.2 Percorso B - Valle del Polcevera (Fig. 3) Il valore di ΔTm lungo la Val Polcevera, nella situazione 1, è decrescente in maniera abbastanza uniforme con una variazione totale piuttosto limitata. Dal ponte di Cornigliano (1) al confine tra il comune di Genova e il comune di Mignanego (19), per una distanza di 12.9 km, si è riscontrata una variazione di ΔTm = -1.1 °C. La curva che rappresenta la situazione 2 mostra al contrario una grande differenza termica tra la costa e l’interno, accresciuta anche dal fatto che il tasso di urbanizzazione è minore: variazione totale di ΔTm = -4.0 °C. La diminuzione è rapida fino al rio Fegino (5), più lenta dopo. La temperatura molto bassa al punto misura estremo è dovuto probabilmente alla presenza di brezze locali. 3.3 Percorso C - Valle del Bisagno (Fig. 4) La curva termica, nella situazione 1, presenta un andamento più complesso rispetto a quello rilevato nella Val Polcevera. Nel percorso tra la stazione ferroviaria di Brignole (3) e l’abitato di Struppa (14) si è rilevata una variazione massima di ΔTm = 1.5 °C. La diminuzione della temperatura in corrispondenza del Giro del Fullo (12) è verosimilmente dovuta al cambiamento di orientamento che assume la valle in quel punto, prima nord-sud, poi repentinamente est-ovest. La successiva caduta della temperatura dipende anche dal fatto che l’ambiente non è più urbanizzato. Il grafico che rappresenta la situazione 2 evidenzia una più regolare diminuzione della temperatura via via che ci si inoltra nell’interno della valle: variazione di ΔTm max = -4.5 °C lungo i 14.5 km di percorso, corrispondenti a un gradiente di -0.3 °C ogni km, valore analogo a quello riscontrato in Val Polcevera. Una significativa variazione di pendenza della curva si riscontra subito a nord del cimitero di Staglieno (7), dove l’urbanizzazione ha minore impatto. 4. Conclusione E’ evidente che questa prima indagine sulla distribuzione spaziale della temperatura nella città di Genova necessita un approfondimento con ulteriori campagne sul campo, in diversi periodi dell’anno. Dai primi risultati, si può sostenere che l’isola di calore urbana a Genova sia mascherata dall’effetto della complessa orografia locale e dalla diversa distanza dal mare delle varie zone oggetto dello studio, potendosi evidenziare, seppur in forma attenuata, forse solo lungo le due valli principali. Bibliografia CARREGA P., 1996; Les spécificités de l'îlot de chaleur urbain à Nice, Côte d'Azur, Nimbus. GIUFFRIDA A., 2001; Effetti dell’urbanizzazione sul clima di una regione e temperatura di effetto, Rivista di Meteorologia Aeronautica GRILLINI B., 1987; Milano: un’esperienza sul limite dell’isola di calore urbana, Rivista di Meteorologia Aeronautica MELHUISH E., PEDDER M., 1998; Observing an urban heat island by bicycle, Weather. UPMANIS H., ELIASSON I., LINDQVIST S., 1998; The influence of green areas on nocturnal temperatures in a high latitude city, International Journal of Climatology. ZANELLA G., 1976; Il clima di Parma, Rivista di Meteorologia
Aeronautica |