|
 LA COP-21 E
L'ACCORDO DI PARIGI:
LA COP-21 E
L'ACCORDO DI PARIGI:
UN MODESTO PUNTO DI PARTENZA
PER LA DECARBONIZZAZIONE,
SERVIRANNO MAGGIORI IMPEGNI
15.12.2015
SMI - Redazione Nimbus
Sabato 12 dicembre 2015
l'attesissima Cop-21, conferenza delle Nazioni Unite per la definizione
di un più ambizioso ed efficace percorso di riduzione delle emissioni di
gas serra dopo il termine del secondo mandato del Protocollo di Kyoto
nel 2020, si è conclusa con l'approvazione dell'Accordo di Parigi
all'unanimità da parte dei delegati di 195 Paesi.
Che cosa prevede
l'Accordo di Parigi?
L'Accordo punta al cruciale obiettivo di mantenere ben al di sotto
dei 2 °C il riscaldamento atmosferico rispetto all'era
preindustriale entro il 2100, possibilmente anche a 1,5 °C,
tramite la messa in pratica (tuttavia non legalmente vincolante, né
ancora sufficiente) dei piani nazionali volontari di
riduzione delle emissioni di gas serra (INDC = Intended Nationally
Determined Contributions) presentati finora da 187 Paesi (l'Unione
Europea si è presentata in maniera compatta con una promessa di
diminuzione del 40% dei gas climalteranti entro il 2030).
Pur senza specificare obiettivi di riduzione a più lungo
termine, l'Accordo parla di
neutralità delle emissioni nella seconda
metà del secolo (bilancio tra le residue emissioni antropiche e il
loro assorbimento in "pozzi" naturali di carbonio come suoli e foreste,
o il loro "sequestro" tramite tecnologie tuttavia almeno
per ora di dubbia efficacia).
Il raggiungimento dei risultati e l'implementazione degli impegni
saranno soggetti a verifica ogni 5 anni a partire dal 2023 ("Global
Stocktake") in
occasione delle Conferenze delle Parti.

12
dicembre 2015, al Parc des Espositions di Paris - Le Bourget si esulta all'accettazione dell'Accordo di Parigi da parte
di tutti i 195 Paesi intervenuti alla Cop-21. Da sinistra, Christiana
Figueres (Segretaria UNFCCC), Ban Ki-moon (Segretario Generale Nazioni
Unite), Laurent Fabius (Ministro degli Esteri del governo francese e
Presidente della
Cop-21) e François Hollande (Presidente della Repubblica francese).
Fonte: UN News Centre.
Altri aspetti importanti dell'Accordo riguardano:
- Responsabilità climatica: nel testo si differenzia il livello
di impegno richiesto o auspicato per ogni Paese in base alla propria
situazione economica, tecnologica e sociale, e al ruolo finora avuto nel
produrre emissioni serra. I termini “devono”, “dovrebbero”
e “possono” sono stati utilizzati, rispettivamente, per i paesi
sviluppati, quelli emergenti e quelli molto poveri e/o particolarmente
vulnerabili.
- Finanza climatica e trasferimento tecnologico: costituzione
(non legalmente vincolante) di un fondo di 100 miliardi di dollari
all'anno a partire dal 2020 da parte dei Paesi sviluppati (con
finanziamenti anche dal settore privato) per aiutare quelli emergenti
nell'adattamento ai cambiamenti climatici e nel raggiungimento della
neutralità delle emissioni, anche tramite l'introduzione di tecnologie
ad elevata efficienza energetica.
Le ratifiche da parte dei singoli Stati saranno aperte
il 22 aprile 2016 (Giornata Mondiale della Terra), e l'Accordo diverrà operativo dal 2020, ma solo se
questo verrà siglato da 55 Paesi responsabili complessivamente di almeno
il 55% delle emissioni globali.
E' un trattato
soddisfacente?
Buon risultato diplomatico, ma sul piano della fisica del clima non
basta
Non è stato facile mettere d'accordo 195 Paesi del mondo, responsabili
pressoché della totalità delle emissioni, dagli Stati Uniti,
alla Cina, ai piccoli stati insulari del Pacifico... su temi così
delicati, dunque, come hanno ricordato il segretario UN Ban Ki-moon e il
premier francese François Hollande, si tratta certamente di un
accordo di portata storica nel percorso dei negoziati sulla lotta ai
cambiamenti climatici, il primo ad essere universale (il
Protocollo di Kyoto escludeva i Paesi emergenti e quelli più poveri), e
molto probabilmente - almeno sotto il profilo negoziale - non si poteva
ottenere di più.
Inoltre la firma dell'accordo
riconosce senza mezzi termini l'esistenza e la gravità del problema
climatico da parte di tutti i governi, mettendo fine a tutte le
dispute negazioniste.
Tuttavia ancora non è sufficiente a raggiungere gli obiettivi
stabiliti e a metterci al sicuro dalle conseguenze più gravi dei
cambiamenti climatici.
Si stima infatti che l'applicazione
degli INDC possa "limitare" il riscaldamento globale al 2100 a 2,7 °C,
anziché a ben meno di 2 °C, per cui ulteriori e più ambiziose
riduzioni delle emissioni saranno indispensabili in futuro per
centrare l'obiettivo, come peraltro specificato nell'Art. 3
dell'Accordo.
Ricordiamo infatti che un incremento termico di 2,7 °C comporterebbe
pur sempre significative destabilizzazioni a lungo termine del clima
e degli ecosistemi terrestri, con totale scomparsa della banchisa
artica, collasso di almeno una parte delle calotte di Antartide e
Groenlandia con aumento dei livelli marini superiore al metro a scala
plurisecolare (e allagamento di pianure costiere oggi abitate da oltre
100 milioni di persone), aumento degli eventi atmosferici estremi, calo
di produttività agricola specialmente nelle regioni calde, maggiore
diffusione di malattie tropicali, crisi sanitarie dovute a ondate di
caldo e carestie, crescenti migrazioni umane.
Inoltre il carattere non vincolante dei "compiti" di ciascuna nazione
lascia dei dubbi sull'effettiva applicazione dei tagli alle emissioni...
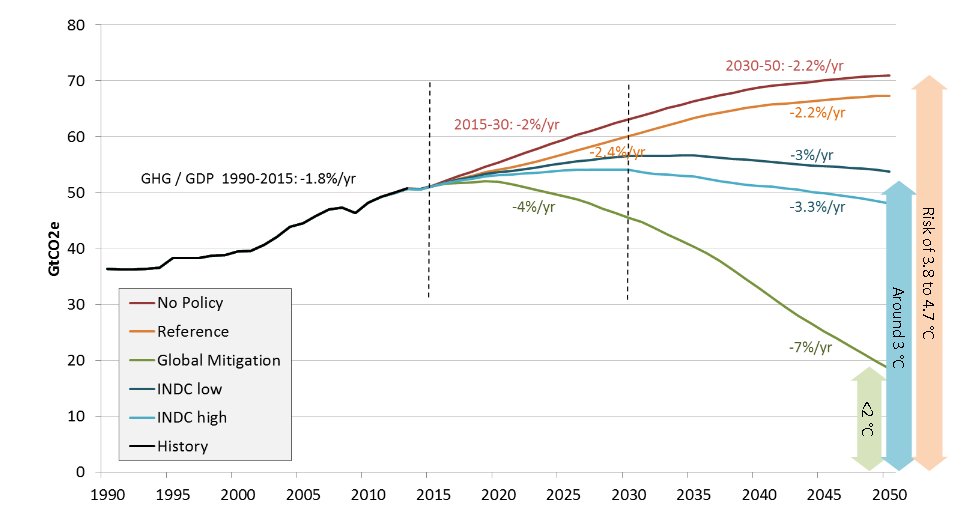
Le simulazioni
indicano che l'applicazione degli INDC (Intended Nationally
Determined Contributions) attualmente presentati dai singoli Paesi
per le riduzioni dei gas serra non sarebbe ancora sufficiente a
raggiungere l'obiettivo di mantenere il riscaldamento al 2100 sotto i 2
°C rispetto all'era preindustriale, concorrendo a uno scenario di poco
inferiore a 3 °C, per cui ulteriori tagli alle emissioni saranno da
pianificare in futuro. Fonte:
"Analysis of scenarios integrating the INDCs" (Joint
Research Centre-EC).
Aspre critiche sono infatti giunte anche dal mondo
scientifico, ad esempio dall'autorevole climatologo ex-NASA e attivista
James Hansen, che
sulle pagine del "Guardian" ha definito i negoziati di Parigi una
"frode", e sottolinea come l'unico modo per tagliare efficacemente e
rapidamente le emissioni serra sia introdurre tasse sulla produzione di
gas climalteranti.
Tuttavia, per lo meno la volontà di porre mano al problema in modo
concreto ora sembra esserci, e la strada verso la decarbonizzazione
entro questo secolo pare imboccata. Ciò non toglie che gli aumenti
termici comunque ormai inevitabili causeranno importanti impatti
sull'ecosistema e sulla società, ragione che rende prioritaria anche una
strategia di adattamento.
D'altra parte, se da un lato è vero che la responsabilità di costruire
le basi politiche e legali un radicale cambiamento spetta ai governi,
tocca poi ai singoli cittadini desiderarlo davvero e applicarlo nella
vita quotidiana: infatti con le nostre scelte - dalla riduzione
degli sprechi e dei rifiuti, ai trasporti, all'uso dell'energia... -
possiamo iniziare a cambiare il mondo fin da subito, anche senza
aspettare l'applicazione dell'Accordo di Parigi!
Vedremo... intanto il prossimo appuntamento è per il 7-18 novembre 2016
alla Cop-22 di Marrakesh (Marocco).
Per maggiori dettagli:
Sito ufficiale della
Cop-21
La Cop-21 in cifre
Sito dell'United
Nations Framework on Climate Change Convention (UNFCCC)
Link al
testo integrale dell'Accordo
«Bollettino» della COP21 di
Italian Climate Network
Leggi un
commento di Luca Mercalli
Ulteriori riflessioni su
Qualenergia.it
Le «Conferenze delle Parti»: FAQ

|