|
COP-21: CHIAMATA ALLE "ARMI"
(DEL DIRITTO) PER SALVARE IL CLIMA
12.01.2016
di Roberto Louvin
Professore associato di Diritto pubblico comparato
Presidente dell’International University College di Torino
1. La Cop-21 e l’Accordo di Parigi
La
Cop-21 di Parigi sui cambiamenti climatici del dicembre 2015 è stato
un evento di portata planetaria, inserito in un lungo percorso di
coinvolgimento internazionale sui temi del clima. Il nome Cop-21 ci
ricorda infatti che si è trattato della ventunesima sessione annuale
della Conferenza delle parti prevista dalla
Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), prodotta e
sottoscritta nel 1992 nel corso del Summit della Terra di Rio de Janeiro
del 1992. Il documento finale elaborato nella capitale francese si
innesta quindi sul tronco di questa Convenzione, prendendo le mosse
dalla constatazione dell’aggravamento del riscaldamento globale per
effetto delle emissioni dei gas serra e dalla conseguente necessità di
ridurre urgentemente tali emissioni.


Durante la
Cop-21 di Parigi, parallelamente ai negoziati ufficiali, appositi spazi
sono stati istituiti per coinvolgere nel dibattito un più vasto pubblico
di osservatori e organizzazioni non governative. Qui sopra, attivisti di
ONG di fronte alle sale delle riunioni plenarie, e François Hollande
incontra i giovani agli "Espaces Générations Climat". Fonte:
Cop-21 Flickr Albums.
L'ambizione della Conferenza sarebbe
stata di concludere, vent’anni dopo l’inizio del negoziato avviato dalle
Nazioni Unite, un accordo di carattere universale sul clima con
carattere vincolante per tutte le nazioni. Il testo finale di questo
accordo, approvato per consenso dai rappresentanti dei 196 paesi
partecipanti, diventerà giuridicamente vincolante dopo la firma
dell’accordo che avrà luogo a New York tra l’aprile del 2016 e l’aprile
del 2017, a condizione che sia ratificato da almeno 55 paesi
che rappresentino insieme oltre il 55 per cento delle emissioni globali
di gas serra. Naturalmente, sarà anche necessario che ciascun paese dia
attuazione all’Accordo per mezzo dei necessari atti di ratifica e di
adesione.
L’attenzione dell’opinione pubblica internazionale e degli esperti si è
concentrata, durante la Conferenza, sulla definizione quantitativa
dell’obiettivo di limitazione del riscaldamento globale, con l’impegno
esplicito (art. 2, c. 1 dell’Accordo) a rafforzare la risposta mondiale
alla minaccia di cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo
sostenibile e della lotta contro la povertà, in particolare “limitando
l’aumento della temperatura media del pianeta nettamente al di sotto
di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l’azione
condotta per limitare l’aumento delle temperature a 1,5 °C rispetto ai
livelli preindustriali”.
L’Accordo di Parigi è stato definito "ambizioso ed equilibrato" e
potrebbe effettivamente costituire una svolta epocale; è però necessario
che la mobilitazione intorno a questi obiettivi sia conseguente e che
gli impegni si traducano in precetti effettivamente vincolanti. Per
questo è necessario che, a sostegno dell’azione collettiva, il
diritto faccia la sua parte nel trasformare un wishful thinking o
un impegno morale in una vera e propria regola di condotta, assistita
dalle necessarie garanzie di effettività.
2. Gli effetti sul piano normativo
Stando al testo dell’accordo, ogni paese che lo ratifica fisserà
autonomamente un obiettivo di riduzione delle emissioni, secondo un
quantitativo rimesso alla sua libera decisione da comunicare e
attualizzare periodicamente, traducendolo quindi in misure attuative
interne (art. 4, c. 2). La responsabilità degli Stati si limita,
sostanzialmente, al dovere di rendere conto del loro contributo
nazionale all’azione globale (art. 4, c. 13), nel quadro di una sorta di
generale ‘contabilità’ delle emissioni e degli assorbimenti antropici
relativi ai rispettivi contributi nazionali, per promuovere
“l’integrità ambientale, la trasparenza, l’esattezza, l’esaustività, la
comparabilità e la coerenza” di tale contabilità. Nessuna
conseguenza diretta è peraltro prevista per la violazione degli obblighi
di comunicazione, malgrado ciascuna delle parti risulti essere
ufficialmente “responsabile del livello di emissioni indicato
dell’accordo”.
Malgrado l’enfasi con cui è stato presentato, l’accordo non sembra
quindi avere carattere realmente e direttamente cogente nei confronti
delle parti, non essendo accompagnato da meccanismi autenticamente
sanzionatori e coercitivi nei confronti dei soggetti inadempienti. È
stato evidente, in questo, l’intento strategico di non castigare, né
economicamente né in altro modo, gli Stati inadempienti, ma di fare
piuttosto leva sul loro senso di responsabilità. Sotto questo
aspetto, l’Accordo appare addirittura più debole del protocollo di Kyoto
che prevedeva, a fronte della mancata riduzione delle emissioni, un
aggravio degli obiettivi da raggiungere, la temporanea sospensione del
diritto di prendere parte al cosiddetto emissions trading e
l’avvio di una procedura di infrazione.
I negoziatori di Parigi hanno probabilmente voluto evitare di incorrere
in procedure che in passato si sono rivelate sostanzialmente inefficaci,
o comunque tali da provocare ostacoli alla ratifica dell’intesa
raggiunta. Questo non implica però che il testo adottato non abbia di
per sé un carattere giuridicamente vincolante. L’accordo di Parigi è
infatti un protocollo addizionale ad una convenzione-quadro dell’ONU, e
quindi di un vero e proprio trattato internazionale, e non una semplice
‘dichiarazione’ o ‘risoluzione’: non è puramente soft law e si
fonda sulla
Piattaforma di Durban per un’azione rinforzata dotata di effettiva
forza giuridica. Solo per motivi puramente tattici è stato omesso l’uso
del termine ‘trattato’, permettendo così ad alcuni Paesi, alle prese con
evidenti difficoltà interne, di evitare le forche caudine della
sottoposizione al voto dei propri organi parlamentari (come nel caso del
Congresso degli Stati Uniti, che potrà essere bypassato, nei termini
previsti dal diritto costituzionale statunitense, seguendo la procedura
dell’executive agreement presidenziale) o della sottoposizione a
consultazione popolare (prevista ad esempio in via eventuale in
Svizzera). Come ogni trattato, l’Accordo deve essere eseguito e
interpretato secondo il principio di buona fede su cui si regge il
vincolo pattizio, in base agli artt. 26 e 31 della Convenzione di Vienna
del 1969 sul diritto dei trattati.
In un gioco semantico sottile che distingue “shall” da “should”,
sono stati definiti obblighi di varia intensità: l’impegno concreto e
quantificato di ridurre le emissioni non ha di per sé valore cogente,
mentre ce l’ha l’obbligo generale di porre in essere una riduzione e di
rivederne l’entità ogni cinque anni, in modo da elevarla
progressivamente sotto la vigilanza di un comitato internazionale di
esperti che svolge l’opera di monitoraggio, notifica e verifica (MRV)
nei confronti di tutti i Paesi.
La scommessa è dunque che la trasparenza, la fiducia reciproca e il
dialogo consentano di arrivare là dove i meccanismi sanzionatori di
Kyoto hanno dimostrato di non poter operare efficacemente: la regola
implicita è, dunque, essenzialmente quella di “name and shame”,
per cui il fatto che sia resa pubblica l’inadempienza e la conseguente
perdita di buona reputazione sul piano internazionale operano come
deterrenti nei confronti del Paese inadempiente. Punto cruciale
dell’Accordo resta comunque l’effettività della sottoposizione di
tutti i Paesi – e non solo di quelli più sviluppati, com’era previsto
dal Protocollo di Kyoto – ad un regime di severo controllo e di piena
trasparenza.
3. Un impegno per i giuristi: non solo commentare...
La lotta per evitare catastrofici cambiamenti climatici non coinvolge
solo gli scienziati, la politica e il mondo dell’economia. Gli operatori
del diritto hanno una loro funzione decisiva nel progettare metodi
efficienti di regolazione delle condotte pubbliche e private che
influiscano positivamente su questi processi.
Se in Italia la mobilitazione dei giuristi è ancora modesta, lo stesso
non si può dire della Francia che ha ospitato la Cop-21 e dove si sono
avviate iniziative significative. Anche senza esaminarle in estremo
dettaglio, è utile darne conto in maniera sufficientemente estesa perché
possono essere di grande utilità per una mobilitazione pubblica efficace
a sostegno dell’azione dei governi. Si deve infatti tenere presente che
la dinamica prodotta da eventi come quello di Parigi può prolungarsi
allargandosi attraverso processi ulteriori e distinti, sia sul piano
internazionale (tanto per mezzo di nuove iniziative pattizie sul piano
ufficiale, quanto attraverso l’azione delle ONG) che nazionale (con
preamboli o emendamenti costituzionali, mediante interventi di legge o
come principio ispiratore di nuova dottrina o di nuova giurisprudenza).
È inoltre probabile che un’influenza decisiva possa essere esercitata
dalla mobilitazione dei soggetti locali o globali che si battono per
la difesa dell’ambiente; anche all’interno di essi o in sintonia con
il loro operato si può dispiegare con successo l’azione di giuristi
impegnati come soggetti partecipi della costruzione di un sistema
economico e relazionale più rispettoso del contesto ambientale.
4. La ‘Missione Lepage’
La prima iniziativa messa in campo dalla dottrina del diritto si è
sviluppata nell’ambito della cosiddetta Missione Lepage ed è
stata affidata dal Presidente Hollande nel giugno del 2015 a Corinne
Lepage, ex Ministro dell’Ambiente, giurista e avvocato specializzato in
diritto dell’ambiente, al fine di fare il punto sulle iniziative in
corso a livello internazionale e predisporre una proposta di
“dichiarazione dei diritti dell’Umanità” da proporre in occasione
della Conferenza di Parigi (1).

25 settembre 2015: il team della giurista Corinne Lepage (al centro), ex
Ministro dell'Ambiente francese (1995-1997) durante la presentazione
all'Eliseo della proposta di
dichiarazione dei diritti dell'umanità in relazione alle sfide
ambientali.
Fonte:
https://twitter.com/corinnelepage.
Benché non manchino patti
significativi a livello internazionale in materia ambientale, come la
Dichiarazione di Stoccolma del 1972, la Carta mondiale della Natura del
1982 e la Dichiarazione di Rio del 1992, la proposta di una
Dichiarazione dei diritti dell’umanità relativa alla conservazione del
pianeta contiene elementi di ulteriore novità e potrebbe diventare un
pilastro decisivo della governance ambientale, ma solo a condizione che
le venga attribuita una reale forza cogente. Si tratta, infatti, di
superare la portata puramente politica, simbolica o retorica, per
mettere decisamente l’accento sul versante della garanzia dei diritti e
sulla valenza giuridica obbligatoria. Il
Rapporto Lepage, redatto da un nutrito gruppo di giuristi e
rappresentanti di ONG, contiene, intanto, numerose e interessanti
proposte in questa direzione.
Il diritto all’informazione ambientale, in primo luogo, sembra
dover essere spinto ben oltre i contenuti essenziali della
Convenzione di Aarhus, prevedendo l’obbligo per tutte le autorità
pubbliche di una piena informazione in materia ambientale e sanitaria e
mettendo online gratuitamente tutte le informazioni disponibili. La
creazione di un’autorità amministrativa indipendente (sul modello di una
Haute autorité de l'expertise), con il compito di generale verifica
dell’attendibilità degli allarmi ambientali e climatici ricevuti anche
confidenzialmente e di controllo di affidabilità delle certificazioni
rese dagli esperti (expertises), dovrebbe confortare l’attendibilità
delle informazioni, che andrebbe supportata anche attraverso la
pubblicazione dei verbali delle commissioni tecniche di settore e delle
opinioni di minoranza espresse in quella sede. Il punto è delicato ed ha
implicazioni rilevantissime.
Utilissimo e meno problematico appare a questo proposito l’invito a
proteggere giuridicamente coloro che segnalano pubblicamente e
responsabilmente un pericolo ambientale, vietando quindi nei loro
confronti misure sanzionatorie dirette o indirette in tutte le
situazioni in cui si opera in buona fede. In parallelo, si ritiene di
dover estendere in termini generali la libertà di espressione in materia
di tutela del sistema ecologico, formalizzando anche un vero e proprio
‘dovere’ di lanciare, in caso di probabile pericolo, l’allarme
all’interno di imprese e di istituzioni pubbliche. Ci sono, in questo
caso, forti analogie con le strategie che si stanno ormai diffondendo in
molti Paesi occidentali nella lotta contro la corruzione, tutelando i
cosiddetti whistleblowers (o gole profonde), ossia coloro che
segnalano alle autorità fatti corruttivi, denunciando pubblicamente
azioni illecite all’interno di enti pubblici o privati, e che rischiano
per questo in mancanza di un’adeguata copertura normativa di subire
pratiche di vessazione o emarginazione.
Il versante dell’informazione del cittadino-consumatore potrebbe essere
rafforzato anche con misure di carattere penale, per contrastare
informazioni incomplete o non veritiere, e con il rafforzamento dei
meccanismi di garanzia della deontologia informativa degli operatori
della comunicazione.
L’approfondimento delle conoscenze in materia di rischi ambientali deve
potersi avvalere di strumenti collaborativi nuovi e rafforzati fra
Università, ONG, enti pubblici e imprese, attraverso schemi
innovativi di “programma di ricerca cooperativa” e con il
riconoscimento, per i soggetti che agiscono a tutela di lavoratori,
utenti o consumatori, del diritto di chiedere anche senza particolari
costi, perizie ambientali da parte di esperti indipendenti o anche di
poter avviare procedure di perizia pubblica, aperta e pluralista.
Sul fronte della responsabilità penale, il Rapporto Lepage sottolinea
poi l’importanza di una corretta declinazione dei delitti specifici
di danno ambientale, categoria che nell’ordinamento italiano è stata
di recente oggetto di un ampio rimaneggiamento con la riforma dei reati
ambientali disposta dalla l. n. 68 del 2015 e l’introduzione dei nuovi
delitti di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro
ambientale (art. 452-quater c.p.), traffico e abbandono di materiale ad
alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), impedimento del controllo
(articolo 452-septies c.p.) e omessa bonifica, (art. 452-terdecies c.p.).
Accanto alle misure di carattere penale, risultano essenziali anche
interventi aggiuntivi di rafforzamento dei principi di responsabilità
civile per danno all’ambiente, in particolare precisando la
responsabilità delle società madri per i fatti commessi dalle loro
filiali, definendo meglio le condizioni di sussistenza della turbativa
ambientale, fissando criteri oggettivi per la quantificazione dei danni
e puntualizzando meglio la distinzione degli ambiti tra le situazioni in
cui è sufficiente una copertura assicurativa e i casi in cui il
principio di precauzione è invece chiamato ad operare in maniera più
stringente imponendo la rinuncia a determinate attività.
Un ulteriore versante di intervento dovrebbe riguardare i criteri di
accesso alla giustizia (ossia la titolarità di diritti di azione o di
intervento in materia ambientale), i meccanismi di prova e la
riparazione dei torti, per consentire una più agevole costituzione di
parte civile da parte degli enti locali, il più agevole esercizio delle
azioni collettive e l’introduzione di meccanismi innovativi di
mediazione ambientale, ambito quest’ultimo ancora scarsamente esplorato
e che dovrebbe consentire con modesto dispendio di tempo e di denaro di
favorire le dispute sui temi ambientali per mezzo di un procedimento
informale facilitato da esperti neutrali.
In materia giudiziale, si deve però ricordare che nella maggior parte
degli Stati l’esistenza di un danno ambientale si configura solo in
presenza di un danno concreto ed immediato alle persone, con la
conseguenza che la tutela dell’ecosistema nel suo complesso risulta
significativamente ristretta. A questo tema sono già particolarmente
attenti alcuni Paesi latino-americani come la Bolivia e l’Ecuador, che
negli ultimi anni hanno già dato concretezza sul piano costituzionale e
legislativo a questo profilo, ricollegandosi alle loro tradizioni
spirituali ancestrali e riconoscendo sul piano tecnico-giuridico
l’autonomia dei diritti della natura e il dovere di preservare
l’integrità della Madre Terra o Pachamama. Caso emblematico di
questa tendenza è la Ley de Derechos de la Madre Tierra boliviana del 21
dicembre 2010 con cui sono stati riconosciuti all’ambiente e all’intero
ecosistema - dichiarato sacro in quanto “sistema vivente dinamico”
- diritti del tutto simili ai diritti degli umani. È il progresso di una
concezione nuova del diritto, che fa emergere una soggettività
giuridica autonoma dell’ambiente, come da anni suggerisce una parte
molto sensibile della dottrina: valga per tutti, come antesignana di
questo orientamento che farebbe sicuramente fare un passo avanti
decisivo all’intera civiltà umana, l’appassionata difesa lanciata già
nel 1973 da Christopher Stone nel suo celebre saggio Should Trees
Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Object.
5. Il club dei giuristi
La seconda iniziativa di grande pregio promossa in campo giuridico a
sostegno della dinamica della Conferenza di Parigi ha avuto come
protagonista, nel novembre del 2015, la Commissione Ambiente del Club
des juristes coordinato dall’avvocato parigino Yann Aguila, che
ha riunito universitari, avvocati e magistrati intorno alla comune
aspirazione di pensare al futuro diritto dell’ambiente. In un
rapporto pubblico dal titolo
“Rafforzare l’efficacia del diritto dell’ambiente. Doveri degli
Stati, diritti degli individui” sono condensate 21 proposte
al servizio della giustizia ambientale nel ventunesimo secolo.
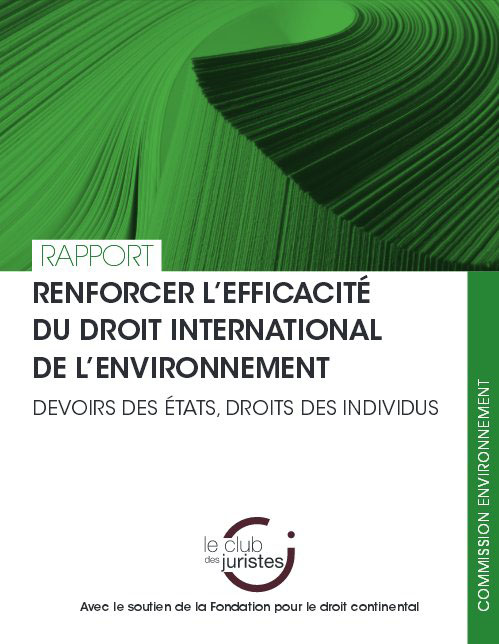
Per affrontare la lotta ai cambiamenti climatici servono nuovi e
migliori strumenti giuridici internazionali, oltre a quelli tecnologici,
culturali ed educativi: diverse proposte sono contenute nel rapporto
“Rafforzare l’efficacia del diritto dell’ambiente. Doveri degli Stati,
diritti degli individui”, redatto in vista della Cop-21 dalla
Commissione Ambiente del
"Club des
juristes".
Partendo dalla
considerazione della necessità, ma anche della scarsa efficacia,
dell’attuale diritto internazionale all’ambiente, il rapporto del
Club des juristes indica realisticamente nella società civile
l’unico vero contrappeso rispetto all’apparente onnipotenza normativa
statale nel contrasto agli squilibri climatici e punta quindi
decisamente alla stesura di una Carta universale dell’ambiente
collegata, per la sua attuazione, a uno strumento applicativo dotato di
efficacia vincolante per i giudici tanto internazionali quanto
nazionali. Un documento di questa natura è sicuramente opportuno e
porterebbe al superamento, attraverso un’opera di sintesi, della
dispersione che si registra oggi in materia di accordi su temi ecologici
e che ha portato a sottoscrivere negli ultimi trent’anni circa
cinquecento diversi trattati di carattere generale riguardanti, in
maniera più o meno diretta, l’ambiente. È qui in gioco non solo
l’accessibilità, ma la stessa efficacia delle norme ambientali
internazionali: un’opera di censimento e di razionalizzazione delle
fonti attuali è certamente indispensabile.
La consacrazione e l’amplificazione dell’influenza che può esercitare la
società civile sull’agenda in materia di tutela dell’ecosistema passa,
secondo questi giuristi, attraverso il riconoscimento di un diritto
d’iniziativa civica nel quadro delle Nazioni Unite, forgiato
sull’esempio del meccanismo di diritto d'iniziativa dei cittadini
europei già operante nell’Unione europea (in base all’art. 11, par. 4
del Trattato sull’Unione europea) e che consente ad un milione di
cittadini europei di partecipare all’elaborazione delle politiche
dell'Unione, sollecitando la Commissione europea a presentare una
proposta legislativa sul tema indicato. Si suggerisce, inoltre, di
riconoscere i diritti di petizione universale e di partecipazione
civica ai negoziati ambientali, fornendo tali iniziative di una
concreta ed autonoma funzione progettuale e di proposta e rendendo
trasparenti i criteri di accreditamento delle ONG. A queste ultime si
propone di consacrare un’apposita convenzione-quadro per favorire il
ruolo e rafforzarne l’autorevolezza nel contesto di questi meccanismi
partecipativi. Da questo punto di vista, l’esperienza di Parigi nel 2015
è comunque stata assolutamente esemplare: sono, infatti, stati
istituiti appositi spazi, accessibili ad un largo pubblico, per
l’espressione dell’opinione degli organismi non governativi sullo
sconvolgimento climatico, in parallelo con l’attività dei negoziatori e
degli osservatori ufficiali.
Il Club des juristes insiste molto sulle garanzie
giurisdizionali, invitando ad estendere le procedure di constatazione
del non rispetto (non-compliance procedures), la pubblicazione,
come meccanismo istituzionale regolare, di rapporti pubblici periodici
sul seguito dell’Accordo e l’individuazione di dispositivi specifici di
assistenza per fare fronte ai casi di inadempimento. Il
coinvolgimento della società civile, oltre che all’adozione
dell’Accordo, potrebbe così estendersi anche ai meccanismi di controllo,
con specifici diritti di informazione e di sorveglianza anche nei
confronti dei Comitati previsti dall’Accordo e purtroppo non ancora
dotati di adeguati mezzi finanziari.
L’analisi contenuta nel documento mette anche l’accento sull’assenza di
giurisdizioni internazionali specializzate nel campo dell’ambiente e
sull’attuale scarsa incisività della stessa Corte internazionale di
Giustizia dell’Aia, di cui alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, la Cina e
la stessa Francia, non accettano peraltro nemmeno la giurisdizione. È,
comunque, in questa direzione, oltre che nel senso auspicabile di creare
un apposito organo internazionale di giustizia ambientale, che guardano
questi giuristi, chiedendo per il momento uno specifico diritto di
azione e di intervento in giudizio in capo almeno ad alcuni soggetti non
governativi e la predisposizione di appositi elenchi di esperti e di ONG
indipendenti per svolgere funzioni consultive rispetto a queste
giurisdizioni. Tutte queste proposte trovano conforto anche
nell’iniziativa avviata con la Carta di Bruxelles per la creazione di
una Corte Penale europea e internazionale per l’Ambiente e per la Salute,
per fare riconoscere i disastri ecologici come crimini contro l’umanità
(2).
Sul versante della giustizia interna, si sottolinea come i giudici
nazionali esitino ancora, in mancanza di riferimenti testuali, a
riconoscere come ricevibili le argomentazioni che si possono trarre dal
diritto internazionale. La violazione degli impegni assunti da un
determinato Paese in quella sede non sono ancora invocabili dalla
società civile se lo Stato stesso non riconosce esplicitamente un
‘effetto diretto’ nei confronti dei propri cittadini alle convenzioni e
ai trattati che sottoscrive. L’obiettivo sarebbe naturalmente centrato
con estrema facilità se fossero apposte clausole espresse di effetto
diretto da cui il giudice nazionale potrebbe trarre dal trattato
sottoscritto ispirazione e argomentazioni fondanti. Osservano
giustamente gli esperti di Parigi che, se fosse stata seguita una
strategia come questa, l’accordo di Parigi avrebbe potuto diventare per
la Dichiarazione di Rio uno strumento attuativo di eccezionale
importanza, come lo sono stati per la Dichiarazione universale dei
Diritti Umani, la Convenzione internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e
politici del 1966. Si sarebbe così formato un ‘trittico’ di
straordinaria importanza per l’intera umanità.
Non bisogna però farsi illusioni e su questo punto occorre una strategia
più complessa, visto che ovviamente ben pochi Stati sono disponibili a
sottostare a giurisdizioni esterne che ne colpiscano eventuali
inadempienze in tema di ambiente. Si deve perciò provare a fare leva sul
fatto che una parte del diritto internazionale già offre un fondamento
esplicito e invocabile a tutela dei diritti dell’uomo, per superare così
la dicotomia esistente fra diritto nazionale ed internazionale e
sostenere un’evoluzione in questo senso della giurisprudenza. La tutela
riservata ai diritti umani può diventare quindi una sorta di passerella
per collegare il diritto interno con quello internazionale.
6. Dodici proposte
Sotto il titolo
Le dérèglement climatique: un défi pour l’humanité, un
collettivo di giuristi capeggiato da Mireille Delmas-Marty e composto da
Luca d’Ambrosio, Caroline Devaux e Kathia Martin-Chenut ha avanzato,
nell’ottobre del 2015, alcune proposte per stimolare la riflessione
dei soggetti impegnati e mobilitati in vista di Cop-21 (3).
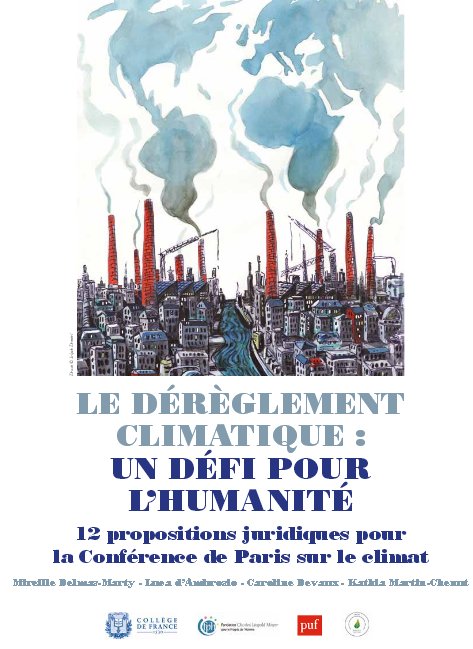
Ulteriori
proposte, riguardanti specialmente la responsabilità ambientale e i
nessi
tra protezione dell'ambiente e diritti umani, sono contenute nel
rapporto
"Le
dérèglement climatique: un défi pour l’humanité",
coordinato da Mireille Delmas-Marty.
Le proposte avanzate
riguardano molti aspetti finora scarsamente considerati e meritano di
essere esaminate in maniera dettagliata, soprattutto perché aprono la
mente a scenari di evidente interconnessione fra campi apparentemente
distanti fra loro.
Si parte dalla necessità allargare gli obiettivi comuni dei Paesi
convenuti in Francia per dibattere degli sconvolgimenti climatici, per
includervi tutti gli aspetti che contribuiscono all’adattamento delle
nostre società ai nuovi equilibri. Il collettivo propone, quindi, di
definire una griglia comune per la definizione dei singoli contributi
nazionali, perimetrando così in modo più omogeneo e secondo una
metodologia condivisa i contributi nazionali per l’attenuazione degli
effetti dei cambiamenti in atto e per l’adattamento al mutamento.
L’accettazione di una responsabilità equamente ripartita emerge
testualmente dal testo finale dell’accordo, precisata attraverso
l’indicazione secondo cui il “debito ecologico” ereditato dal passato
deve essere ripartito in modo equo (secondo un principio di
storicizzazione) e al tempo stesso oggettivamente accettabile (sulla
base di un principio di contestualizzazione).
Quanto alle garanzie di applicazione e controllo delle iniziative di
autoregolazione previste dall’Accordo, viene suggerita intelligentemente
dal collettivo l’istituzione di “punti di contatto nazionali” per
raccogliere le denunce della cittadinanza e dei soggetti organizzati.
Per dare efficacia a questa strategia la via possibile è quella di
estendere al campo ambientale le ‘Linee Guida destinate alle Imprese
Multinazionali’ adottate dalla riunione ministeriale dell’OCSE del 25
maggio 2011.
Un vero e proprio mix di misure di incitamento e di dissuasione è poi
indicato come opportuno, soprattutto per far assumere alle imprese una
vera e propria ‘responsabilità climatica’. L’ottica degli autori delle
12 proposte punta infatti a collegare più strettamente la qualità
dell’ambiente alla protezione dei diritti dell’uomo, attraverso la
fissazione in capo agli gli attori economici di un preciso obbligo di
evitare la causazione di impatti climatici in danno dei diritti tanto
degli individui quanto dei popoli indigeni. Sostenendo l’utilità di
adottare in questo senso uno specifico strumento giuridico, ci si
richiama soprattutto all’orientamento già assunto dall’ONU con la
propria Risoluzione del 25 giugno 2014 del Consiglio dei diritti
dell’Uomo per cercare di inquadrare in maniera più incisiva l’attività
delle imprese transnazionali nella cornice del diritto internazionale.
Riprendendo uno spunto già presente nel Rapporto Lepage, il collettivo
evidenzia la necessità di rafforzare la responsabilità delle società
madri come società capofila (indicate in francese con il termine
suggestivo e calzante di donneuses d’ordre) di imprese
transnazionali di dimensioni globali. È più che opportuno che siano
rafforzati gli obblighi di vigilanza in capo a questi soggetti quanto
mai ‘sfuggenti’ per metterli di fronte alle loro responsabilità: sul
piano tecnico, lo strumento suggerito a questo scopo è il ricorso al
criterio di ragionevole diligenza, o due diligence, da
incorporare nel sistema di gestione dei rischi d’impresa in senso ampio.
La tecnica per raggiungere l’obiettivo è resa esplicita dal punto 17
delle "Linee Guida destinate alle imprese multinazionali" emanate dall’OCSE
nel 2011 e prevede l’estensione della responsabilità a tutta la catena
decisionale dell’impresa transnazionale. All’approfondimento di questa
tematica, particolarmente complessa, del collegamento tra i diritti
fondamentali e l’azione dei soggetti economici internazionali
contribuisce utilmente un recente pregevole studio della Scuola
Superiore Sant’Anna dal titolo
Imprese e diritti umani: il caso Italia. Analisi del quadro normativo e
delle politiche di salvaguardia, condotto sotto la supervisione
dell’internazionalista Andrea de Guttry.
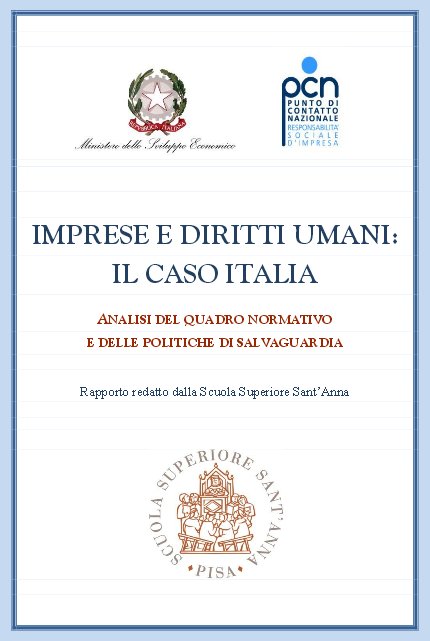
Un punto
fondamentale è la responsabilità delle imprese, alle quali si chiede di
superare le logiche capitalistiche di mera attenzione ai profitti,
includendo anche l'interesse sociale e ambientale nelle proprie
attività. Argomenti trattati in
"Imprese
e diritti umani: il caso Italia. Analisi del quadro normativo e delle
politiche di salvaguardia",
curato dall'internazionalista Andrea
de Guttry.
Il proposito di
‘curvare’ l’orientamento dei grandi attori economici globali in un senso
maggiormente sociale, ripensando la missione e la nozione di impresa,
è sicuramente fra gli intenti più ambiziosi suggeriti dal documento,
perché punta a superare gli effetti perversi del turbocapitalismo
finanziario e la sua logica esclusiva di massimizzazione dei
profitti, integrando nei suoi scopi anche l’interesse sociale. Sotto
questo profilo, il documento richiama alcune indicazioni altamente
innovative che sono state raccolte dal Groupe de réflexion
presieduto da Jacques Attali nel 2012 e sono contenute nel Rapporto
Pour une économie positive.
Strettamente connessa con la logica dell’allargamento sociale degli
scopi dei grandi players economici internazionali è l’ambiziosa
prospettiva di integrare quest’obiettivo negli accordi
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, come primo passo per
l’integrazione delle problematiche ambientali nel quadro dell’intero
diritto internazionale economico. La logica utilitaristica che ha
ispirato finora questo ordine giuridico, a cui gli Stati hanno
consentito di scaricare tutte le esternalità negative ambientali sulla
società senza sufficienti contrappesi, deve essere riportata entro
limiti ben più stretti, superando la perfetta autonomia finora concessa
all’ordine economico mondiale del mercato. Secondo la teoria della
giustizia distributiva prospettata da Michael Waltzer, il
rafforzamento delle clausole sociali dell’OMC è dunque un primo passo
necessario per riportare le logiche di profitto nell’ambito esclusivo
della sfera economica, impedendo loro di invadere le altre sfere di
valore, e in primis quelle della salute umana e dell’integrità
dell’ecosistema.
Il secondo passo in questa stessa direzione è dato dal
riposizionamento degli Stati al centro delle pratiche di arbitrato
internazionale in materia di investimenti. Si deve considerare che i
più massicci saccheggi ambientali, con conseguenze talvolta drammatiche
per l’ambiente e la salute, sono oggi resi possibili e garantiti da
regole internazionali di protezione degli investimenti stranieri che
marginalizzano le problematiche socio-ambientali, per garantire una
tutela pressoché esclusiva alla salvaguardia dei capitali investiti e
alle prospettiva della loro remunerazione. Recenti vicende messicane (il
caso Tecmed) e argentine (la vicenda Suez-Vivendi Universal) mettono in
chiarissima luce questo deleterio fenomeno, che tende a privare gli
Stati e le popolazioni di ogni possibile difesa giuridica. Lo scudo di
queste clausole arbitrali non deve continuare a operare a senso unico a
favore dei soggetti economicamente più forti, penalizzando lo stesso
ruolo di garanzia degli Stati sovrani.
A chiusura del cerchio, il collettivo guidato da Mireille Delmas-Marty
invita infine a concepire meccanismi nuovi di sorveglianza e
controllo nel quadro degli accordi commerciali che possano coinvolgere
direttamente la società civile, monitorando costantemente i loro
effetti sulle popolazioni locali e su quelle variazioni climatiche da
cui queste popolazioni sono investite in maniera spesso drammatica.
Alcuni piccoli passi avanti in questo senso sono stati fatti nell’ambito
dell’accordo di libero scambio fra Canada, Messico e Stati Uniti (ALENA)
e nell’accordo di libero scambio fra Unione Europea, Colombia e Perù,
intese peraltro fortemente contestate, come noto, dal fronte
altermondialista. È comunque soprattutto quest’ultimo documento che
contiene alcuni spunti interessanti sul piano tecnico circa i possibili
meccanismi di monitoraggio (art. 280), i punti di contatto o gruppi
nazionali in rappresentanza delle organizzazioni locali (art. 281) e il
dialogo almeno annuale con le organizzazioni della società civile e
l’opinione pubblica (art. 282). Queste strategie hanno al momento un
effetto molto limitato, essendo state poste in essere allo scopo
essenzialmente preventivo (in order to carry out a dialogue on
matters related to the implementation, come sottolinea l’accordo fra
UE, Colombia e Perù) di attutire possibili effetti deflagranti di eventi
come quelli che si verificarono a Cochabamba, con lo scoppio della
cosiddetta ‘guerra dell’acqua’, in seguito alla privatizzazione del
servizio idrico locale. Si tratta di un inizio, certamente, ma siamo
ancora lontani dal poter provocare riflessi immediati e consistenti nel
contenimento delle spinte estrattive dell’economia globalizzata.
7. Un cantiere aperto
Come si può vedere da questa ricostruzione sommaria delle principali
proposte avanzate dal mondo del diritto francese in concomitanza con
Cop-21, siamo appena ai primi vagiti di una colossale e necessaria
opera di riscrittura dell’ordinamento giuridico globale. Abbiamo
tentato di dare conto in maniera generale della portata del tema e di
alcune possibili strategie, ma è evidente che molte delle implicazioni
dell’Accordo di Parigi non hanno purtroppo nemmeno potuto essere
menzionate in questo scritto, come ad esempio quella, pur di capitale
importanza, della definizione giuridica del ‘rifugiato climatico’ in
base al diritto internazionale.
Gli allarmi lanciati dai rapporti scientifici, le spinte
volontaristiche, la mobilitazione popolare e gli appelli etici non
bastano comunque più: occorre mettere mano alla ricomposizione di un
ordine giuridico ed economico più sano, guidato razionalmente e non
fatalmente rassegnato alla prevaricazione da parte degli interessi
egoistici con evidenti rischi per la stessa sopravvivenza dello genere
umano.
Il ruolo essenziale degli operatori del diritto in questa direzione
costituisce però anche un’opportunità eccezionale per fare uscire le
scienze giuridiche da un ruolo puramente ‘esecutivo’, dando prova invece
di un’autentica creatività attraverso un contributo decisivo nella lotta
per il mantenimento dell’equilibrio climatico e per una vera giustizia
ambientale.
Con una modesta concessione alla retorica, giustificata dall’altezza
della posta in gioco, possiamo parlare di una vera e propria chiamata
anche dei giuristi alle armi – ovviamente solo del diritto - per la
salvezza del clima sul nostro pianeta.
Note
1. Il testo in 16 articoli
della Proposta è riprodotto dal sito
www.droitshumanite.fr attraverso il quale lo si può anche
sottoscrivere la dichiarazione stessa. Il documento non ha peraltro
avuto, al momento, un particolare effetto.
2. I contenuti
dell’iniziativa e i documenti relativi sono reperibili su
www.tribunal-nature.org.
3. Il documento, che
riprende ampiamente il contenuto del quarto capitolo del volume curato
da A. Supiot e M. Delmas-Marty, Prendre la responsabilité au sérieux,
Parigi, Presses universitaires de France, 2015, è consultabile sul sito
del
Collège de France.

|