|
A Torino e dintorni, tra gli eventi talora intensi del lungo periodo
di tempo instabile e piovoso cominciato a fine aprile 2023 e terminato
a metà giugno, si è distinto per violenza il nubifragio della notte
tra domenica 11 e lunedì 12 giugno.
Le celle temporalesche, formatesi nella tarda sera dell'11 giugno sul
Piemonte settentrionale all'arrivo di un impulso di aria relativamente
fresca e instabile da Nord-Est, sono poi migrate verso Sud-Sud-Ovest,
passando per Biella, Ivrea e la pianura centrale del Canavese,
rinvigorendosi in un ampio sistema a multicella fino ad approdare su
Torino intorno all'una di notte.
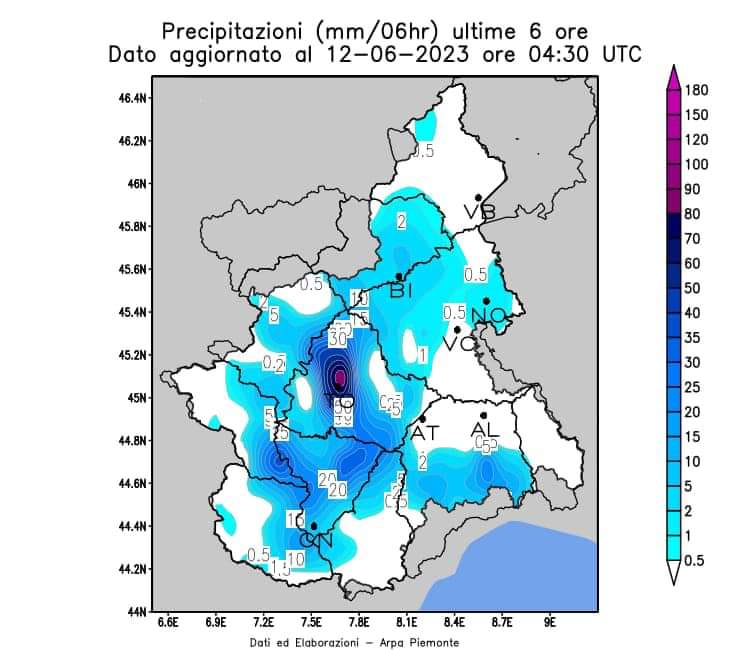
Precipitazioni cumulate in Piemonte
tra le h 22:30 UTC dell'11 giugno e le
h 04:30 UTC del 12 giugno 2023 (ovvero tra le 00:30 e le 06:30 ora
legale italiana). Si nota un nucleo >100 mm proprio su Torino-centro
(fonte: Arpa
Piemonte).
Gran parte dell'area urbana ha ricevuto precipitazioni importanti,
prossime o superiori a 50 mm, ma i valori più significativi sono stati
registrati dalla stazione meteorologica
Arpa Piemonte
dei Giardini Reali, con 73,5 mm in periodo di un'ora
terminante alle h 00:12 UTC, ovvero le 02:12 ora legale italiana, e
98,5 mm nelle tre ore con termine alle h 02:04 UTC, le
04:04 in Italia (*).
Quest'ultimo valore, superando i
94,2 mm del 22 giugno 2021 in via della Consolata (anche questo un
pluviometro
Arpa Piemonte), rappresenta il nuovo primato di piovosità noto
su tre ore per l'intero territorio cittadino, ovvero si è trattato
della pioggia più intensa su un intervallo così breve mai rilevata da
tutte le stazioni succedutesi nel tempo a Torino per lo meno dal 1928,
anno in cui in centro città si avviò la registrazione continua delle
precipitazioni con apparecchi a bascula.
Molto probabilmente l'eccezionalità si estende anche ai periodi
precedenti fino al 1802 (osservatori dell'Accademia delle Scienze,
Palazzo Madama, Istituto di Fisica), in cui la registrazione
dell'intensità oraria delle precipitazioni non era regolare, tuttavia
un evento di questa entità sarebbe stato ragionevolmente notificato in
dettaglio dai responsabili delle misure.
Quanto al periodo di un'ora, resta invece
imbattuto il record cittadino di 83,4 mm dell'11 agosto 2010 alla
Consolata.
L'evento ha prodotto allagamenti di strade ed
edifici (quasi inevitabili con tali intensità di precipitazione su
superfici urbane impermeabilizzate), tuttavia l'ora notturna in cui è
avvenuto per lo meno ne ha ridotto l'impatto sulle attività dei
torinesi e sulla circolazione stradale.
(*) I valori originali registrati dal pluviometro
dei Giardini Reali, e pubblicati tra le
misure in
tempo reale Arpa Piemonte, corrispondevano a 87,4 mm in 1 h e
114,4 mm in 3 h, tuttavia in fase di validazione da parte dell'ente
sono stati ricalcolati rispettivamente in 73,5 e 98,5 mm tramite le
correzioni - suggerite in letteratura per intensità di pioggia elevate
- da applicare alle precedenti generazioni di pluviometri.
Da un estremo di precipitazioni all'altro, anche con
il contributo dei cambiamenti climatici antropogenici
La violenza del nubifragio e in generale l'insistenza e
l'abbondanza delle piogge dell'ultimo mese e mezzo stupiscono
soprattutto per la loro rapida insorgenza dopo l'eccezionale
periodo secco durato da dicembre 2021 ad aprile 2023.
A tal proposito, uno studio pubblicato a maggio 2023 sulla rivista
scientifica internazionale
Nature
Communications (Increasing
global precipitation whiplash due to anthropogenic greenhouse gas
emissions) identifica il ruolo dei cambiamenti climatici
antropogenici (emissioni di gas serra) nel rendere più rapide,
frequenti e intense le transizioni da un estremo di precipitazioni a
quello opposto nel giro di poche settimane o mesi, come avvenuto
questa primavera in Italia.
Grazie a ...
Arpa Piemonte,
e in particolare a Roberto Cremonini del Dipartimento Rischi
Naturali, per la tempestiva comunicazione di dati e informazioni sul
nubifragio; inoltre a Gennaro Di Napoli, che insieme a Luca
Mercalli ha analizzato tre secoli di storia meteorologica torinese
nel
libro "Il clima di Torino".
Devolvi il 5 per mille alla SMI!
Sosterrai
le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,
e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|