|
Venerdì 19 settembre 2025 gli operatori della Società Meteorologica Italiana,
di Arpa
Piemonte e dell'Ente Parco Nazionale
Gran Paradiso - in collaborazione
con IREN Energia
e nel quadro delle campagne di misura della
Fondazione
Glaciologica Italiana - ha condotto i consueti rilievi di
bilancio di massa e variazione frontale al Ghiacciaio Ciardoney, in
Valle Soana.
Le operazioni sono avvenute in atmosfera serena, calma e
straordinariamente calda per un giorno di metà settembre (Tmin 7,7
°C, Tmax 16,1 °C, rispettivamente circa 8 °C e 10 °C sopra media), al
culmine di un periodo dominato dall'anticiclone nord-africano.
Tuttavia pochi giorni dopo, mentre andiamo on line con questo
resoconto (23 settembre), aria fredda sopraggiunta sul lato
occidentale della depressione "Alessio" posizionata proprio sulla
regione alpina si accinge a portare la prima nevicata rilevante
della stagione sul ghiacciaio, ponendo fine a un'altra lunga e intensa
stagione di ablazione.
.jpg)
19
settembre 2025, fronte del ghiacciaio Ciardoney: il regresso del
margine glaciale, seppure moderato (5 m rispetto a fine estate 2024)
tra agosto e settembre ha liberato una piccola depressione che si è
colmata d'acqua di fusione dando origine a un piccolo lago proglaciale.
Perdite di massa glaciale
nella sfavorevole media di un trentennio di misure, nonostante
l'abbondante innevamento primaverile.
Bilancio -1,36 m di acqua equivalente
Le straordinarie precipitazioni
della primavera 2025, e di aprile in particolare, avevano accumulato
un manto nevoso importante, che ai
rilievi del 30 maggio
risultava spesso tra 340 cm e 550 cm (media 429 cm) ed equivalente a
una lama d'acqua di ben 2500 mm: era il secondo valore più
elevato della serie di misura, quanto meno in riferimento alla sua
porzione più omogenea dal 2012 in poi (ovvero da quando è stato
adottato il carotiere pesaneve Valtecne), peraltro dopo il primato
recente del 2024 (3150 mm).
Un giugno estremamente caldo, secondo solamente a quello record
del 2003 sulle Alpi, ha determinato una fusione accelerata della neve, che
alla stazione meteorologica al margine del pianoro proglaciale
(2850 m) si è esaurita il 1° luglio 2025, con 8 giorni di
anticipo rispetto alla data mediana di scomparsa (periodo
2013-2024, teleosservazioni da
webcam).
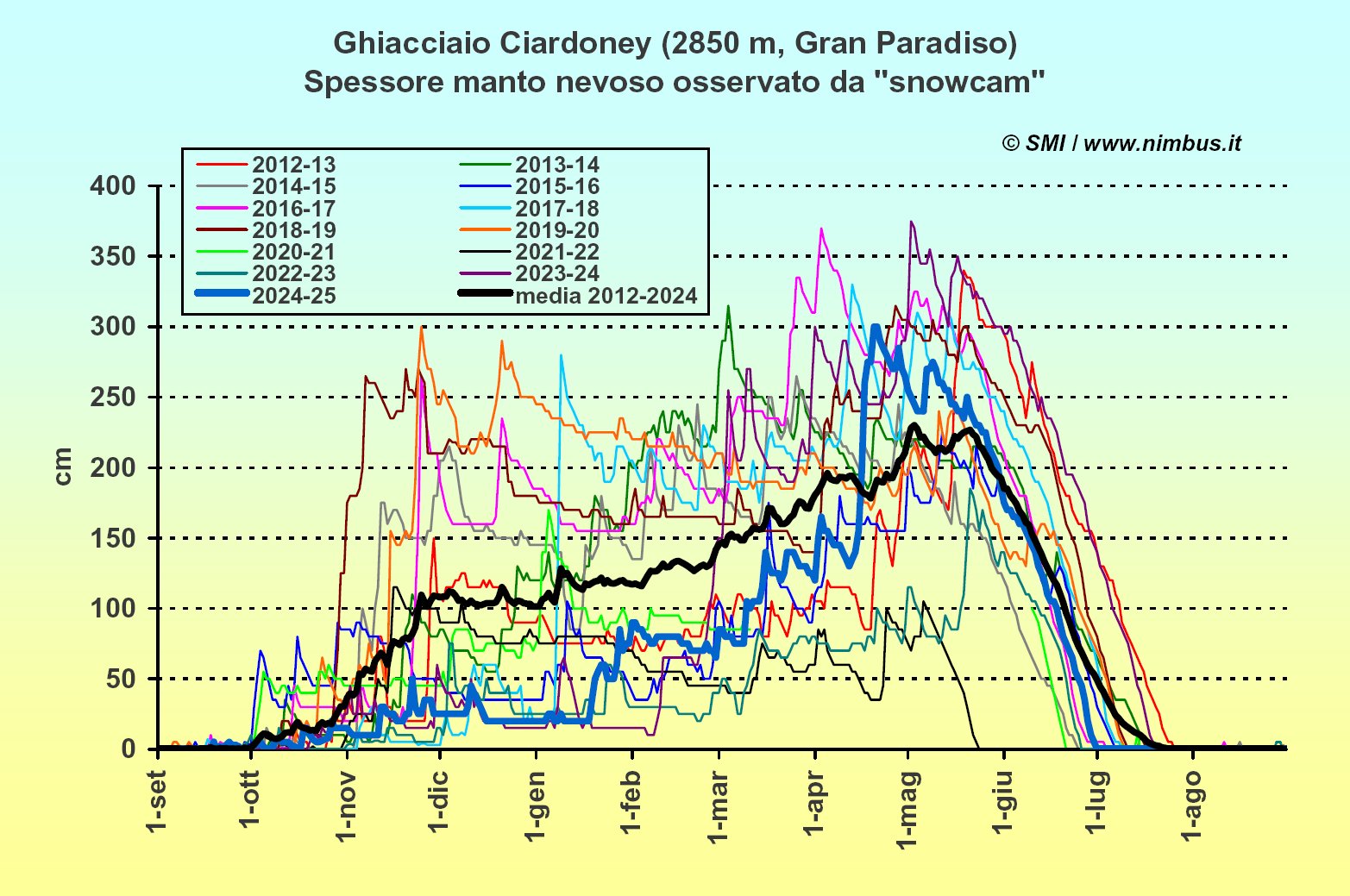
Grafico dell'andamento giornaliero dell'altezza totale della neve all'asta nivometrica,
teleosservata da
webcam nelle stagioni dalla 2012-13 in poi. La linea blu
spessa indica la stagione 2024-25. L'inverno è trascorso con innevamento inferiore al consueto, poi le
precipitazioni primaverili hanno determinato una graduale ripresa
degli spessori nevosi, divenuti importanti con l'eccezionale
perturbazione del 16-17 aprile e le ulteriori precipitazioni di Pasqua
(massimo di 300 cm proprio domenica 20 aprile). Tuttavia il caldo
eccessivo di giugno ha determinato una rapida fusione della neve,
esauritasi all'asta nivometrica il 1° luglio, con 8 giorni di
anticipo rispetto alla data mediana calcolata sul periodo 2013-2024
(grafico sotto).
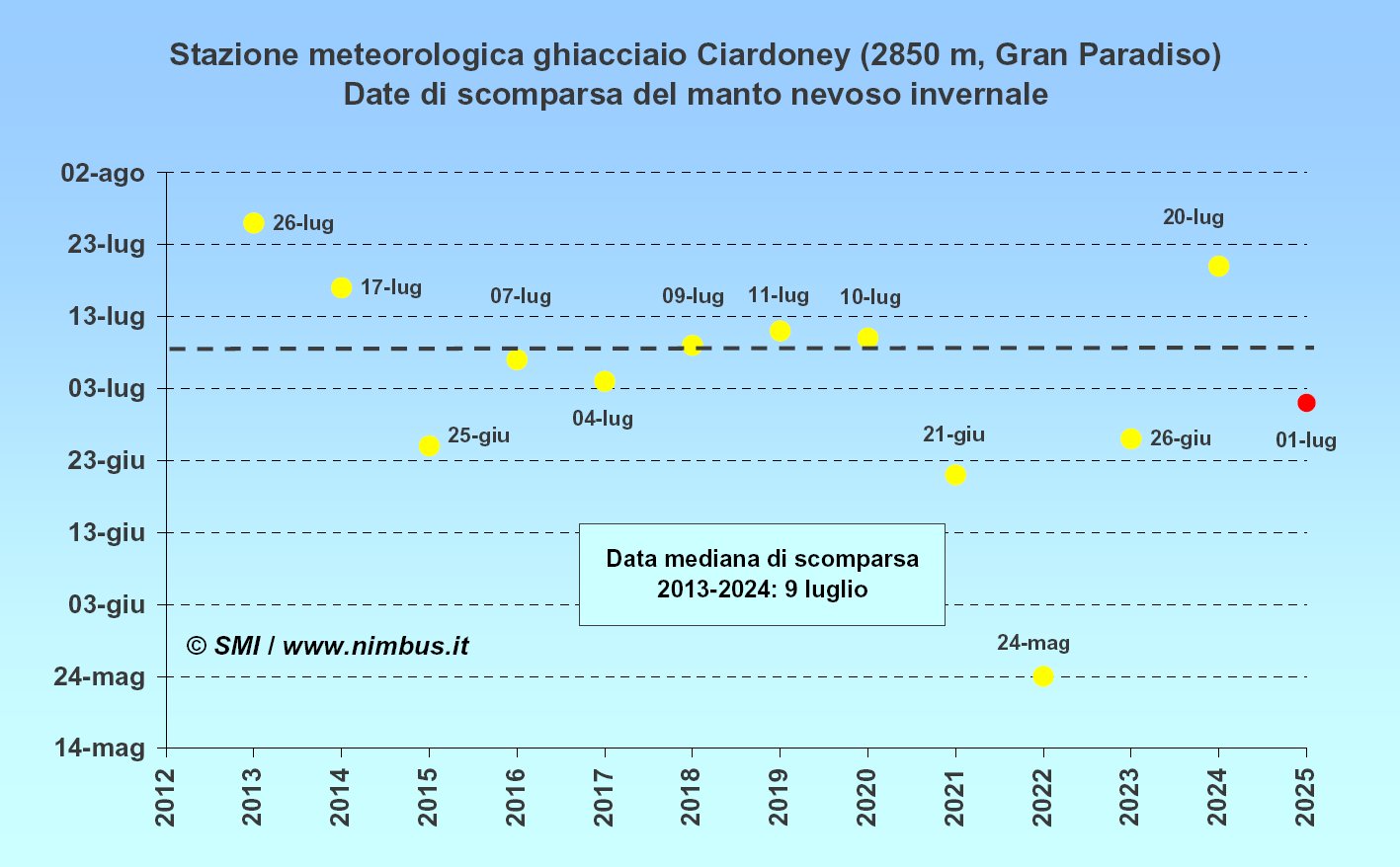
Intorno al 15
luglio 2025 sul ghiacciaio sono apparsi i primi affioramenti di ghiaccio
"vivo", tuttavia le temperature rientrate complessivamente nella norma
(perfino fresche a fine mese) hanno rallentato l'esaurimento del
nevato, che a un successivo sopralluogo del 5 agosto copriva
ancora almeno due terzi dell'apparato glaciale (stima eseguita
anche con l'aiuto di
immagini satellitari Sentinel-2).

5 agosto 2025: il Ghiacciaio Ciardoney (visto dai pressi del Colle)
ancora coperto per due terzi dalla neve invernale, che tuttavia
fonderà pressoché del tutto entro il mese e mezzo successivo, con il
determinante contributo della lunga e intensa ondata di caldo di metà
agosto.
Tuttavia la successiva ondata
di calore dell'8-18 agosto, straordinaria per intensità e durata,
ha spogliato il ghiacciaio della neve residua fino alla sua
sommità (Colle Ciardoney), esponendo il
ghiaccio a marcata fusione che è poi proseguita - seppure attenuata
rispetto al culmine dei calori estivi, e con alcune pause - fino alla data di chiusura del
bilancio di massa il 19 settembre.
Pochi e insignificanti residui di nevato (accumuli di valanga)
sono rimasti solamente in destra orografica alla base delle pareti
settentrionali delle Uje di Ciardoney e, in sinistra, sotto la Cima
occidentale di Valeille presso il Colle Ciardoney, e in prossimità
della fronte, coprendo una superficie inferiore al 5% dell'area
totale del ghiacciaio (AAR/Accumulation Area Ratio = <
0,05).
Dunque ancora una volta la linea delle nevi si è venuta a
trovare al di sopra della quota massima del ghiacciaio (3120 m),
come ormai accade nella quasi totalità degli anni. Occorre risalire al
2014 per trovare una significativa situazione di accumulo
nevoso nel settore sommitale del bacino glaciale, con 75 cm di neve
residua il 22 settembre al Colle Ciardoney, peraltro sovrapposti agli
ulteriori 70 cm rimasti dalla stagione
2013.
A parte alcune giornate fresche nella terza decade di luglio e verso
metà settembre, la fusione nivoglaciale ha potuto proseguire pressoché
senza sosta anche con il concorso della completa assenza di nevicate
estive - che sarebbero state in grado di aumentare per qualche giorno l'albedo della
superficie glaciale altrimenti annerita dai detriti (riflettività
elevata della neve fresca) - e di un lungo periodo senza gelo durato
76 giorni, dal 9 luglio al 22 settembre 2025, alla stazione
meteorologica a 2850 m.
Se non altro le deposizioni di polveri sahariane, decisamente
minori rispetto al 2024, hanno evitato di fornire un ulteriore
contributo alla fusione tramite un abbassamento della riflettività del
manto nevoso.
Ecco dunque le perdite di spessore di ghiaccio rispetto al
precedente rilievo del
17 settembre 2024, misurate alle paline ablatometriche, da monte a
valle:
palina n. 1 (Colle Ciardoney): 121 cm
palina n. 2: 205 cm
palina n. 3: 242 cm
palina n. 4: 61 cm
palina n. 6: 232 cm
(la palina n. 5 non è più presente da svariati anni, poiché in quel
punto, in sinistra orografica del settore mediano, il ghiaccio è
scomparso)
Il bilancio di massa specifico, riferito alla
superficie glaciale 2023 di 0,46 km2 (ottenuta
tramite
rilievo fotogrammetrico da drone), è stato valutato in
-1,36 m di
acqua equivalente, valore nella media
dello sfavorevole periodo di deglaciazione 1992-2024 (-1,4 m di
acqua equivalente).
Alla data del sopralluogo (19
settembre 2025) la fusione glaciale era ancora molto attiva
nelle ore diurne a causa dell'intenso soleggiamento e delle
temperature straordinariamente elevate per il periodo (Tmin
del giorno 7,7 °C, Tmax 16,1 °C), tuttavia il netto
raffrescamento dei giorni successivi e i primi, sottili depositi
di neve fresca sul ghiacciaio del 22-23 settembre hanno posto fine
alla stagione di ablazione pressoché in fase con i rilievi di chiusura
del bilancio.

5 agosto 2025: il guardaparco PNGP Gianpaolo Palladino alla palina n.
6 durante il sopralluogo di mezza estate, che ha permesso di calcolare
il tasso medio giornaliero di fusione su ghiaccio nella seconda parte
della stagione (qui pari a 4,6 cm/giorno tra il 5 agosto e il 19
settembre).
Il confronto tra le sporgenze
delle paline ablatometriche misurate il 5 agosto (laddove il ghiaccio
era già affiorato) e il 19 settembre 2025 ha permesso di valutare il
tasso medio giornaliero di ablazione nella seconda metà
dell'estate, rispettivamente pari a 4,0 cm di ghiaccio/giorno,
4,5 cm/giorno e 4,6 cm/giorno alle paline n. 2, 3 e 6.
Si presume che durante le giornate più calde dell'estate, ad esempio
intorno al 10 agosto, la fusione abbia asportato fino a 7-8 cm di
ghiaccio al giorno.
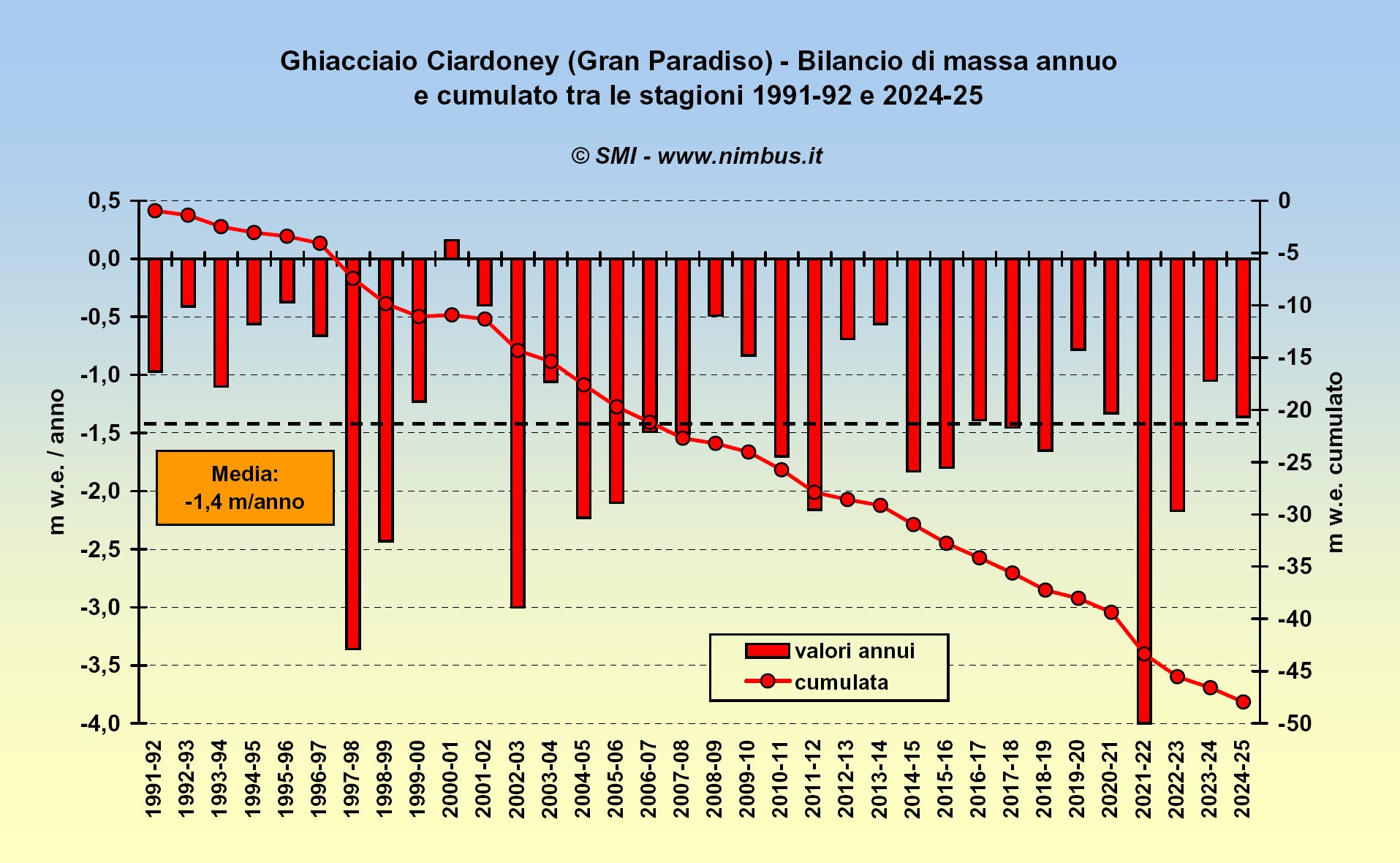
Serie dei bilanci di massa (saldo tra accumuli invernali di neve e
fusione estiva, espressi in acqua equivalente) dalla stagione 1991-92. Il valore dell'annata idrologica 2024-25 (-1,36 m di equivalente d'acqua)
risulta in linea con la sfavorevole media del periodo di osservazione
dal 1992.
Le perdite di massa cumulate
raggiungono i
-48 m di acqua equivalente,
pari a oltre 50 m di spessore di ghiaccio.
Regresso della fronte moderato: -5 metri
Nonostante le marcate perdite di massa nell'insieme del
ghiacciaio, la locale e più prolungata persistenza della neve a
ridosso del margine frontale (probabile accumulo di valanga, oppure
eolico) ha fatto sì che il suo ritiro sia stato moderato, pari a 3
m in corrispondenza del segnale di riferimento A4H
(direzione di misura 245°).
Il regresso cumulato dal 1971 ammonta a circa 545 m.
Il ritiro del ghiaccio sta liberando un avvallamento (ora in
parte occupato da un piccolo lago proglaciale sviluppatosi
proprio nell'estate 2025), la cui morfologia concava è favorevole a
notevoli accumuli di neve in inverno-primavera e alla permanenza di
banchi di nevato anche fino a estate inoltrata, la cui presenza
non è tuttavia rappresentativa delle (pessime) condizioni generali del
ghiacciaio.
Malgrado la fronte immersa in acqua, è stato possibile
individuarne correttamente il margine, procedendo senza ostacoli alla
misurazione della variazione frontale.
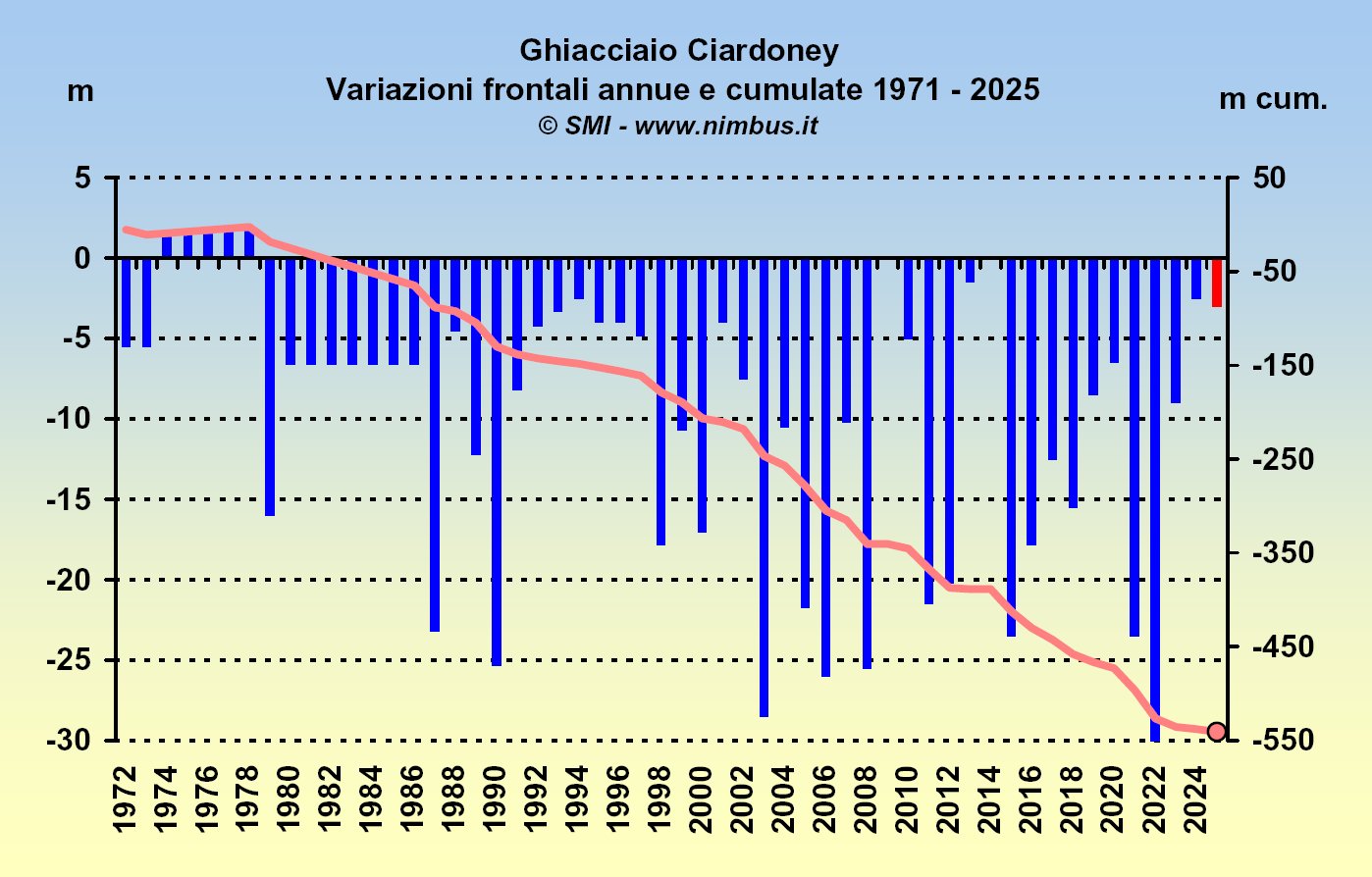
Serie delle variazioni
frontali dalla posa del primo segnale di misura nell'estate 1971
(l'operatore CGI all'epoca era Gianpaolo Ravarino). In rosso il ritiro
del 2025 (-3 m).
Importanti
variazioni morfologiche: inghiottitoi glaciali assenti, affioramenti
rocciosi e un nuovo lago proglaciale
Benché le perdite di massa glaciale dell'estate 2025
siano state meno estreme rispetto ad altri anni recenti, si sono
verificate alcune importanti variazioni morfologiche sul ghiacciaio e
ai suoi margini.
1) Fatto molto raro in decenni di osservazioni, non
erano visibili gli inghiottitoi (mulini o pozzi
glaciali), solitamente presenti nel settore mediano del ghiacciaio
poco a monte della palina n. 3, ma di cui già da alcuni anni si era
notata una progressiva riduzione di numero e dimensioni; le acque di
fusione, convogliate dalle consuete bédières che nella zona
degli ex-inghiottitoi si approfondiscono fino a 2-3 m, almeno in parte
si inabissano in fratture della massa glaciale, tuttavia non
visibili dalla superficie e senza le classiche ed evidenti
imboccature circolari.
.jpg)
Nonostante la stagione
avanzata, nelle ore centrali del 19 settembre la fusione era ancora
molto attiva e alimentava con notevoli portate d'acqua il reticolo
idrografico superficiale del ghiacciaio, costituito da marcate
bédières.
Assenti invece, i consueti inghiottitoi (mulini, o pozzi glaciali).
Di fronte a queste forme della complessa rete di drenaggio idrico del
ghiacciaio, il gruppo di lavoro si è soffermato per un momento di
raccoglimento in memoria del
geologo planetario Riccardo Pozzobon, ricercatore
dell'Università di Padova tragicamente scomparso il 2 settembre
2025 in un inghiottitoio del grande Ghiacciaio Mendenhall (Juneau
Icefield, Alaska),
mentre era impegnato nel
progetto internazionale Gemini per lo studio delle fratture
dei ghiacciai terrestri come modello per la comprensione della
tettonica di satelliti ghiacciati come quelli di Giove e Saturno.
2) La perdita di spessore glaciale di oltre 2 m ha determinato l'affioramento
del substrato roccioso (alcuni metri quadrati di rocce montonate)
poco a valle della palina n. 6 (la più bassa), avviando così un
processo di frammentazione del pendio frontale che nell'arco di pochi
anni minaccia di isolare la porzione inferiore del ghiacciaio dal
resto dell'apparato.
In realtà questa porzione di ghiaccio potrà rimanere più a lungo
collegata al bacino superiore del ghiacciaio in destra orografica,
dove la coltre di detrito roccioso e il maggiore ombreggiamento
rallentano la fusione e la perdita di spessore, ma ciò difficilmente
potrà evitarne la trasformazione in un corpo di ghiaccio "morto",
privo di alimentazione e di dinamica. In tal caso la fronte
"attiva" del ghiacciaio diverrà quella che si sta delineando a ridosso
dell'affioramento roccioso, circa 150 m a monte (in proiezione
orizzontale) della fronte attuale.
Al Ciardoney, in un quarantennio di campagne glaciologiche, è la prima
volta che si osserva un fenomeno di questo tipo, divenuto molto comune
sui ghiacciai delle Alpi in questi tempi di intensa deglaciazione,
comportando diffusi eventi di disarticolazione e collasso di lingue
glaciali.
Che a breve termine potesse avvenire un affioramento del substrato
roccioso lo si sospettava a seguito delle perforazioni di settembre
2024 per la posa della nuova palina n. 6: in due punti distanti pochi
metri tra loro, la lancia termica della sonda a vapore "Heucke" si era
fermata a circa 6 m di profondità, lasciando intuire il raggiungimento
del bedrock e un sottile spessore glaciale residuo in quel tratto del
pendio frontale.
3) Come già accennato, il ritiro della fronte ha
liberato una depressione allungata in direzione Sud-Est / Nord-Ovest
che tra agosto e settembre 2025 si è riempita di acqua di fusione
dando luogo alla formazione di un piccolo lago proglaciale, in
cui il margine inferiore del ghiacciaio si immerge (la profondità
stimata dell'acqua è dell'ordine del metro). Curiosamente, le acque
fuoriescono dal modesto corpo idrico attraverso due emissari
alle estremità sud-orientale e nord-occidentale, in quest'ultimo caso
scorrendo per alcune decine di metri sotto la morena di fondo (till
di alloggiamento) deposta negli anni recenti dal ghiacciaio in
ritiro.
.jpg)
Il nuovo lago proglaciale in
cui la fronte si immerge.
.jpg)
Vista dal segnale di misura A4H: la
freccia indica l'affioramento del substrato roccioso che
ragionevolmente nell'arco di pochi anni determinerà la separazione del
settore frontale dal resto del ghiacciaio, lungo una traiettoria
ipotizzata con il tratteggio.
.jpg)
.jpg)
Due vedute più ravvicinate
dell'affioramento del substrato roccioso.
Qui di seguito, un
fotoracconto della missione del 19 settembre 2025.
.jpg)
.jpg)
Due vedute aeree del settore
superiore del Ghiacciaio Ciardoney, con la sella
dell'omonimo colle (3120 m), spartiacque tra la Valle Soana e la Valle
Orco.
.jpg)
Il Colle Ciardoney ripreso da
Sud-Est, quasi interamente libero da neve residua (il modesto accumulo
visibile in alto a destra risale probabilmente alla stagione 2024).
Gli spessori glaciali sono ormai ridotti, ragionevolmente inferiori a
10 m (la palina n. 1 è ancora infissa nel ghiaccio per
7 m), ed entro un decennio
potrebbe completarsi la deglaciazione dell'intera sella.
.jpg)
Dettaglio del Colle Ciardoney.

Parte della sella del Colle
Ciardoney è già priva di copertura glaciale (a partire dal 2023), come
non avveniva da secoli se non dai tempi dell'Optimum Termico Olocenico
tra circa 8000 e 6000 anni fa. A fine estate 2025 un ignoto
escursionista ha eretto un piccolo "menhir" come segnavia per il
transito da e per il vallone di Valsoera.
.jpg)
Colle Ciardoney: la palina
ablatometrica n. 1 è stata spezzata ragionevolmente al livello del
ghiaccio da parte di valanghe di fondo nelle stagioni sia 2023-24 sia
2024-25. Nel settembre 2024 la valutazione dell'ablazione su ghiaccio
era incerta (stimati circa 55 cm, peraltro in parte attribuibili al
caldo tardivo di fine settembre-inizio ottobre 2023), ma ora la misura
della lunghezza degli spezzoni rotti e la fuoriuscita del segmento di
palina sottostante, intatto, ha permesso di chiarire l'entità della
fusione di ghiaccio nelle ultime due annate: 42 cm nella stagione
idrologica 2023-24 (portando una piccola correzione del
bilancio di massa nell'insieme del ghiacciaio, da -1,04 m a -1,00 m
di acque equivalente), e 121 cm in quella 2024-25.

Panoramica del ghiacciaio dai
pressi del Colle Ciardoney.
.jpg)
Alessio Golzio e Daniele Cat
Berro durante il rilievo
della sporgenza dal ghiaccio della palina n. 2, dove la perdita di
spessore glaciale rispetto al 17 settembre 2024 è stata di 205 cm.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Nelle tre immagini
soprastanti: coni di detrito sulla superficie del ghiacciaio,
nel settore mediano poco a monte della palina n. 3. Si tratta di
accumuli di sedimenti a granulometria fine (per lo più sabbie e
piccole ghiaie), concentrati dal ruscellamento delle acque di fusione
probabilmente al fondo di cavità ora scomparse (anse di bédières,
oppure inghiottitoi); affiorato in superficie con la perdita di
spessore del ghiacciaio, ha protetto dalla radiazione solare il
ghiaccio sottostante, rimasto così in rilievo per ablazione
differenziale. Sono forme effimere, di durata solitamente non
superiore a un anno.
.jpg)
Nel corso della mattinata si è
riattivato un vivace
ruscellamento
dell'acqua di fusione nelle bédières.
.jpg)
.jpg)
Alessio Golzio alla palina n. 3: qui
si è misurata la massima ablazione su ghiaccio dell'estate 2025, pari
a 242 cm (con un tasso medio di 4,5 cm/giorno nel periodo
5 agosto-19 settembre).
.jpg)
Il pendio inferiore del
ghiacciaio, verso la fronte. A sinistra, un banco di neve residua
(circa un ettaro di superficie) ragionevolmente attribuibile a un
accumulo di valanga sopravvissuto all'estate in una posizione insolita
e prossima al margine frontale, senza tuttavia impedire le misure di
arretramento.
.jpg)
Affioramento del substrato
roccioso lungo il pendio inferiore del ghiacciaio. Questa, a breve,
potrebbe divenire la nuova fronte "attiva" del ghiacciaio, con
l'imminente separazione del settore inferiore dal resto del corpo
glaciale. Sullo sfondo, Lorenzo Colombo indica la posizione della
palina n. 6, che - al perdurare dei tassi attuali di fusione -
verrà definitivamente persa entro 1-2 anni: rimane infissa nel
ghiaccio per soli 370 cm, al di sotto dei quali c'è il fondo roccioso.
.jpg)
La fronte e il nuovo lago
proglaciale.

Panoramica del settore
inferiore del ghiacciaio e della fronte
dal segnale di misura A4H (clicca sull'immagine per ingrandirla).
.JPG)

L'impressionante smagrimento del
ghiacciaio intervenuto tra il 2004 e il 2025,
ripreso dalla stazione fotografica "F" in destra idrografica del
torrente ablatore.


Un altro schiacciante confronto
fotografico tra le situazioni del 1971 e del 2025 (stazione "S2", a
pochi metri dall'attuale stazione meteorologica).
La foto d'epoca è dell'operatore CGI Gianpaolo Ravarino, che proprio
54 anni fa avviò le misure frontali, ancorché discontinue fino alla
ripresa sistematica dei rilievi nel 1986 da parte di Luca Mercalli e
Fulvio Fornengo.
Rispetto a mezzo secolo fa l'assetto dei massi nel pianoro frontale è
in parte cambiato a causa della lieve avanzata del ghiacciaio nel
corso degli Anni Settanta e del rimaneggiamento da parte del torrente
ablatore il cui percorso nei primi tempi dopo il regresso della fronte
era più instabile e mutevole di oggi.
.jpg)
Dalla stazione meteorologica,
uno sguardo a Sud-Est, verso l'imponente mole del Monte Gialin (3270
m): ai piedi della parete settentrionale si annida il minuscolo
glacionevato di Geri, che sopravvive grazie alla posizione in una
nicchia ombrosa e favorevole alla persistenza di accumuli di valanga.
.jpg)
.jpg)
19 settembre 2025, due riprese
aeree del Ghiacciaio Ciardoney: in primo piano la sella del Colle
Ciardoney, al centro delle immagini si scorge la fronte, nei pressi
del piccolo banco di neve residua; a destra, la scura parete
settentrionale della Grande Uja di Ciardoney (3325 m); lontano, a
sinistra, il Monte Rosa.
.jpg)
La testata del vallone di Valsoera (Valle Orco) ripresa dal Colle
Ciardoney: al di là dei residui di nevato, pressoché nulla rimane dei ghiacciai di Valsoera,
di fatto estinti salvo
la probabile presenza di resti di ghiaccio sepolto da una spessa coltre di
detriti. L'unità settentrionale, che si estendeva nella nicchia
visibile nella parte centro-destra dell'immagine, è stata sorvegliata
con misure di variazione frontale fino al 2000, dopodiché
queste hanno perso di significato in virtù della crescente copertura
detritica.
In primo piano la conca sottostante il Colle Ciardoney, occupata dalla trasfluenza del
Ghiacciaio Ciardoney fino ai decenni
finali del Novecento, e ora da un laghetto e da banchi di neve residua
di estensione variabile in base all'andamento climatico delle annate.
La stazione e i dati
meteorologici:
seconda estate più calda nella breve serie dal 2011 al Ciardoney
(quinta dal 1958 in Piemonte)
La manutenzione
della stazione meteorologica a quota 2850 m sul pianoro proglaciale,
curata dal socio SMI Alessio Golzio, ha comportato
un sopralluogo intermedio il 5 agosto 2025 (con pernottamento al
casotto di sorveglianza PNGP della Muanda di Forzo, grazie alla
disponibilità dell'Ente
Parco): si è così provveduto alla sostituzione del collettore del
pluviometro, peraltro installato da pochi mesi, nel settembre
2024, ma poi rotto alla base da una tempesta di vento invernale (senza
tuttavia pregiudicare le misure di precipitazione liquida durante i
primi mesi estivi del 2025) e dell'anemometro-banderuola, la
cui elica non era più ben accoppiata all'asse
dell'apparecchio (lo strumento vecchio verrà riparato in laboratorio e
sottoposto a taratura).
La stazione meteorologica, la
webcam e gli apparati di trasmissione di dati e immagini si trovano in
piena e ottimale operatività in vista dell'inverno.
.jpg)
Con il sopralluogo di manutenzione
del 5 agosto 2025 e il successivo controllo del 19 settembre,
la stazione meteorologica è pronta ad affrontare l'inverno alpino.
Ecco una
sintesi delle principali caratteristiche climatiche dell'estate
2025 (trimestre giugno-agosto; gli orari indicati sono UTC+1,
ovvero ora solare).
Temperatura
media: 8,1 °C
seconda
estate più calda
del breve periodo dal
2011, dopo quella del 2022 (8,4 °C), e pari merito con quelle del 2023 e 2024;
1,3 °C sopra la media decennale 2011-2020
Temperatura estrema minima: -1,5 °C l'8 luglio (h 22:58)
Temperatura estrema massima: 17,7 °C l'8 agosto (h 08:16) e 9
agosto (h 12:08)
Temperatura minima più elevata: 10,4 °C il 10 agosto (h 23:26)
Massima sequenza di giorni consecutivi senza gelo (incluso settembre):
76 gg, dal 9 luglio al 22 settembre
(ritorno del gelo dal 23 settembre)
Precipitazioni
totali: 289,4 mm (-31% rispetto alla media 2011-2020)
Giorno più
piovoso: 28 agosto (47,5 mm)
Massima velocità del vento: 118 km/h da Ovest-Sud-Ovest
(7 luglio, h 20:24)
Neve fresca totale: nessuna nevicata misurabile (primo velo di
neve il 23 settembre 2025).
Data di esaurimento del manto nevoso invernale: 1° luglio
(con 8 giorni di anticipo rispetto alla data mediana di
esaurimento
del periodo di osservazione 2013-2024, 9 luglio)
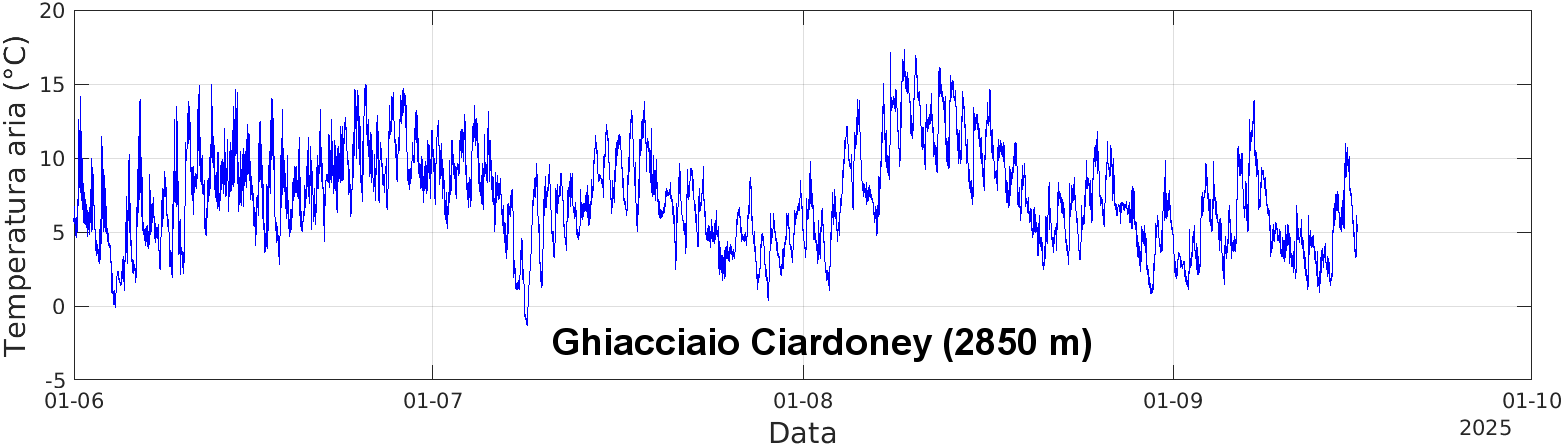
Grafico delle temperature
rilevate dalla stazione meteorologica nel periodo 1° giugno - 19
settembre 2025 (risoluzione 10 minuti).
Si noti in particolare il lungo periodo con temperature sempre >0 °C,
anomalo per una località alpina a 2850 m: ben 73 giorni consecutivi
dal 9 luglio al 19 settembre, che tuttavia diventeranno
76 fino al 22 settembre, prima del ritorno del gelo e di lievi
spruzzate di neve il giorno 23, chiudendo così la stagione di fusione
sul ghiacciaio.
Importanti ondate di caldo si sono verificate nella seconda metà di
giugno e intorno alla metà di agosto (quando per tre giorni, dall'8 al
10, le Tmax hanno superato i 17 °C), ma anomali episodi di tepore sono
avvenuti anche in settembre. Al contrario condizioni più fresche del
solito hanno caratterizzato la terza decade di luglio e i primi giorni
di agosto, senza eventi di gelo alla stazione meteorologica, ma con
temperature minime comunque vicine a 0 °C (0,2 °C il 29 luglio).
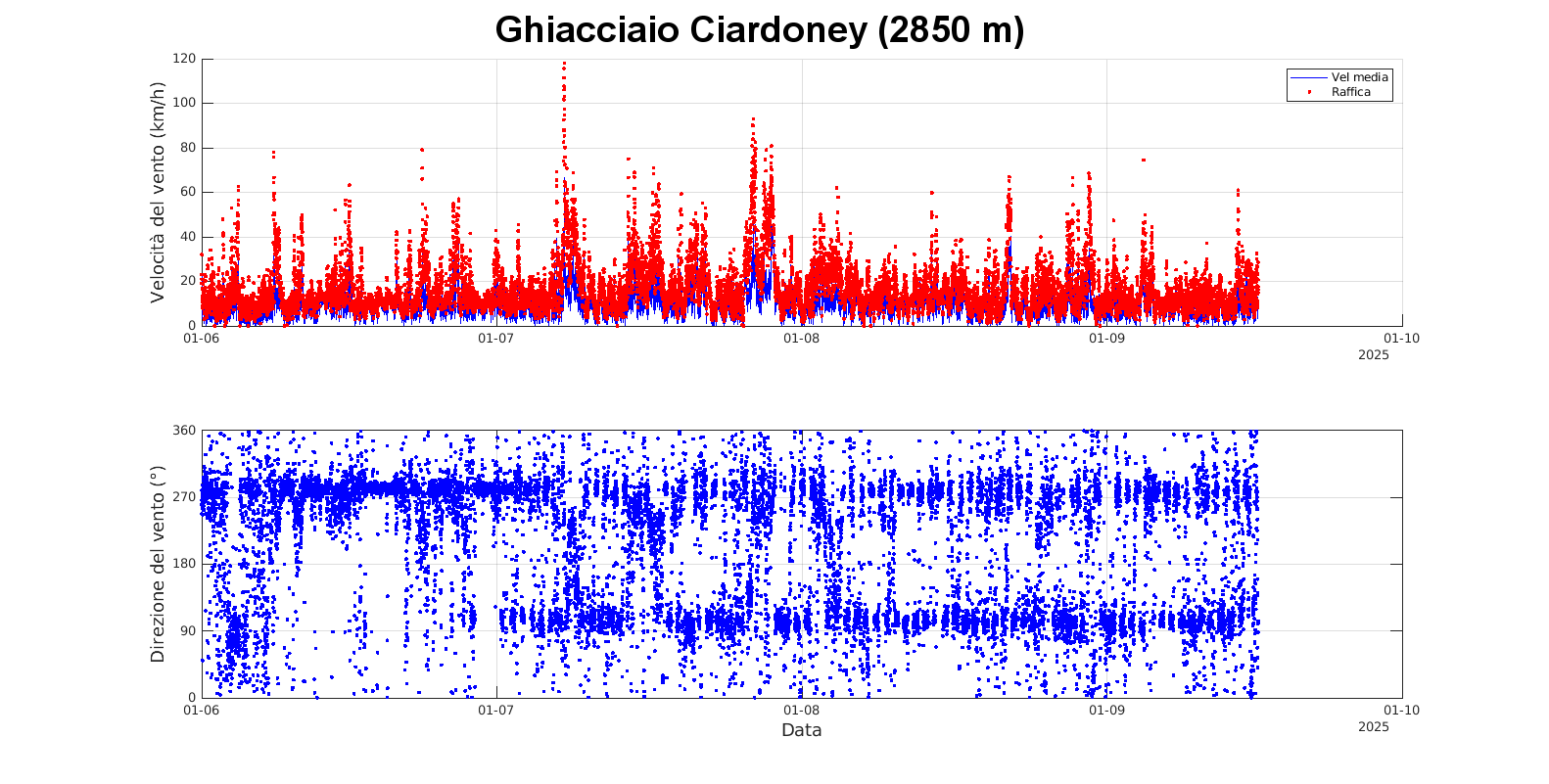
Grafico in alto: velocità media (elementi blu) e massima del vento (elementi rossi)
dal 1° giugno al 19 settembre 2024 (risoluzione 10 minuti). Spicca la
tempesta da Ponente del 7 luglio, in corrispondenza del transito di un
fronte freddo (118 km/h).
Grafico in basso: direzioni di provenienza del vento (risoluzione 10
minuti); il vistoso addensamento di osservazioni intorno ai valori 90°
e 270° indica la netta prevalenza dei flussi occidentali (venti
associati ai flussi a grande scala delle medie latitudini, oppure
brezze locali di ghiacciaio) e orientali (brezze diurne di valle),
incanalati dall'orografia nel circo glaciale con asse disposto in
direzione Ovest-Est.
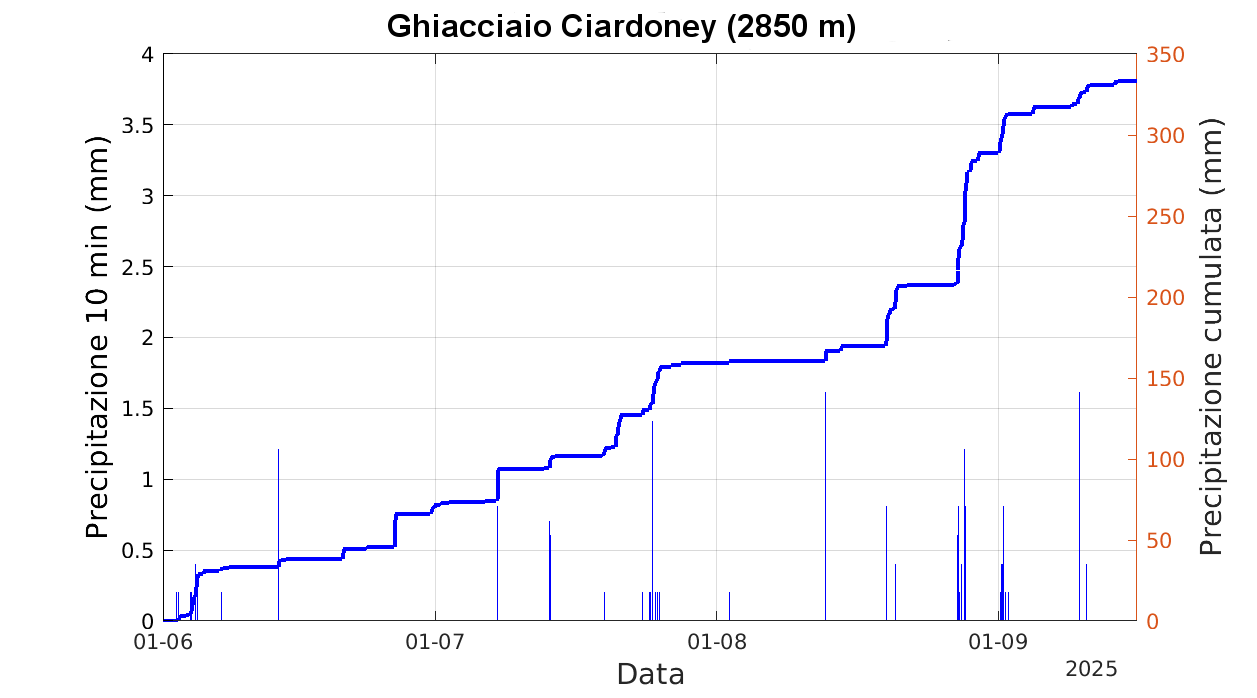
Precipitazioni in 10 minuti e
totali, dal 1° giugno al 19 settembre 2025. L'estate si è
caratterizzata per l'assenza di eventi pluviometrici di particolare
rilievo: le quantità massime in 10 minuti e in un giorno sono state
rispettivamente di 1,6 mm (h 23:10-23:20 del 12 agosto) e di 47,5 mm
(28 agosto), di conseguenza non si sono verificati significativi
episodi di piena del torrente glaciale. Nel trimestre giugno-agosto
si sono totalizzati 289 mm di pioggia (-31% rispetto alla media del
decennio 2011-2020), in aumento a 333 mm considerando anche il
periodo fino al 19 settembre, giorno di chiusura del bilancio di massa
sul ghiacciaio. Tuttavia vale la pena segnalare che, subito dopo,
sistemi temporaleschi in arrivo da Sud-Ovest hanno scaricato ulteriori
75 mm di pioggia il 21-22 settembre 2025.
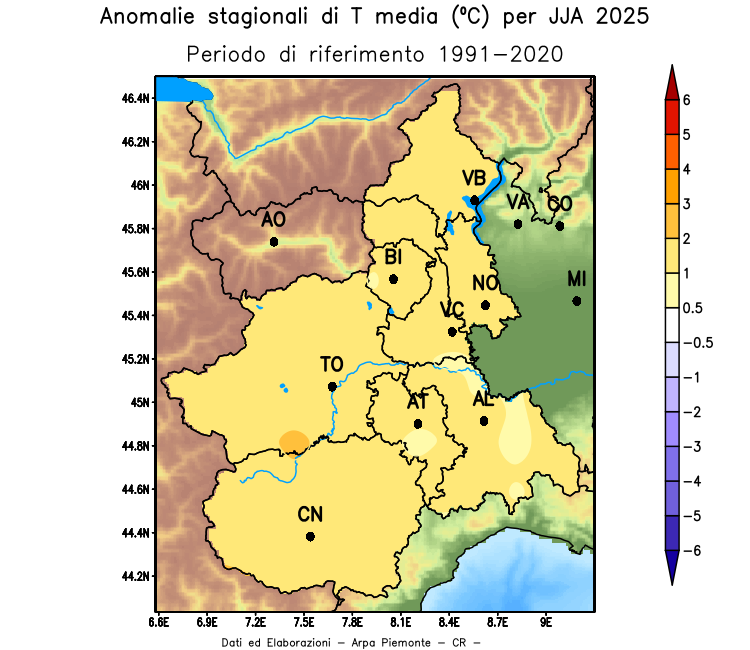
Ampliando lo sguardo sul clima
dell'estate 2025 a scala regionale,
l'analisi
Arpa Piemonte indica che il trimestre giugno-agosto si è collocato
quinto tra i più caldi nella serie regionalizzata delle
temperature con inizio nel 1958 (dopo le estati 2003, 2022, 2017 e
2015),
con anomalia termica di +1,4 °C rispetto alla media dell'attuale
trentennio di riferimento standard 1991-2020.
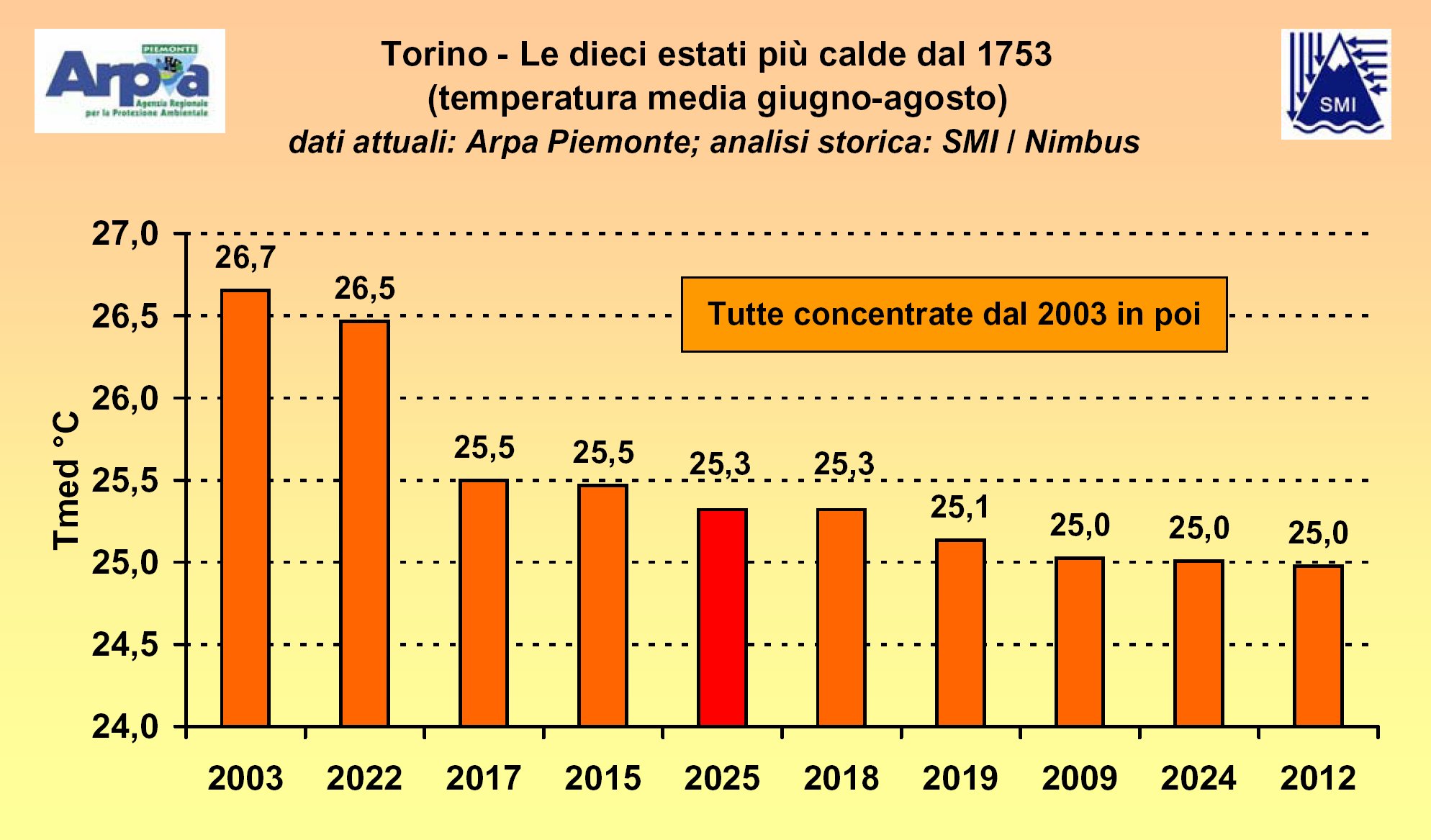
La serie meteorologica plurisecolare
di Torino-centro conferma sia la
quinta estate più calda nella serie termometrica omogeneizzata
dal 1753 (d'altra parte tutte e dieci le stagioni estive più calde
sono concentrate dal 2003 in poi), sia l'anomalia termica
trimestrale di +1,4 °C rispetto al 1991-2020.
Ulteriori informazioni sulla calda
estate 2025 al Nord Italia in questo
report SMI.

Due giorni dopo la chiusura del
bilancio di massa, con l'avanzata di una depressione atlantica
associata ad aria molto fresca la stagione di ablazione è bruscamente
terminata: le immagini della
webcam hanno mostrato che dapprima, il 22-23 settembre, sottili
spruzzate di neve sotto temporali hanno velato per lo più il
ghiacciaio, poi al mattino del 24 settembre era imbiancata da
circa 5 cm di neve anche la piana proglaciale, primo evento
nevoso significativo dallo scorso 20 maggio. L'episodio fresco in
corso in questa fine di settembre si annuncia rilevante per entità e
durata, ma non straordinario a lungo termine. Anzi, semmai a essere
molto anomale a questa quota - dove in passato nevicava abitualmente
anche in piena estate - sono la precedente e lunga assenza di nevicate
(quattro mesi) e le ripetute e intense ondate di caldo avute in
giugno, agosto e settembre 2025.
Campionamenti Arpa Piemonte per il monitoraggio
della radioattività nella crioconite e nelle acque di fusione
(di
Marco Frasca, ARPA Piemonte)
Nel 2025 è proseguita l’attività di
monitoraggio della radioattività ambientale avviata lo scorso anno
da parte del
Dipartimento Radiazioni ionizzanti di ARPA Piemonte, sede tematica di
Ivrea, sugli apparati glaciali del territorio regionale.
Venerdì 19 settembre l’attività di campionamento delle crioconiti
ha interessato nuovamente il Ghiacciaio Ciardoney, già sede di primi
rilievi nel 2024.
.jpg)

Esempi di "vaschette" crioconitiche
sul Ghiacciaio Ciardoney: il concentrarsi di sedimento scuro (crioconite)
in un sottile strato riduce localmente l'albedo e amplifica la fusione
del ghiaccio, determinando dunque l'approfondimento di una cavità, che
si riempie d'acqua. Si tratta di formazioni molto comuni sulla
superficie di ghiacciai, che rappresentano peraltro un elemento di
grande interesse per il monitoraggio ambientale: infatti la crioconite
ha notevoli capacità di accumulo di radionuclidi di origine sia
naturale, sia antropica.
Il termine “crioconiti” deriva dall’unione delle parole greche
κρύον (freddo) e κόνις (polvere),
e identifica una
caratteristica tipologia di sedimenti di polvere aerodispersa di
colore scuro che si originano esclusivamente sulla superficie dei
ghiacciai interessati stagionalmente dal fenomeno della fusione e
conseguentemente dalla presenza di acqua allo stato liquido. Si tratta
di un sedimento non consolidato a granuolometria molto fine di origine
composita, costituito principalmente da particelle minerali e
subordinatamente da una minima (ma importante) frazione organica,
formatosi dalla complessa interazione tra le componenti biogeniche,
geogeniche, cosmogeniche e antropogeniche.
Tali sedimenti si possono comunemente trovare dispersi sulla
superficie dei ghiacciai o accumulati sul fondo di caratteristiche
“vaschette” o veri e propri “fori” scavati nel ghiaccio per
ablazione differenziale e riempite da acqua di fusione (il colore
scuro del sedimento riduce l'albedo, dunque favorisce l'assorbimento
di radiazione solare e accentua la fusione rispetto al ghiaccio
circostante, approfondendo queste cavità che di solito hanno
diametro da uno a pochi decimetri).
Rappresenta una matrice con caratteristiche uniche di
rilevante importanza per il monitoraggio della radioattività
ambientale: infatti è stato ormai accertato che le crioconiti
possiedono una notevole capacità di accumulo di radionuclidi
artificiali e naturali dispersi nell’ambiente (con tempi di
integrazione dell’ordine delle decine di anni) e la loro presenza è
stata riscontrata sui ghiacciai di tutto il mondo, da quelli
polari a quelli montani.
I nuovi campioni prelevati al Ciardoney verranno analizzati in
laboratorio per stabilire il contenuto di radionuclidi tramite
spettrometria gamma e tecniche radiochimiche.
I risultati delle analisi condotte nel 2024 hanno
già accertato la presenza di radionuclidi sia naturali sia artificiali,
confermando il grande interesse per questa matrice, potenzialmente in
grado di fornire preziose informazioni - attraverso lo studio dei vari
rapporti isotopici - sulle complesse dinamiche presenti negli ambienti
glaciali interconnesse con l’atmosfera e i suoi mutamenti. L’attività
di campionamento condotta anche quest’anno sui ghiacciai delle Alpi
occidentali consentirà di estendere l’area di indagine sul territorio
della Regione Piemonte.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
19 settembre 2025, Colle Ciardoney: Marco Frasca (Arpa Piemonte)
provvede
al prelievo di campioni di acqua di fusione e di crioconite per le
analisi
della radioattività ambientale.
.jpg)
.jpg)
19 settembre 2025: ulteriore raccolta di acqua di fusione alla
fronte,
per indagare il trasporto di specie chimiche attraverso il ghiacciaio.
Agosto 2025: posa di nuovi segnali delle
posizioni storiche
della fronte del Ciardoney (1971-2020)
Nell'estate 2025 al Ciardoney si sono svolte non solo
operazioni di misura glaciologica, ma anche un'iniziativa di
valorizzazione delle campagne osservative dei decenni precedenti, in
ottica di preservazione della memoria storica del ghiacciaio e di
sensibilizzazione degli escursionisti sul tema della deglaciazione.
Peraltro, conservare la memoria dei ghiacciai (anche e soprattutto di
quelli che entro pochi decenni non ci saranno più, come il Ciardoney),
rientra nello spirito del
"2025 -
International Year for Glaciers' Preservation" indetto dalle
Nazioni Unite.
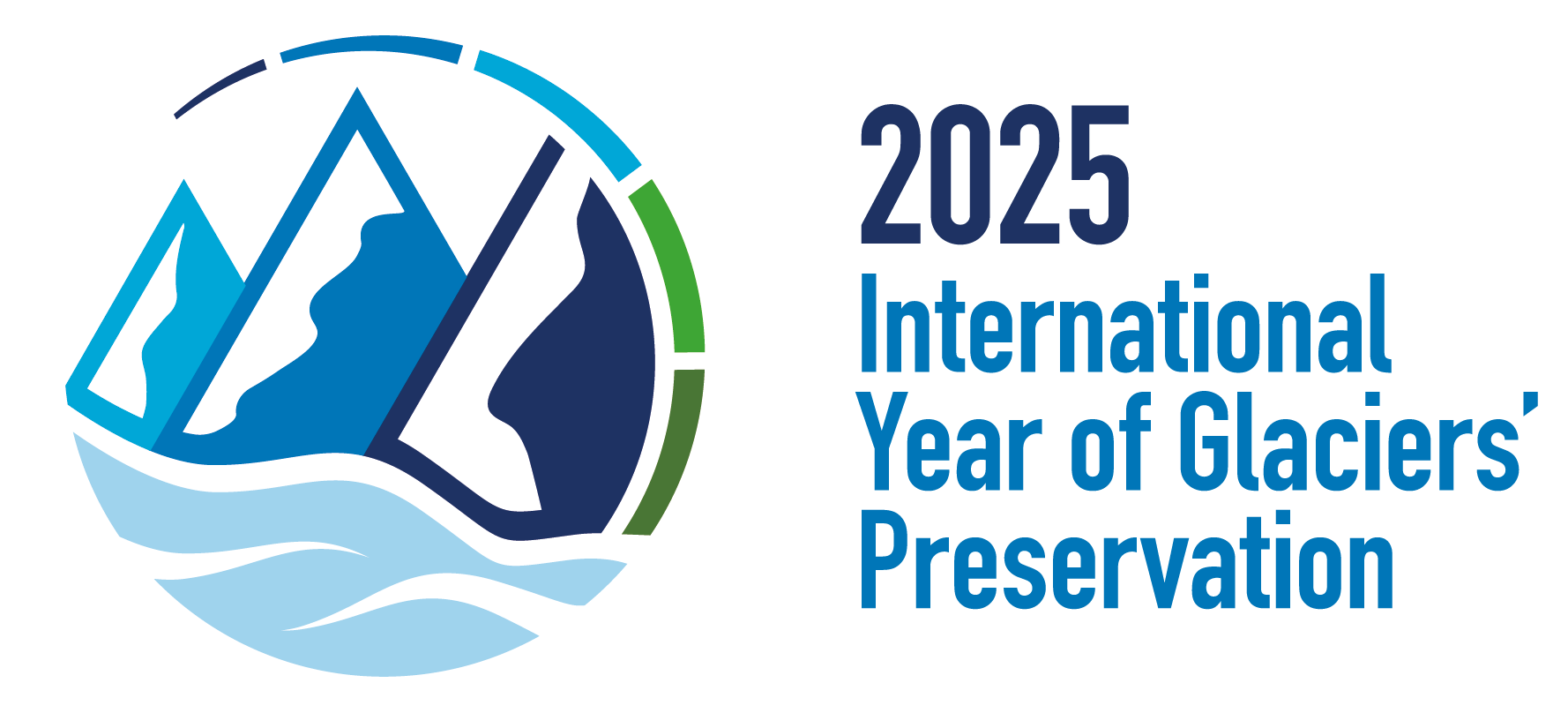
Così, con una lunga salita di mezza estate (ripartita in due giorni
grazie alla possibilità di pernottare al casotto PNGP della Muanda di
Forzo, per gentile concessione dell'Ente Parco), martedì 5 agosto 2025
è stata completata l'installazione dei cartelli indicanti alcune
tappe del ritiro della fronte del Ghiacciaio Ciardoney nell'ultimo
mezzo secolo, corrispondente a un regresso di oltre mezzo
chilometro.
La ricostruzione delle posizioni della fronte in annate
significative (1971, 1979, 1986, 1990, 2000, 2010, 2020) è stata
possibile rintracciando i vecchi massi-segnale istituiti come
caposaldi per le misurazioni (cominciate nel 1971 con l'operatore
Gianpaolo Ravarino e riprese con continuità nel 1986 da Luca
Mercalli e Fulvio Fornengo), e analizzandone i dati
contenuti nelle relazioni delle campagne di osservazione della
Fondazione Comitato
Glaciologico Italiano (CGI).
Percorrendo la piana proglaciale verso la fronte ci si
potrà rendere conto dell'accelerazione del regresso negli ultimi
decenni, giacché i cartelli, riferiti a intervalli di tempo
(quasi) regolari, tendono a essere sempre più distanti tra loro.
Un piccolo progetto nato a margine del
"Percorso glaciologico Federico Sacco" grazie alla collaborazione
tra SMI, CGI,
Comune di Ronco Canavese (che ha sostenuto economicamente la
stampa dei cartelli) e
Parco Nazionale Gran Paradiso.
Un ringraziamento va dunque al sindaco di Ronco
Lorenzo Giacomino e all'Ente Parco nelle persone di Bruno
Bassano (già direttore dell'Ente, fino al 31 agosto 2025),
dell'ispettore di sorveglianza Renzo Guglielmetti, di
Marcella Tortorelli che ha curato la grafica dei cartelli, e al
guardaparco di zona Gianpaolo Palladino, il cui lavoro sul
campo è stato determinante per la loro installazione.








Alcuni dei cartelli indicanti la posizione della fronte dagli Anni
Settanta in poi
(fotografie del 5 agosto 2025).
Ringraziamenti
Un ringraziamento particolare va a
IREN Energia
per il concreto e sempre tempestivo appoggio logistico alle operazioni
sul Ghiacciaio Ciardoney, ad
Arpa Piemonte
e all'Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso per la costruttiva collaborazione.
Devolvi il 5 per mille alla SMI,
sosterrai le ricerche sul Ghiacciaio Ciardoney!

|