|
Giovedì 14 settembre
2023, approfittando di un breve e risicato intervallo mattutino di
schiarite, l'équipe della Società Meteorologica Italiana e dell'Ente Parco Nazionale
Gran Paradiso - in collaborazione
con IREN Energia e nel quadro delle campagne di misura del
Comitato
Glaciologico Italiano - ha condotto i consueti rilievi di
bilancio di massa e variazione frontale al Ghiacciaio Ciardoney.
Alla missione ha partecipato anche un gruppo di operatori afferenti ad
Arpa
Piemonte e al
DiSAFA dell'Università di Torino (Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimentari) per la manutenzione della stazione
meteorologica e l'esecuzione - tramite sorvolo con drone - di un nuovo
modello fotogrammetrico del ghiacciaio che, confrontato con quello
precedente del settembre 2019, ha permesso
l'aggiornamento dei dati di superficie glaciale e il calcolo del
bilancio di
massa con metodo geodetico.
Inoltre il cineoperatore RAI Ivo Bonato, già intervenuto in precedenti
missioni al Ciardoney, ha ripreso le operazioni girando un
servizio andato in onda sul TG1 la stessa sera di giovedì 14
settembre 2023 (vedi il video dal minuto 20 circa).
SESTO BILANCIO DI MASSA PIù NEGATIVO
IN 32 ANNI DI MISURE, E SAREBBE STATO ANCOR PEGGIO
SENZA LE COPIOSE NEVICATE DI MAGGIO 2023
Per il quarto anno consecutivo
sul ghiacciaio non è rimasta traccia di neve residua dell'inverno,
per cui su tutta la superficie affiorava il ghiaccio "vivo" e annerito
dai detriti rocciosi, inclusi massi di grandi dimensioni franati dalle
pareti circostanti e anno dopo anno sempre più numerosi specialmente
nel settore destro orografico sotto le Uje di Ciardoney (effetti del crioclastismo e dello scongelamento del permafrost sui versanti che
sovrastano il ghiacciaio).
Queste sono le perdite di spessore glaciale rispetto al
precedente rilievo del
20 settembre 2022, misurate alle paline ablatometriche:
palina n. 1: 178 cm
palina n. 2: 285 cm
palina n. 3: 287 cm
palina n. 4: 303 cm
palina n. 6: 273 cm
(la palina n. 5 non è più presente da svariati anni, poiché in quel
punto, in sinistra orografica del settore mediano, il ghiaccio è
scomparso)
Media pesata sulle superfici di
pertinenza per l'intero ghiacciaio: 250 cm
Siccome nel 2022 la fusione si interruppe quattro giorni dopo le misure
(strato di neve fresca persistente a partire dal 24 settembre),
pressoché tutta la fusione rilevata attualmente è attribuibile
all'estate 2023.
Il bilancio di massa specifico, riferito alla
superficie glaciale 2022 di 0,47 km2 (calcolata da
ortofoto Google Maps del 18 settembre 2022), è stato valutato in
-2,17 m di
acqua equivalente, valore che si pone al
sesto posto tra i
peggiori nella serie di misure iniziata nella stagione idrologica
1991-92 (dopo i casi del 2021-22, 1997-98, 2002-03, 1998-99 e 2004-05).
Si tratta inoltre di quasi il
doppio di quanto in media si è rilevato,
annualmente, nel già sfavorevole periodo di deglaciazione 1992-2022
(-1,4 m di acqua equivalente).
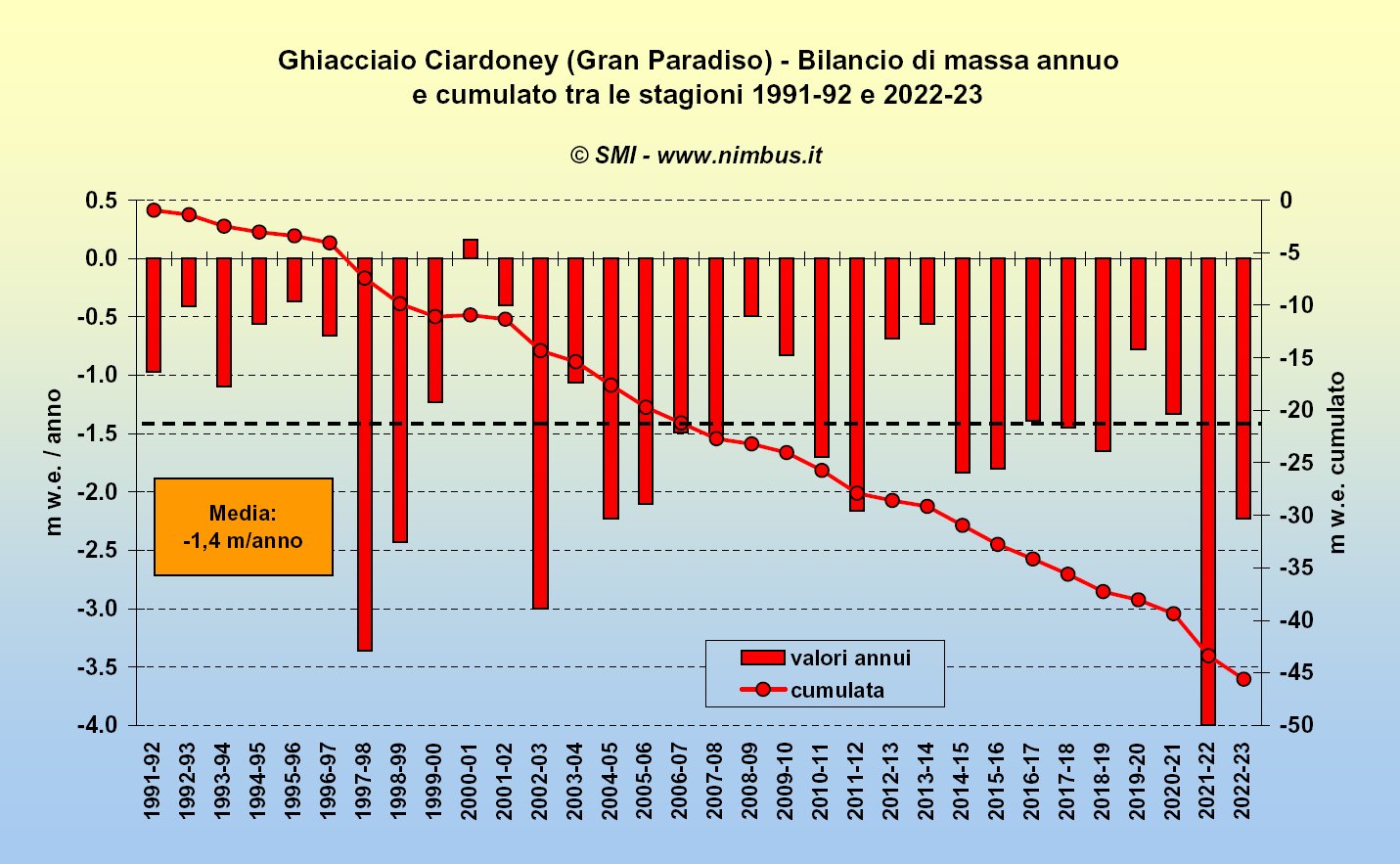
Serie dei bilanci di massa (saldo tra accumuli invernali di neve e
fusione estiva, espressi in acqua equivalente) dalla stagione 1991-92. Il valore dell'annata idrologica 2022-23 (-2,17 m di equivalente d'acqua) è meno estremo
rispetto al record negativo del 2022 (-4,00 m), ma risulta pur sempre
nel gruppo dei peggiori per il glacialismo,
in sesta posizione tra i
più sfavorevoli in 32 anni di misure.
Le perdite di massa cumulate
sfiorano i
-46 m di acqua equivalente,
pari a oltre 50 m di spessore di ghiaccio.
All'ennesima notevole
perdita di massa hanno contribuito sia la
mediocre alimentazione nevosa invernale - resa meno avara di
quella del 2022 solo dalle tardive nevicate di maggio 2023 - sia il
caldo insistente dell'estate, prolungatosi a tutta la prima metà
di settembre e brevemente interrotto da periodi freschi solo a inizio
e fine agosto (grafici e commenti climatici più avanti).
Nel corso della
stagione la coltre di neve stagionale ha cominciato a esaurirsi,
lasciando affiorare il ghiaccio sottostante, a partire dal settore
mediano/destro orografico intorno al 10 luglio, fondendo poi su tutta
la superficie entro inizio agosto.
Per lo meno la nevicata del 28 agosto 2023, l'unica di tutto il
trimestre estivo alla stazione meteorologica a 2850 m (stimati da
webcam circa 5 cm di neve fresca), ha imbiancato il ghiacciaio per
quasi una settimana, evitando perdite di spessore glaciale ancora
maggiori.
Probabilmente un
contributo non
trascurabile alla fusione del ghiaccio è derivato anche da
alcuni violenti temporali avvenuti sotto forma di pioggia a
tutte le quote del bacino glaciale, il più intenso dei quali,
accompagnato da un'impetuosa piena torrentizia, il 24 agosto
(23,0 mm in 1h e 10 minuti, di cui 7,8 in 10 minuti).
REGRESSO DELLA FRONTE:
9 METRI
Nonostante una perdita di spessore dell'ordine di
2,5-3 metri sul pendio inferiore, il regresso del margine frontale
rispetto a settembre 2022 è stato relativamente moderato, pari a -9
m al segnale di misura A4G, grazie a fattori morfologici locali
(fronte attuale in corrispondenza di un'area dotata di maggiore
profondità del ghiaccio rispetto alle posizioni degli anni precedenti;
concavità del letto roccioso-detritico sottostante).
L'inattesa erosione al piede del grande masso su cui nel 2022 venne
collocato il segnale A4G - avvenuta probabilmente durante la piena del
24 agosto 2023 - ne ha determinato il basculamento di 90° verso Nord,
tuttavia ciò non ha alterato la distanza del segnale dal margine del
ghiaccio, per cui la misura di variazione frontale non ne ha
risentito.
In vista della campagna di misure 2024, un nuovo caposaldo (A4H) è
stato istituito in posizione più stabile, pochi metri a Sud,
mantenendo invariata la direzione di misura (230°).
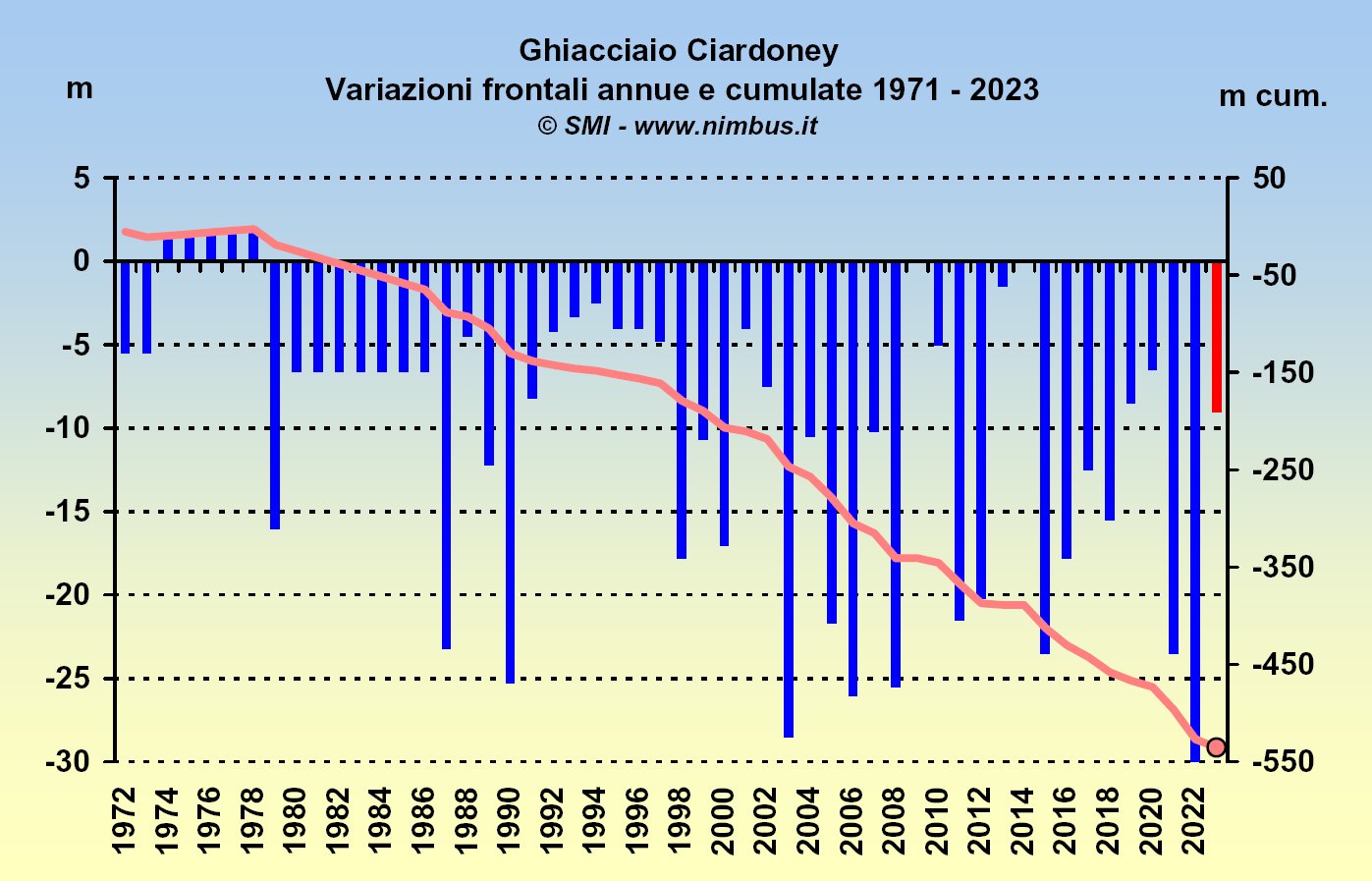
Serie delle variazioni
frontali dalla posa del primo segnale di misura nell'estate 1971
(l'operatore CGI all'epoca era Gianpaolo Ravarino). In rosso il ritiro
del 2023 (-9 m), che porta il regresso cumulato a oltre 530 m.
Qui di seguito, un
fotoracconto della missione del 14 settembre 2023.
.JPG)
.JPG)
Al Colle Ciardoney la perdita di spessore glaciale (178 cm alla
palina n. 1, rispetto al 20 settembre 2022) ha determinato la completa
scomparsa dell'ormai piccola lingua di ghiaccio che si protendeva sul
lato Valsoera (Sud-Ovest) e l'affioramento del substrato roccioso
in prossimità della sella, come non avveniva da secoli se non dai
tempi dell'Optimum Termico Olocenico tra circa 8000 e 6000 anni fa.
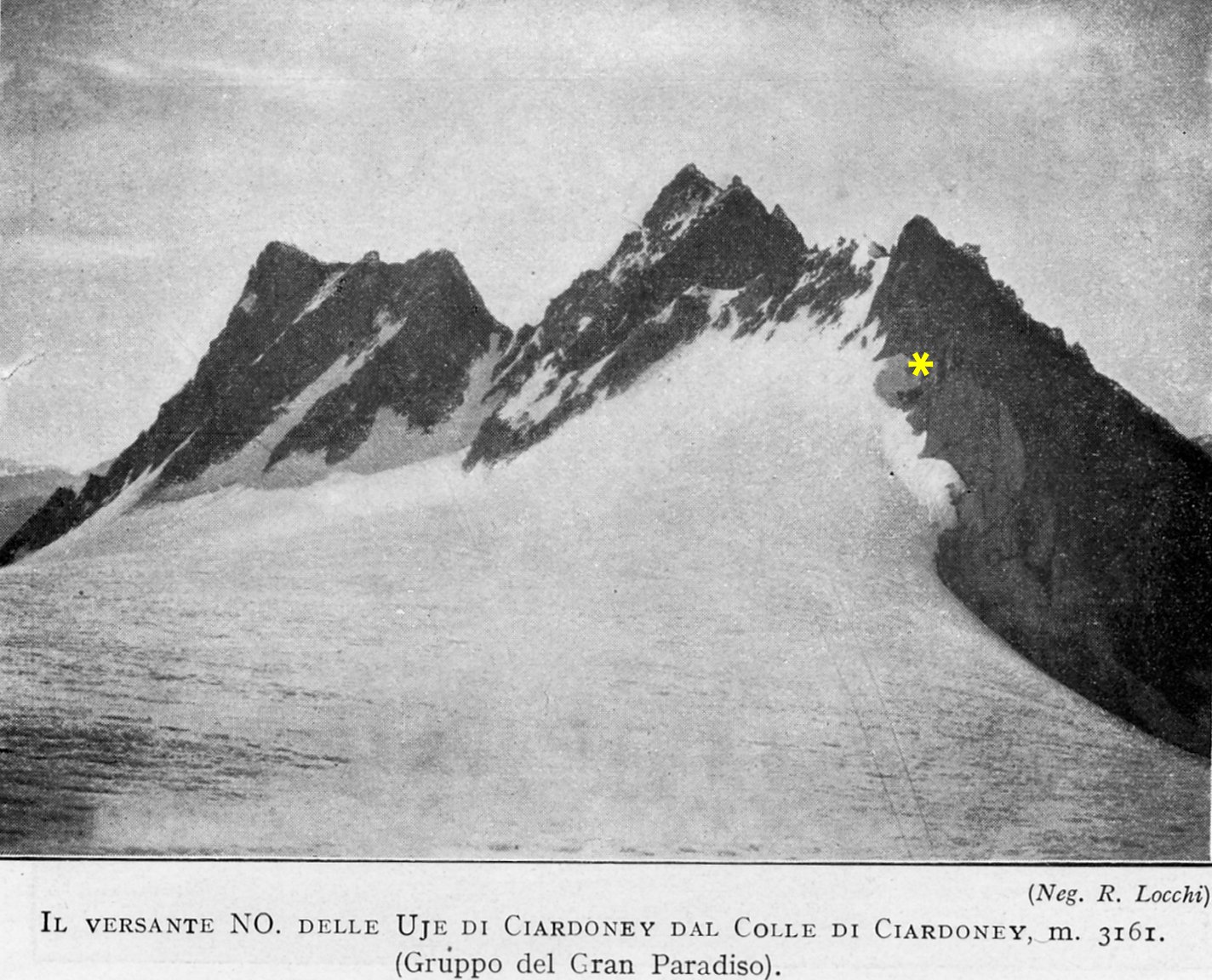
Il confronto con la foto ripresa negli Anni Venti del Novecento da
R. Locchi,
per quanto scattata da un punto un po' più elevato e con inquadratura
differente, permette di rendersi conto della profonda deglaciazione
intervenuta in un secolo (immagine tratta da
Rivista Mensile
CAI, vol. 46, fascicolo 1-2, p. 8).
Il picco che sovrasta il Colle, ben visibile nella foto 2023, si
confonde con la cresta retrostante in quella degli Anni Venti del
Novecento (asterischi).
.JPG)
I due minuscoli Ghiacciai di Valsoera, qui ripresi dal Colle
Ciardoney, sono molto vicini all'estinzione, essendo costituiti da
insignificanti placche di ghiaccio sepolto da abbondante detrito e
pressoché invisibili. Il laghetto in primo piano, evoluto a partire
dai primi Anni Duemila a spese della trasfluenza glaciale
Ciardoney-Valsoera, ora scomparsa, ha dimensioni analoghe a quelle di
fine estate 2022.
.JPG)
Il Colle Ciardoney, alla sommità del ghiacciaio: al perdurare delle
condizioni climatiche attuali potrebbe liberarsi completamente dal
ghiaccio in meno di 5-10 anni.
Dopo gli ampi rasserenamenti notturni, alle ore 8:30 iniziano ad
addensarsi stratocumuli sulle creste a 3300 m, ed entro fine mattinata
l'ulteriore sviluppo di cumuli anche a quote più basse coprirà quasi
completamente il cielo.
.JPG)
.JPG)
Sul settore superiore del ghiacciaio, in prossimità della palina n.
2. Un crollo roccioso dopo l'altro, la presenza di detriti anche di
grandi dimensioni aumenta con il passare degli anni, soprattutto al
piede dei versanti settentrionali delle Uje di Ciardoney
(a destra nell'immagine).
.JPG)
Alla palina n. 4, nel settore mediano
del ghiacciaio, si osservano spesso le più elevate perdite di
spessore glaciale: infatti, probabilmente a causa di una più marcata
asportazione della neve da parte dei forti venti incanalati da Ovest
in inverno, gli spessori nevosi al controllo di fine primavera sono
più esigui qui che nel resto dell'apparato, e di conseguenza
l'esaurimento del manto nevoso durante l'estate è più rapido, e più
lunga l'esposizione del ghiaccio alla radiazione solare.
Il guardaparco PNGP Gianpaolo Palladino mostra con il bastoncino,
sulla palina ablatometrica, il livello del ghiaccio del 20 settembre
2022, abbassatosi di 3 m nell'estate 2023.
.JPG)
.JPG)
Consueta presenza dei "mulini" o "pozzi" glaciali poco a monte
della palina ablatometrica n. 3, nel settore mediano. Il loro numero e
le dimensioni sono tuttavia diminuiti rispetto a 10-20 anni fa
probabilmente a seguito di mutazioni del profilo del ghiacciaio e del
reticolo idrografico superficiale che li genera. Nelle immagini, uno
dei mulini attivi il 14 settembre 2023, alimentato dall'acqua di una
modesta bédière.
.JPG)
Il ritiro del ghiacciaio sul lato sinistro orografico, poco a monte
della fronte, ha abbandonato lembi di ghiaccio "morto" e sepolto dal
detrito al piede della morena laterale. I temporali dell'estate hanno
prodotto ulteriori erosioni e trasportato colate di detrito sulla
superficie del ghiacciaio.
.JPG)
A pochi metri dalla fronte, il grande masso del segnale di misura
A4G - scalzato al piede dall'erosione del torrente glaciale - si è
ribaltato verso Nord di circa 90° forse durante la piena del 24 agosto
2023, tanto che la sigla in vernice rossa, collocata nel settembre
2022 per le misure di variazione frontale, si trova ora sul lato
superiore del blocco roccioso. La sua distanza dal ghiaccio tuttavia
non è cambiata a seguito del basculamento, di conseguenza la misura di
variazione frontale non ne ha risentito,
ma si è comunque provveduto a stabilire un nuovo segnale (A4H) che
sarà di riferimento per i prossimi anni.
.JPG)
Il Ghiacciaio Ciardoney ripreso dalla stazione fotografica S2
presso la stazione meteorologica, il 14 settembre 2023.
RILIEVO FOTOGRAMMETRICO DA DRONE:
AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ALTIMETRICO DEL GHIACCIAIO, DELLA SUA
SUPERFICIE, E VALUTAZIONE DEL BILANCIO GEODETICO
Con
l'intervento del geologo Walter Alberto (Arpa
Piemonte) e dei topografi Luigi Perotti (Università
di Torino/DiSAFA e
Comitato
Glaciologico Italiano) e Francesco Parizia (UniTO/DiSAFA)
è stato possibile ripetere un rilievo fotogrammetrico da drone a
quattro anni
dal precedente del 13 settembre 2019.
La
georeferenziazione del mosaico di 720 immagini
aeree ha permesso di ottenere, oltre all'aggiornamento del dato
di superficie del ghiacciaio (e delle sotto-aree di riferimento di
ciascuna palina ablatometrica), un nuovo modello di altimetria della
superficie glaciale (DTM, Digital Terrain Model), con
precisione dell'ordine di alcune decine di centimetri.
Confrontando quest'ultimo con quello del 2019, condotto dal medesimo
personale con metodo e strumenti identici, è stato possibile
quantificare - tramite le differenze di quota di circa 170 milioni di
punti - le perdite di spessore e volume nell'insieme del ghiacciaio in
4 anni, ovvero:
-8,2 m di
spessore di ghiaccio, in media (riferendosi alla superficie
originaria 2019 per non escludere dal calcolo porzioni di ghiacciaio
presenti allora e poi scomparse),
pari a -7,1 m di acqua equivalente;
-3,6 milioni
di m3 di ghiaccio nell'insieme del ghiacciaio.
Il bilancio
geodetico così ottenuto ha il vantaggio di considerare in maniera
continua, tramite le variazioni altimetriche, tutta la superficie
glaciale, anche le zone coperte da detrito e battute da frane che
sarebbe impossibile monitorare tramite paline ablatometriche (bilancio
glaciologico diretto, condotto sul Ciardoney dal 1992).
Solo una ristretta fascia a ridosso delle pareti settentrionali delle
Uje di Ciardoney, dove non era possibile spingersi con il drone, è
stata esclusa dal modello.
Per la prima
volta dunque è possibile un confronto affidabile tra bilancio
geodetico e bilancio glaciologico su questo ghiacciaio, e i risultati
sono incoraggianti.
Negli ultimi
quattro anni (settembre 2019 - settembre 2023) la stima del bilancio
glaciologico diretto tramite paline (-8,3 m di acqua equivalente) è
stato superiore del 17% a quello geodetico (-7,1 m di acqua
equivalente) che per le sue caratteristiche offre una valutazione più
aderente al vero.
In sostanza, la
collocazione delle paline ablatometriche per lo più lungo la zona
assiale e soleggiata del ghiacciaio, con copertura detritica
relativamente modesta e sparsa - che dunque non attenua in modo
rilevante la fusione a differenza della spessa coltre detritica sotto
le Uje di Ciardoney, dove non è possibile installare paline - porta a
una inevitabile sovrastima nella valutazione delle perdite di
massa, che tuttavia riteniamo di entità contenuta e accettabile
(17%), nel quadro dell'incertezza
che inevitabilmente caratterizza questo tipo di stime.
Le nuove quote
delle paline ablatometriche, ottenute tramite georeferenziazione con
GPS differenziale, sono:
1 (Colle
Ciardoney): 3119 m
2: 3046 m
3: 2991 m
4: 3008 m
6: 2953 m
fronte presso il segnale di misura A4F: 2900 m.
Il bilancio
geodetico è più preciso
rispetto al bilancio glaciologico diretto ottenuto da poche paline ablatometriche,
ma anche più complesso e oneroso da eseguire, e per questo meno
diffuso.
Una sua applicazione in siti-campione come il Ciardoney è ragionevole
a intervalli di alcuni anni, in modo da ottenere aggiornamenti sulle
variazioni areali e volumetriche e stime di fattori correttivi
eventualmente da applicare alle misure di bilancio glaciologico
diretto.
.JPG)
Francesco Parizia (Università di Torino/DiSAFA) pilota il drone con
il quale viene eseguito il rilievo fotogrammetrico completo del
ghiacciaio. L'acquisizione e l'orientamento di 720 fotogrammi hanno
permesso di ottenere un modello della superficie glaciale
caratterizzato da una nuvola di circa 170 milioni di punti.
.JPG)
Per ogni sequenza di riprese (sono
stati eseguiti tre voli distinti su rispettivi settori del ghiacciaio,
superiore, mediano e inferiore) la stazione GPS di riferimento
consente la georeferenziazione dei punti sulla superficie del
ghiacciaio con precisione dell'ordine
di alcuni decimetri, anche sull'altimetria.
.jpg)
Walter Alberto (Arpa
Piemonte) e Luigi Perotti (Università
di Torino/DiSAFA) durante la fase conclusiva del terzo e ultimo
volo del drone sopra il settore inferiore del ghiacciaio, qui a
ridosso della fronte. Il passaggio di alcuni banchi di nebbia non ha
intaccato la qualità delle riprese aerofotogrammetriche.

Mosaico dei 720 fotogrammi ripresi
dal drone sull'intero ghiacciaio e sul pianoro antistante, fino ai
pressi della stazione meteorologica.
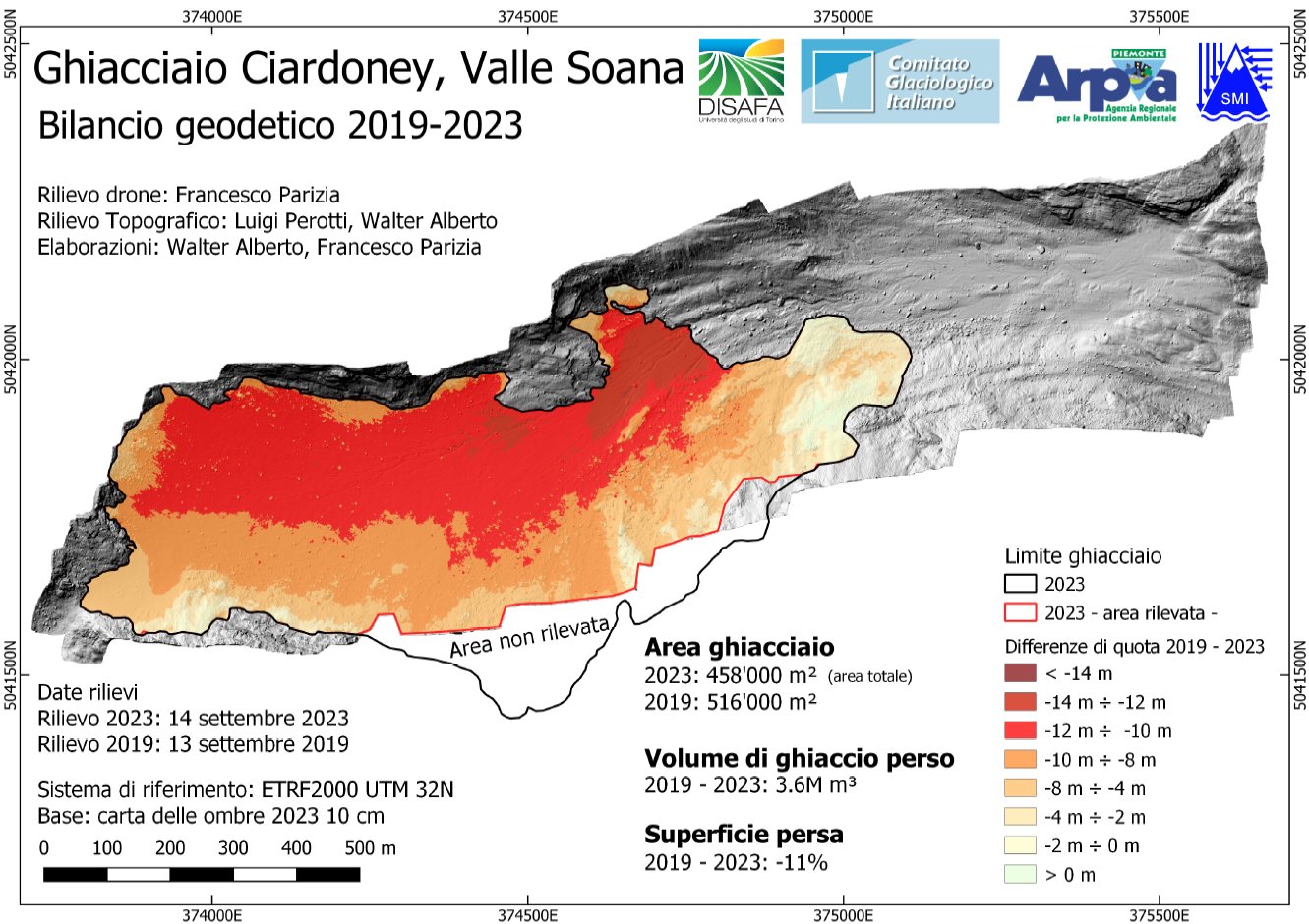
Carta delle variazioni di spessore tra il 13 settembre 2019 e il 14
settembre 2023:
i colori rosso-marrone evidenziano che le maggiori perdite si
verificano sul settore sinistro orografico del ghiacciaio, più
soleggiato e sgombro da detrito, con valori superiori a 10 m in
quattro anni in una vasta fascia che dalla fronte risale fino alle
quote più elevate. Le riduzioni di spessore decrescono portandosi in
destra orografica, per effetto combinato dell'abbondante detrito
roccioso, che protegge il ghiaccio dalla radiazione solare, e del
maggiore ombreggiamento da parte delle Uje di Ciardoney. Sono dunque
questi due i fattori più importanti di controllo della fusione, più
che la modesta differenza di quota tra fronte e sommità del ghiacciaio
(circa 220 m).
La carta è stata ottenuta dalla
rappresentazione delle variazioni altimetriche nei circa 170 milioni
di punti che compongono il modello altimetrico del ghiacciaio.
SUPERFICIE GLACIALE:
-11% IN SOLI QUATTRO ANNI
La
fotogrammetria da drone ha permesso anche l'aggiornamento dei dati di
superficie del ghiacciaio, che tra il settembre 2019 e il settembre
2023 è passata da 0,516 km2 a 0,458 km2,
pari a una riduzione dell'11% in soli quattro anni.
L'ottima ortofoto Google Maps del settembre 2022 è stata utilizzata
come base per completare il perimetro del ghiacciaio nel settore in
destra orografica - sotto le pareti delle Uje di Ciardoney, a ridosso
delle quali il drone per motivi di sicurezza non ha potuto spingersi -
in modo da ottenere valori di area più completi e realistici.
Considerando la
superficie ottenuta da fotointerpretazione di immagini aeree Regione
Piemonte 2010 (0,57 km2), si ottiene che il tasso di
riduzione areale 2019-2023 (-11% in 4 anni) è più che
raddoppiato rispetto al
precedente periodo 2010-2019
(-9% in 9 anni).
I nuovi dati di area 2023 (e relative sotto-aree di
riferimento per ciascuna palina) verranno impiegati per il calcolo del
bilancio di massa il prossimo anno.
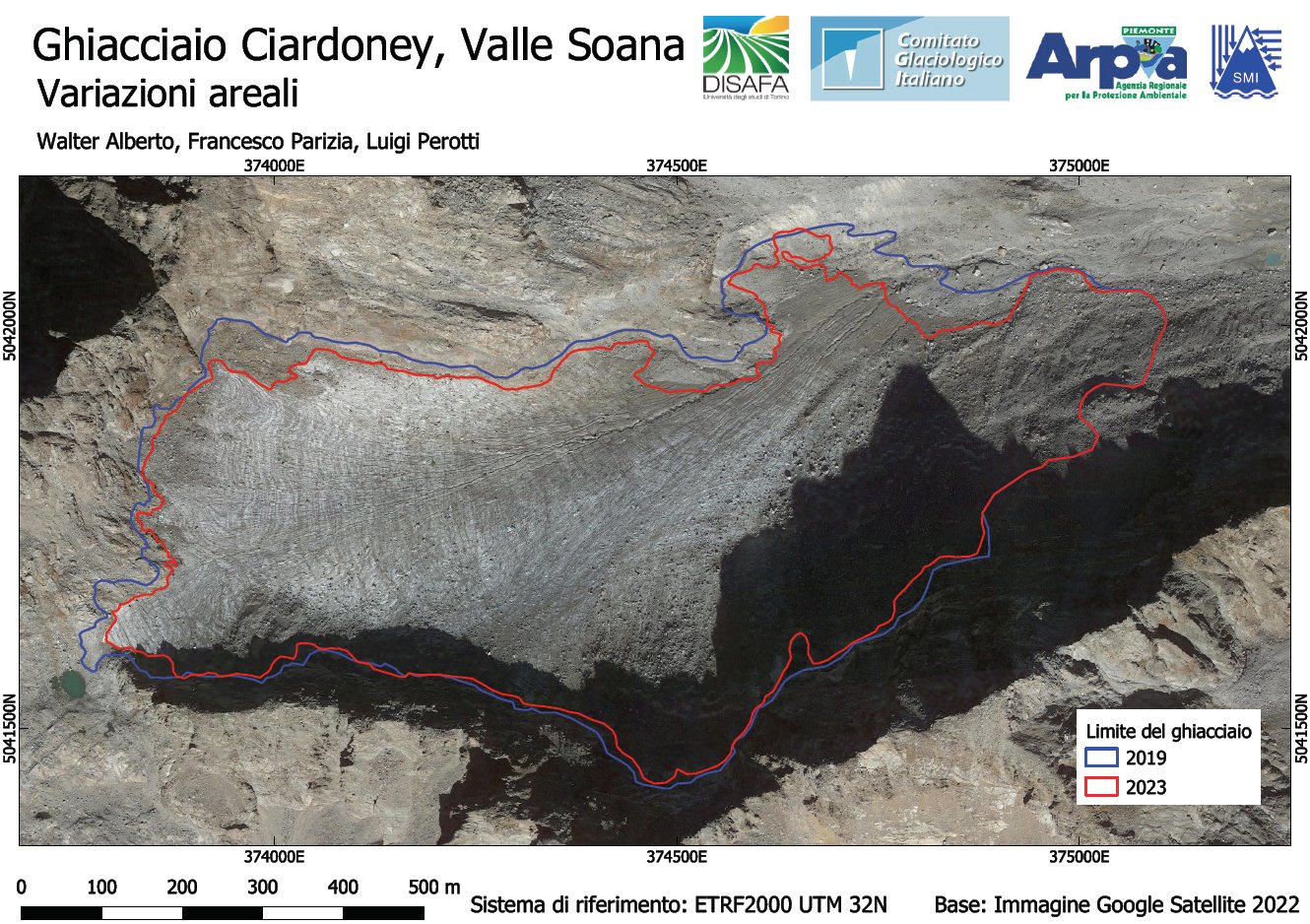
Perimetro del Ghiacciaio Ciardoney il 13 settembre 2019 e il 14
settembre 2023
(su base ortofoto Google Maps del settembre 2022). A contrarsi è stato
soprattutto
il settore frontale in sinistra orografica (in alto a destra
nell'immagine).
La superficie glaciale si è ridotta da 0,516 km2 nel 2019 a
0,458 km2 nel 2023,
pari a -11%.
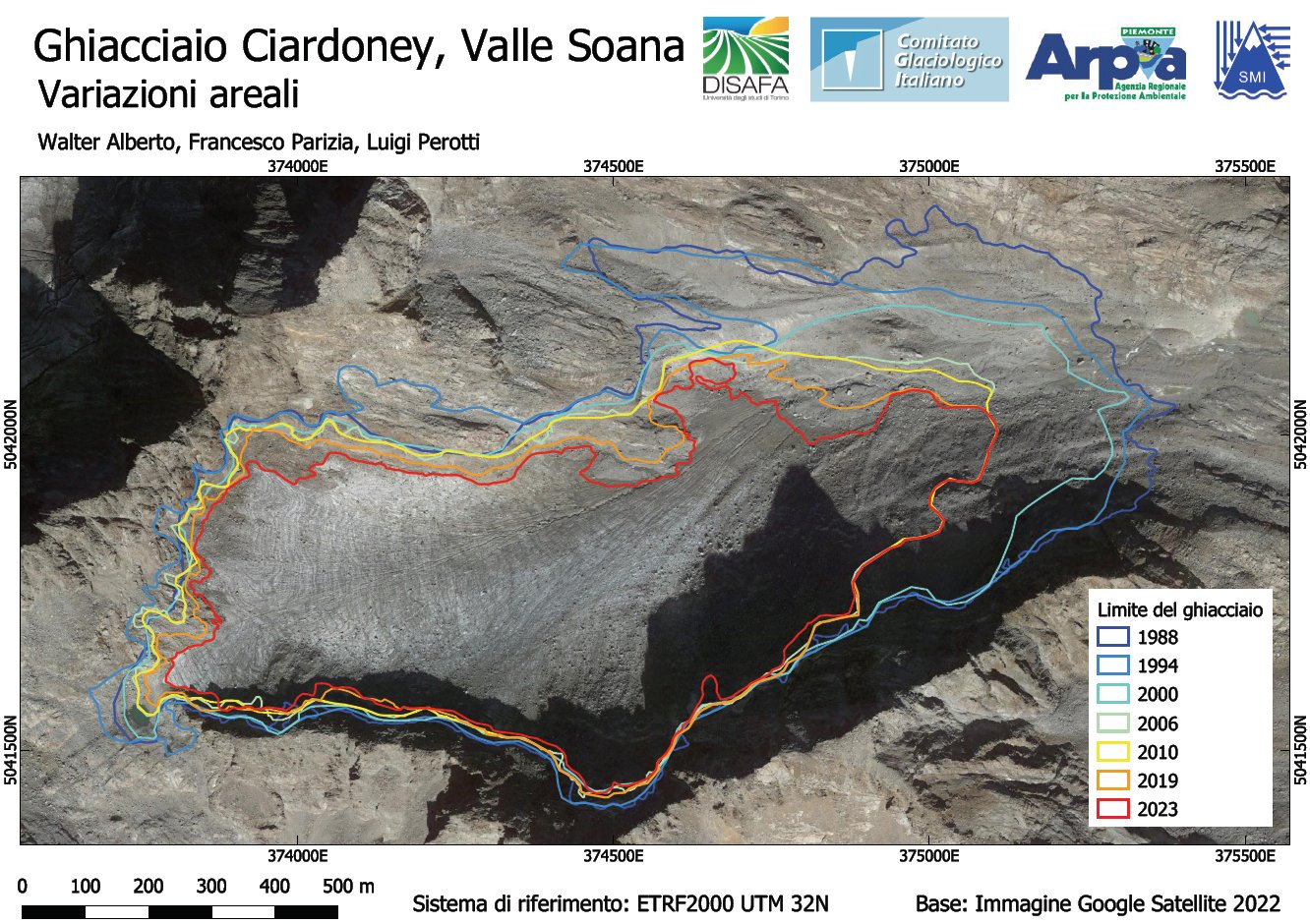
Perimetro del Ghiacciaio Ciardoney ottenuto tramite interpretazione di
immagini aeree riprese a fine estate in diversi anni dal 1988 al 2023
(da drone nel 2019 e 2023).
La superficie glaciale si è ridotta da 0,825 km2 nel
1988 a 0,458 km2 nel 2023,
pari a -44%, ovvero quasi dimezzandosi in 35 anni!
LA STAZIONE E I DATI
MeTEOROLOGICI:
seconda estate piu' calda Nella breve serie dal 2011
Mentre il resto
dello staff era impegnato nelle misure glaciologiche e topografiche,
il socio SMI e meteorologo Arpa Piemonte Alessio Golzio ha
provveduto alla manutenzione della stazione meteorologica, con la
reinstallazione del sensore di altezza neve a seguito di una
riparazione, e l'aggiornamento del programma di acquisizione e
trasmissione dei dati e delle immagini webcam.
Anche nell'estate 2023 i sensori (eccetto quello di altezza
neve) hanno funzionato in modo ottimale e continuo. Solo il
cilindro protettivo dell'idrometro a pressione, immerso nel torrente
glaciale per le misure di livello dell'acqua, è stato riempito di
sedimenti durante la piena del 24 agosto con probabile alterazione di
qualità delle misure, e occorrerà valutare una nuova modalità di
collocazione più resiliente di fronte agli impetuosi ingrossamenti del
corso d'acqua con erosioni di sponda ed elevato trasporto solido.
L'idrometro, pur senza subire danni all'elemento sensore, era già
stato travolto da un'erosione spondale durante la
piena del 2-3
ottobre 2020.
.jpg)
La stazione meteorologica Campbell.
A sinistra del traliccio si scorge il braccio con il sensore del
nivometro a ultrasuoni, che - nuovamente operativo - nel prossimo
inverno 2023-24 consentirà il confronto dei dati automatici di altezza
del manto nevoso con quelli derivanti da
osservazione diretta dell'asta nivometica tramite webcam.
Ecco una
sintesi delle principali caratteristiche climatiche dell'estate
2023 (trimestre giugno-agosto; gli orari indicati sono UTC+1,
ovvero ora solare).
Temperatura
media: 8,1 °C
seconda estate più calda del breve periodo dal 2011, dopo quella
del 2022 (8,4 °C);
1,3 °C sopra la media decennale 2011-2020
Temperatura estrema minima: -2,6 °C il 7 agosto (h 02:40)
Temperatura estrema massima: 20,9 °C il 3 giugno (h 12:40)
record assoluto, per qualunque mese, nella serie 2010-2023
Temperatura minima più elevata: 11,7 °C il 23 agosto
record assoluto, per qualunque mese, nella serie 2010-2023
Massima sequenza di giorni consecutivi senza gelo: 54 gg, dal 2
giugno al 25 luglio
Precipitazioni totali: 348
mm (pioggia e neve fusa)
Massima precipitazione giornaliera (intervallo h 00-24): 41,4 mm
il 27 agosto
Massima precipitazione in 10 minuti: 7,8 mm il 24 agosto (h
15:00 - 15:10)
Numero giorni con almeno 1 mm di precipitazione: 40 (43% del
totale)
Massima velocità del vento: 131 km/h (12 luglio, h 05:40; 19
luglio, h 02:40)
Neve fresca totale: 5 cm (unico evento: 28 agosto)
Data di esaurimento del manto nevoso invernale: 26 giugno
(8 giorni più precoce rispetto alla data media del periodo
2013-2022), 4 luglio
Segnaliamo
inoltre che:
1) i 17,8 °C del 23 agosto 2023 sono la seconda Tmax
giornaliera più elevata per questo mese nella serie dal 2010 dopo i
18,4 °C del 19 agosto 2012 (e sono la più elevata per la terza decade
di agosto);
2) i 18,4 °C
del 5 settembre 2023 sono il nuovo record di temperatura
massima per questo mese nella serie dal 2010 (superano di gran lunga i 15,2 °C del
13 settembre 2019).
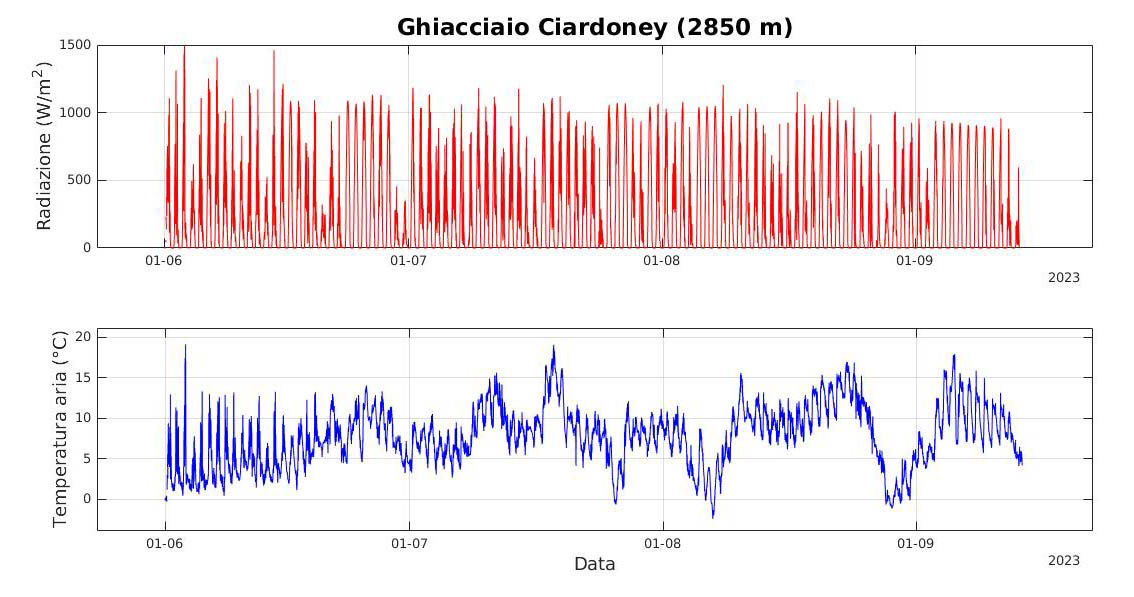
Andamento della radiazione solare globale e delle temperature
dell'aria, registrazioni ogni 10 minuti, dal 1° giugno al 14 settembre
2023, rispettivamente le date delle misure di accumulo nevoso e di
chiusura del bilancio 2022-23.
Le temperature sono rimaste sopra 0 °C per quasi tutta la stagione,
salvo alcune gelate notturne il 26 luglio, 6-7 agosto e dal 28 al 31
agosto.
Quello di fine agosto-inizio settembre 2023 è stato un
intervallo fresco più significativo, per quanto non straordinario,
della durata di circa una settimana, curiosamente inserito tra due
periodi di caldo estremo. Insieme alla nevicata di
5 cm del 28 agosto ha permesso una temporanea interruzione della
fusione glaciale.
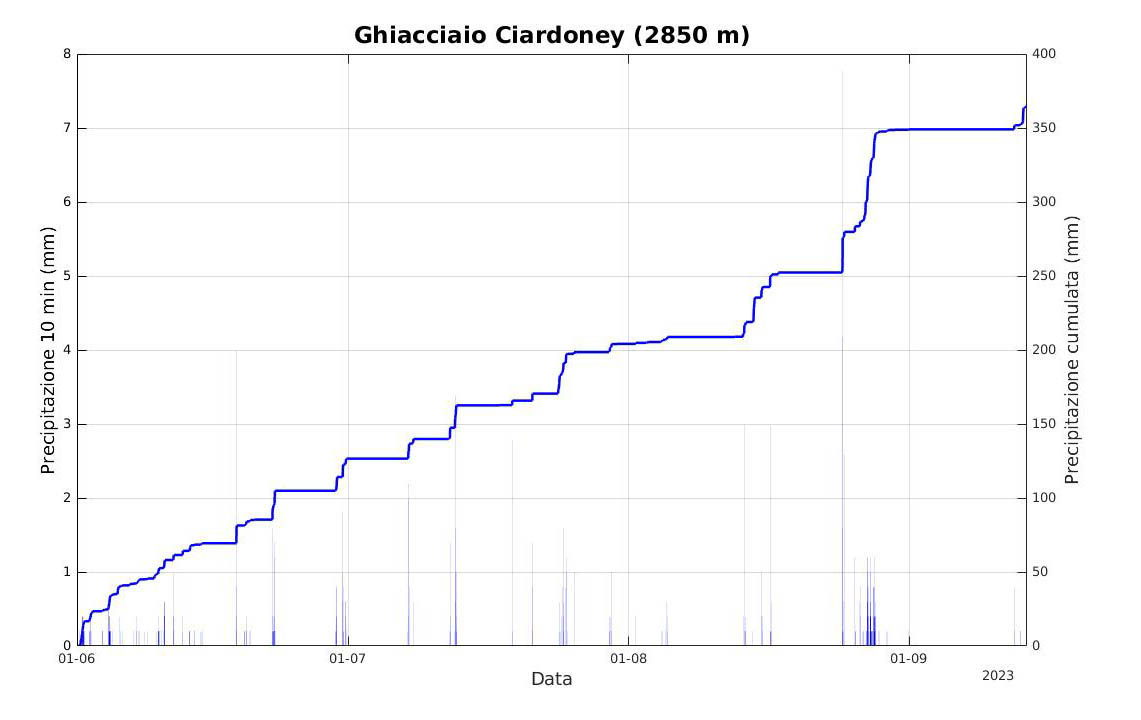
Precipitazioni ogni 10 minuti e
cumulate dal 1° giugno al 14 settembre 2023. Gli apporti sono stati
piuttosto frequenti ma non hanno raggiunto la quantità totale normale
(348 mm nel trimestre giugno-agosto, rispetto a una media prossima a
400 mm). Spicca il periodo senza la minima precipitazione dall'1
all'11 settembre.
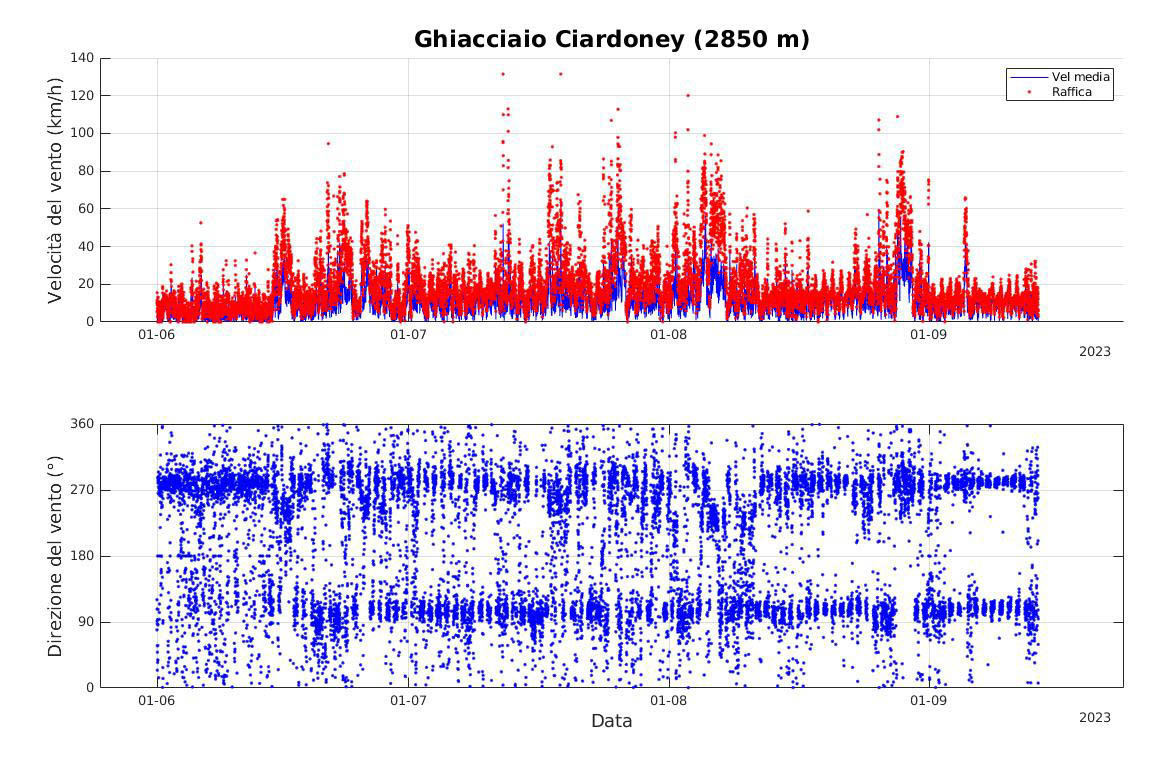
Velocità medie e massime del vento,
e direzioni di provenienza, su intervalli di 10 minuti. In 8 giorni si
sono rilevate raffiche superiori a 100 km/h, sempre in occasione di
burrasche da Nord-Ovest (i cui venti, per ragioni orografiche, si
orientano intorno Ovest/Sud-Ovest alla stazione meteorologica).
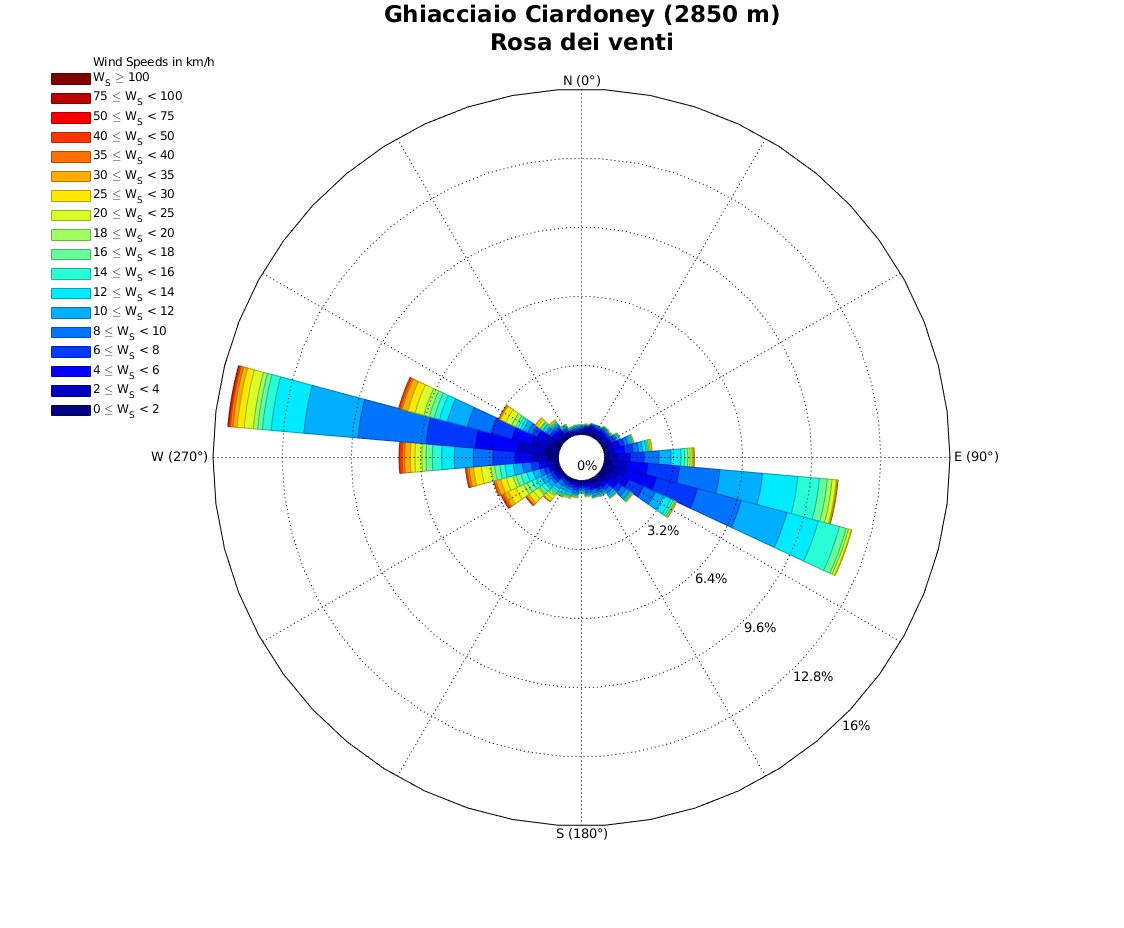
La canalizzazione del vento da parte
dell'orografia è evidente nella distribuzione delle direzioni (rosa
dei venti). Le correnti sono quasi sempre orientate o intorno
Ovest-Nord-Ovest (burrasche nord-atlantiche, brezze di monte/di
ghiacciaio) o intorno Est-Sud-Est (brezze di valle, o flussi sinottici
di origine sciroccale).

La fusione glaciale è proseguita
tardivamente anche dopo il sopralluogo del
14 settembre 2023, come testimonia il torrente ingrossato nel primo
pomeriggio del 17 settembre, in occasione di una successiva missione.
TEMPORALE E PIENA TORRENTIZIA
DEL 24 AGOSTO 2023
Dopo
una settimana di caldo estremo che ha portato
l'isoterma 0 °C a 5200-5300 m sulle Alpi, il 24 agosto 2023 un primo e
lieve cedimento della potente struttura anticiclonica in quota e
l'instabilità diurna alimentata dal forte surriscaldamento del suolo
hanno favorito l'innesco di temporali pomeridiani sulle Alpi. Uno di
questi ha interessato il bacino del Ghiacciaio Ciardoney, da cui si è generata una notevole piena del torrente
dovuta al sommarsi dei contributi della massiccia fusione glaciale
delle ore precedenti e dei violenti rovesci, caduti in forma
piovosa fino alle quote più elevate. Infatti, nonostante il rapido
calo termico avvenuto durante il temporale, ai 2850 m della stazione
meteorologica la temperatura non è riuscita a scendere sotto i 9,7 °C,
dopo una massima giornaliera di ben 17,2 °C (degna di nota, poi, la
temperatura minima del 23 agosto, pari a 11,7 °C, la più elevata nella
pur breve serie di misura 2010-2023).
Il pluviometro ha rilevato 23,0 mm di precipitazione tra le h
14:10 e le 15:20 (ora solare, UTC+1), di cui 14,2 concentrati in 20 minuti
e 7,8 mm in 10 minuti.
Da quanto si deduce dalle immagini radar Arpa Piemonte, è probabile
che quantità ancora più elevate siano cadute a monte, sul ghiacciaio
(peraltro con ulteriore contributo alla fusione del ghiaccio).
Data la ridotta dimensione del bacino sotteso alla stazione
meteorologica (1,7 km2) e l'acclività dei versanti che lo
coronano, la risposta del torrente è stata molto rapida - il suo tempo
di corrivazione è inferiore a mezz'ora - con fenomeni di erosione
lungo le morene ed estesi alluvionamenti del pianoro in
sinistra idrografica, come rare volte osservato da quando il sito è
equipaggiato con sensori meteo-idrologici e webcam (agosto 2010).
Episodi temporaleschi con effetti al suolo analoghi si verificarono il
3-4 settembre 2011, il
22 agosto 2012 e l'8-9 agosto
2015, oltre che (in un contesto di precipitazioni alluvionali ben
più estese) durante la tempesta "Alex" il
2-3 ottobre 2020.
Le temperature in aumento, l'incremento di frequenza e intensità delle
ondate di caldo, e, parallelamente, la risalita del limite
pioggia-neve, rendono più probabile il verificarsi di
precipitazioni intense e liquide anche ad alta quota, sui suoli -
detritici e facilmente erodibili - recentemente liberati dai ghiacciai
in regresso, favorendo l'innesco di episodi di dissesto e di ingente
trasporto solido fin dalle porzioni più elevate dei bacini torrentizi
alpini.
.jpg)
La violenta piena del torrente
glaciale del Ciardoney ripresa alle h 16:09 locali
(ora legale) del 24 agosto 2023, al culmine dell'episodio, dalla
webcam della stazione meteorologica. Sullo sfondo, a destra
nell'immagine, si nota lo straripamento del corso d'acqua in sinistra
orografica e il conseguente esteso alluvionamento del pianoro
antistante il ghiacciaio.
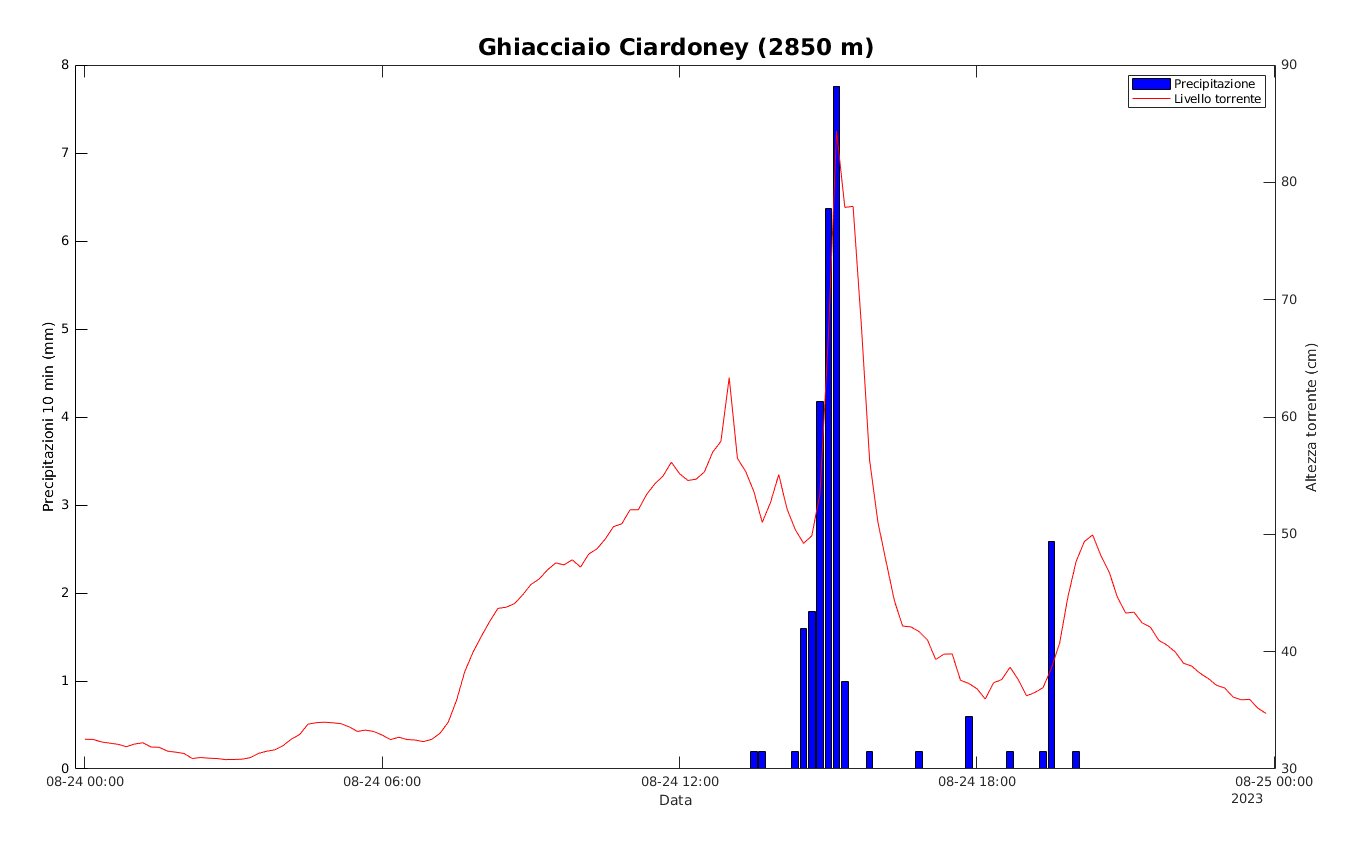
Precipitazioni e livello medio del
torrente su intervalli di 10 minuti il 24 agosto 2023.
Il livello medio più elevato (84 cm) si è registrato tra le h 15:00 e
15:10 (ora solare) esattamente in fase con l'apice di intensità del
temporale (7,8 mm in 10').
Il livello massimo istantaneo è stato invece di 112 cm.
Il tempo di risposta di un bacino così piccolo (1,7 km2) è
molto breve, dell'ordine di 15-20 minuti (si tenga anche presente che,
al picco di intensità della pioggia alla stazione meteorologica, le
precipitazioni erano probabilmente già in attenuazione alla testata
del bacino, da cui la piena si è trasferita a valle).
.JPG)

Il 14 e 17 settembre 2023 erano ben
visibili gli effetti dell'esteso alluvionamento
del pianoro proglaciale, con massicce deposizioni di sedimenti
ghiaioso-limosi
anche intorno al segnale storico del 1971.
IL CIARDONEY TRA I GHIACCIAI DI RIFERIMENTO
DEL WORLD GLACIER
MONITORING SERVICE
Dal 2023 il Ghiacciaio Ciardoney, insieme ad altri 49
ghiacciai di diverse catene montuose del mondo - dalle Ande, alle
Alpi, all'Himalaya - è ufficialmente un "reference glacier"
(ghiacciaio campione, di riferimento) del
WGMS/World Glacier
Monitoring Service (Zurigo) per i bilanci di massa, avendo la sua
serie di misura superato i 30 anni di lunghezza (inizio nel 1992). I dati che misuriamo ogni
anno contribuiranno dunque alla quantificazione dell'impatto a lungo
termine del cambiamenti climatici sulla criosfera terrestre.
L'unico
altro ghiacciaio "campione" WGMS in Italia è, da tempo, quello del
Careser nel gruppo del Cevedale, la cui serie di bilancio di massa
venne avviata nel 1967, e prosegue tuttora a cura di Luca Carturan
dell'Università di Padova e Mauro Gaddo di MeteoTrentino.
Si tratta di un obiettivo che ci riempie di
soddisfazione, raggiunto grazie al costante appoggio e alla
collaborazione di IREN Energia e del Parco Nazionale Gran Paradiso, a tutti gli amici e colleghi che
in questo lungo periodo ci hanno accompagnati nelle variegate attività
sul ghiacciaio, nonché ai sostenitori che tramite il
5*1000 a SMI
permettono il mantenimento dei rilievi e la manutenzione della
stazione meteorologica.
Scheda WGMS del Ciardoney, che verrà aggiornata di anno in
anno con i nuovi dati.
Elenco
dei "reference glaciers" mondiali.
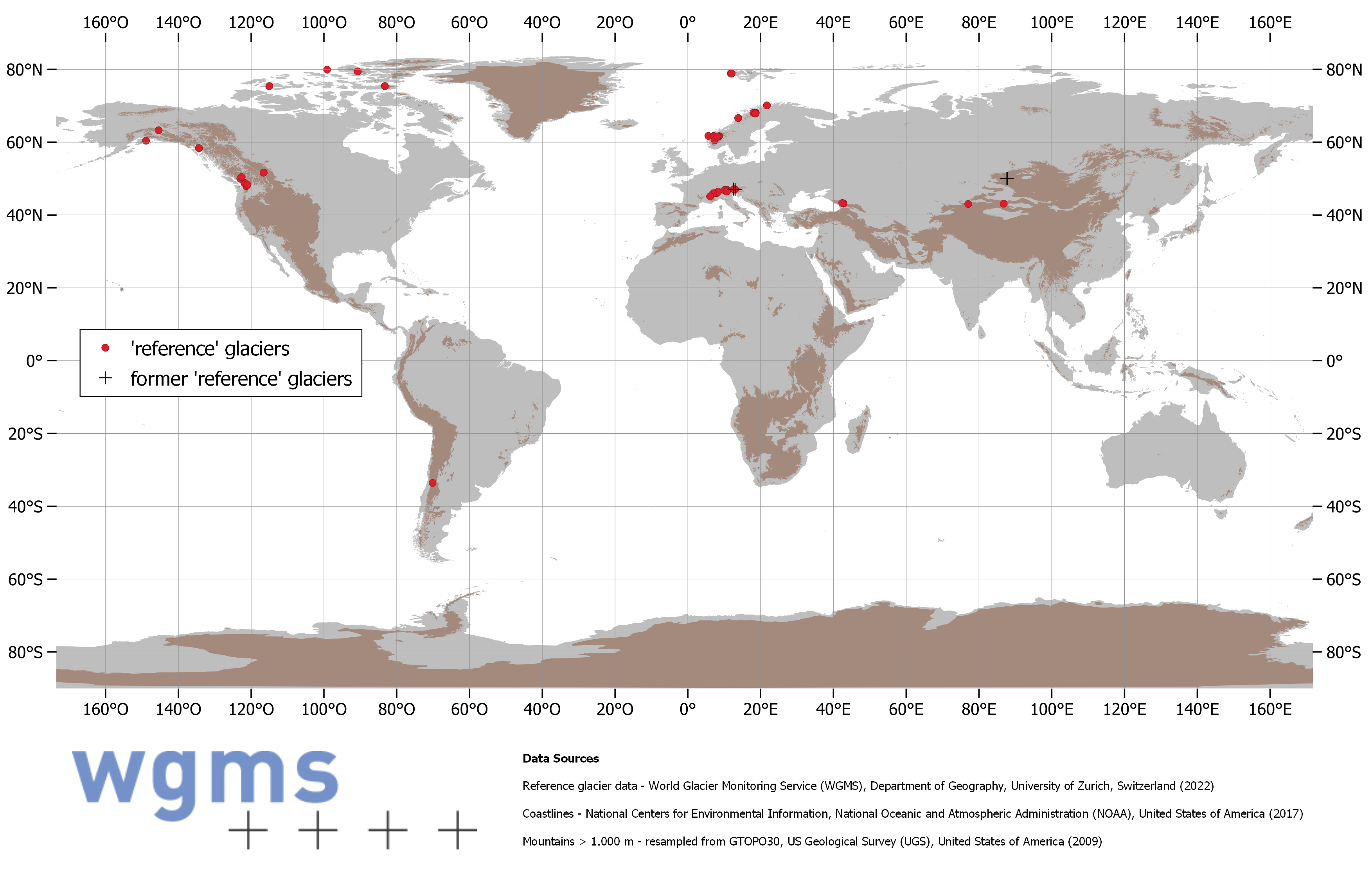
Distribuzione dei cinquanta ghiacciai di riferimento WGMS per i
bilanci di massa,
nelle diverse e principali catene montuose glacializzate del mondo
(sono escluse le calotte polari, il cui monitoraggio avviene per lo
più grazie a misure gravimetriche satellitari).
AGOSTO 2023: INAUGURAZIONE
DEL PERCORSO GLACIOLOGICO "FEDERICO
SACCO"
AL CIARDONEY
Nell'estate 2023, su iniziativa del
Parco Nazionale Gran
Paradiso e della SMI, e con il determinante appoggio del
Comune di Ronco Canavese, è stato segnalizzato ed equipaggiato con
apposite stazioni di riferimento il sentiero che dal Bivacco
Revelli (2610 m) in circa un'ora di cammino porta alla stazione
meteorologica del Ciardoney (2850 m), passando per le morene della
Piccola Età Glaciale.
Il percorso glaciologico, di livello escursionistico ma
con brevi tratti esposti, è stato intitolato a Federico Sacco
(1864-1948), illustre geologo, paleontologo e glaciologo piemontese
particolarmente attivo nel rilevamento del territorio e dei ghiacciai
delle Alpi occidentali (tra cui il Ciardoney) nei primi decenni del
Novecento.
Le cinque soste proposte, segnalate lungo il
percorso con cartelli numerati che fanno riferimento a un dépliant
esplicativo, consentono di osservare le variegate forme glaciali e
periglaciali a valle del Ciardoney, dal rock-glacier di Geri, alle
morene storiche, alle rocce montonate, fino alla vista del ghiacciaio
stesso dalla stazione meteorologica.
Il percorso è stato presentato al pubblico con una
serata divulgativa martedì 1° agosto 2023 al teatro comunale di Ronco
Canavese, e inaugurato domenica 6 agosto con un'escursione
sul posto guidata dal guardaparco PNGP Gianpaolo Palladino,
ideatore dell'iniziativa, e da Daniele Cat Berro della SMI.
Ulteriori informazioni sul percorso e dépliant in pdf
scaricabile
qui.
Il dépliant è disponibile anche in formato cartaceo presso gli
uffici turistici e i centri visitatori del Parco nelle valli Orco e
Soana, ed è scaricabile tramite QR code da appositi cartelli
nelle borgate di Forzo e Tressi (Val Soana), basi di partenza per
raggiungere il Bivacco Revelli e il percorso glaciologico, nonché alla
diga del Telessio (Valle Orco).
Museo e Fondazione Federico Sacco, Fossano.

6 agosto 2023, stazione meteorologica SMI al Ciardoney: foto di
gruppo dei
14 partecipanti all'inaugurazione del percorso glaciologico "Federico
Sacco", in una giornata fredda, ventosa ed eccezionalmente limpida per
il periodo, con temperature minima e massima di -0,7 °C e 4,4 °C, e
velocità massima del vento da Ovest
di 94 km/h (foto di Lorenzo Bossotto).

Stazione n. 3 lungo il percorso glaciologico presso l'apice delle
morene della Piccola Età Glaciale. Le difficili condizioni ambientali,
soprattutto invernali, hanno suggerito la scelta di una soluzione
minimale con piccoli segnali numerici riferiti a descrizioni in un
apposito
dépliant, evitando così l'installazione di bacheche più complesse
ed esposte a danni da vento e neve.

Il Ghiacciaio Ciardoney ripreso dalla stazione fotografica S2
presso la stazione meteorologica, punto di arrivo del percorso
glaciologico "Federico Sacco", nell'ambito del quale sono stati
collocati alcuni cartelli indicatori delle posizioni storiche della
fronte. Qui, secondo la cartografia Sacco, si attestava il margine del
ghiacciaio intorno al 1930, oggi collocato oltre 800 m più a Ovest.
Parte dell'abbigliamento
indossato dall'équipe al lavoro sul ghiacciaio
è stata gentilmente offerta da
Cape Horn,
azienda di materiale tecnico per l'outdoor.

Segui in in tempo reale la situazione
sul Ghiacciaio Ciardoney (dati
meteo e webcam)
Devolvi il 5 per mille alla SMI,
sosterrai le ricerche sul Ghiacciaio Ciardoney!

|