|








«TORBCLIM»:
PROGETTO RICOSTRUZIONE PALEOCLIMA DA TORBIERE
NEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC (VALLE D'AOSTA)
La Società Meteorologica Italiana Onlus,
nell'ottica di promuovere le ricostruzioni del clima storico in area alpina,
ha dato avvio a un progetto di analisi paleo-palinologica
(pollini fossili) in torbiera, grazie all'indispensabile supporto
finanziario di Daikin
Italy e alla collaborazione di:
Università
degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia
dei Sistemi
Università
degli Studi del Molise (Campobasso) - Dipartimento di Agricoltura,
Ambiente e Alimenti
Parco Naturale Mont Avic
Studio Associato di Geologia Maffeo (Biella)
Équipe Arc-en-ciel (La Salle, Aosta)
STI - Servizi Tecnici Integrati
(Biella)
Le torbiere alpine derivano
dall'impaludamento di
laghetti glaciali via via invasi dalla vegetazione, che vi si accumula
decomponendosi solo in piccola parte in scarsità d'ossigeno. Questi
suoli umidi e acidi caratteristici di regioni temperato-fredde
presentano una successione ordinata di strati (orizzonti), databili con
il metodo del carbonio-14 (14C),
in cui si possono rintracciare pollini dei differenti gruppi vegetali
che si sono susseguiti nel tempo in risposta alle variazioni climatiche.
I pollini sono
infatti estremamente resistenti grazie alla robusta parete cellulare (esina)
e possono conservarsi inalterati per milioni d'anni. Tuttavia le
torbiere alpine sono tutte successive alla fine delle grandi glaciazioni
circa 11.500 anni fa, e consentono dunque di aggiungere elementi di
conoscenza del clima passato alla scala di alcuni secoli o millenni, a
seconda della loro età e stadio evolutivo: la scienza che se ne occupa
si chiama «paleo-palinologia» e permette di estendere la conoscenza del clima a periodi precedenti all'inizio
delle misurazioni strumentali (XVIII secolo).
L'obiettivo è dunque mettere in relazione
gli attuali rapidi cambiamenti climatici e ambientali con quelli avvenuti
durante l'Olocene, l'era che, a partire da circa 11.500 anni fa, è
seguita al termine delle grandi glaciazioni del Pleistocene, e che ha
visto lo sviluppo della civiltà umana e la colonizzazione delle Alpi.
Come sito di ricerca è stata individuata
la torbiera «Pessey» nel
Parco Naturale del Mont Avic, a 1730 m in bassa
Valle d'Aosta.
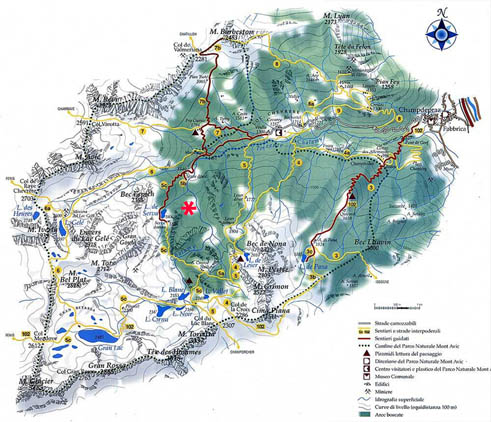
Ubicazione della torbiera «Pessey» (asterisco) nell'alto vallone del
torrente Chalamy,
affluente destro della Dora Baltea (da
www.parks.it/parco.mont.avic/).
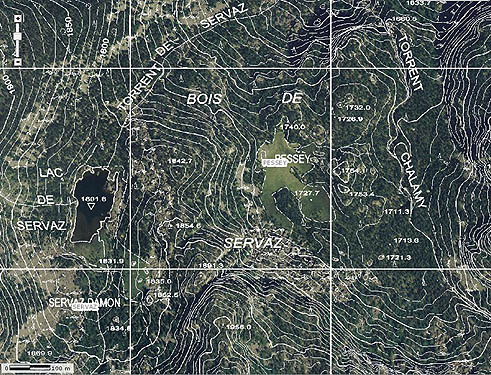
La torbiera in una veduta aerea del 2005
sovrapposta alla
Carta Tecnica della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Il sito si trova attorno a 1730 m di quota, circondato da boschi
pressoché puri di Pinus uncinata,
in esposizione nord-orientale. L'assenza di versanti ampi e ripidi nelle
immediate vicinanze e di un significativo torrente immissario limita le
azioni di disturbo da parte di valanghe o piene torrentizie, situazione
che sembrerebbe dunque favorevole alla deposizione piuttosto
indisturbata delle torbe
alla scala degli ultimi secoli-millenni, una volta ritiratisi i grandi
ghiacciai pleistocenici.
Un primo sopralluogo
per la verifica delle potenzialità del sito è stato condotto il 30
luglio 2013 (fotoracconto qui sotto), mentre il carotaggio profondo
per il prelievo dei
campioni di torba è previsto per
settembre 2013.

Panoramica della torbiera Pessey, ripresa in direzione Est.
Si tratta della più ampia e significativa torbiera del Parco Naturale
del Mont Avic (f. Studio Maffeo).

Particolare del
lobo occidentale della torbiera. Sullo sfondo, chiudono l'orizzonte
l'acuminato
Mont Avic (3006 m, al centro) e il più piatto Mont Ruvi (2922 m, a
destra).
Il moderato vento da Nord-Ovest dopo il fronte temporalesco del giorno
precedente mantiene serena e radiosa l'atmosfera al Sud delle Alpi (f.
SMI).

Ore 7.30, Covarey
(Champdepraz, AO): l'elicottero preleva i materiali da trasportare alla
torbiera (f. Studio Maffeo).

L'arrivo delle attrezzature per l'esecuzione dei sondaggi (f. Studio
Maffeo).

Il lobo orientale della torbiera, depresso di circa 2 metri rispetto a
quello occidentale. Dei due, questo settore sembrerebbe quello evoluto
in situazione più tranquilla, come indicherebbe la maggiore e più
promettente presenza di torba (f. SMI).

Dettaglio della tipica vegetazione da ambiente acido di torbiera:
Eriophorum latifolium (f. SMI).
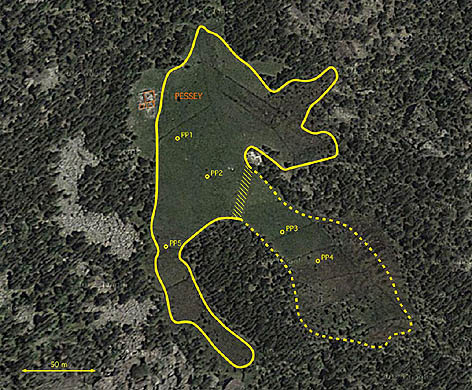
Ubicazione dei
siti in cui sono stati eseguiti sondaggi tramite penetrometro dinamico
leggero (vedi immagini seguenti) per identificare gli spessori dei
sedimenti e la loro durezza, indizio della tipologia dei depositi
(torba, sabbie, limi, argille...).




Nelle quattro
immagini qui sopra, prove con penetrometro dinamico leggero:
si tratta di un apparecchio composto da un maglio percussore da 30 kg
azionato da un generatore accoppiato a circuito oleodinamico, che infigge nel suolo un'asta graduata cui si
aggiungono elementi mano a mano che si scende in profondità, fino a
raggiungere il substrato roccioso.
In questo modo è possibile conoscere
lo spessore (in questo caso fino a 8-10 m)
e le caratteristiche fisiche dei depositi (f. SMI).

Stefano Maffeo (Équipe Arc-en-ciel) annota i risultati delle prove
penetrometriche (f. SMI).


A corredo delle prove penetrometriche, sono stati eseguiti anche alcuni
saggi con carotiere manuale per l'estrazione e una prima analisi visiva
di campioni di torba (f. SMI).

La palinologa Elisabetta Brugiapaglia (Università degli Studi del
Molise)
osserva un campione di torba dall'aspetto promettente per le prossime
ricerche (f. SMI).

Luca Mercalli
(Società Meteorologica Italiana), promotore del progetto «TorbClim»
con due campioni di torba appena estratti (f. SMI).

Elisabetta
Brugiapaglia (Università degli Studi del Molise) e Consolata Siniscalco
(Università degli Studi di Torino) sovrintenderanno alla datazione della
torba
e all'analisi dei pollini fossili contenuti (f. SMI).

Dettaglio di
campioni di torba, in cui si può ancora distinguere
il materiale
vegetale di origine (f. SMI).

L'ambiente della torbiera Pessey, ripreso verso Est, con la cresta
rocciosa
tra il Bec de Nona (2329 m) e Cima Piana (2511 m) (f. SMI).


Il ritrovamento di
antichi elementi legnosi (fusti e rami di Pinus uncinata) inglobati
nella torba e riportati alla luce dall'azione erosiva del piccolo rio
emissario della torbiera, potrà aiutare a ricostruire il paleoambiente locale
(f. SMI).

Il gruppo di lavoro. Da sinistra a destra: in piedi, Stefano Maffeo
(Studio Maffeo ed Équipe Arc-en-ciel),
Giuseppe Massaro (STI Biella), Loris Gyppaz (tecnico Parco Naturale Mont
Avic), Luca Mercalli (Società Meteorologica Italiana), Paolo Dalla Ore e
Mauro Giovannini (STI Biella), Elisabetta Brugiapaglia (Università del
Molise), Consolata Siniscalco (Università di Torino), Sergio Gaioni
(Guida Natura - La Genziana, Verres),
Gabriele Francini (Studio Maffeo); accosciati, Brunello Maffeo (Studio
Maffeo)
e Massimo Bocca (direttore Parco Naturale Mont Avic) (f. SMI).
A seguito di questo sopralluogo, il
progetto «TorbClim» è proseguito con l'esecuzione dei carotaggi
della torbiera Pessey l'8-11 ottobre 2013: ecco il
fotoracconto delle operazioni.
|