|



 






PROGETTO
«TORBCLIM»:
EFFETTUATI I CAROTAGGI
ALLA TORBIERA PESSEY,
PARCO NATURALE DEL MONT AVIC
(VALLE D'AOSTA)
15.10.2013
A cura di SMI / Redazione Nimbus
Ricordiamoci in grazia che il cercar la costituzione del mondo
è de' maggiori e de' più nobil problemi che sieno in natura.
Galileo Galilei,
Dialogo, II
A seguito dei sopralluoghi estivi e delle
indagini eseguite il 30 luglio scorso, nei giorni tra l'8 e l'11
ottobre 2013 sono state condotte le operazioni di carotaggio a fini di
ricerche paleoclimatiche e paleoambientali alla torbiera Pessey
(progetto «TorbClim»), a quota
1800 m nel Parco Naturale del Mont Avic (bassa Valle d'Aosta).
«TorbClim» è un progetto voluto e finanziato dalla Società
Meteorologica Italiana, anche grazie al contributo di
Daikin Italy
nonché ai proventi del
5 per
mille.
Ecco un fotoracconto
delle giornate di lavoro, a cui hanno partecipato:
- Società Meteorologica Italiana,
Studio Associato di Geologia Maffeo
(Biella)
ed
Équipe
Arc-en-ciel (La Salle, Aosta) per il coordinamento.
- Parco Naturale Mont
Avic per l'assistenza alla logistica.
-
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e
Biologia dei Sistemi e
Università degli Studi del Molise (Campobasso) - Dipartimento di
Agricoltura, Ambiente e Alimenti, per la consulenza scientifica.
- La ditta CTE -
Costruzioni Tecno - Elettriche (Acqui Terme) per l'esecuzione dei
carotaggi.
- Airstar
Elicotteri (Mottalciata, Biella) per l'elitrasporto dei materiali.
- La
sede RAI di Aosta e il
fotografo Franco
Borrelli per la documentazione dei lavori con fotografie e riprese
video in alta qualità.

8 ottobre 2013, ore 12: dopo una settimana di cielo ostinatamente
coperto e visibilità ridotta sulle Alpi occidentali, il lento colmamento
della depressione presente sull'Italia consente alcune schiarite,
sebbene pur sempre in un contesto di nuvolosità irregolare che ostacola
a tratti i voli in elicottero, ma è l'ultima finestra disponibile prima
dell'arrivo della neve.
Ecco i pesanti materiali (totale oltre 50 quintali) della ditta CTE, che
provvederà all'esecuzione dei carotaggi, radunati sul piazzale di
Covarey (Champdepraz) in attesa dell'elitrasporto (f. SMI).

8 ottobre 2013: ore 13,
si inizia... (f. SMI).


... ma presto le nebbie
avvolgono nuovamente la zona. La squadra - sotto l'efficientissimo
coordinamento logistico di Stefano Maffeo (Studio Geologi Maffeo ed
Équipe Arc-en-ciel) - giunta sulla torbiera Pessey per l'avvio del
montaggio della sonda geognostica,
attende una schiarita (f. Franco Borrelli).

La nebbia si dilegua e
riprendono le rotazioni d'elicottero. In primo piano, uno dei cingoli
che permetteranno di muovere la sonda sul suolo in parte paludoso della
torbiera
(f. Franco Borrelli).


8 ottobre 2013:
terminate le operazioni di trasporto, gli operai CTE provvedono al
montaggio della sonda geognostica (f. Franco Borrelli).



9 ottobre 2013: il
secondo giorno di lavori è dedicato all'inizio dei carotaggi.
Il temporaneo afflusso di aria più asciutta permette ampie schiarite
nelle valli alpine interne: al primo mattino, dopo una notte serena, il
raffreddamento dei bassi strati atmosferici in assenza di vento produce
lieve brina al suolo, e una sottile nebbia che si dissolve al levar del
sole, producendo un'atmosfera suggestiva (f. Franco Borrelli).
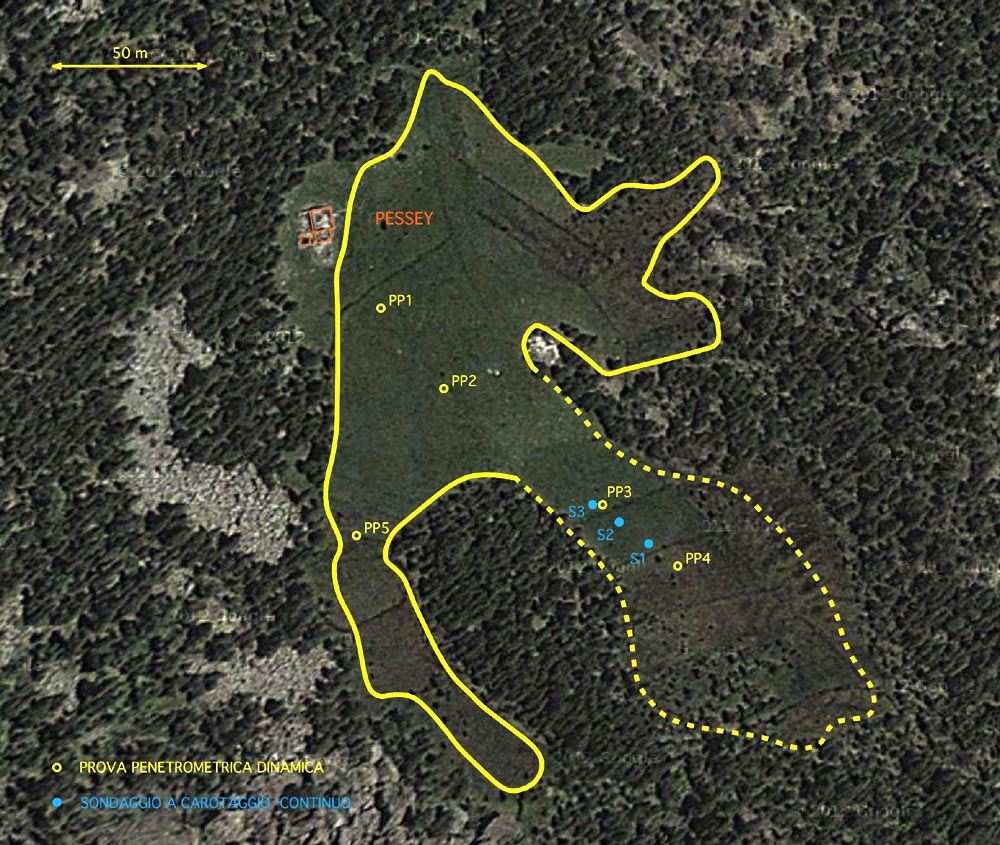
Ubicazione dei
siti in cui sono stati eseguiti i sondaggi preliminari del 30 luglio
2013 (sigle in giallo da PP1 a PP5) e quelli prescelti per l'estrazione
di 3 «carote» complete fino a profondità di 10 m circa (sigle in
azzurro, da S1 a S3). Le indagini si sono concentrate sul lobo orientale
della torbiera, lievemente più depresso rispetto a quello occidentale, e
che in base alle prove penetrometriche della scorsa estate mostrava le
maggiori potenzialità in base a spessori e caratteristiche fisiche dei
sedimenti (elaborazione Studio Maffeo).

9 ottobre 2013: per
evitare danni alla fragile cotica erbosa della torbiera
si è disteso un nastro di geotessuto su cui si sono appoggiate plance
metalliche traforate
in grado di distribuire il peso della macchina operatrice (f. SMI).

Ed ecco la sonda che si avvicina (qui sopra) e viene messa in attività
(qui sotto) al primo sito prescelto per la perforazione e l'estrazione
dei campioni di torba (S1) (f. SMI).


L'elemento perforatore porta al suo interno una fustella cilindrica in
PVC
della lunghezza di 1,5 m, che ospiterà il campione prelevato (f. SMI).

Durante le operazioni di carotaggio, un telo plastico protegge il suolo
sottostante da eventuali perdite di sostanze oleose. La perforazione
procede per intervalli di 1,5 m, estraendo ogni volta la sonda e un
campione di sedimento, fino alla profondità di 10,5 m, più o meno
lentamente in base alla natura dei materiali incontrati (f. SMI).

In queste immagini, l'estrazione della prima «carota». La presenza di
torba coinvolge
il primo metro circa dalla superficie, mentre al di sotto prevalgono
limi di origine lacustre,
qui saggiati da Luca Mercalli. Sopra, in secondo piano, compaiono anche
Roberto Facchini, guardaparco del Mont Avic, nonché Michele D'Amico e
Consolata Siniscalco, dell'Università di Torino -
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei
Sistemi
(f. Franco Borrelli).


Luca Mercalli mostra un
campione dei materiali estratti
alla telecamera dell'operatore RAI Pietro Taldo (sede
regionale di Aosta) (f. Franco Borrelli).

Mentre Stefano Maffeo (Studio Geologi Maffeo ed Équipe Arc-en-ciel)
consulta gli operai CTE, Consolata Siniscalco (Università di
Torino) annota le informazioni
sulle prime operazioni di estrazione... (f. Franco Borrelli).

... e osserva insieme a Luca Mercalli alcuni campioni (f. Franco
Borrelli).

Roberto Giacometti (geologo CTE) ripulisce e prepara per le analisi di
laboratorio
la prima fustella estratta dalla sonda (0 - 1.5 m di profondità, sito
S1) (f. SMI).

Per evitare perdite di materiale, le estremità vengono sigillate
con paraffina liquefatta... (f. SMI).
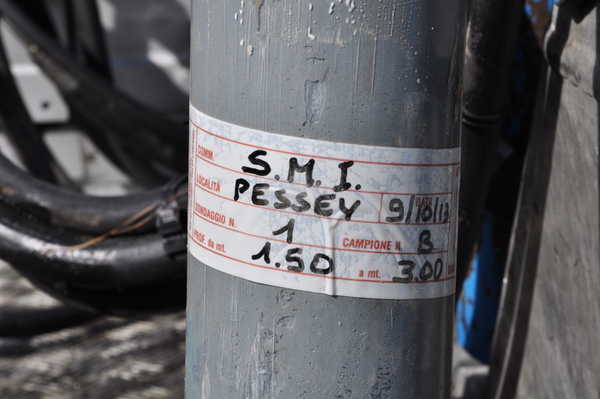
... ciascuna fustella viene numerata e contrassegnata con una etichetta
... (f. SMI).

... e riposta in cassette per il successivo trasporto a valle (f. Franco
Borrelli).

10 ottobre 2013: un momento dei lavori al sito S2. Brunello Maffeo
(Studio Geologi Maffeo) e Roberto Giacometti (CTE) osservano le cassette
contenenti i campioni estratti fino a 10 m di profondità (f. SMI).

La cassetta contenente i primi 5 m dalla superficie (in questo caso,
ciascun campione è lungo un metro). Il profilo sedimentologico è simile
a quanto già riscontrato in S1: da sinistra, il primo metro è
interamente contraddistinto da torba, che gradualmente cede il passo a
limi di origine lacustre al di sotto di 1.2 - 1.3 m. Alcuni orizzonti
sono costituiti da sedimenti ghiaiosi e materiale lapideo di natura
serpentinitica, probabilmente attribuibili a trasporto solido
alluvionale (f. SMI).

Ma, in questo sito (S2) l'elemento di grande interesse è dato dal
rinvenimento, a 5.3 m dalla superficie, di un tronco sepolto
(probabilmente di Pinus uncinata, molto diffuso in zona) che consentirà
una più precisa datazione dei sedimenti con il metodo del
carbonio-14 (14C)
e migliorerà
la ricostruzione del paleoambiente locale (f. SMI).

10 ottobre 2013: nel pomeriggio si prosegue con i carotaggi al sito S3
(profondità 10,5 m), che conferma la situazione riscontrata in S1 e S2.
Intanto una perturbazione da Ovest si addossa alle Alpi e produce
pioggia moderata, seguita dopo le h 16 da schiarite in atmosfera
turbolenta al passaggio del fronte freddo, con vento in rinforzo,
temperatura in calo e una prima spruzzata di neve sopra i 2200 m (f.
SMI).

11 ottobre 2013: i lavori sono terminati, il cantiere viene smontato e
verso mezzogiorno, approfittando delle schiarite portate dal vento da
Nord,
inizia l'elitrasporto dei materiali verso valle (f. SMI).

Smontato il cantiere, l'aspetto della torbiera Pessey appare pressoché
inalterato, salvo l'inevitabile calpestio delle specie erbacee che
scomparirà alla ripresa vegetativa della prossima stagione (f. SMI).
Come evolverà il progetto «TorbClim» ?
I campioni estratti alla torbiera Pessey sono ora conservati presso il
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - Orto
Botanico - dell'Università
di Torino (Consolata Siniscalco, Rosanna Caramiello), che insieme all'Università
del Molise (Elisabetta Brugiapaglia) e al
Museo
Archeologico del Finale (Daniele Arobba) coordinerà nei prossimi mesi le
analisi palinologiche dei sedimenti.
Franco Gianotti (Dipartimento
di Scienze della Terra, Università di Torino) curerà le indagini
sedimentologiche; dettagliate analisi chimiche verranno inoltre condotte
dall'équipe di Michele Freppaz (sempre dell'Università di Torino),
mentre la datazione dei campioni sarà eseguita dall'Università
di Lecce - Centro di Datazione al Radiocarbonio (CEDAD).
Un ringraziamento particolare va a Massimo Bocca, direttore del
Parco Naturale Mont
Avic,
per l'importante disponibilità offerta, e a tutti coloro che - anche se
non espressamente nominati - hanno lavorato insieme con grande
professionalità, flessibilità e spirito di squadra.
|