|
CON LA TAPPA DEDICATA AL GRAN PARADISO TERMINA
LA "CAROVANA DEI GHIACCIAI" 2021 DI LEGAMBIENTE
12 settembre
2021
Daniele Cat Berro -
SMI/Redazione Nimbus
Con la tappa dedicata al Gran Paradiso (8-11 settembre
2021) e con una conferenza stampa al
Forte di Bard
(Valle d'Aosta, 13 settembre) termina la seconda edizione della
"Carovana dei ghiacciai" di Legambiente, che in venti giorni ha
percorso le Alpi - aggiungendo anche una digressione appenninica al
ghiacciaio del Calderone - per sensibilizzare cittadini e
amministratori sulla gravità dei cambiamenti climatici e della
deglaciazione.

La rassegna, che si è avvalsa della collaborazione e assistenza
scientifica del
Comitato Glaciologico Italiano, ha toccato diversi gruppi
montuosi (tanto o poco) glacializzati, Adamello, Cevedale, Alpi Giulie,
Gran Sasso e Gran Paradiso, presso cui sono stati organizzati
eventi-conferenze per il pubblico con esperti del settore
glaciologico-ambientale, escursioni e simboliche cerimonie di "saluto"
ai ghiacciai in sofferenza e talora in estinzione, come il
Ghiacciaio del Calderone, l'unico dell'Appennino e il più meridionale
d'Europa.
La SMI ha partecipato alle due giornate sul versante
piemontese del Gran Paradiso (8-9 settembre), che hanno contemplato
la conferenza "Ghiacciai e servizi ecosistemici in quota" presso il
salone del Parco Nazionale
del Gran Paradiso al Grand Hotel di Ceresole Reale, e l'escursione
al piccolo Ghiacciaio della Capra, sempre in alta Valle Orco.
I ghiacciai della zona sono particolarmente sensibili al
riscaldamento atmosferico, tanto che in meno di due secoli, dalla
fine della Piccola Età Glaciale (1820-1850) hanno perso circa il 65%
della loro superficie, passando da circa 88 km2 a meno di
30km2 (info SMI - Università di Torino/DST - Fondazione
Montagna Sicura).


Una considerevole
parte della deglaciazione avvenuta negli ultimi due secoli si è
concentrata a partire dalla fine degli Anni 1980. Qui vediamo la
massiccia riduzione dei ghiacciai intorno al Lago Serrù (alta Valle
Orco, Gran Paradiso) tra il 5 settembre 1988 (foto Luca Mercalli)
e il 4 settembre 2018 (foto Daniele Cat Berro): il ghiacciaio
Occidentale del Carro (a sinistra), della Capra (al centro, meta
dell'escursione della Carovana dei Ghiacciai 2021 di Legambiente) e
della Losa (a destra, pressoché estinto).
Ecco una rassegna fotografica degli eventi di questa tappa sulle Alpi
occidentali.

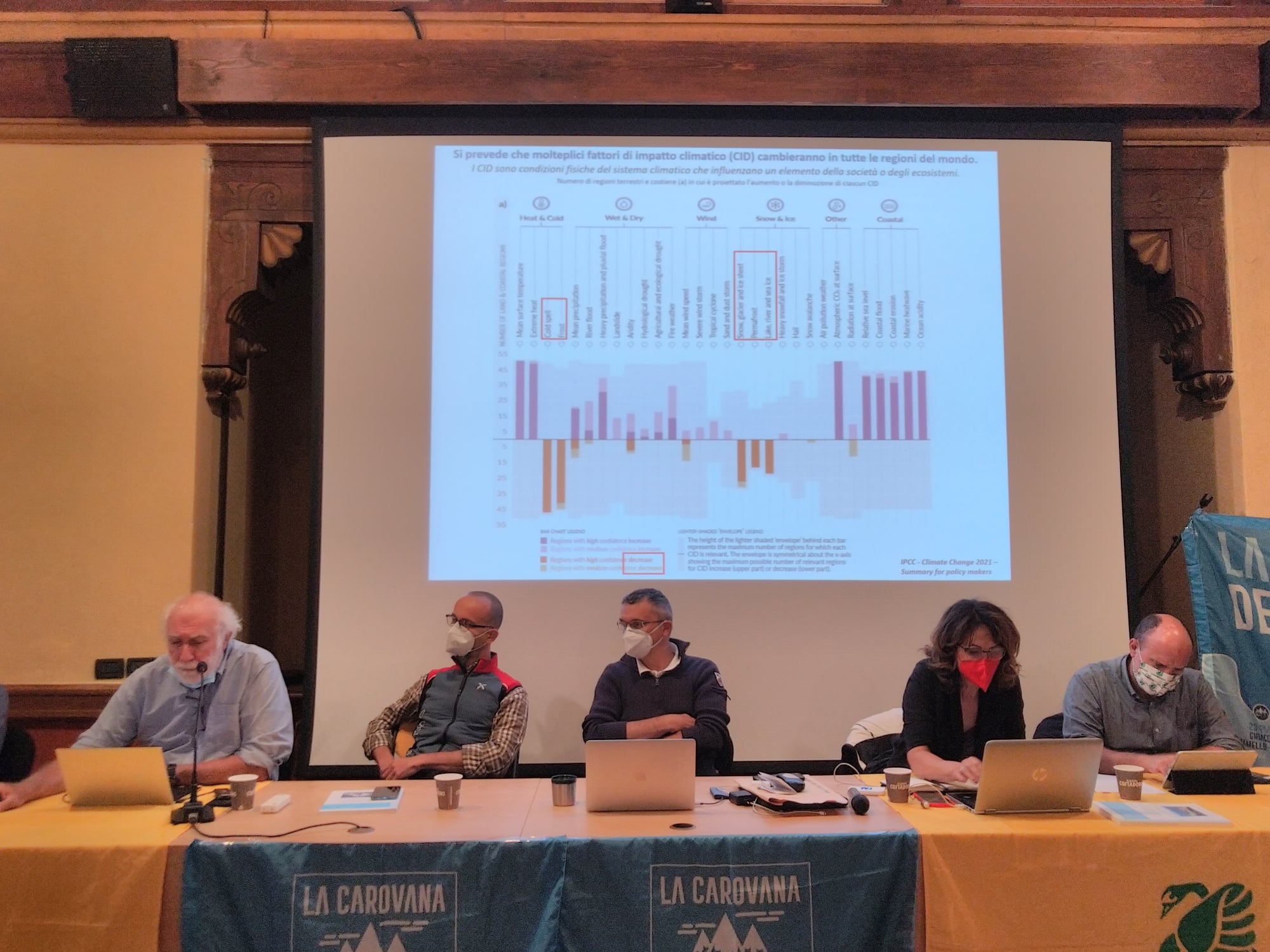
Ceresole Reale, 8 settembre 2021: due
momenti della conferenza "Ghiacciai e servizi ecosistemici in quota",
con la presenza di Giorgio Prino (Presidente Legambiente Piemonte e
Valle d'Aosta, a sinistra nella foto in alto), Riccardo Santolini,
biologo e docente all'Università di Urbino, Daniele Cat Berro della
Società Meteorologica Italiana, Marco Giardino, segretario del Comitato
Glaciologico Italiano e docente di scienze della Terra all'Università di
Torino, Vanda Bonardo, Responsabile nazionale Alpi di Legambiente e
Presidente CIPRA Italia, e Giorgio Zampetti, Direttore generale
Legambiente (da sinistra a destra nella foto qui sopra).

Il 9 settembre 2021 una nebbia a
tratti fitta e piovigginosa non ha impedito lo svolgimento
dell'escursione lungo il sentiero glaciologico del Serrù (scarica
il
volantino informativo sul sentiero e sul Glaciomuseo del Serrù) e al
piccolo ghiacciaio della Capra. Qui sopra Valerio Bertoglio,
ex-guardaparco del Gran Paradiso e attuale osservatore CGI del
ghiacciaio, ne illustra le caratteristiche ai circa venti partecipanti.

Dalla sponda del Lago Serrù si risale
verso le morene della Piccola Età Glaciale del Ghiacciaio della Capra.


Alla base delle
morene del ghiacciaio della Capra è stato effettuato un momento di
raccoglimento per riflettere e discutere sull'urgenza di arginare gli
effetti dei cambiamenti climatici, nonché un simbolico e peculiare
"commiato musicale" al ghiacciaio morente, concerto per corno alpino del
musicista
scozzese Martin Mayes.

L'escursione al
ghiacciaio della Capra è stata anche l'occasione per compiere
osservazioni scientifiche: qui sopra, misure di pH e conducibilità
elettrica dell'acqua di fusione nel torrente glaciale da parte degli
studenti del prof. Marco Giardino (Dipartimento di Scienze della Terra,
Università di Torino).

Risalendo all'interno delle morene si
incontra il vecchio segnale denominato "CA" per le misure di variazione
frontale, istituito nel 1954 dall'operatrice CGI Anna Casucci. La serie
di rilievi è proseguita grazie a
Corrado Lesca (Anni Sessanta-inizio Settanta), Fulvio Fornengo e
Luca Mercalli (Anni Ottanta-Novanta) e Valerio Bertoglio (attualmente),
che ha rinnovato il segnale più a monte per mantenere la continuità
delle osservazioni.

Giunti presso la
fronte del ghiacciaio, il prof. Marco Giardino assiste alle misure di
variazione frontale dal segnale CA2 nel quadro della campagna
glaciologica annuale del CGI. Sullo sfondo, il gruppo di partecipanti si
trova in corrispondenza del margine glaciale, quest'anno tuttavia
occultato dai residui di una valanga che ne impedisce la corretta
individuazione. Seppure in un contesto di generale e protratta
deglaciazione, la sua posizione si può considerare stazionaria dal
settembre 2020.


Flash-mob in
prossimità della fronte del ghiacciaio. La nebbia impedisce la vista
verso la parte alta del bacino, chiusa dall'imponente parete
settentrionale della Cima d'Oin (3280 m).
Nell'immagine qui sopra, da sinistra, Vanda Bonardo (Responsabile
nazionale Alpi di Legambiente e Presidente CIPRA Italia),Giorgio
Zampetti (Direttore Generale Legambiente), Marco Giardino (Università di
Torino) e Alessandra Masino (guida del Parco Nazionale del Gran
Paradiso).

Un momentaneo
sollevamento dello strato nebbioso permette di scorgere il lago del
Serrù dalle morene del ghiacciaio.

Il 10-11 settembre,
favorita da un tempo più soleggiato soprattutto l'11, la Carovana si è
poi spostata in Val di Cogne, sul versante valdostano del Gran Paradiso
(foto Stefano Perona, da
pagina FB Legambiente Alpi).


Qui le attività
didattiche hanno comportato in particolare una "caccia" agli antichi
segnali glaciologici utilizzati nel XIX secolo per le prime
osservazioni delle variazioni frontali del grande ghiacciaio della
Valnontey, in seguito smembratosi in più apparati glaciali, tuttora tra
i più grandi del massiccio (Money, Grand Croux e Tribolazione). Questi
segnali, alcuni dei quali solo di recente rintracciati dopo decenni di
oblio, sono stati valorizzati nel quadro del nuovo percorso "Il Giardino
dei Ghiacciai", su iniziativa del Comitato Glaciologico Italiano, di
Legambiente e del Parco Nazionale Gran Paradiso (foto Stefano Perona,da
pagina FB Legambiente Alpi).


Il masso-segnale "AD
1817" in corrispondenza della morena frontale deposta dal grande
ghiacciaio della Valnontey durante uno dei culmini della Piccola Età
Glaciale (f. Marco Giardino, Università di Torino, Dipartimento di
Scienze della Terra).
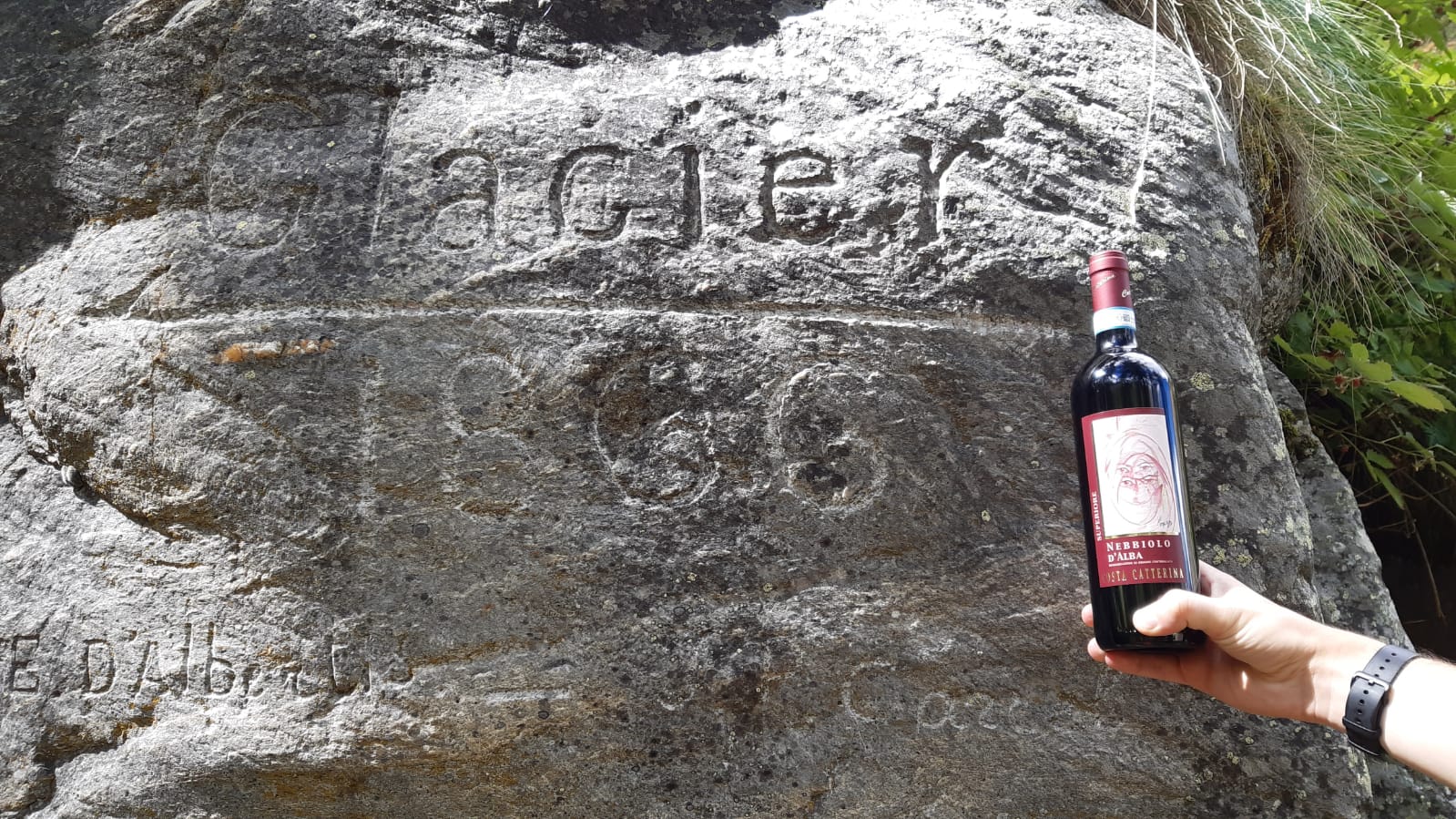
Allo storico
masso-segnale "Glacier 1866", istituito dall'abate Giovanni Pietro
Carrel e dall'esploratore genovese Enrico D'Albertis, si tenta di
sdrammatizzare la mesta e preoccupante atmosfera della deglaciazione
(foto Beppe Quaglia, Politecnico di Torino).

|