|
MAGGIORE RISCHIO ALLUVIONI DOPO LA SICCITA' ?
UN LUOGO COMUNE,
SALVO SITUAZIONI LOCALI
28
marzo 2022
SMI/Redazione Nimbus
Il blocco anticiclonico che - prima sull'Atlantico, poi
sul Nord Europa - per quasi quattro mesi ha inibito le precipitazioni su
gran parte d'Italia e
soprattutto nel bacino padano è destinato ad allentarsi
permettendo finalmente l'ingresso di saccature e sistemi perturbati
tra fine marzo e inizio aprile 2022.
Le piogge attese in questa prima fase non basteranno
ancora a estinguere il massiccio deficit pluviometrico accumulato
in
un periodo così lungo e su territori così estesi, ma è un inizio...
nella speranza che un cambiamento di configurazione atmosferica duraturo
e a grande scala possa riservare ulteriori occasioni piovose, come
peraltro quasi sempre avviene al Nord Italia tra aprile e maggio.

La
straordinaria magra fluviale del marzo 2022 alla confluenza del Trebbia
nel Po presso Piacenza, la città sullo sfondo (veduta aerea del
24 marzo 2022, foto Antonio Carpenetti).
Al ritorno di precipitazioni dopo un lungo periodo di
siccità, molti si domandano se queste possano generare più
facilmente piene fluviali e in generale dissesti idrogeologici,
presumendo una minore capacità dei suoli secchi e polverosi di assorbire
l'acqua improvvisamente ritornata.
Ma quanto è vero questo? Analizziamo
alcuni punti.
SUOLI E BACINI FLUVIALI IN SICCITà
ASSORBONO PIU' ACQUA
In linea generale, un bacino fluviale in stato
siccitoso, con suoli ben lontani dalla saturazione e livelli di
falda molto bassi, è in grado di assorbire maggiori quantità d'acqua
e dunque di sopportare meglio un grande episodio
di precipitazioni.
Pertanto -
a parità di intensità, durata ed estensione delle piogge - è più difficile subire un evento
idrogeologico importante e dannoso al termine di un lungo periodo
asciutto.
A tal proposito diversi autori hanno identificato, in
Europa e nel mondo, una recente riduzione delle portate fluviali e
dell'occorrenza di alluvioni nonostante un aumento delle precipitazioni
estreme.
La causa di questa evoluzione in apparenza controintuitiva è stata
attribuita proprio ai suoli resi più frequentemente secchi
(dunque in grado di assorbire più acqua all'arrivo della pioggia)
dall'intensa evaporazione associata al riscaldamento globale e/o a
una maggiore concentrazione degli eventi piovosi, alternati a periodi
asciutti più lunghi, come nel caso italiano dell'inverno 2021-22.
In sostanza, nella maggioranza dei casi i suoli più secchi negli
intervalli senza precipitazioni controbilancerebbero gli effetti
dell'apporto più rapido e concentrato di acqua durante rovesci divenuti
più intensi.
Si veda ad esempio:
- articolo "Evidence of shorter more extreme rainfalls and increased
flood variability under climate change", di
Wasko et al. (2021) sul Journal of Hydrology, basato sui dati
di 2776 stazioni di portata fluviale nel mondo;
- studio “Evaporation enhancement drives the European
water-budget deficit”, di
Massari et al., 2022, su Hydrology and Earth System Sciences:
si sottolinea il ruolo dell'evaporazione - in un pianeta più caldo – nel
peggiorare le magre fluviali e le siccità, già di per sé più lunghe e
frequenti in molte regioni, con pesanti effetti sulla produzione di
energia, l'agricoltura e la gestione dell'acqua;
-
articolo sulla riduzione delle alluvioni attribuita ai suoli più
secchi in Australia, sempre a cura di Conrad Wasko e di Rory Nathan
(Università di Melbourne), da cui è tratto il seguente grafico che in
base all'analisi di 49 mila eventi mostra, a parità di intensità
pluviometrica, alluvioni peggiori al crescere del contenuto idrico
dei suoli, e viceversa.
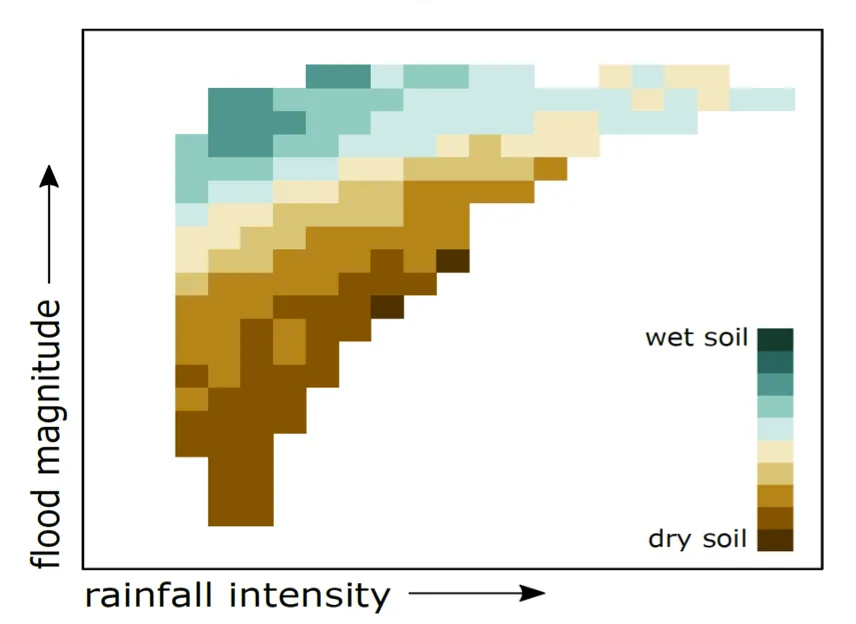
LOCALMENTE, ASSORBIMENTO LIMITATO
NEI SUOLI PERCORSI DA INCENDI
Tuttavia, oltre al loro contenuto idrico, anche altre
caratteristiche dei suoli possono influenzarne la capacità di
assorbimento dell'acqua meteorica (grado di compattazione, tessitura, porosità,
tipo e stato della copertura boschiva...), ad esempio a seguito di
incendi forestali o di pratiche agronomiche intensive, ma a
livello per lo più locale.
Per capirne di più sul ruolo dei suoli nell'assorbimento
dell'acqua e nel ciclo idrologico, abbiamo
chiesto un commento al
prof. Michele Freppaz, docente al
Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari dell'Università di Torino ed esperto di
pedologia, suoli alpini, ecologia della neve, nonché Presidente dell'Alpine
Soil Partnership.
"Tra i molteplici servizi ecosistemici che il suolo
garantisce all'uomo, il contributo alla regolazione del ciclo
idrologico riveste una straordinaria importanza. In particolare esso
si riferisce alla riduzione del ruscellamento superficiale, a
favore dell’infiltrazione delle acque provenienti da precipitazioni,
fusione nivale, ecc... L'infiltrazione dell’acqua nel suolo riduce il
ruscellamento e di conseguenza l’erosione, con effetti positivi sulla
conservazione dei nutrienti e della sostanza organica, e sul filtraggio
e la purificazione delle acque.
Sono molteplici i fattori che influenzano l'infiltrazione dell'acqua
nel suolo, tra i quali la tessitura, la possibile presenza di una
crosta superficiale, il grado di aggregazione e la struttura, la
compattazione, il contenuto idrico e la porosità. In generale, le
aree boscate danno un buon contributo a questo servizio, ma in ogni
caso è necessario porre attenzione alla composizione vegetazionale, ai
metodi di utilizzazione, alle pratiche di gestione forestale che possono
ridurre l’infiltrazione modificando alcune specifiche proprietà del
suolo (densità, spessore e tipo di lettiera, tipo di humus, porosità
dovuta all’attività biologica).
A seguito dei cambiamenti climatici ci si attende un incremento
delle temperature, accompagnato da lunghi periodi secchi e frequenti
incendi che potrebbero determinare la formazione di croste idrofobiche
sulla superficie del suolo, con conseguente riduzione dell’infiltrazione
e l'innesco di fenomeni erosivi anche importanti.
Solo un suolo "in salute" e ben gestito è in grado di assorbire
efficacemente l'acqua, riducendo il ruscellamento superficiale,
garantendo allo stesso tempo un altro servizio ecosistemico
fondamentale, e cioè la ritenzione idrica. Un suolo pienamente
funzionante può immagazzinare tra 100 e 300 litri di acqua per metro
cubo. La capacità del suolo di trattenere e immagazzinare acqua
dipende in larga misura dall’uso e dalla gestione. In agricoltura, la
coltivazione e le lavorazioni possono ridurre la capacità di ritenzione
idrica, ad esempio nel caso di forte compattazione da parte di
macchinari pesanti, oppure aumentarla nel caso in cui si utilizzino
ammendanti organici. Per ulteriori approfondimenti visitare
questo link."
TIMORI SOVRADIMENSIONATI,
SALVO SITUAZIONI LOCALI
Dunque da un lato è vero che suoli compattati e/o polverosi/crostosi,
soprattutto in assenza di copertura forestale, in zone
interessate da
precedenti incendi o da pratiche agronomiche intensive, al
ritorno di
rovesci intensi possono temporaneamente assumere caratteristiche
idrofobiche e incentivare l'innesco di dissesti per rapido ruscellamento
superficiale, erosioni e colate
detritiche soprattutto in piccoli bacini montani.
Ma, in generale, si tratta di fenomeni locali, e il timore di una maggiore probabilità di
dissesti all'arrivo di piogge su suoli precedentemente inariditi dalla siccità
è sovradimensionato, e
genera quello che possiamo considerare un luogo comune.


L'arrivo di
rovesci
intensi su territori percorsi dal fuoco - privati dunque della
vegetazione e dello strato organico superficiale, con suoli dalle
caratteristiche talora idrofobiche, e con abbondanti detriti
mobilizzabili - può predisporre più facilmente le
condizioni locali per rapido ruscellamento, erosioni e colate detritiche.
Nelle
immagini, suoli e sottobosco di pino silvestre mineralizzati e inariditi
dal passaggio di incendi in Val Susa, rispettivamente sulle alture di
Mompantero e di Chianocco (eventi di fine ottobre 2017 e fine febbraio 2022,
f. Daniele Cat Berro).
Tuttavia, per quanto gli incendi forestali siano attesi in aumento a causa del
riscaldamento globale, tali fenomeni di accresciuto rischio
idrogeologico al termine di siccità sono da considerarsi
locali e minoritari rispetto alla generale migliore capacità di
assorbimento di acque meteoriche da parte di un bacino fluviale lontano
dallo stato di saturazione dopo un lungo periodo asciutto.

7 giugno
2018: l'abitato di Bussoleno (Val Susa, Torino) invaso da una violenta colata di
fango innescatasi durante un temporale breve e intenso sui suoli
percorsi dagli
incendi di ottobre 2017. Non vi era documentazione relativa a
episodi analoghi in passato nel piccolo bacino montano
del Rio Reforno o Rio delle Foglie, a conferma del ruolo
esercitato da una situazione dei suoli del tutto nuova.
In questo caso però la responsabilità è da ricercarsi nella mancata
protezione del suolo da parte della vegetazione bruciata, e dalla
grande quantità di detriti e ceneri disponibili in superficie dopo
gli incendi, e non tanto all'arrivo di piogge su suoli secchi: al
contrario, si proveniva da un periodo (novembre 2017 - maggio 2018) di
precipitazioni eccessive e suoli già decisamente saturi d'acqua (f. Daniele Cat
Berro).

|