ESTATE
2014 AL NORD ITALIA: LIEVEMENTE FRESCA,
MA MOLTO NUVOLOSA E PIOVOSA
Luca Mercalli, Daniele Cat Berro,
SMI / Redazione Nimbus
3 Settembre 2014
Dopo un luglio
fresco e straordinariamente piovoso, l'anomala persistenza di
flussi atlantici umidi e instabili verso il Nord Italia è proseguita -
sebbene in maniera un po' attenuata - anche durante l'agosto 2014. Il
trimestre estivo si è così chiuso con temperature nel complesso
leggermente sotto media sulle regioni settentrionali, quantità e
frequenza delle precipitazioni elevate tuttavia in generale non eccezionali,
in netto contrasto con la situazione a scala globale (estate
più calda dal 1880 nel mondo!).

Anche agosto 2014 ha sperimentato numerosissimi
temporali al Nord Italia, ma le quantità di precipitazione sono state
nel complesso meno straordinarie rispetto a luglio 2014. Tuttavia alcuni
episodi sono stati particolarmente violenti: qui l'imponente grandinata
del mattino di Ferragosto a Oggiono, presso Lecco (fonte:
LeccoNews).
A livello stagionale la configurazione meteorologica sul continente
europeo è stata nettamente delineata, con robusti anticicloni
confinati a latitudini artiche che hanno permesso a numerosissime
perturbazioni atlantiche di scorrere lungo il 45° parallelo o talora
anche più
a Sud, dove hanno prevalso situazioni più depressionarie del consueto
per l'estate mediterranea.
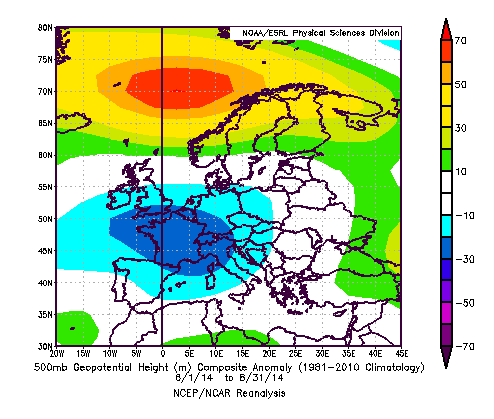
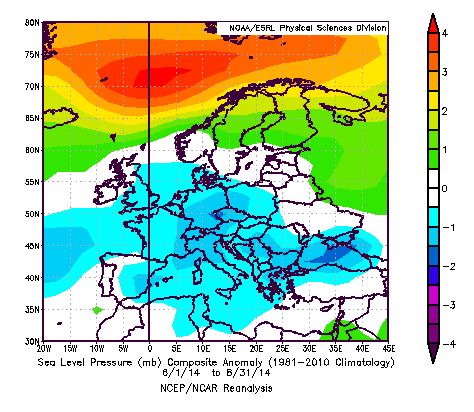
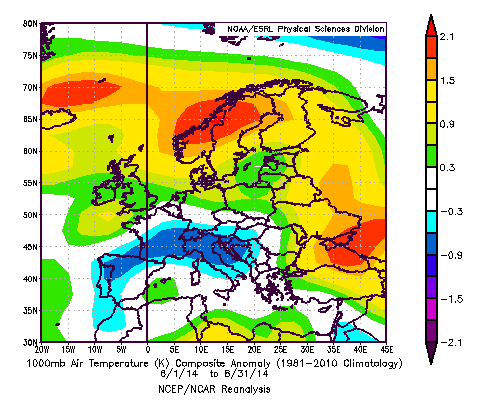
Anomalie di geopotenziale alla superficie isobarica di 500 hPa (in alto), della pressione
(al centro) e delle temperature al suolo (qui sopra) nel trimestre giugno-agosto 2014
in Europa. In tutte e tre le carte si nota una situazione più
depressionaria e fresca della norma (trentennio 1981-2010) sull'Europa
meridionale, attraversata da ripetute perturbazioni atlantiche, mentre
agli anticicloni consolidati sulla Scandinavia si sono associate marcate
anomalie termiche positive, fin oltre +2 °C a livello trimestrale (Fonte:
ESRL-NOAA).
Qui sotto, una sintesi delle principali
anomalie termo-pluviometriche registrate nel trimestre presso alcuni osservatori
storici dell'Italia settentrionale (cliccare sopra la tabella per
ingrandirla; in corsivo i valori che eguagliano o superano i primati
precedenti).
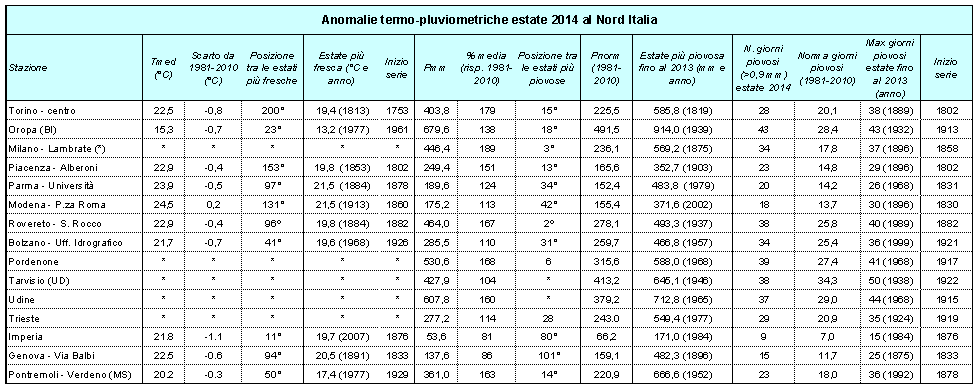
(*) confronto storico eseguito con la serie di Milano-Brera.
Temperature: estate fresca al Nord,
ma solo in rapporto agli ultimi decenni molto caldi
L'estate 2014 è stata fresca
soprattutto sulle zone alpine, prealpine e pedemontane del Nord Italia e
dalla Liguria all'Appennino Tosco-Emiliano, ma solo se la si
confronta con le recenti stagioni molto calde, che peraltro hanno
sensibilmente modificato la percezione delle temperature estive da parte
della popolazione facendo dimenticare le ben più fredde stagioni degli
Anni 1970, ad esempio.
In queste fasce di territorio, con anomalie negative dell'ordine di
mezzo grado°C rispetto al trentennio 1981-2010 (-0,3 °C a
Pontremoli, -0,4 a Piacenza e Rovereto, -0,5 a Varese e Parma,
-0,8 a Torino, -1,1 a Imperia), in generale si è trattato del
trimestre giugno-agosto più fresco dal 1997, situazione che tuttavia
sarebbe stata normale prima degli Anni 1980-1990.
Se infatti - anziché il 1981-2010 - si prende come riferimento il
trentennio standard internazionale 1961-90 (considerato per gli studi
sui cambiamenti climatici, secondo le direttive
WMO), ecco che spuntano
perfino delle lievi anomalie positive (+0,2 °C a Torino, +0,3 °C a
Parma...).
Rispetto alla fascia prealpina, la bassa Pianura Padana ha
risentito di un maggiore soleggiamento e di temperature più elevate:
a Modena la Tmed stagionale di 24,5 °C ha superato di 0,2 °C anche la
media 1981-2010 (e di +1,4 °C la norma 1961-90).
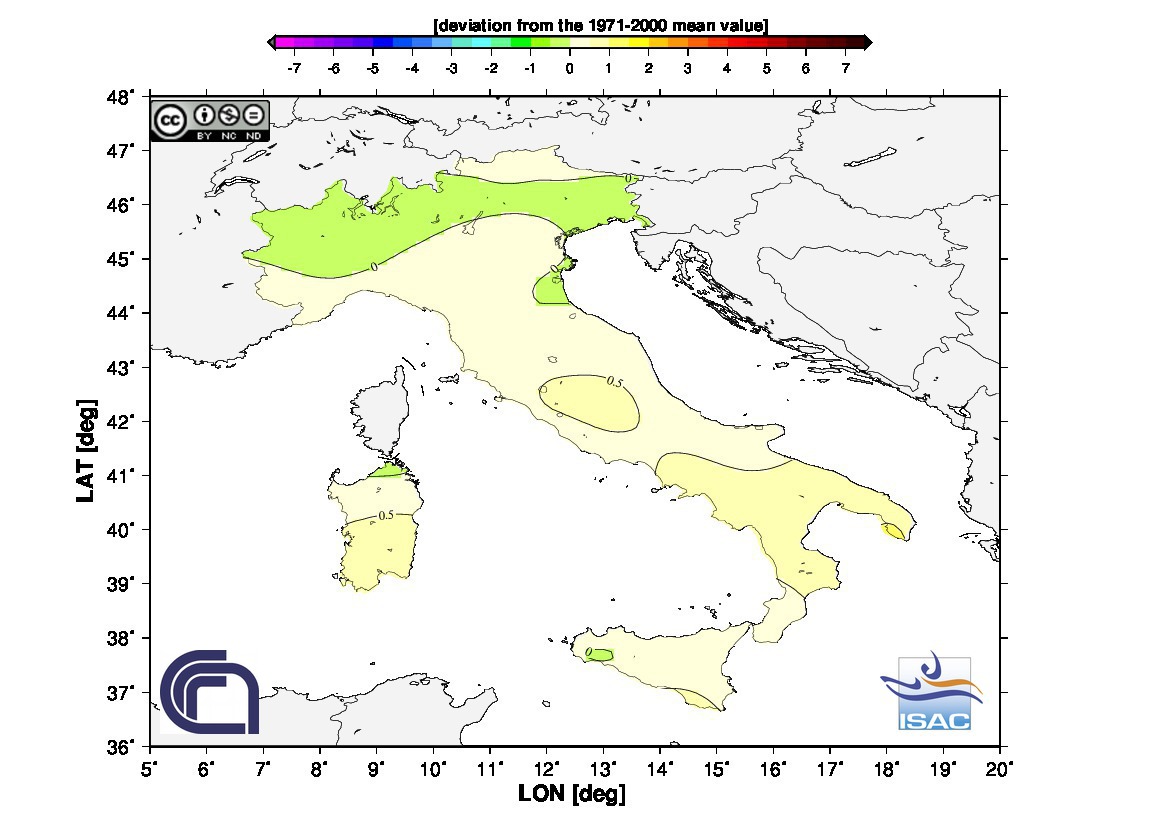
Secondo l'analisi dell'ISAC-CNR l'estate 2014 è stata leggermente
fresca in prevalenza a Nord del Po (anomalie trimestrali tra 0 e -0.5
°C), dove maggiore è stato l'effetto della frequente nuvolosità: altrove
hanno prevalso moderate anomalie positive (tra 0 e 1 °C) e a livello
italiano è stata pur sempre la trentottesima estate più calda dal 1800
con deviazione di +0,3 °C.
(Fonte: ISAC-CNR).
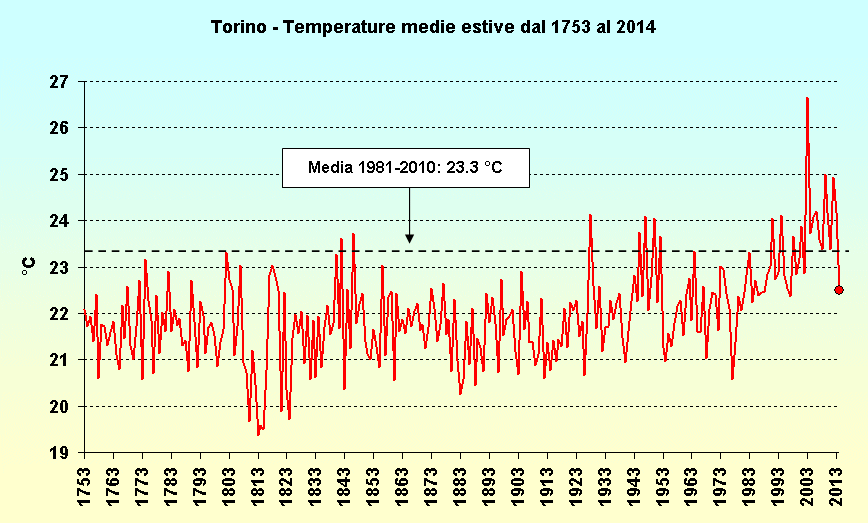
A Torino - con temperatura media di 22,5 °C, 0,8 °C inferiore alla norma
del trentennio 1981-2010 - l'estate 2014 è risultata la più fresca dal
1997, ma
ampliando lo sguardo a una prospettiva di più lungo periodo, si nota
come fino agli Anni 1980 - prima del recente e rapido riscaldamento
atmosferico - sarebbe stata una stagione del tutto normale
(perfino +0,2 °C rispetto al trentennio standard internazionale
1961-1990).
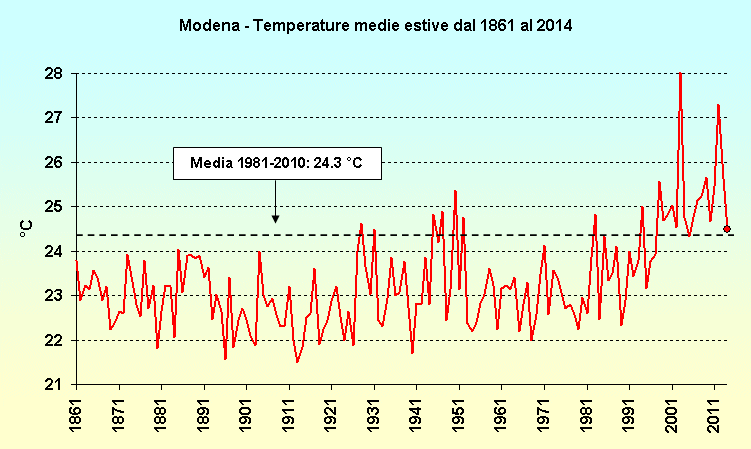
La bassa Valpadana
ha risentito meno della relativa frescura, indotta più dalla scarsità di
radiazione solare che da afflussi di aria fresca a grande scala. A
Modena la Tmed di 24,5 °C è perfino lievemente superiore (+0,2 °C) alla
norma del trentennio 1981-2010.
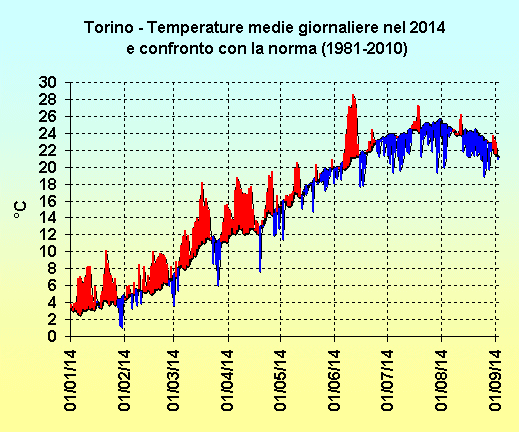
Andamento della temperatura media giornaliera a Torino
dal 1° gennaio al 2 settembre 2014, e i relativi scostamenti dalla norma
(linea nera):
in rosso i periodi più caldi, in blu quelli più freddi della norma
climatica.
Luglio e agosto 2014 sono stati insolitamente freschi (anomalia
bimestrale -1,6 °C), come non accadeva nello stesso periodo dal 1978 (Tmed
22,1 °C), ma molto simile fu la situazione del luglio-agosto 1996 e 2002
(22,6 °C). Tuttavia i primi 8 mesi del 2014 mostrano pur
sempre nel loro insieme
un'anomalia di +0,6 °C, a causa della marcata mitezza del periodo
gennaio-aprile.
Estate nuvolosa e poco
soleggiata
La straordinaria frequenza di corpi
nuvolosi in scorrimento dall'Atlantico verso il Nord Italia e i Balcani
ha determinato un'eccezionale scarsità di soleggiamento lungo le Alpi,
tanto che a Lugano l'estate 2014 è stata
la più povera di sole da oltre un secolo e mezzo.
Sempre molto anomala, ma meno estrema, la situazione di nuvolosità e ore
soleggiate a Sud del Po: dal 1° giugno al 31 agosto all'eliofanografo di
Pontremoli
il sole ha brillato per 715 ore, minimo da inizio misure nel
1994, ma la nuvolosità media, pur molto elevata (4,9 decimi di cielo
coperto), non ha raggiunto i valori delle grigissime estati 1977 e 1986
(rispettivamente 5,1 e 5,0 decimi).
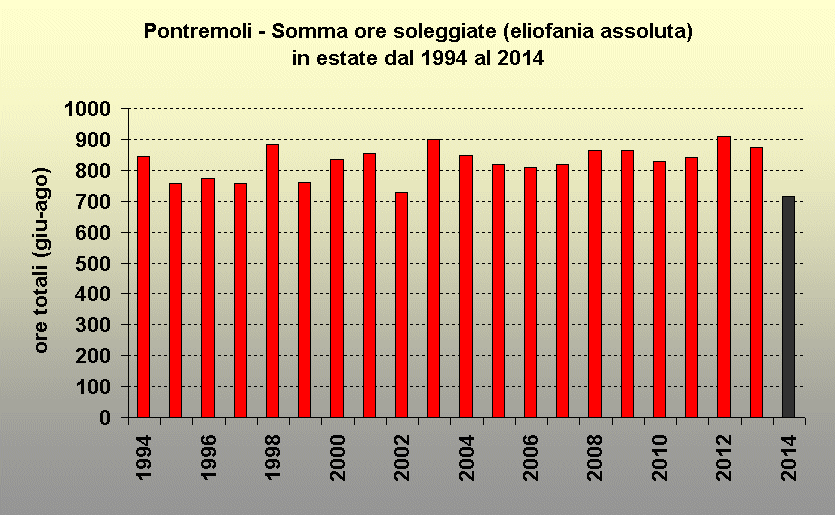
A Pontremoli nel trimestre giugno-agosto 2014 il sole è apparso per un
totale di 715 ore (-14% rispetto alla media 1994-2013 di 829 ore). Si è
trattato dell'estate meno soleggiata degli ultimi 21 anni, sebbene molto
simile a quella del 2002 (728 ore).
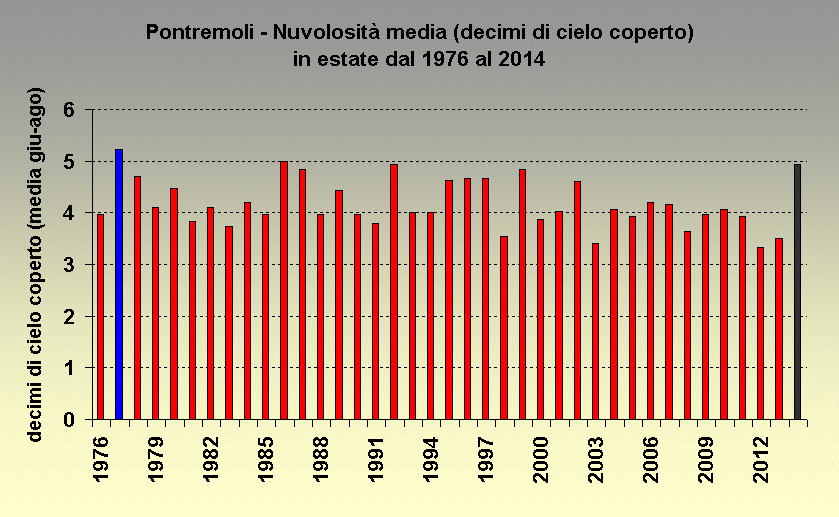
Parallelamente,
anche la nuvolosità media (4,9 decimi di cielo coperto) è stata elevata,
ma inferiore ai casi dell'estate 1977 (media 5,1 decimi) e 1986 (5,0
decimi). Anche in questo caso l'anomalia è più evidente in relazione
alle recenti estati, particolarmente radiose, oltre che calde (minimo di
nuvolosità nel 2012, con appena 3,3 decimi di cielo coperto).
Piogge straordinarie per frequenza e
quantità
Dal 1° giugno al 31 agosto 2014 i
pluviometri del Nord Italia hanno raccolto quantità di pioggia che
raramente si misurano d'estate, collocando la stagione talora tra le
prime 10 più piovose in un secolo od oltre: oltre 400 mm sono caduti
lungo tutta la fascia pedemontana e prealpina dal Piemonte al Friuli,
con punte anche superiori a 600 mm. Particolarmente colpita da
ripetuti nubifragi l'area tra Milano e il Lago di Como: nel
capoluogo lombardo si sono totalizzati 446 mm d'acqua, quantità quasi
doppia rispetto al normale (189%) e terza estate più piovosa dal 1858.
Non a caso il Seveso a Milano è straripato ben 5 volte (25 giugno, 8, 26
e 28 luglio, 20 agosto).
Inoltre, seconda estate più piovosa a Rovereto (464 mm, dopo i 493 mm
del 1937), sesta a Pordenone (531 mm), ma "solo" quindicesima a Torino
(404 mm), dove il ritorno di una piovosità normale in agosto ha
attenuato l'anomalia trimestrale.
Solo alcune zone alpine interne del settore atesino-carnico-friulano,
già di norma soggette a copiose piogge estive, hanno raccolto
precipitazioni ordinarie: 285 mm a Bolzano (110%) e 428 a Tarvisio
(104%).
Anche procedendo verso la bassa Valpadana le anomalie pluviometriche
si sono affievolite: 175 mm a Modena (113% del normale e solo
quarantaduesima estate più piovosa dal 1830). Perfino sotto media la
Liguria centrale e di Ponente, quasi sempre al margine degli eventi perturbati di
questa stagione: 54 mm a Imperia, pari all'81% del normale.
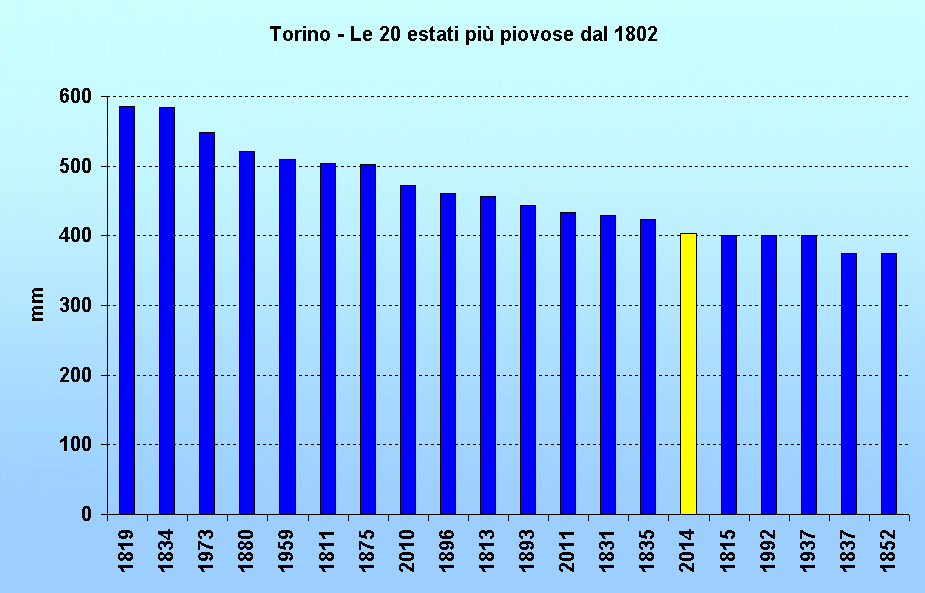
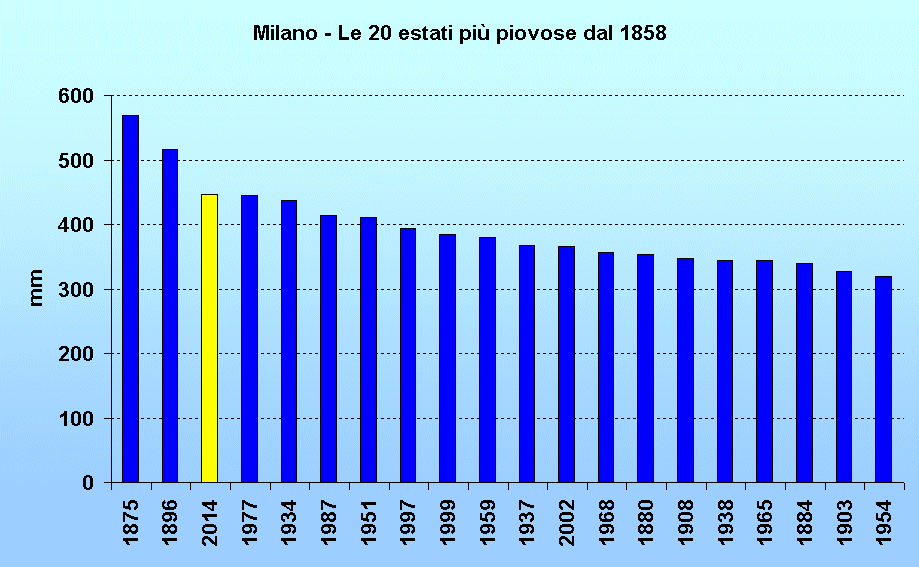
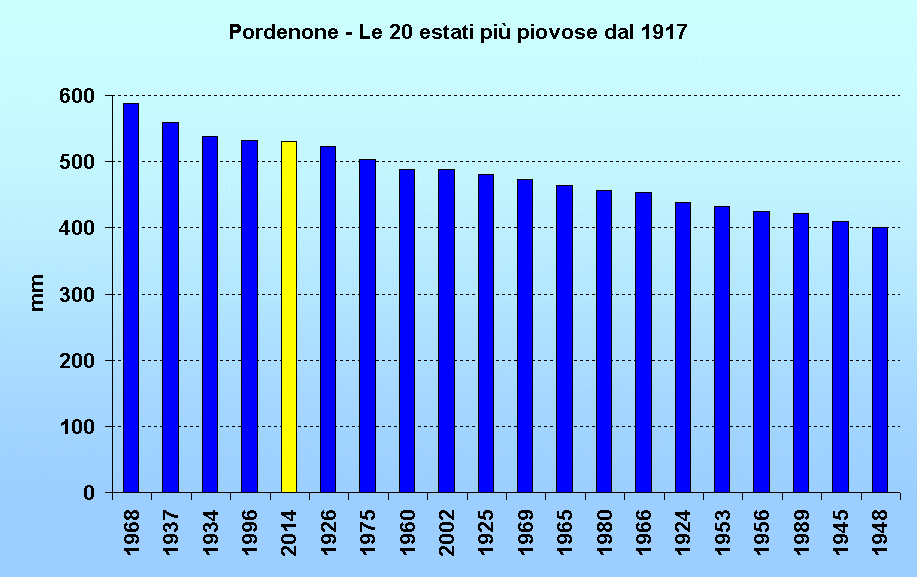
Le piogge
dell'estate 2014 sono state frequenti e abbondanti soprattutto sulle
pianure pedemontane e sulla fascia prealpina a Nord del Po, dove in
varie località la stagione rientra tra le prime 10-20 estati più ricche
di precipitazioni nelle lunghe serie di misura: in particolare, i 446 mm
di Milano sono superati solo dai casi del 1875 (569 mm) e 1896 (517 mm).
Quinta posizione per Pordenone (531 mm) e quindicesima a Torino (404
mm), dove gli apporti di agosto, più ordinari, hanno stemperato
l'anomalia stagionale.
Straordinaria la frequenza delle precipitazioni: il numero di
giorni piovosi è stato ovunque ben superiore al normale, sfiorando in
qualche caso o eguagliando i massimi noti in precedenza, come a
Oropa (43 giorni, come nel 1932), Rovereto (38 giorni, non distante dal
primato di 40 giorni dell'estate 1989), e Milano (34 giorni; massimo di
37 nell'estate 1896).

16.08.2014: splendida veduta della Via Lattea
dalla Sacra di San Michele (bassa Val Susa, Torino) in una delle poche
notti completamente serene dell'estate 2014, grazie alle correnti da
Nord-Ovest che si sono instaurate nei giorni intorno al Ferragosto (f.
Valerio Minato).


Effetti delle
piene torrentizie originatesi in Val Veny, sul versante italiano del
Monte Bianco, con le forti piogge del 26 agosto 2014 (70-80 mm in circa
15 ore, con precipitazioni liquide fino a circa 3500 m), causate da una
perturbazione associata a impetuosi venti occidentali in quota:
erosioni di strade minori e piste sciistiche, crollo di numerosi piccoli
ponti, trasporto di detriti. L'evento si è manifestato anche
sull'opposto versante del Monte Bianco con una notevole piena dell'Arve
a Chamonix. Benché meno esteso e grave, l'episodio ha ricordato
l'alluvione valdostana del 24 luglio 1996 (f. Philip Deline).
RINGRAZIAMENTI
La redazione di Nimbus ringrazia tutti i numerosi collaboratori ed enti
che hanno trasmesso fotografie, cronache e dati, ma in particolare Luca Lombroso (Osservatorio
Geofisico di Modena), Maurizio Ratti (Pontremoli), Roberto Pedemonte
(Genova), Carlo Montini (Osservatorio meteo-sismico di Imperia), Matteo
Cerini (Osservatorio Collegio Alberoni, Piacenza), Paolo Fantini
(Osservatorio Università di Parma), Alberto Nobili (Osservatorio
"Valerio" di Pesaro), Paolo Valisa (Centro
Geofisico Prealpino, Varese), Silvano Cuffolo (Osservatorio
meteo-sismico di Oropa), Alessio Bozzo (Rovereto), Claudio Mutinelli
(Ufficio
Idrografico Provincia Autonoma di Bolzano), Bruno Renon e Mauro Valt
(ARPA Veneto),
inoltre ARPA
Piemonte, ARPA
Lombardia, OSMER -
Friuli Venezia Giulia,
MeteoSvizzera - Centro Regionale Sud / Locarno-Monti.
|