|
INVERNO 2015-16 AL NORD ITALIA:
UNO TRA I PIU' MITI; INIZIO SECCO, FINALE PIOVOSO
4
marzo 2016, Daniele Cat Berro - SMI/Redazione Nimbus
L'inverno 2015-16 al Nord Italia è stato
tra i più miti nelle serie di misura secolari, collocandosi
generalmente in seconda posizione (dopo il primato del 2006-07,
come a Torino e Genova) o in terza (es. Parma, Modena, Pontremoli,
Urbino, Rovereto, dove anche il vicinissimo caso del 2013-14 è rimasto
insuperato), con anomalie stagionali per lo più tra +1 e +2 °C
rispetto al 1981-2010, talora superiori (ben +2,7 °C a Modena).
A livello trimestrale il ritorno di precipitazioni più abbondanti in
gennaio-febbraio 2016, specie su Appennino, Emilia e Nord-Est, ha
invece bilanciato la
straordinaria siccità di inizio stagione.

La confluenza del F. Sesia nel Po presso Frassineto (AL) il 3 febbraio
2016. Entrambi i fiumi erano in forte magra, con
portate ai minimi storici invernali,
dopo il
trimestre novembre-gennaio più secco mai registrato dall'inizio
delle misure pluviometriche nel 1802 a Torino. Infatti, mentre in
Liguria, Toscana e al Nord-Est gennaio 2016 ha segnato il ritorno di
precipitazioni più abbondanti grazie a flussi umidi occidentali, il
Nord-Ovest, sottovento alle Alpi, è ancora rimasto in gran parte
all'asciutto (f. Toni Farina).
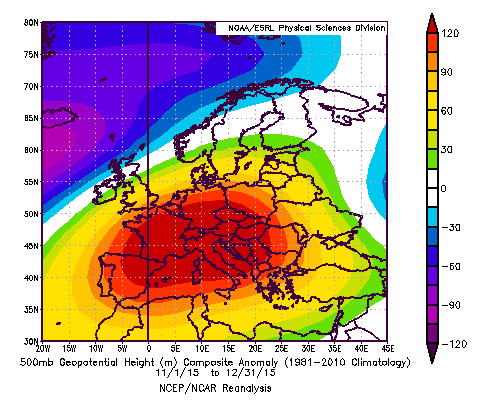
La carta delle anomalie del geopotenziale alla superficie isobarica di 500 hPa
(circa 5500 m di quota) nel
periodo 1° novembre - 31 dicembre 2015
in Europa mostra come la prima parte dell'inverno 2015-16 sia stata
fortemente anticiclonica (colori arancio-rossi), ed
eccezionalmente tiepida, calma e secca sulla regione alpina e in Italia
(Fonte:
ESRL-NOAA).
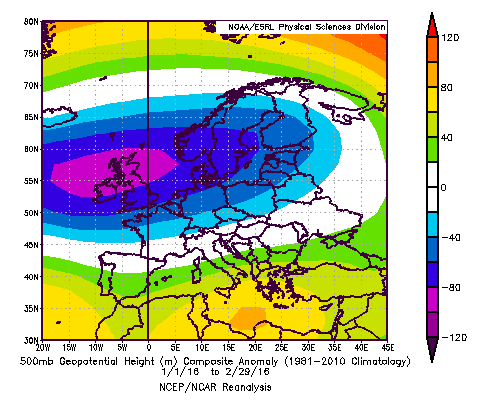
La situazione ha iniziato a cambiare a inizio gennaio 2016: il dominio
degli anticicloni si è interrotto a favore di regimi occidentali più
umidi, e generalmente meno miti soprattutto in quota, legati alle
grandi depressioni nord-atlantiche (colori blu-viola). La seconda
parte dell'inverno è dunque stata più dinamica (Fonte:
ESRL-NOAA).
In sintesi, le
caratteristiche meteo-climatiche dominanti:
Dicembre 2015: anticicloni stazionari, aria calma, nebbiosa e
inquinata in Valpadana; Alpi spoglie di neve anche a 3000 m, mitezza
eccezionale soprattutto in montagna, meno straordinaria in pianura a
causa delle inversioni termiche.
Gennaio-febbraio 2016: ritorno di flussi occidentali più umidi e
atmosfera più dinamica, perfino diversi temporali - inusuali - tra
Lombardia, Emilia e Nord-Est (3, 9 e 18 febbraio); nel complesso sempre
mite, salvo un periodo di (normale) freddo intorno al 20 gennaio (Tmin
tra -5 e -10 °C in pianura al Nord).
Periodi anticiclonici più brevi, ma ancora alcune punte di mitezza
estrema (0 °C a 4000 m sulle Alpi il 21-22 febbraio).
Ed ecco due tabelle di
sintesi delle principali statistiche termo-pluviometriche
di alcuni osservatori del Nord Italia: intero trimestre invernale, e
febbraio 2016.
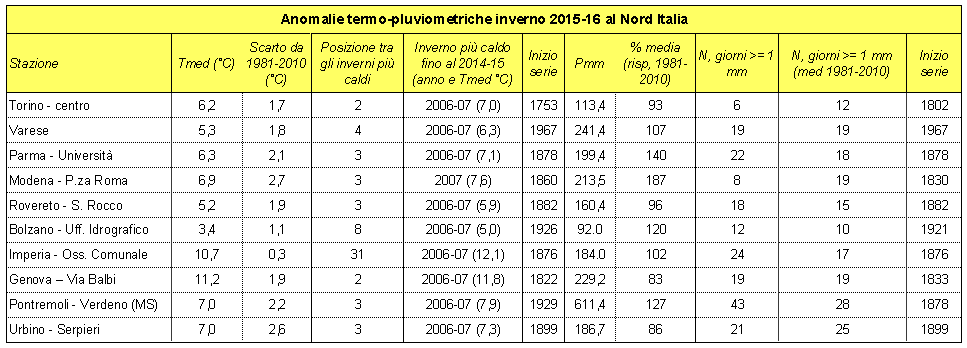
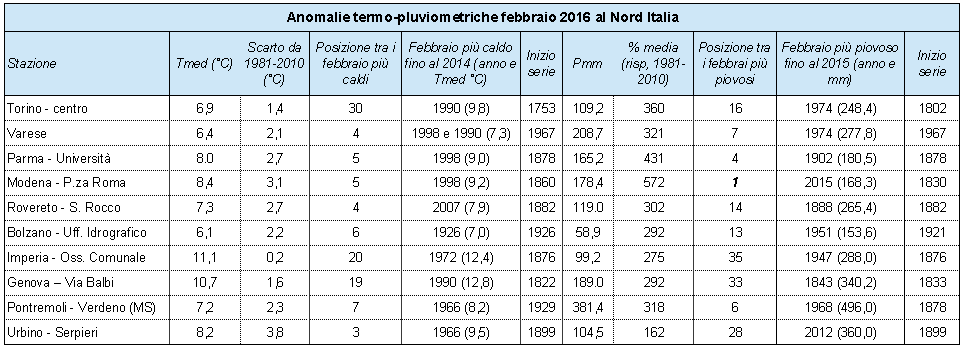
Ovunque sono rimaste imbattute le temperature medie da record
dell'inverno 2006-07, spesso anche quelle del
mite e umidissimo inverno 2013-14, ma ciò che maggiormente stupisce
è la concentrazione - negli anni recenti - delle più tiepide stagioni
invernali degli ultimi 150-200 anni.
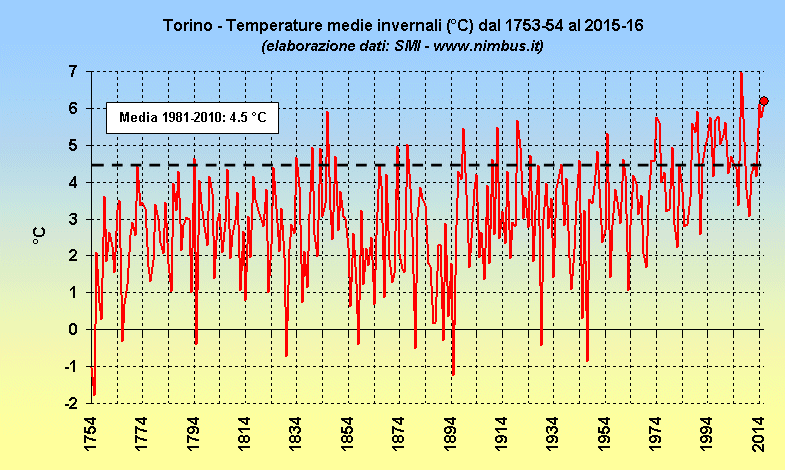
Temperature medie invernali (trimestre dicembre-gennaio) a Torino dal 1753.
La stagione 2015-16 si è collocata seconda tra le più tiepide nella
serie, e 8 dei 10 inverni più miti in 213 anni appartengono al periodo
successivo al 1989 (elaborazione SMI).
Nelle precipitazioni stagionali non si
notano anomalie di sorta perché i frequenti fronti atlantici di
gennaio e febbraio 2016 hanno colmato quasi ovunque il deficit
precedente, sebbene soltanto in chiusura di stagione in Piemonte: fino
al 25 febbraio Torino aveva totalizzato appena 23 mm d'acqua nel
trimestre (un quinto della media 1981-2010), poi le piogge della
vigorosa depressione "Zissi" (27-29 febbraio) hanno fatto balzare "in
extremis" il valore cumulato a 113 mm, quasi normale (93%).
In Liguria e alta Toscana
precipitazioni abbondanti si erano già avute nel gennaio 2016, poi
intorno all'Appennino settentrionale soprattutto gli apporti di febbraio
sono stati molto copiosi, da 3 a 6 volte la norma: a Modena mai aveva
piovuto così tanto (178 mm) in questo mese dall'inizio delle misure
nel 1830, e ripetute piene fluviali si sono propagate lungo i
bacini appenninici, l'ultima delle quali, il 29 febbraio, ha allagato
vaste zone in riva al Secchia.
Inoltre, febbraio 2016 è
stato un mese molto grigio sul versante ligure-tirrenico, esposto
alla frequente nuvolosità medio-bassa da sbarramento del libeccio: all'osservatorio
di Pontremoli (MS), appena 65 ore di sole (minimo da
inizio misure nel 1995), solo il 21% rispetto a quelle possibili con
cielo teoricamente sempre sereno (eliofania relativa), ben 17 su 29 i
giorni completamente privi di soleggiamento!
Scarsissima o nulla la
neve caduta durante l'inverno in Pianura Padana:
a Milano e Piacenza sottile spruzzata il 2 gennaio; a Torino invece il
suolo non si è mai imbiancato (qui dal 1787 sono stati solo 6, incluso
questo, gli inverni completamente senza neve, 4 dei quali concentrati
dopo il 1989).

3 gennaio 2016: vista
dalla Colma di Mombarone (presso Ivrea, TO) verso le Alpi Liguri
all'orizzonte Sud. Dall'esteso strato nebbioso che copre la pianura
piemontese fino a 600 m emerge appena la sommità della collina di
Superga (Torino). Una situazione frequente nella prima metà dell'inverno
2015-16, ostinatamente anticiclonica, dopodiché la configurazione
atmosferica diverrà via via più variegata e dinamica, benché con tempo
ancora in gran parte asciutto all'estremo Nord-Ovest italiano (f.
Silvano Beduglio).

Nel febbraio 2016 le
precipitazioni sono divenute frequenti e copiose soprattutto
sull'Appennino settentrionale, talora eccezionali per il mese sulla
vicina pianura emiliana. Qui inondazioni in riva al Fiume Secchia,
presso Modena,
il 29 febbraio 2016 (f. Luca Lombroso).

Dopo il bimestre novembre-dicembre 2015, di siccità straordinaria, le
Alpi sono tornate ad imbiancarsi tra gennaio e febbraio 2016, anche in
abbondanza intorno al Monte Bianco, più esposto ai venti umidi da Ovest,
mentre inizialmente i rilievi delle medie e basse valli piemontesi
(sottovento) sono rimasti in gran parte spogli.
Qui sopra circa 30 cm coprono finalmente Montgenèvre, a 1860 m tra alta
Val Susa e Briançonnaise, il 16 gennaio 2016 (f. Tony Scalera).

Solo con l'intensa depressione "Zissi", a fine febbraio 2016,
l'innevamento è divenuto più consistente lungo tutto l'arco alpino
italiano. Qui sopra, circa 1 m di manto al suolo ai 1737 m del Bivacco
Menegazzi, nel gruppo delle Pale di San Martino, Bellunese (f. Milos
Lago).
Leggi anche:
Inverno più mite da oltre un secolo in Francia
Inverno tra i più tiepidi anche in Svizzera
Regno Unito: mitezza e precipitazioni eccezionali
Febbraio 2016: banchisa artica ai minimi storici
RINGRAZIAMENTI
La redazione di Nimbus ringrazia tutti i numerosi collaboratori ed enti
che hanno trasmesso i dati, ma in particolare Luca Lombroso (Osservatorio
Geofisico di Modena), Maurizio Ratti (Pontremoli), Carlo Montini (Osservatorio meteo-sismico di Imperia), Paolo
Fantini (Osservatorio Università di Parma), Paolo Valisa (Centro
Geofisico Prealpino, Varese), Alessio Bozzo e Filippo Orlando (Rovereto), Claudio Mutinelli
(Ufficio
Idrografico Provincia Autonoma di Bolzano), Piero Paolucci (Osservatorio
"Serpieri" - Università di Urbino).
Devolvi il 5 per mille alla SMI!
Sosterrai
le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,
e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|