|
A un mese dall'articolo
di inizio agosto in cui abbiamo descritto le caratteristiche
dell'eccezionale anomalia caldo-secca del 2022 fino al mese di luglio,
possiamo ora aggiornare l'analisi in occasione della chiusura di
un'estate confermatasi straordinaria per durata e intensità della
calura, per di più concomitante con condizioni ancora in gran
parte siccitose nonostante una maggiore frequenza di temporali -
talora rovinosi - in agosto.

Un'immagine che testimonia lo scempio subito dai ghiacciai alpini
nell'estate 2022: alcuni banchi di neve residua permangono alla
sommità del piccolo Ghiacciaio del Travignolo (gruppo delle Pale di
San Martino, Trentino orientale), ma per il resto l'apparato glaciale è al collasso e in
parte ricoperto da abbondante detrito roccioso (25 agosto 2022, f. Milos Lago).
Per la descrizione completa delle configurazioni
atmosferiche dominanti rimandiamo dunque alla precedente notizia,
limitandoci qui a riportare, nella tabella sottostante, le principali
statistiche climatiche di una serie di osservatori meteorologici
storici del Nord Italia (temperature medie giugno-agosto e
maggio-agosto; precipitazioni gennaio-agosto; clicca per
ingrandire).
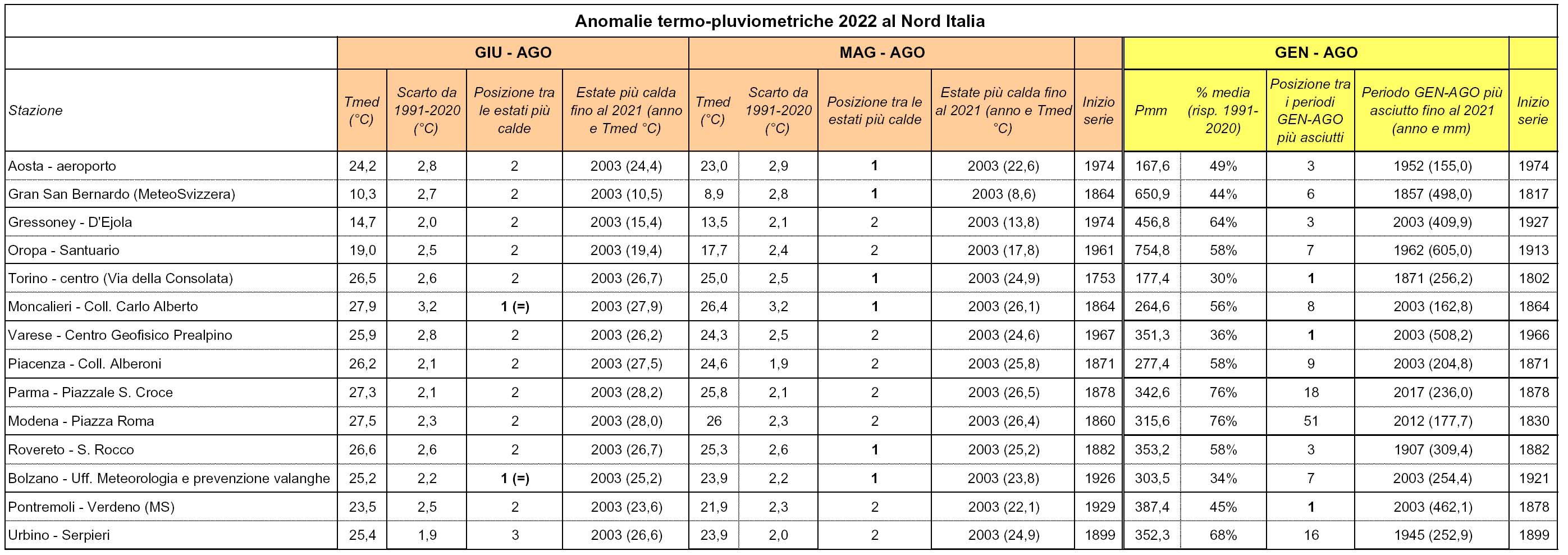
TEMPERATURE:
DOPO SOLI 19 ANNI,
UN'ALTRA STAGIONE "FUORI SCALA" SIMILE AL 2003,
SPECIALMENTE AL NORD ITALIA
Dai dati emerge, con una certa omogeneità tra una
regione e l'altra del Nord Italia, come l'estate sia risultata per
lo più seconda tra le più calde nelle serie storiche
ultrasecolari dopo il caso epocale del 2003 riferendosi al
canonico trimestre giugno-agosto, ma con un distacco modesto e quasi sempre inferiore a 0,5 °C.
Fa eccezione la fascia che va dalla pianura emiliana alle Marche, dove
l'episodio rovente di 19 anni fa è rimasto con maggiore franchezza in
prima posizione (1,3 °C di divario all'osservatorio di
Piacenza-Alberoni). Al contrario, a Moncalieri e Bolzano l'estate del
2003 è stata eguagliata da quella attuale.
Considerando il quadrimestre maggio-agosto, che permette di
rappresentare in maniera ancora più efficace il connubio tra intensità
e durata del caldo estivo, insorto precocemente proprio alla metà di maggio,
l'eccezionalità dell'episodio del 2022 primeggia in molti casi
rispetto a quello del 2003, come ad Aosta, al Gran San Bernardo, a
Torino, Moncalieri, Bolzano e Rovereto. Altrove rimane in seconda
posizione talora per appena 0,1-0,2 °C (Oropa, Pontremoli),
confermando distacchi più marcati invece dall'Emilia alle Marche
(1,2 °C inferiore a Piacenza).
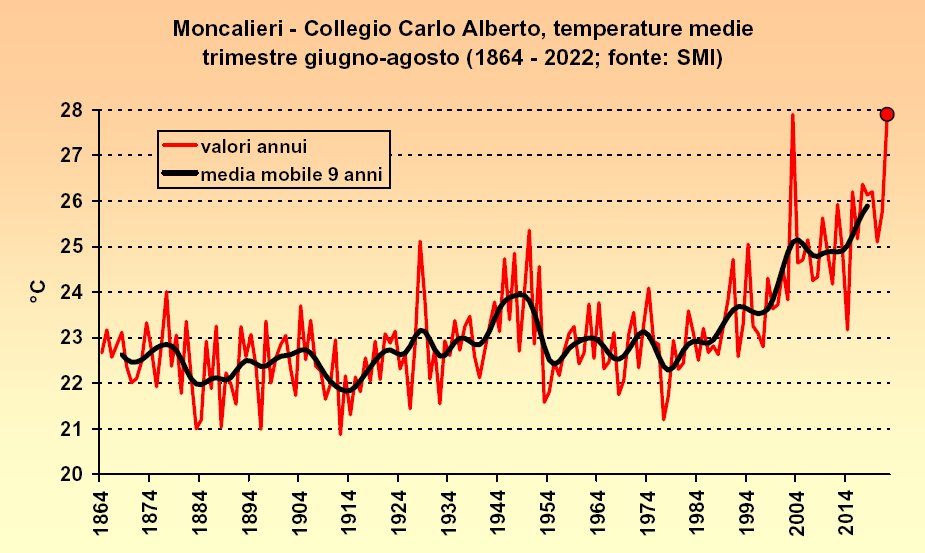
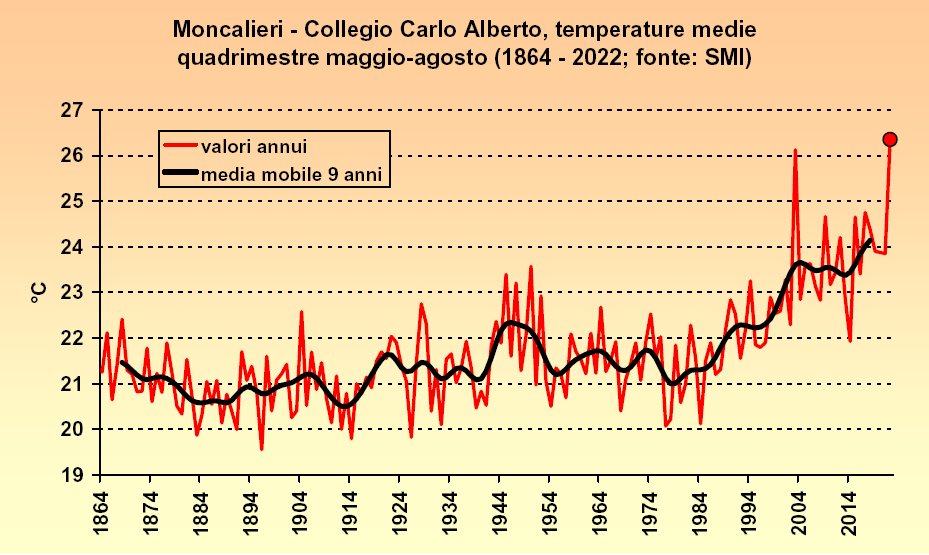
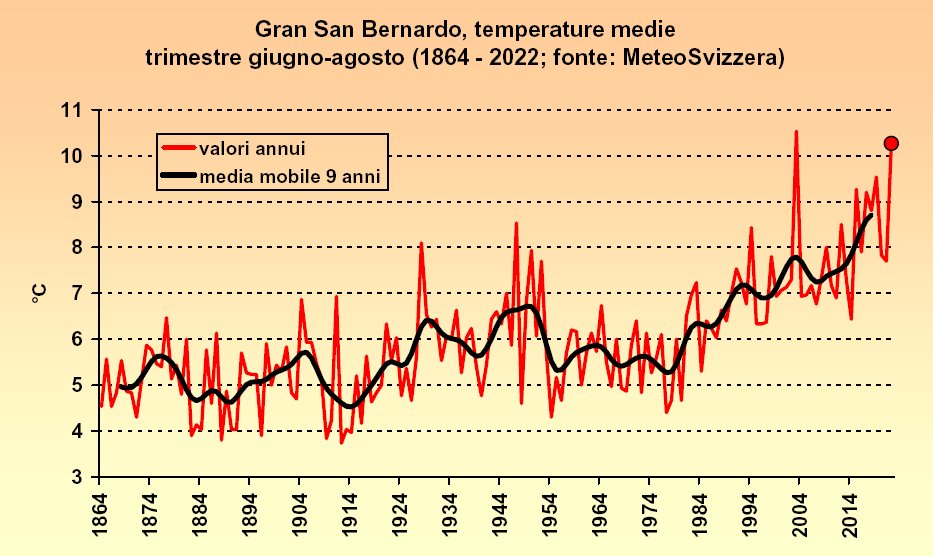
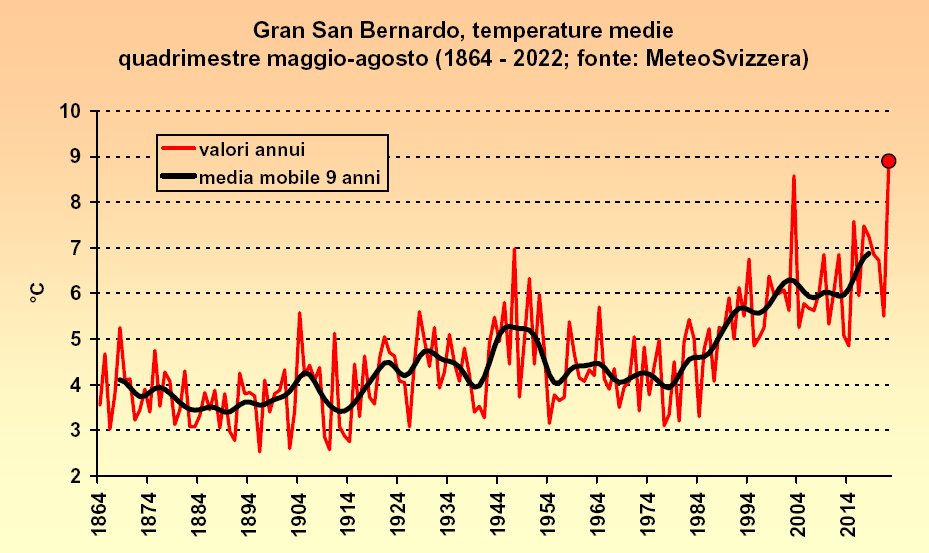
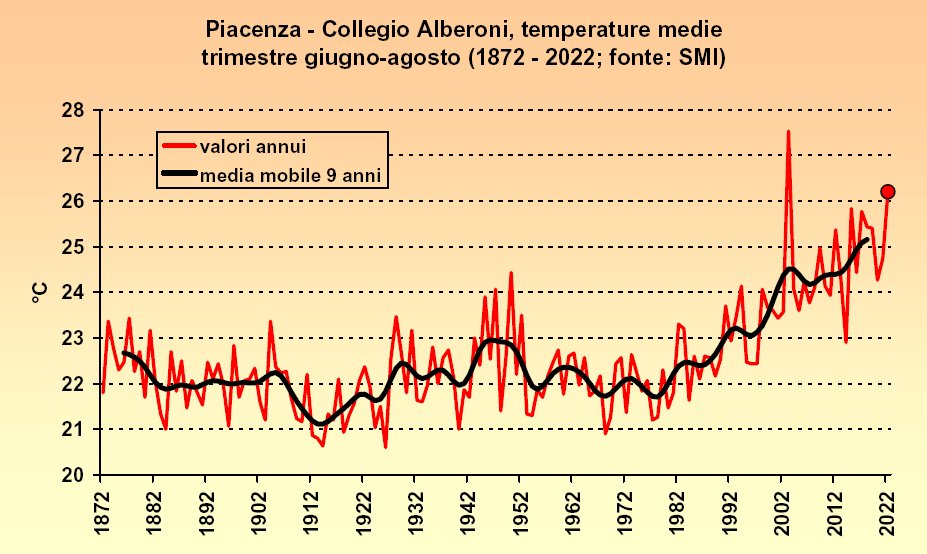
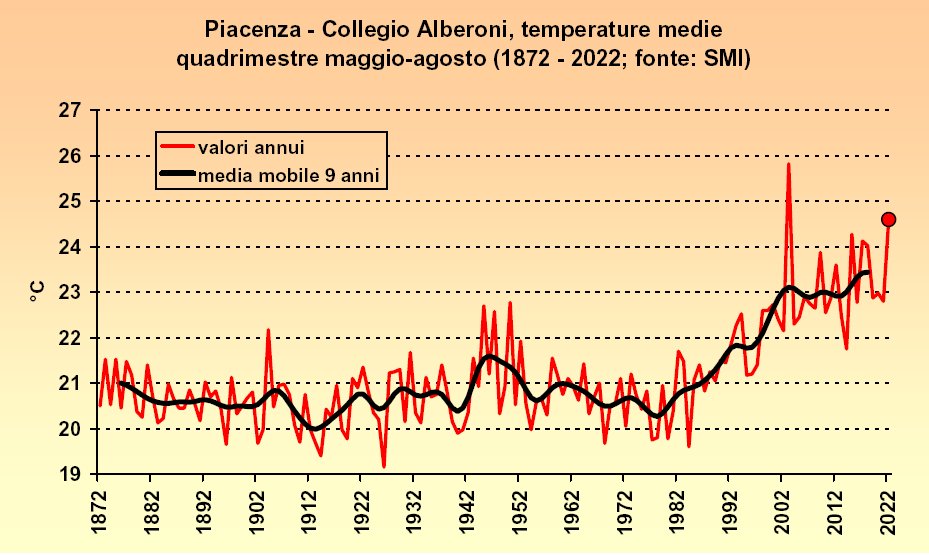
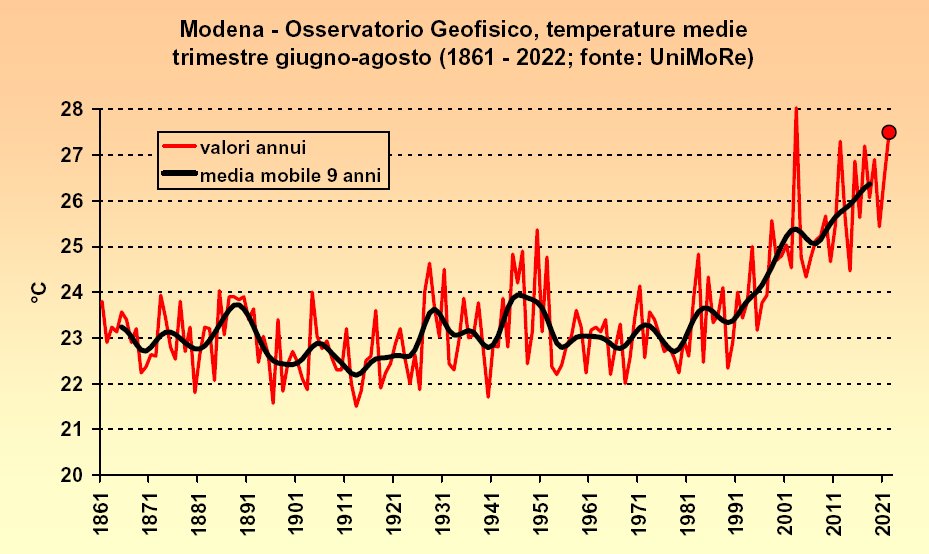
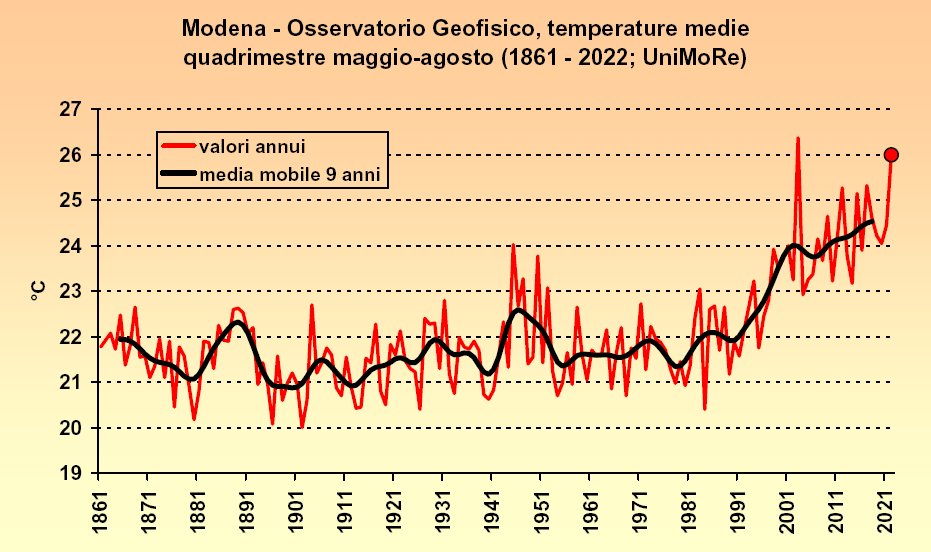
Tutte le serie storiche analizzate mostrano i vistosi "outliers"
rappresentati dalle stagioni estive 2003 e 2022, al di là delle
modeste differenze che hanno portato a superare o meno (soprattutto
nel caso del quadrimestre maggio-agosto) il caso di 19 anni fa. La
tendenza al riscaldamento è evidente ovunque da fine Anni Ottanta del
Novecento, e la frequenza di episodi così estremi in rapporto al clima
passato (quando erano sconosciuti) aumenta nettamente.
LA SITUAZIONE
A SCALA NAZIONALE:
SECONDA ESTATE PIU' CALDA, POCO SOTTO IL 2003
Le
analisi
del CNR-ISAC di Bologna (a cura del dr. Michele Brunetti)
indicano che il trimestre estivo giugno-agosto 2022 è stato il
secondo più caldo, sia a livello nazionale (anomalia da 1991-2020:
+2,06 °C), sia al Nord (+2,32 °C), al Centro (+2,15 °C) e al Sud
(+1,89 °C), nella serie storica con inizio nel 1800 (1831 nel caso del
Centro Italia).
Il 2003 è rimasto in cima alla classifica, seppure con distacchi
limitati a
0,52 °C nell'insieme del Paese, 0,48 °C al Nord, 0,51 °C al Centro
e 0,55 °C al Sud.
Più in dettaglio, anche maggio, giugno e luglio 2022
sono stati secondi tra i più caldi a livello nazionale, seguiti
da un agosto in sesta posizione.
Il periodo gennaio - agosto resiste invece al primo
posto tra i rispettivi periodi più caldi dal 1800, a scala
italiana (+0,99 °C) come in tutte le singole sottozone (+1,33 °C al
Nord, +0,93 °C al Centro e +0,76 °C al Sud).
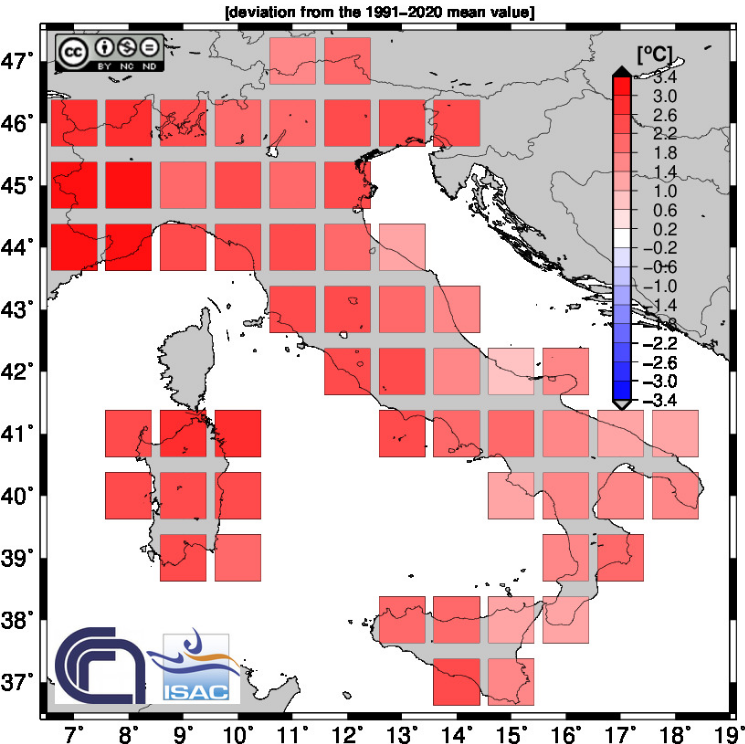
Anomalie termiche giugno - agosto
2022 in Italia,
rispetto alla media 1991-2020 (fonte:
CNR-ISAC
Bologna).
Gli eccessi di caldo più marcati hanno interessato il Nord, il
medio-alto Tirreno e la Sardegna; scarti dalla norma meno pronunciati invece tra l'Adriatico
e l'estremo Sud.
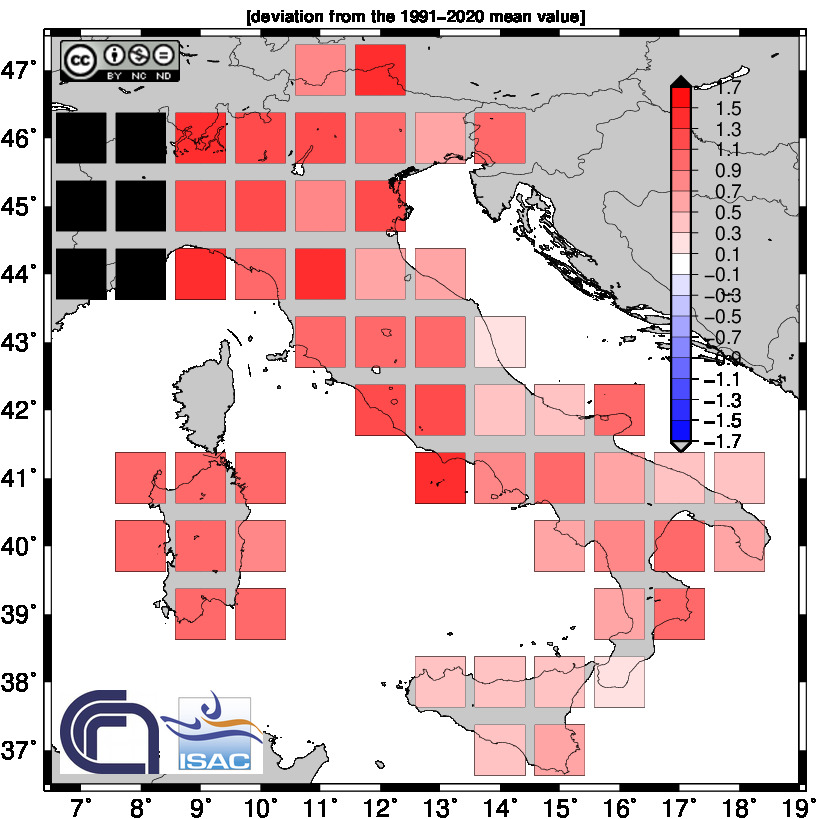
Anomalie termiche gennaio - agosto
2022 in Italia,
rispetto alla media 1991-2020 (fonte:
CNR-ISAC
Bologna).
In questo caso il Nord-Ovest si distingue particolarmente come la zona
più interessata dalle anomalie calde, con oltre 1,7 °C sopra la norma
su un lungo periodo di 8 mesi.
CALDO OSTINATO
E SENZA INTERRUZIONI, GIORNO E NOTTE
Ai numerosi record mensili e assoluti di temperatura massima
giornaliera registrati tra maggio e luglio 2022, ed elencati
qui, in agosto si sono ancora aggiunti i 44,3 °C registrati
il giorno 18 durante un episodio di intenso scirocco a
Palermo - Punta Raisi (stazione ENAV), primato per qualunque mese dell'anno
nella serie iniziata nel 1960.
All'osservatorio "Vaiana" dell'Università, in centro a Palermo, con
43,8 °C è rimasto invece imbattuto il record di 44,6 °C del 25 giugno
2007.
Ma oltre alle singole punte di caldo estremo, più
numerose tra il Nord e le regioni tirreniche, a
sorprendere è stata la continuità del caldo anomalo. Ecco un paio di
esempi al proposito.
1) Torino - Via della Consolata (ARPA Piemonte)
74 giorni con temperatura massima >= 30 °C, pari merito con
quanto osservato nel 2003 fino a tutto settembre (ma alla data attuale
nel 2003 si era a 73). Media annua 1991-2020: 42 giorni.
Le massime non sono mai scese sotto i 30 °C dal 29 giugno al 28 luglio
inclusi (30 giorni consecutivi), né sotto i 33 °C dal 14 al 26 luglio
(13 giorni).
Soffocanti sono state pure le ore notturne: fino al 7 settembre, in
ben 79 giorni la temperatura minima non è scesa sotto i 20 °C
(media annua 1991-2020: 40 giorni), battendo clamorosamente il
precedente primato di 62 giorni del 2003.
2)
Modena - Osservatorio Geofisico / Piazza Roma
(UniMoRe)
Anche in questa stazione storica, riferimento per la pianura
emiliana orientale, si sono contati 74 giorni con Tmax >= 30 °C,
frequenza superata solo nel 2003 (80 giorni). La media annua 1991-2020
di è 47 giorni.
Fino al 5 settembre sono state 96 le notti "tropicali", con
minima >= 20 °C (media 1991-2020: 62 casi), superando così il precedente
primato del 2003 (91 casi).
Il
sistema di sorveglianza della mortalità da caldo del Ministero
della Salute attribuisce alla calura esagerata un
aumento dei decessi rispetto all'andamento ordinario di fondo,
preliminarmente valutato nel 36% nella seconda metà di luglio 2022
a scala nazionale, sulla base dei dati raccolti in 33 città campione.
PROLUNGATA ASSENZA DI GELO E NEVICATE
IN ALTA MONTAGNA
Prosegue tuttora il lungo periodo senza gelo in alta
montagna, per lo meno a quote inferiori a 3000 m.
La stazione meteorologica SMI alla fronte del Ghiacciaio Ciardoney
(2850 m, Gran Paradiso) da 89 giorni attende di rivedere una
pur flebile gelata notturna (ultimo episodio i -1,2 °C del 10 giugno
2022), e per due settimane, dal 14 al 27 luglio, le temperature minime non sono mai scese
sotto i 9 °C, giorno e notte! Nella pur breve serie storica della
stazione (2010-2022) non si era mai registrato un periodo senza gelo
così lungo.
Inoltre lì non si vede nevicare in maniera apprezzabile perfino dal
6 maggio 2022, mentre di solito alcune imbiancate - per quanto
effimere - a quelle quote prossime a 3000 m si verificano di solito anche nel cuore dell'estate, e
contribuiscono a
rallentare la perdita di ghiaccio che invece quest'anno è proseguita
senza posa fino ad asportare probabilmente 4 metri e più di spessore
glaciale, ma avremo modo di verificarlo con precisione tra pochi di
giorni durante la campagna di misure di fine stagione.
Modeste spruzzate di neve sono avvenute solo a quote
superiori (ad esempio dai 3000 m il 18-19 agosto sulle Alpi Graie), o
localmente più in basso sulle Alpi orientali (il 13 agosto ai 2752 m
del Rifugio Lagazuoi, Dolomiti).

Il Ghiacciaio Ciardoney (Gran
Paradiso) ripreso dalla webcam della stazione meteorologica al mattino del
23 agosto 2022: da fine giugno in poi il ghiacciaio si è
ininterrottamente presentato così, totalmente privo di neve residua e
senza il minimo sollievo di alcuna nevicata, ancorché effimera. Il
torrente glaciale, gonfio d'acqua cerulea per le fini particelle di
limo in sospensione, testimonia proprio l'intensa fusione glaciale.
ONDATA DI CALORE MARINO IN ATTENUAZIONE,
MA ANCORA TROPPO CALDO
Il caldo straordinario ha riguardato non solo
l'atmosfera ma anche le acque del Mediterraneo, che per gran parte
dell'estate hanno mostrato anomalie termiche fin prossime a 5 °C
in superficie
tra Golfo del Leone, Mar Ligure, Corsica e Sardegna.
A fine agosto 2022 gli eccessi termici si sono ridotti, ma rimaneva
un'area di anomalia intorno a +3 °C tra la Corsica e le coste del Midi
francese.
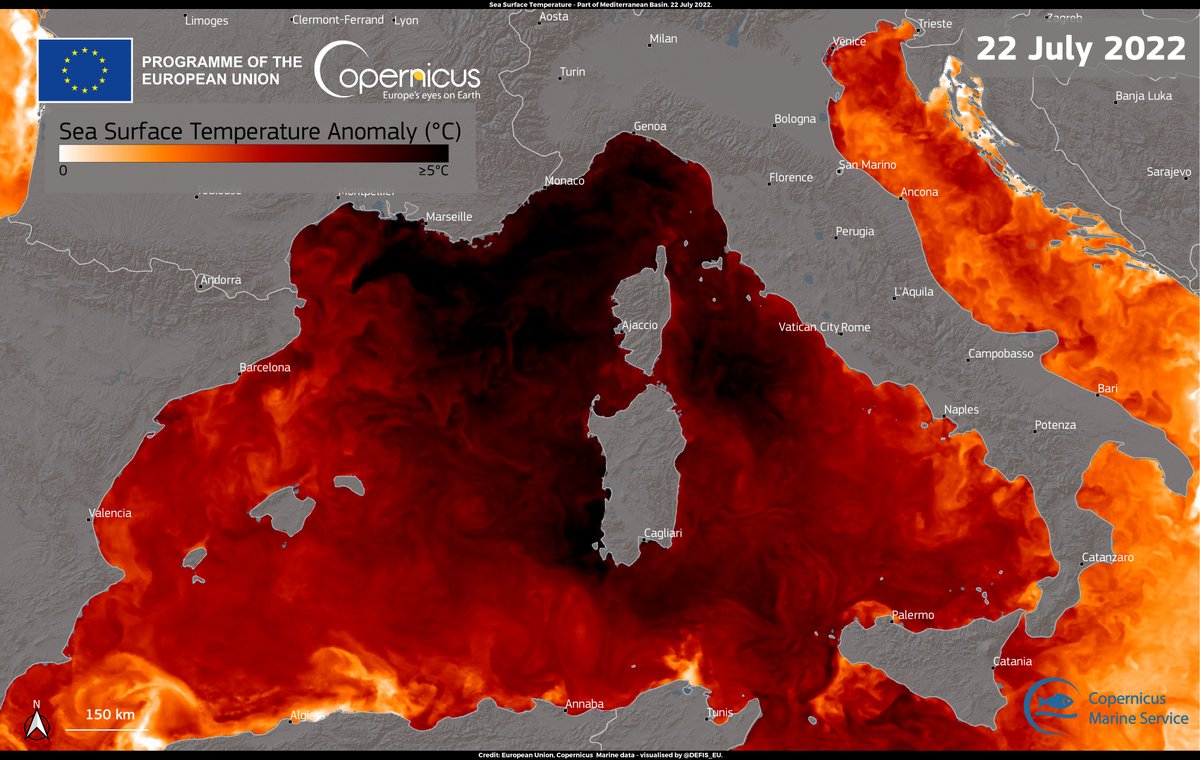
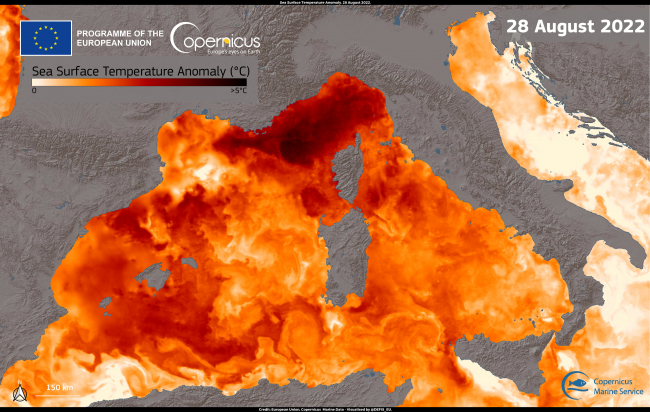
Anomalie della temperatura
superficiale (SST, Sea Surface Temperature) del Mediterraneo il 22
luglio e 28 agosto 2022
(fonte: European Union,
Copernicus
Marine Service data).
Secondo il report
“State of the climate” dell'American Meteorological Society,
già
nel 2021 si era stabilito un nuovo record di contenuto di calore negli
oceani globali: assorbendo questi il 91% dell'energia in eccesso intrappolata nel
sistema-Terra dal crescente effetto-serra, sono loro l'indicatore
principale del disequilibrio energetico del pianeta, ben più della
temperatura atmosferica.
I mari globali sempre più caldi favoriscono lo sviluppo di tempeste
più violente e intensificano la fusione e fratturazione delle piattaforme di
ghiaccio costiere (ice-shelf) in Antartide, accelerando il flusso
del ghiaccio da monte e dunque
la perdita di massa glaciale anche dall'interno del continente.
A tal proposito, lo studio “Antarctic
calving loss rivals ice-shelf thinning” del Jet Propulsion
Laboratory (NASA), pubblicato su Nature ad agosto 2022, ha raddoppiato
le precedenti stime della perdita di massa per distacco di iceberg
dalle piattaforme glaciali galleggianti antartiche, destabilizzate
proprio dalle acque oceaniche più calde: 12 mila miliardi di
tonnellate negli ultimi 25 anni.
AGOSTO ED
ESTATE 2022: I PIU' CALDI IN EUROPA
Secondo gli aggiornamenti del servizio di monitoraggio
satellitare del pianeta
EU-Copernicus,
sia agosto sia l'intero trimestre estivo 2022 in Europa sono stati
con ampio margine
i più caldi nella serie di dati satellitari cominciata nel
1979 (ma, ragionevolmente, da tempi ben più lunghi).
Agosto con un'anomalia continentale di +1,72 °C rispetto al
trentennio 1991-2020 ha superato di ben 0,8 °C il precedente record
del 2018. Inoltre nell'agosto 2003 (quarto in classifica) si
registrarono anomalie ancora più intense in alcune parti d'Europa ma
altre zone furono più fresche del solito, mentre stavolta gli
eccessi di caldo sono stati particolarmente estesi, con massime
anomalie (anche intorno a +4 °C) in Russia europea, dal Mare di
Barents al Caucaso.
Il trimestre giugno-agosto (anomalia
continentale: +1,34 °C) ha superato di 0,4 °C il primato stabilito
appena un anno fa, nell'estate 2021, di 0,5 °C le stagioni 2010
e 2018, e di 0,6 °C l'estate 2003.
Inoltre, agosto più caldo anche a livello globale,
pari merito con quelli del 2017 e 2021.
Più dettagli nell'analisi
mensile/stagionale EU-Copernicus.
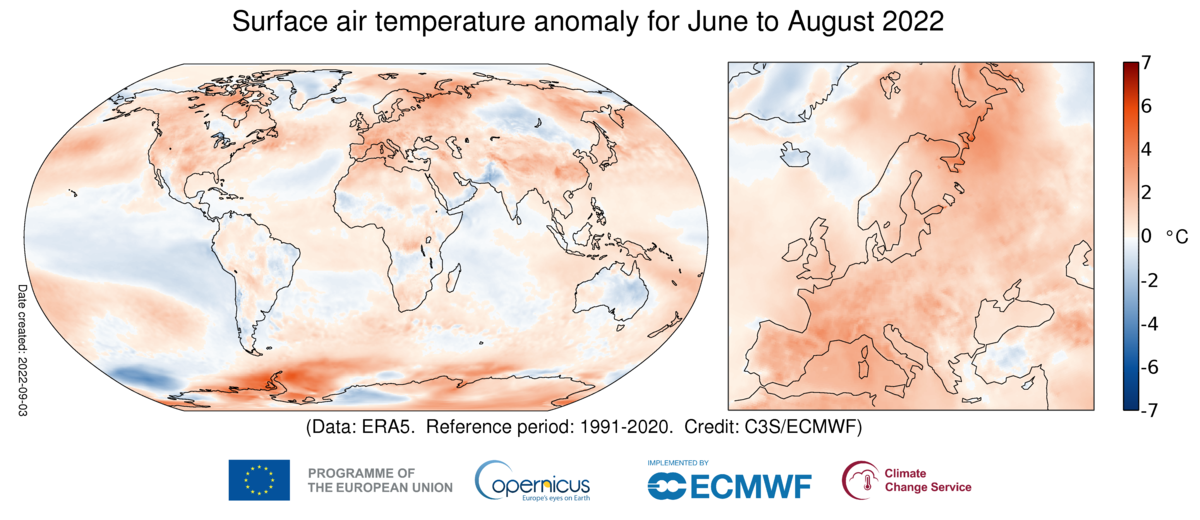
Anomalie globali ed europee di
temperatura dell'aria in superficie nel trimestre giugno-agosto 2022
(fonte:
Copernicus Climate Change Service/ECMWF).
PRECIPITAZIONI:
TEMPORALI PIU' FREQUENTI IN AGOSTO, DEFICIT IN LIEVE CALO, MA RESTA
MARCATO
Più variegata la situazione delle precipitazioni. In
generale, rispetto a quanto descritto
nel precedente approfondimento, persiste la situazione di marcato
deficit pluviometrico, tuttavia - grazie ai temporali tornati più
frequenti in agosto - sempre secondo il CNR-ISAC l'ammanco di
precipitazioni rispetto al consueto a scala nazionale e da inizio 2022
si è ridotto da -47% (gennaio-luglio) a -41% (gennaio-agosto).
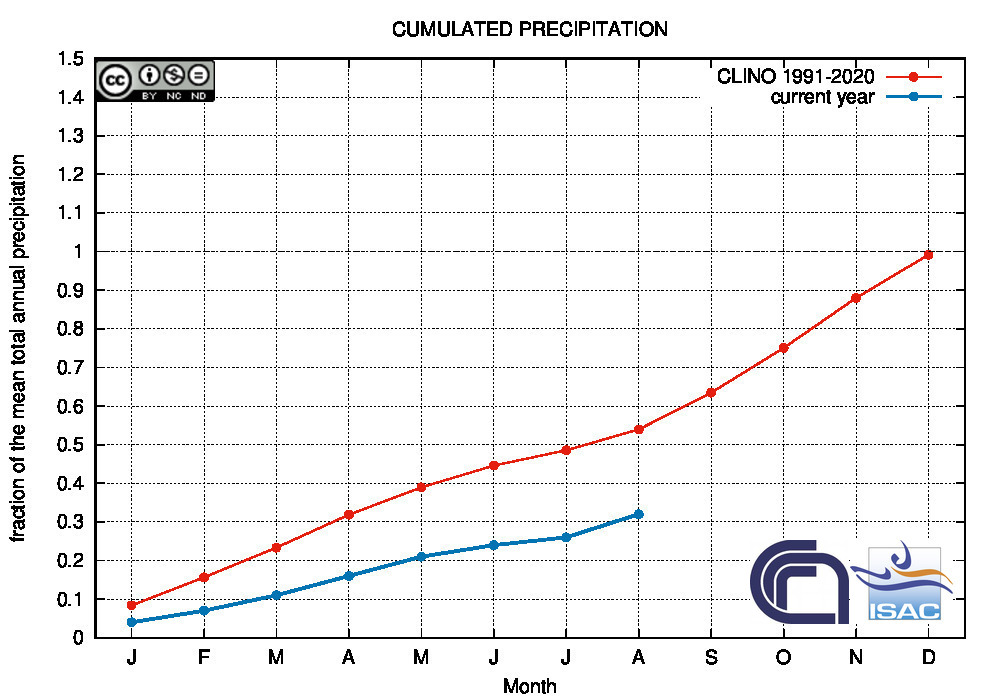
Precipitazioni cumulate a scala
nazionale, espresse in forma di frazione mensile progressiva rispetto
al totale annuo normale (da 0 a inizio anno, a 1 a fine anno). Tra
gennaio e agosto 2022 nell'insieme del Paese si è raccolto circa il
32% del valore normale annuo, rispetto al 54% che si sarebbe già
dovuto accumulare secondo la media 1991-2020. Ciò significa che nei
primi otto mesi del 2022 si è totalizzato il 59% della precipitazione
normale, ovvero con un'anomalia di -41% (fonte:
CNR-ISAC
Bologna).
A livello locale, Torino, Varese e Pontremoli segnalano i loro
periodi gennaio-agosto più secchi nelle serie pluviometriche
iniziate rispettivamente nel 1802, 1966 e 1878, con quantità pari a
solo 30%, 36% e 45% della norma 1991-2020 (ovvero deficit di -70%, -64%
e -55%).
Spiccano soprattutto i miseri 177 mm di Torino-centro, zona
ostinatamente scansata da rovesci e temporali, quantità di gran lunga
inferiore al precedente minimo storico di 256 mm del periodo
gennaio-agosto 1871.
Inoltre, sempre a Torino, i 189,2 mm del periodo dicembre 2021
- agosto 2022 sono in seconda posizione tra i minimi assoluti per
qualunque sequenza possibile di 9 mesi consecutivi nella serie dal
1802, a pochi millimetri dal record bisecolare dell'agosto 1816 - aprile 1817
(grafico qui sotto).
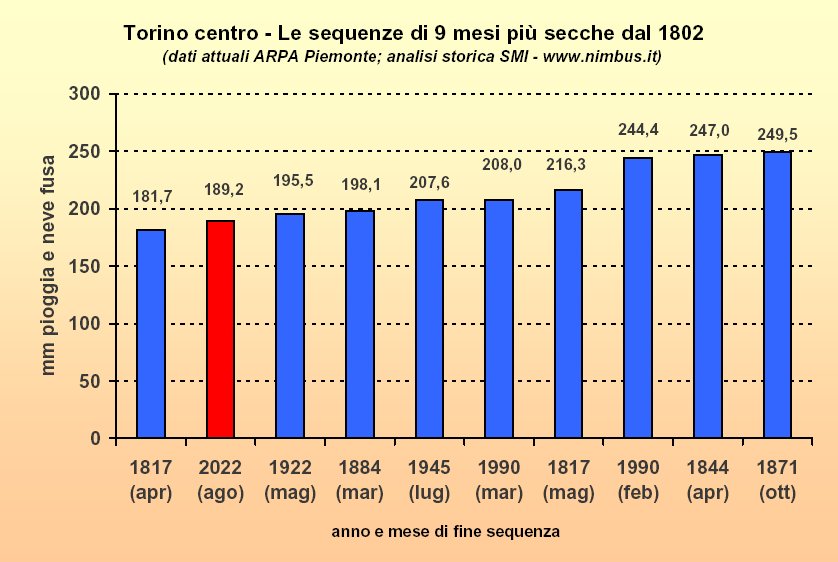
Altre località mostrano invece situazioni meno anomale, in
particolare lungo la pianura emiliana: a Modena i 316 mm
totalizzati in otto mesi (gennaio-agosto 2022) corrispondono al 76%
del normale (deficit -24%) e si pongono solo in cinquantunesima posizione dal 1830
riferendosi sempre ai periodi gennaio-agosto (in media un
caso simile avviene ogni 3-4 anni). Identica anomalia a Parma per i 343 mm
caduti, corrispondenti però alla diciottesima posizione tra i periodi
gennaio-agosto più secchi (un caso ogni 8 anni).
Tuttavia i dati di precipitazione totale talora
nascondono comunque al loro interno lunghi periodi critici di
siccità, intervallati a precipitazioni brevi e concentrate: all'osservatorio
"Serpieri" di Urbino, dei 127 mm raccolti nel trimestre
estivo, solo 27 mm appartengono ai 79 giorni dal 1° giugno
al 18 agosto, dopodiché tre violenti temporali hanno scaricato 100
mm, il primo dei quali con chicchi di grandine simili a palle da
tennis nei dintorni della città.
All'osservatorio di Parma gli 80,6 mm piovuti il
19 agosto da soli rappresentano il 23% di quanto totalizzato nei primi
otto mesi del 2022.
Dopo il minimo assoluto bisecolare di portata raggiunto
dal Po alla stazione idrometrica storica di Ferrara -
Pontelagoscuro il 24 luglio 2022, pari ad appena 104 m3/s,
un temporale dopo l'altro i deflussi del fiume sono via via
aumentati nel corso di agosto fino a riportarsi a 542 m3/s
il giorno 21 (a seguito dei forti rovesci del 18-19), per poi
stabilizzarsi poco sopra i 350 m3/s a inizio settembre.
Per quanto in miglioramento, si tratta pur sempre di un valore pari a
circa un terzo della portata normale del periodo.
Il maggiore apporto di acqua dolce ha comunque permesso
un arretramento del cuneo salino da 40 a circa 20 km dalla costa
adriatica.
ANCHE NUBIFRAGI
E TEMPESTE
Alcuni eventi temporaleschi di agosto 2022 sono stati
particolarmente violenti e dannosi, ecco una cronaca dei più
significativi.
5 agosto 2022, Alpi
Nubifragi sulle Alpi al termine di una giornata canicolare, numerose
colate di fango e detriti dalla Val Ferret (Courmayeur) alle Dolomiti,
con gli eventi più rovinosi in Val di Fassa e Badia (123 mm a Pozza di
Fassa, caduti in gran parte in un'ora, rete
Meteonetwork).
9-11 agosto 2022, Sud Italia
Al cedere dell'anticiclone nord-africano intensi temporali si sono
formati al Centro-Sud e sulle isole.
Martedì 9 agosto i fenomeni più violenti hanno investito la Campania e
in particolare Monteforte Irpino, raggiunto da impetuose colate
di fango sotto uno scroscio da 56 mm di pioggia in poco più di
mezz'ora: un evento che, seppure in scala minore e senza vittime,
ricorda le dinamiche del disastro di Sarno del maggio 1998, e che
proprio a Monteforte si era già verificato il 27 settembre 2020.
Anche l'alluvione-lampo che al mattino di venerdì 12 ha colpito Scilla (Reggio Calabria), innescata dai 68 mm piovuti
in un'ora sui rilievi soprastanti il borgo (stazione
ARPA Calabria di Monte Scrisi), ha un precedente analogo recente,
il 16 luglio 2017. Contemporaneamente, gravi dissesti e danni pure a
Stromboli. Agli esiti rovinosi di questi episodi ha contribuito
in varia misura un mix di concause antropiche tra cui la
costrizione di rii in alvei cementificati e di sezione insufficiente
a smaltire i pur rari deflussi di piena, e il denudamento dei
versanti da parte di incendi boschivi.
Altri nubifragi e inondazioni giovedì 11 nel Cagliaritano, e a
causa dei fulmini una vittima a Casteltermini (Agrigento)
e quattro feriti a Soverato (Catanzaro).
17-19 agosto 2022, Centro-Nord (tempeste in Liguria
e Toscana)
L'enorme quantità di energia e vapore acqueo messi in gioco
dall'atmosfera afosa e dal mare 5 °C più caldo del normale hanno
incentivato la violenza dei fenomeni all'arrivo dall'Atlantico del
primo sistema
perturbato organizzato di fine estate.
Episodi rovinosi
già la sera di mercoledì 17 tra il Modenese e il Ferrarese
(decine di tetti scoperchiati dal vento), poi nelle ore centrali di
giovedì 18 un esteso e potente sistema temporalesco ha fatto disastri
su Levante Ligure, Appennino Settentrionale e Toscana con venti
fino a 144 km/h alla Spezia, due vittime sotto alberi
caduti a Carrara e Lucca e decine di feriti, grandine copiosa a
Sestri Levante e a Bardi (Parma); scompiglio per il furioso temporale
anche a Venezia, e nel Saluzzese (Cuneo) si è passati dalla siccità
agli allagamenti per rovesci da ben 201 mm in poche ore, mentre lo
scirocco rovente portava la temperatura a 44,3 °C a Palermo-Punta
Raisi (vedi commento sopra).
Venerdì 19
temporali in trasferimento verso l’Adriatico, strade inondate
da circa 100 mm di pioggia a Ferrara e molti danni per
grandine gigante nel Montefeltro e nel Barese.
Le caratteristiche dell'eccezionale tempesta che il
18 agosto - attraversata la Corsica pure lì con
gravissimi danni e ben 6 vittime - ha colpito Liguria e Toscana,
rendono l'evento assimilabile ai "derecho" che di quando in
quando spazzano le pianure statunitensi: violente linee temporalesche
associate a sistemi convettivi a mesoscala che rimangono attive per
almeno sei ore producendo danni da vento oltre 94 km/h su gran parte
di un'area di almeno 100 km di larghezza e 640 km di lunghezza.

Pistoia, un camion colpito dagli
alberi abbattuti dalla tempesta
del 18 agosto 2022 (f. Corpo dei Vigili del Fuoco, via
ANSA).
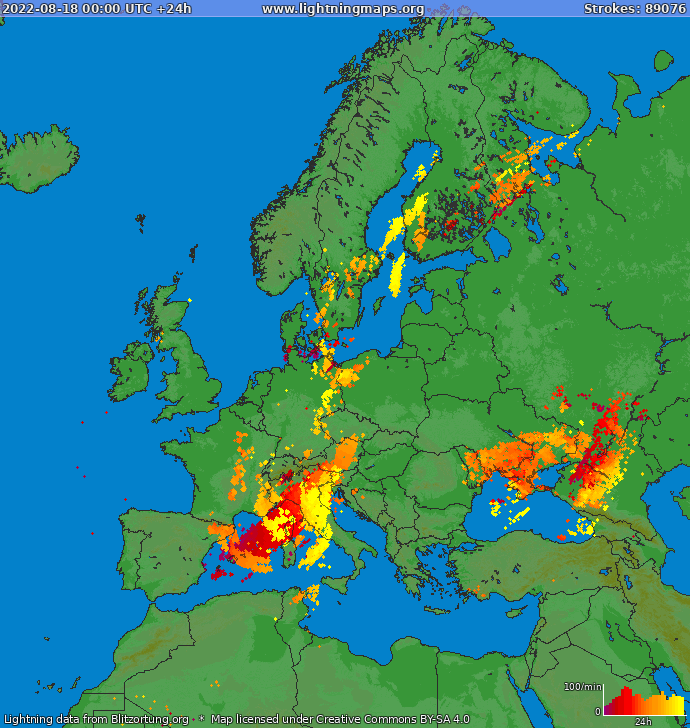
Fulminazioni del 18 agosto 2022 in
Europa. Si nota il massiccio ammasso di scariche del violentissimo
sistema temporalesco che in una dozzina d'ore ha percorso circa
1500 km dalle Baleari al confine tra Austria e Repubblica Ceca,
passando per il Centro-Nord Italia
(fonte: Blitzortung -
www.lightningmaps.org).
ALTRE RISORSE
SU CALDO E SICCITA'
DELL'ESTATE 2022
- Estate più calda pari merito con quella del 2017 in
Inghilterra, seconda in
Francia e
Svizzera, terza (pari merito con il 2019) in
Germania e quarta in
Austria.
- Francia:
stima preliminare di 11 mila vittime probabilmente dovute al caldo
eccessivo nell'estate 2022.
GRAZIE A...
... tutti i soggetti ed enti che hanno condiviso e
pubblicato dati e informazioni, in particolare i
soci e corrispondenti SMI Maurizio Ratti
(osservatorio di Pontremoli), Paolo Fantini
(osservatorio di Parma), Luca Lombroso (Osservatorio Geofisico
di Modena), Alessio Bozzo e Filippo Orlando
(osservatorio di Rovereto), Paolo Valisa (osservatorio
di Varese,
Centro Geofisico Prealpino),
Piero Paolucci (osservatorio
di Urbino).
Inoltre, Luca Maraldo (Provincia
Autonoma di Bolzano, Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe),
Denise Ponziani (Centro
Funzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nonché il
Copernicus
Climate Change Service/ECMWF, il
CNR-ISAC di Bologna,
ARPA Piemonte,
l'osservatorio meteo-sismico del Santuario di Oropa e
MeteoSvizzera.
Devolvi il 5 per mille alla SMI!
Sosterrai
le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,
e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|