|
L'Italia, così come gran parte dell'Europa
centro-meridionale, sta soffrendo da mesi un connubio inedito di
siccità e caldo estremi che determina gravi ripercussioni negative
su ecosistemi naturali, ghiacciai alpini, agricoltura, produzione
idroelettrica, benessere umano e animale, e favorisce la propagazione
di numerosi e vasti incendi boschivi, dal Carso, alla Toscana e
alla Liguria, oltre alle regioni meridionali già maggiormente soggette
in estate.
Tale anomalia meteo-climatica ha preso origine a
dicembre 2021,
ha caratterizzato tutto l'inverno, protraendosi poi nella
primavera 2022 solo con temporanei e modesti sollievi da parte di
alcuni episodi piovosi diffusi giunti sul Nord Italia tra fine aprile e inizio
maggio, infine si è ulteriormente intensificata con l'instaurarsi di
condizioni precocemente estive fin da metà maggio.
Responsabile è una situazione di blocco atmosferico caratterizzata dal
continuo rigenerarsi di pulsazioni dell'anticiclone nord-africano
verso l'Europa (configurazione più manifesta alle quote medio-alte
della troposfera, mentre d'estate al suolo la pressione tende a essere
più livellata, e l'anomalia barica in atto in superficie appare meno
evidente).

Il
Nord-Ovest e in particolare l'area intorno a Torino sono tra le zone
italiane più penalizzate sia dalla siccità sia dal caldo anomalo in
relazione ai valori medi. Il marcato stress fisiologico induce gli
alberi a un precoce ingiallimento e caduta delle foglie, come, qui
sopra, al Parco Piemonte nel quartiere Mirafiori, periferia Sud di
Torino
(28 luglio 2022, f. Daniele Cat Berro).

Rovereto, fine luglio 2022: i boschi di rovere, farnia e carpino sulle
pendici del Monte Finonchio al centro e del Monte Zugna a destra, sono
andati incontro a precoce colorazione e disseccamento delle foglie
fino a quote di circa 700 m sui versanti più soleggiati, come non si
era mai visto su simili estensioni in questo periodo dell'anno (f.
Alessio Bozzo).
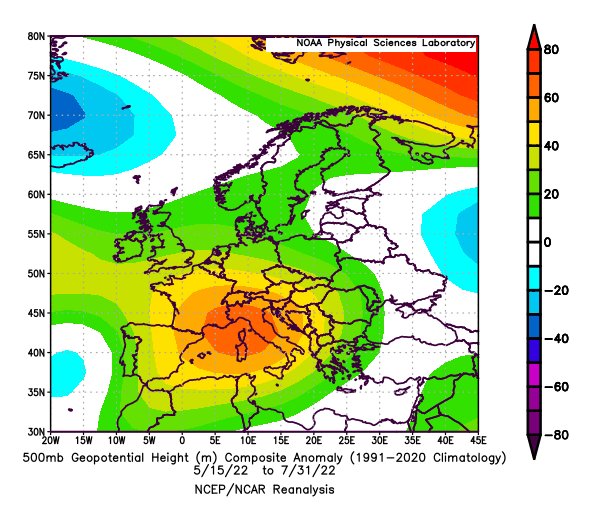
Anomalie di altezza del geopotenziale alla superficie di 500 hPa
(circa 5600 m di quota) sull'Europa nel periodo 15 maggio - 31 luglio
2022. Gli anticicloni in quota hanno insistito più del solito su quasi
tutto il continente, ad eccezione del settore più orientale e
dell'estremo Nord Atlantico, raggiungendo l'apice dell'intensità
rispetto al consueto proprio sul Centro-Nord Italia. Ad essi erano
associati marcati apporti di aria subtropicale molto calda (Fonte:
PSL-NOAA; clicca
sull'immagine per ingrandire).
SICCITA' SENZA
PRECEDENTI A SCALA NAZIONALE
Nel corso dei mesi la carenza di precipitazioni ha
raggiunto un'entità eccezionale, dapprima al Nord e poi anche
nell'insieme del Paese.
Secondo le
analisi del CNR-ISAC di Bologna, la quantità d'acqua cumulata a
livello nazionale dal 1° gennaio al 31 luglio è inferiore del 47%
alla media del nuovo trentennio di riferimento 1991-2020 (-52% al
Settentrione), e per ora il 2022 - relativamente ai primi sette
mesi - risulta l'anno più secco nella serie storica italiana
con inizio nel 1800. Svariate località dal Torinese, alla bassa
emiliana, alla Toscana non hanno ricevuto nemmeno 200 mm d'acqua da
inizio anno.
Torino è una città tra le più colpite
dall'anomalia negativa di precipitazioni: dal 1° dicembre 2021 al 31
luglio 2022 si sono raccolti appena 147 mm di pioggia e neve
fusa al pluviometro
ARPA Piemonte
di via della Consolata, riferimento per la serie storica del
centro-città, 39% della media 1991-2020 e minimo per il
periodo dicembre-luglio nella serie dal 1802.
Carenza molto marcata anche nella zona insubrica solitamente molto
piovosa: sempre dal 1° dicembre al 31 luglio, solo 356 mm a Varese
(Centro
Geofisico Prealpino), 38% del normale, minimo storico nella
serie dal 1967, di gran lunga inferiore al precedente (535 mm nel
dicembre 2004 - luglio 2005).
Sulle Alpi orientali, 281 mm all'osservatorio di
Rovereto (47% della norma), anche qui minimo nella serie
dal 1882.
A Piacenza - Collegio Alberoni 252 mm totali
(38%), ma in questo caso in quinta posizione dal 1871 dopo gli
episodi del dicembre 1944 - luglio 1945 (188 mm, record negativo per
tale intervallo di mesi), 1951-52 (210 mm), 1949-50 (221 mm) e 1928-29
(232 mm).
A Parma-Università (Piazzale Santa Croce) 293 mm
(53%), quindicesimo caso nella serie dal 1830 (minimo: 246 mm
nel dicembre 1952 - luglio 1953).
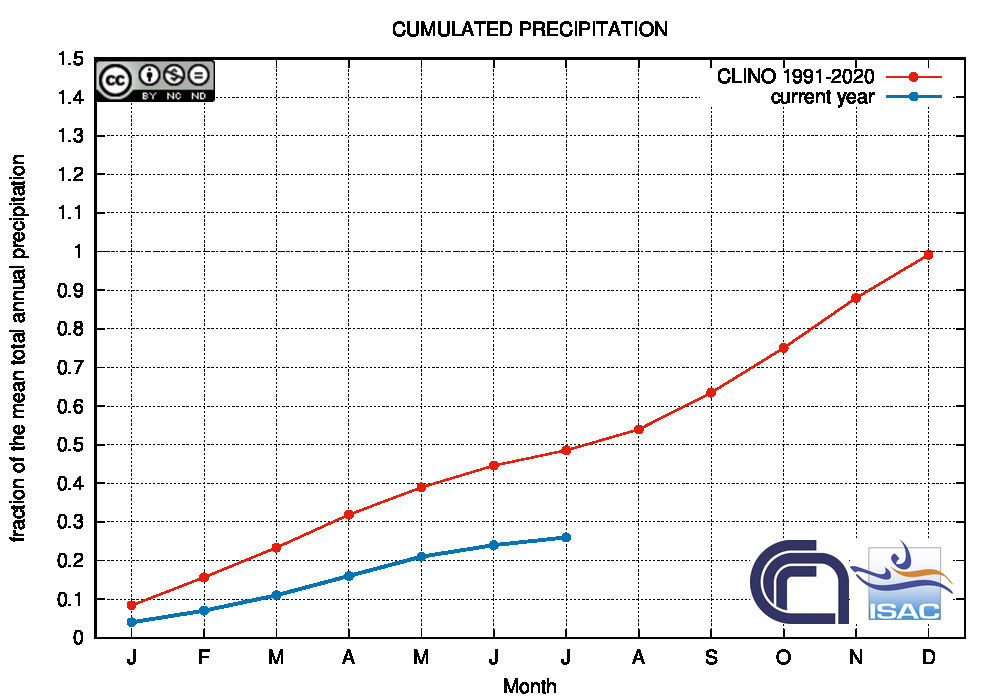
Precipitazioni cumulate a scala nazionale, espresse in forma di
frazione mensile progressiva rispetto al totale annuo normale (da 0 a
inizio anno, a 1 a fine anno). Tra gennaio e luglio 2022 nell'insieme
del Paese si è raccolto circa il 26% del valore normale annuo,
rispetto al 49% che si sarebbe già dovuto accumulare secondo la media
1991-2020. Ciò significa che nei primi sette mesi del 2022 si è
raccolto il 53% della precipitazione normale, ovvero con un'anomalia
di -47% (fonte:
CNR-ISAC
Bologna).
IL CALDO ESTREMO AGGRAVA
UNA SICCITA' GIA' STORICA
Parallelamente alla scarsità di precipitazioni, la
prevalenza di situazioni anticicloniche associate a risalite di masse
d'aria subtropicale - con l'ulteriore contributo dell'effetto-serra
antropogenico - ha determinato anomalie calde pressoché ininterrotte e
particolarmente evidenti dalla metà di maggio in poi.
In base alle statistiche
CNR-ISAC,
sia maggio, sia giugno, sia luglio 2022 si sono
collocati secondi tra i più caldi almeno dal 1800 in Italia,
rispettivamente dopo i casi record del 2003, ancora 2003, e 2015, con
anomalie nazionali di +1,83 °C, +1,88 °C e +2,26 °C rispetto al già
caldo trentennio 1991-2020.
Se a livello di medie dei singoli mesi non si sono raggiunti valori da
primato, il solo fatto di aver sfiorato a distanza di così pochi anni
episodi "fuori scala" come quelli del 2003 e 2015 rappresenta già di
per sé un fatto eccezionale e preoccupante.
In più, l'ostinazione delle anomalie calde ha fatto sì che i
primi sette mesi dell'anno, considerati insieme, risultino i
più caldi nei 223 anni di serie storica nazionale, sia come media
dell'intero Paese (+0,98 °C), sia nelle sottozone del Nord, Centro e
Sud, con scostamenti dalla norma fin prossimi a +2 °C al Nord-Ovest.
Il 2022 finora risulta dunque l'anno insieme più caldo e secco mai
registrato in Italia.
Caldo e siccità peraltro si alimentano
vicendevolmente in una spirale di retroazioni positive: le
temperature elevate accelerano il disseccamento di suoli e
vegetazione, peggiorando gli effetti della carenza di piogge a parità
di quantità d'acqua cadute, e a sua volta la secchezza dei suoli,
attraverso la riduzione dell'evaporazione e del suo effetto
rinfrescante, favorisce l'aumento delle temperature (ovvero il calore
non speso per far evaporare l'acqua si traduce in calore sensibile
e in un aumento termico dell'aria).
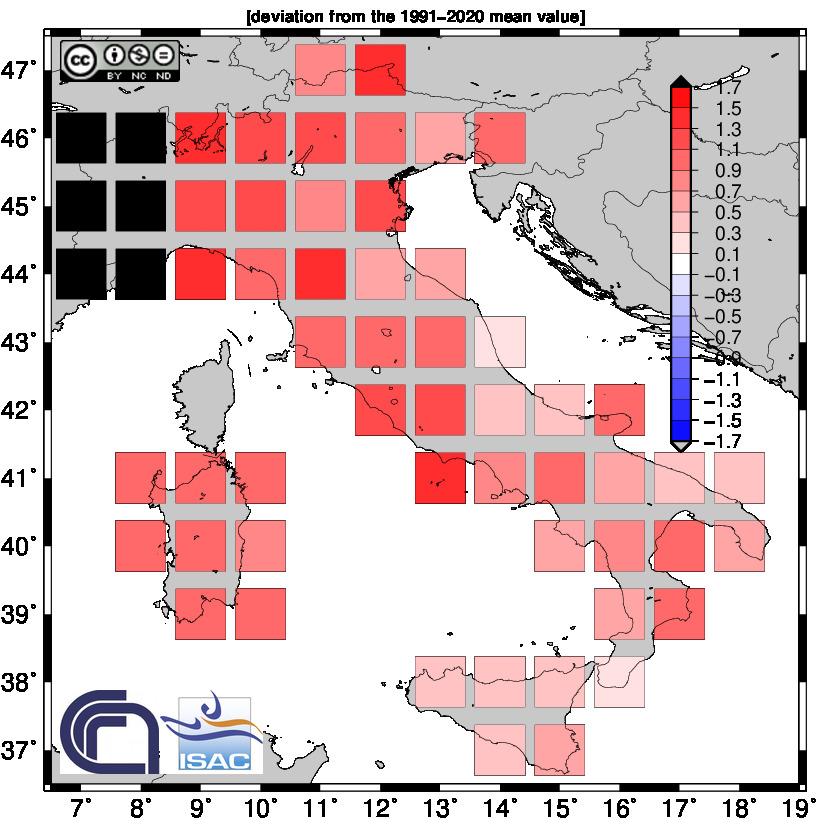
Anomalie termiche maggio-luglio 2022 in Italia, rispetto alla media
1991-2020 (fonte:
CNR-ISAC
Bologna). Il caldo è stato eccessivo in tutto il Paese, ma con
scarti più marcati al Nord-Ovest, regione d'altronde più vicina ai
massimi di anomalia positiva della pressione in quota (anticicloni).
La pressione più elevata del normale sul Mediterraneo
centro-occidentale ha inibito gli episodi di scirocco che di solito
determinano le temperature più roventi al Sud, zona che infatti ha
registrato temperature elevate, sì, ma senza episodi di caldo estremo.
A
Palermo - Osservatorio Vaiana in tutta l'estate 2022 fino all'8
agosto le temperature massime non sono salite oltre i 37,7 °C del 27
giugno, mentre un anno su cinque si sale almeno una volta a 40 °C o
più.
I singoli osservatori del Nord Italia confermano il luglio 2022
come il secondo più caldo nelle lunghe serie storiche, inferiore
in genere di circa mezzo grado °C al record del luglio 2015.
Per Torino, Varese e Rovereto è anche il secondo mese più caldo in
assoluto, seguito dall'agosto 2003, mentre negli osservatori lungo
la Via Emilia (Piacenza, Parma e Modena) slitta in terza posizione dal
momento che l'agosto 2003 compare al primo posto.
All'osservatorio di Pontremoli (Massa-Carrara) luglio
2022 si colloca invece in terza posizione dopo quelli del 2015 e 2006,
e quarto come mese in assoluto.
Decimo di grado °C più, decimo meno, ciò che conta e preoccupa di più
è che tutti i mesi (e gli anni) più caldi mai osservati si sono
affollati nell'ultimo ventennio.
Ecco dunque la classifica delle temperature medie dei
tre mesi più caldi in alcune località dotate di lunga serie storica:
Torino-centro (serie dal 1753)
1) luglio 2015, 28,5 °C
2) luglio 2022, 27,9 °C
3) agosto 2003, 27,5 °C
Varese-CGP (1967)
1) luglio 2015, 27,8 °C
2) luglio 2022, 27,5 °C
3) agosto 2003, 27,1 °C
Piacenza-Alberoni (1871)
1) agosto 2003, 28,8 °C
2) luglio 2015, 28,4 °C
3) luglio 2022, 27,6 °C
Parma-Università (1878)
1) agosto 2003, 29,4 °C
2) luglio 2015, 29,1 °C
3) luglio 2022, 28,9 °C
Modena-Oss. Geofisico (1860)
1 ex-aequo) luglio 2015 e agosto 2003, 29,4 °C
2) luglio 2022, 28,8 °C
3) agosto 2012, 28,3 °C
Rovereto-San Rocco (1882)
1) luglio 2015, 28,6 °C
2) luglio 2022, 28,2 °C
3) agosto 2003, 27,3 °C
Pontremoli (1929)
1) agosto 2003, 25,1 °C
2) luglio 2015, 24,9 °C
3) luglio 2006, 24,8 °C
4) luglio 2022, 24,7 °C
A conferma dell'eccezionale persistenza del caldo anomalo, la
temperatura media del trimestre maggio-luglio 2022 è in gran parte
del Nord Italia la più elevata in oltre un secolo, superando con un
buon margine perfino il caso del 2003 (vedi grafico di Torino
sotto).
L'episodio del 2003 è rimasto invece insuperato, sebbene per un
soffio, a Parma (media 25,6 °C maggio-luglio 2003, 25,4 °C nel
2022).
Nel 2003 ad essere straordinario fu in particolare il mese d'agosto,
che quest'anno con tutta probabilità non si avvicinerà al caso di 19
anni fa, ma non è del tutto escluso che il record del maggio-luglio
2022, magari non ovunque, si mantenga anche sui periodi maggio-agosto
e giugno-agosto.
L'ostinazione da primato della calura si evince anche
dalla lunghezza delle sequenze ininterrotte di giorni con
temperatura massima > 30 °C. Ad esempio, a Rovereto è stata
di ben 45 giorni (23 giugno - 6 agosto), di gran lunga
superiore al massimo precedente di 35 giorni (27 giugno - 31 luglio
2015).
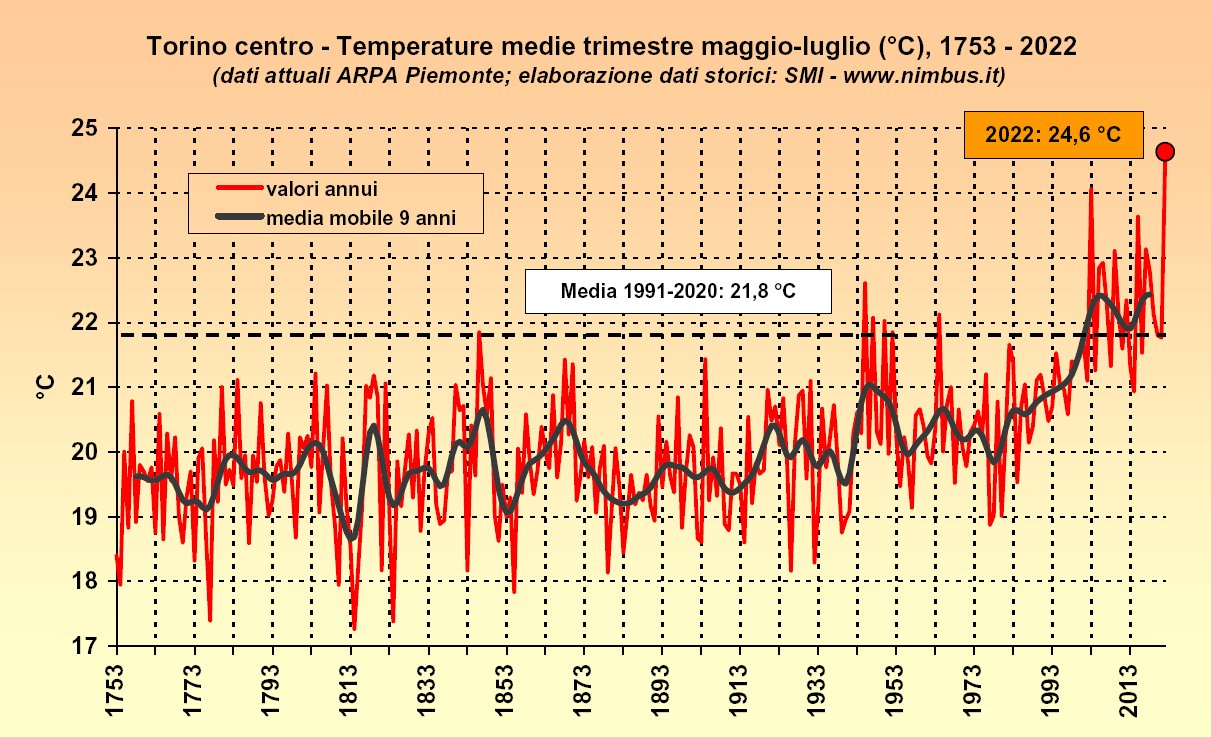
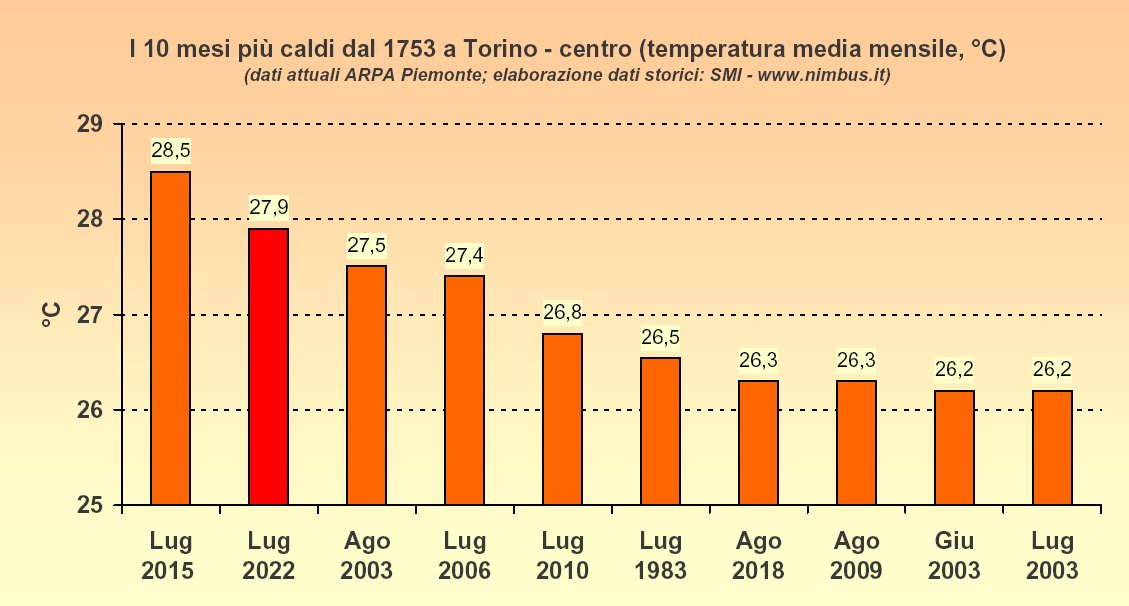
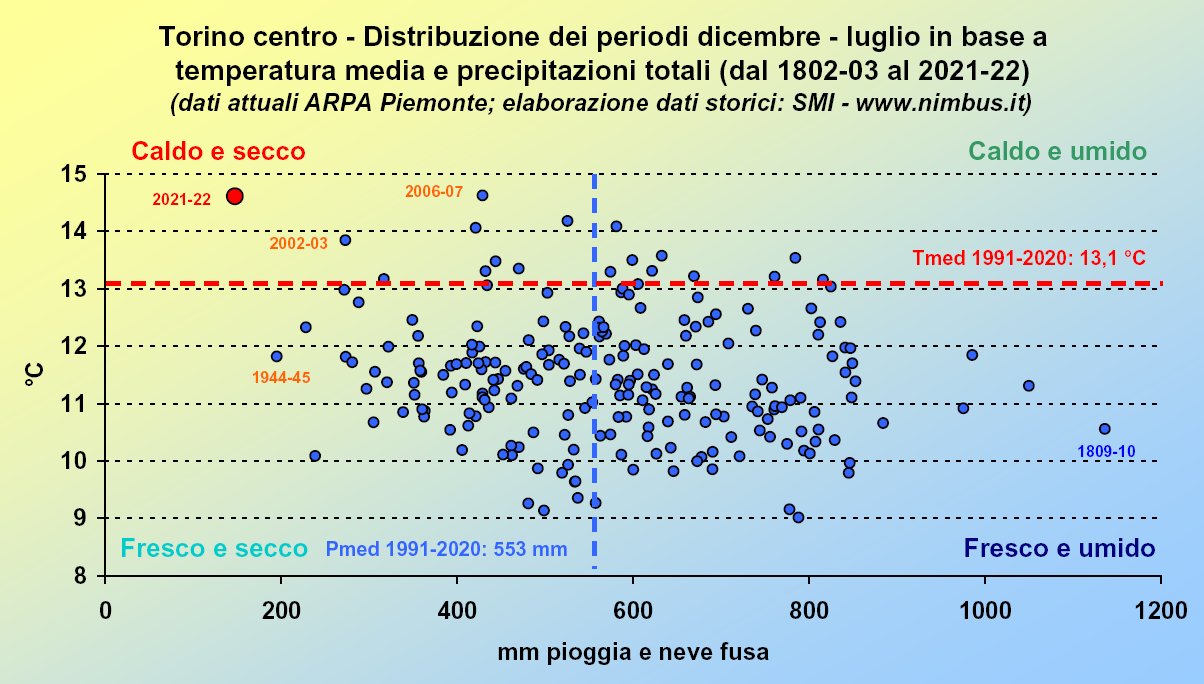
Grafici che rappresentano l'entità dell'anomalia termo-pluviometrica a
Torino, città tra le più colpite dalla concomitanza caldo-secco. Qui
sopra, il pallino rosso del caso del 2021-2022 (il più in alto a
sinistra) indica che in oltre due secoli di misure nel periodo
dicembre-luglio non c'era mai stata una situazione così asciutta e
calda insieme, ben peggio dei casi 1944-45, 2002-03 e 2006-07.

L'osservatorio SMI di
Moncalieri - Collegio Carlo Alberto ha rilevato nel luglio 2022 un
nuovo record mensile di temperatura massima di 40,4 °C
il giorno 15 nella capannina nel sito di misura storico dal 1865
(termometro a massima di precisione qui sopra), lasciando invece
insuperato il primato assoluto di 42,3 °C del 28 giugno 2019.
Da segnalare inoltre il record assoluto (per qualunque mese,
non solo per luglio) di temperatura minima più elevata, 27,1 °C
(precedente: 26,8 °C il 30 luglio 1947).
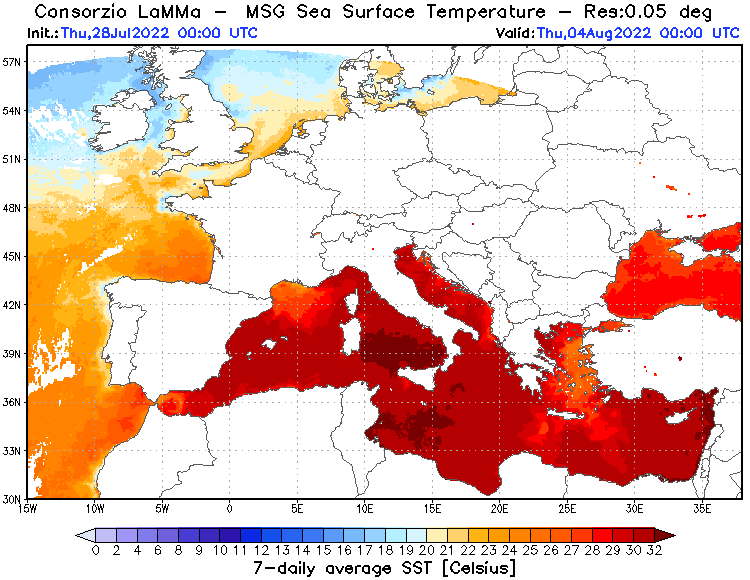
Ondate di caldo così insistenti e
anomale non si sono limitate a interessare l'atmosfera, ma si sono
trasferite anche al mare. Con la persistenza degli anticicloni
nordafricani e l'assenza di episodi di maestrale in grado di
rimescolare lo strato d'acqua superficiale, il Mediterraneo centrale e
soprattutto il Tirreno ha estesamente raggiunto temperature di 30-32
°C in superficie come media del periodo 28 luglio - 4 agosto 2022, da
4 a 6 °C sopra la norma e nefaste per gli ecosistemi marini
(fonte:
LAMMA Toscana).
NUOVI RECORD DI TEMPERATURA MASSIMA
Numerosi nuovi record mensili di temperatura massima
sono stati stabiliti nella rete di stazioni sinottiche dell'Aeronautica
Militare e dell'ENAV,
attive per lo più da almeno un sessantennio. Ecco un elenco non
esaustivo.
MAGGIO 2022
32,6 °C Pratica di Mare (giorno 27), 33,5 °C Fiumicino (27), 34,0 °C
Pisa (27), 34,3 °C Viterbo (27), 35,6 °C Grosseto (27), 36,1 °C
Firenze (27), 33,4 °C Ustica (31).
GIUGNO 2022
40,4 °C Alghero (4), 38,6 °C Pescara (5), 41,2 °C Guidonia (27-28,
anche per le stazioni seguenti), 41,0 °C Firenze-Peretola, 39,4 °C
Grazzanise (Caserta), 39,3 °C Ciampino, 39,0 °C Fiumicino e Latina,
38,9 °C Arezzo, 38,2 °C Pratica di Mare, 38,0 °C Napoli-Capodichino,
37,5 °C Ronchi dei Legionari (Trieste), 37,4 °C Campobasso.
LUGLIO 2022
40,0 °C Grosseto (4), 37,5 °C Genova-Sestri (18), 37,8 °C
Milano-Malpensa (22; primato assoluto, per qualunque mese), 40,2 °C
Treviso-Istrana (23), 40,0 °C Ferrara-San Luca (25).
Degni di rilievo anche i record per la seconda
decade di luglio di 37,0 °C a Pontremoli (SMI), 38,0 °C a
Piacenza-Alberoni (SMI), 38,7 °C a Parma-Piazzale Santa Croce
(Università) e 39,5 °C a Firenze-Peretola (AM).
Inoltre, il 22 luglio si sono registrati 41,2 °C a Carpi e 41,3 °C a
San Possidonio, nel Modenese (rete
associazione Emilia-Romagna Meteo/ASMER); il 23 luglio, ben
43,4 °C a Moie, sui colli anconetani (rete
Assam,
servizio agro-meteo delle Marche).
MAGRA DEL PO E
DEGLI AFFLUENTI:
DEFLUSSI AI MINIMI IN OLTRE DUECENTO ANNI
La scarsità dei contributi di pioggia, e di fusione
della neve sulle Alpi, ha portato allo sviluppo di una magra
eccezionale in tutti i bacini idrografici del Nord Italia a partire
dal tardo inverno e dalla primavera 2022.
Rovesci e temporali per lo più localizzati non hanno potuto impedire
al Po, esaurita precocemente la già miserrima risorsa nivale
alpina e appenninica, di raggiungere un minimo bisecolare di
portata di appena 104 m3/s il 24 luglio 2022 alla
stazione idrometrica di Ferrara-Pontelagoscuro, la più
importante di tutta l'asta fluviale a una sessantina di chilometri
dalla foce in Adriatico (fonte:
ARPAE).
Lo scarso apporto d'acqua dolce ha permesso una
notevole risalita, nei suoli e nelle falde, del cuneo salino
dall'Adriatico fino a 40 km dalla costa, con gravi conseguenze
per l'agricoltura data l'inutilizzabilità a fini irrigui dell'acqua
troppo salata.
Leggi
l'analisi idrologica per il Po del prof. Renzo Valloni
(docente di Geologia e Valutazione di Impatto Ambientale presso
l’Università di Parma, e Centro Etica Ambientale), aggiornata a giugno
2022.
Inoltre, aggiornamenti dell'Autorità
di Bacino del Fiume Po sugli indicatori idrometrici e la siccità.
_MilosLago.jpg)
7
agosto 2022: la secca del Brenta al ponte di Limena,
alla periferia Nord di Padova (f. Milos Lago).

Già il
29 aprile 2022, all'inizio di quello che dovrebbe essere il periodo di
morbida con le portate medie più elevate dell'anno a causa delle
piogge primaverili e della fusione nivale sulle Alpi, il Po a Chivasso
(Torino) appariva poco più che un rigagnolo (f. Luca Mercalli).

31 luglio 2022, alta Valsavarenche (Gran Paradiso): piccolo lago
completamente disseccato a circa 2600 m di quota nei pressi di Pian
Borgno. Poco profondo (< 1 m) e soggetto a normali abbassamenti di
livello a fine estate, non si era mai completamente prosciugato, per
lo meno a memoria dei guardaparco del
Parco nazionale Gran
Paradiso operativi in questa zona. Sullo sfondo la sommità del
Gran Paradiso (4061 m) con i ghiacciai privi di neve residua talora
fin quasi a 4000 m
(f. Daniele Cat Berro).
POCHI
TEMPORALI, MA ROVINOSI
Pur in quadro complessivo di forte carenza di
precipitazioni, i temporali che di quando in quando, irregolarmente,
si sono presentati all'arrivo di infiltrazioni di aria più fresca,
umida e instabile dal Nord Atlantico o dall'Europa centro-orientale,
sono stati talora particolarmente violenti al Nord e più marginalmente
altrove.
Tra i casi più rilevanti:
* sera del 28 maggio 2022: irruzione fresca da
Nord-Est, imponenti grandinate tra Lombardia e Piemonte, colture e
auto devastate in particolare a Crema e Tortona;
* notte tra 6 e 7 giugno: nubifragi nel Comasco,
alluvionato l'abitato di Laglio con le stesse dinamiche del 28 luglio
2021;
* 28-29 giugno: fronte temporalesco atlantico,
rovesci copiosi e grandine dapprima sulle Alpi occidentali (95 mm a
Cuneo il
28), poi sui settori orientali (213 mm il 29 sulle
Prealpi
Carniche e dintorni, strada interrotta da una colata detritica a
Vigo di Cadore);
* 30 giugno: tempesta serale sulla cintura
Nord-Ovest di Torino con grandine da oltre 5 cm di diametro e raffiche
di vento a 112 km/h all'aeroporto di
Caselle che
devastano lo storico Parco della Mandria di Venaria schiantando decine
di alberi secolari;
* notte tra 26 e 27 luglio: aria più fresca e
umida da Est innesca temporali violenti e grandinate specie tra
Milano, Novara, Pavia e Lodi, inoltre strade invase dal fango in Val
Tidone (Piacenza) e rovesci torrenziali pure tra Cebano e Savonese
(rari a vedersi, in Piemonte, i
130 mm caduti in
un'ora a Viola, Cuneo). Nel pomeriggio del 27 grandine dal
diametro fino a quasi 10 cm con gravi danni presso Teramo;
* notte tra 27 e 28 luglio: nubifragio in Val
Camonica rovescia ben
187 mm di pioggia in due ore e mezza (di cui 79 in 20 minuti!) sul
paese di Niardo (stazione privata di Amerigo Lendvai,
Associazione
Meteopassione), invaso dall'imponente colata detritica del
torrente Valle Re a 35 anni dall'episodio del 24 agosto 1987. Gravi
danni anche nelle vicine località di Ceto e Braone.
* sera del 5 agosto: ulteriori nubifragi sulle
Alpi al termine di una giornata canicolare, numerose colate di fango e
detriti dalla Val Ferret (Courmayeur) alle Dolomiti, con gli eventi
più rovinosi in Val di Fassa e Badia (123 mm a Pozza di Fassa, caduti
in gran parte in un'ora, rete
Meteonetwork),
L'atmosfera troppo calda, ricca di energia e vapore
acqueo, ha molto probabilmente contribuito alla potenza dei temporali
di questa estate, d'altra parte inefficaci nel risolvere la
siccità alla scala dei grandi bacini idrografici.
Inoltre rovesci intensi fanno più danno su territori densamente
infrastrutturati, e a tal proposito il nuovo
rapporto Ispra “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi
ecosistemici” fotografa una situazione ormai intollerabile: nel
2021 nuovi edifici, strade e parcheggi come metastasi hanno
cementificato altri 69 chilometri quadrati di suolo italiano (19
ettari al giorno) a svantaggio di produzione agricola, biodiversità e
protezione da alluvioni e ondate di calore.


Rovinosi effetti delle colate detritiche della notte del 28 luglio
2022
a Niardo, Val Camonica - Brescia (fonti:
araberara.it e
localteam.it).

Una delle numerose colate di fango della sera
del 5 agosto 2022 in Val Badia.

7 agosto 2022: l'Adige gonfio e carico di sedimenti nei pressi di
Trento a seguito dei violenti temporali del giorno 5 (f. SMI).
POCHISSIMA NEVE
INVERNALE, CALURA ESTIVA,
L'ANNO PEGGIORE PER I GHIACCIAI
L'inedita combinazione tra la
scarsissima alimentazione nevosa invernale e il caldo precoce e
straordinario sta inevitabilmente causando gravose perdite di massa
sui ghiacciai delle Alpi, rimasti in gran parte privi di neve
stagionale e in balìa della radiazione solare fin dalla metà di giugno.
Anche qualora l'estate 2022 subisse nel suo finale un
ridimensionamento di configurazione meteorologica, con temperature
meno elevate e precipitazioni più diffuse, è ormai molto probabile
che a metà settembre questa si concluderà come la peggiore stagione
mai sperimentata (forse da molti secoli) dalla criosfera alpina
in termine di bilanci di massa e di arretramenti delle fronti.

19 giugno 2022: copiose cascate d'acqua dal Ghiacciaio orientale di
Fellaria, (quota 2900 m circa, Val Malenco - Bernina, f. Daniele Cat
Berro) testimoniano la fusione glaciale precoce e intensa. Nella
stessa giornata svariati record di temperatura massima per il mese di
giugno venivano superati nella vicina Svizzera e Liechtenstein (34,9
°C a Payerne, 35,2 °C
a Vaduz, 36,5 °C a Neuchâtel... fonte
Meteosvizzera).

14 luglio 2022, Colle Ciardoney (3120 m, Gran Paradiso): in occasione
di un sopralluogo di mezza estate del team SMI per l'installazione di
nuove paline ablatometriche, in affiancamento a quelle già esistenti e
in procinto di fuoriuscire del tutto dal ghiaccio proprio a causa
della rapida fusione glaciale, è stato possibile rilevare perdite
di spessore di ghiaccio - in meno di un mese - variabili tra 102 cm
(Colle Ciardoney, palina nella foto) e 215 cm (settore mediano). Il
ghiacciaio si presentava, a metà luglio, in condizioni già peggiori
rispetto a quanto osservato nel 2003
il 9 agosto, delineando una situazione mai sperimentata prima non
solo nei 37 anni di monitoraggio continuo, ma ragionevolmente da tempi
molto più lunghi (f. Daniele Cat Berro).

Colle Ciardoney, 14 luglio 2022: ghiaccio completamente esposto alla
radiazione solare e frequenti crolli dalle pareti rocciose, stimolati
dallo scongelamento del permafrost e dal "rilassamento" dei versanti a
seguito della scomparsa di neve e ghiaccio (f. Pierluigi Cullino).

Colle Ciardoney, 14 luglio 2022: Raffaella Miravalle (guardaparco PNGP)
e Daniele Cat Berro (SMI) installano nuove paline ablatometriche che
serviranno a proseguire le misure di perdita di spessore glaciale per
alcuni anni (f. Pierluigi Cullino).

La
situazione dei ghiacciai nell'estate 2022 è estremamente critica in
tutte le Alpi. Ecco il ghiacciaio dell'Adamello, completamente privo
di neve residua, ripreso dalla webcam della Punta del Venerocolo
all'alba dell'8 agosto, con davanti ancora almeno un mese di
potenziale fusione
(fonte:
Associazione Meteopassione). Quello che è il più grande ghiacciaio
d'Italia se si considera insieme il vasto Pian di Neve e la sua
effluenza del Mandrone (circa 15
km2 totali) è molto penalizzato dal riscaldamento
atmosferico, dal momento che il suo bacino di alimentazione non supera
i 3500 m e ormai con crescente frequenza si trova interamente al di
sotto della linea del nevato (linea di equilibrio, ELA = Equilibrium
Line Altitude), dunque privo di alimentazione e in totale
disequilibrio con il clima attuale che nell'arco di questo secolo lo
condannerà all'estinzione pressoché completa anche qualora non ci
fosse un ulteriore aumento delle temperature, scenario peraltro molto
improbabile.

Ciò
che restava, il 6 agosto 2022, del Ghiacciaio Meridionale di Suretta
(zona Spluga, Val Chiavenna - Sondrio): il caldo della prima parte
dell'estate ha già asportato spessori di ghiaccio fino a ben 365 cm
nel settore inferiore a quota 2745 m. La massiccia deglaciazione in
corso minaccia l'esistenza stessa di questo apparato e delle misure di
bilancio di massa che vi vengono condotte, all'orizzonte di pochi anni
(f. Fabio Villa,
Servizio Glaciologico Lombardo).
CALDO ESTREMO E SICCITA' ANCHE ALTROVE IN EUROPA
Caldo estremo, siccità e incendi hanno interessato
anche gran parte dell'Europa centro-meridionale.
In particolare quello del 17-19 giugno 2022 è
stato un weekend "infuocato". La Francia ha vissuto
l'ondata di calore più precoce e intensa della sua storia nota,
con nuovi record assoluti - ovvero per qualunque mese dell'anno - di
41,9 °C a Cap Ferret e 42,9 °C a Biarritz (21 °C sopra media!).
Sbalorditivi pure i 43,5 °C di San Sebastian, nei Paesi Baschi
spagnoli; in Germania i 39,2 °C di Cottbus non hanno precedenti
dall'inizio delle misure nel 1888; inoltre, eguagliato il record
nazionale per giugno in Svizzera (36,9 °C) e in Polonia (38,3 °C),
superato invece in Repubblica Ceca (39,0 °C).
Ma anche il caldo di metà luglio ha raggiunto punte inedite a
scala plurisecolare, come i nuovi record nazionali per qualunque mese
dell'anno di 40,3 °C in Inghilterra – definiti dal MetOffice una
“pietra miliare nella storia del clima del Regno Unito” – di 35,1
°C in Scozia e 37,2 °C in Svezia; su singole località, mai registrati
prima anche i 39,3 °C a Brest, nella fresca Bretagna (stracciato il
precedente estremo di 35,1 °C del 9 agosto 2003!) e i 40,1 °C di
Londra e Amburgo; in Danimarca 35,9 °C, nuovo primato nazionale per
luglio (info sui primati nazionali da
"Extreme
temperatures around the world"). Incendi sono divampati in mezzo
continente, il peggiore ha divorato la Forêt du Pilat in Gironda
(Francia), costringendo a evacuare seimila persone.
Il 25 luglio 2022 il radiosondaggio eseguito
dalla stazione aerologica di Payerne, sull'altipiano svizzero,
alle h 00 UTC, ha rilevato lo zero termico a una quota di ben 5184
m, massimo dell'intero periodo di misure cominciato nel 1959 in questa
località, ma record anche per tutto il territorio elvetico (fonte:
MeteoSvizzera). Sempre al di sopra di Payerne, in un sessantennio
la quota media dell'isoterma 0 °C in libera atmosfera è aumentata di
circa 600 metri! Al Sud delle Alpi, l'altitudine dello zero termico
era un po' più bassa, ma pur sempre a livelli fuori dal comune, 4961 m
sui cieli di Cuneo-Levaldigi, 4983 m a Udine-Rivolto e 5063 m a San
Pietro Capofiume (Bologna).
Lo studio
“Accelerated western European heatwave trends” coordinato dal
Potsdam
Institute for Climate Impact Research e apparso su Nature, indica
che le grandi ondate di caldo in Europa sono aumentate tre-quattro
volte più rapidamente che nelle altre zone temperate boreali
nell'ultimo quarantennio, a causa di cambiamenti nella dinamica
delle correnti a getto a loro volta forse innescati da inedite
differenze termiche nell'Artico (dove il riscaldamento in terraferma è
molto veloce ma l'aria sopra l'oceano si riscalda quasi per nulla
poiché il calore in eccesso viene speso per fondere il ghiaccio
marino).
GRAZIE A...
... tutti i soggetti ed enti che hanno condiviso dati,
fotografie e informazioni con la nostra redazione, in particolare i
soci e corrispondenti SMI Maurizio Ratti
(osservatorio di Pontremoli), Paolo Fantini
(osservatorio di Parma), Luca Lombroso (Osservatorio Geofisico
di Modena), Alessio Bozzo e Filippo Orlando
(osservatorio di Rovereto), Paolo Valisa (osservatorio
di Varese,
Centro Geofisico Prealpino),
Riccardo Scotti (Servizio
Glaciologico Lombardo).
Devolvi il 5 per mille alla SMI!
Sosterrai
le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,
e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|