|
In attesa di valutazioni più complete nei prossimi giorni, possiamo
già dire che il sistema perturbato di ieri, 23 aprile 2022, è stato
indubbiamente il più vigoroso a interessare il Nord-Ovest italiano non
solo dall'inizio della
lunghissima siccità il 9 dicembre scorso, ma almeno dal 15
novembre se non dall'episodio ancora precedente del
4-5 ottobre 2021.
Il gradiente di precipitazioni pianura-montagna è stato
particolarmente forte, per cui se soprattutto in serata gli apporti
sono stati di "solenne" intensità e abbondanza sui rilievi dal
Torinese al Verbano (anche oltre 100 mm in 24 ore), Torino e
dintorni, rimasti sottovento al flusso umido principale da S-SW in
quota, sono rimasti perfino sotto i 10 mm.
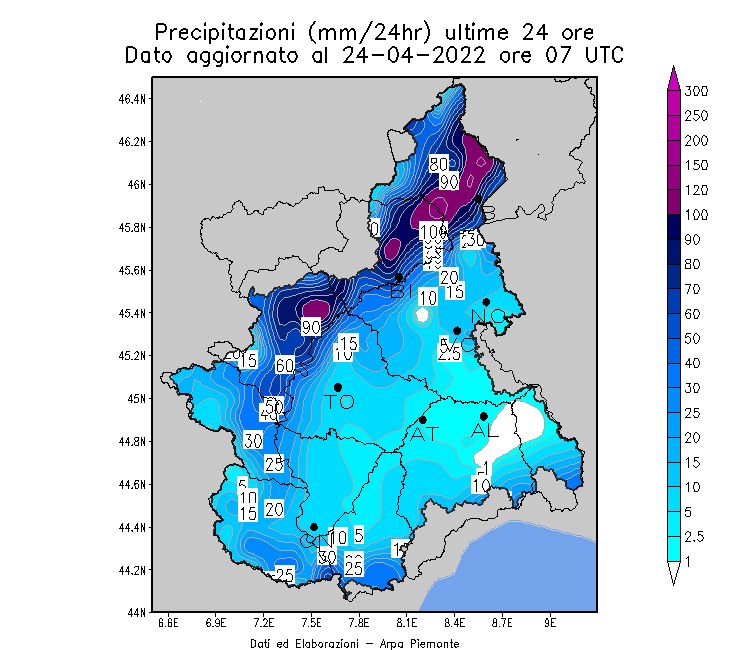
Carta delle precipitazioni del 23
aprile 2022 tratta da
ARPA Piemonte,
in cui si nota il forte gradiente pluviometrico tra la Valpadana
occidentale (meno di 10 mm presso Torino e nulla o quasi su parte
dell'Alessandrino), e i rilievi dal Canavese al Verbano che hanno
ricevuto quantità provvidenziali anche superiori a 100 mm, benché
cadute fin troppo rapidamente e capaci di colmare non più di un terzo
del deficit che si era trascinato dallo scorso dicembre 2021.
In generale non c'è dubbio che sia giunto un sollievo alla siccità,
benché in maniera parziale e iniqua sul territorio: le zone più
battute hanno visto ripianarsi per il 30% circa il deficit di
precipitazioni che si era accumulato dal 9 dicembre 2021, come nei
casi delle stazioni di Balme, nelle Valli di Lanzo (72 mm
misurati dal solerte sindaco Gianni Castagneri rispetto all'ammanco di
250 mm che fino a metà settimana gravava rispetto alla media
1991-2020) e Oropa, nel Biellese (117 mm caduti rispetto a
circa 400 mm di carenza; dati
Arpa Piemonte
e
osservatorio del Santuario).
Al contrario, Torino non ha visto recuperare che un misero 4%...
e con gli 8 mm di ieri sera alla stazione
Arpa della
Consolata il totale provvisorio dicembre-aprile (37 mm) resta
pressoché identico al record minimo della serie dal 1802 per il
medesimo pentamestre in centro città (36,2 mm nel dicembre 1843 -
aprile 1844); nel capoluogo il Po quanto a deflussi non si è
praticamente accorto di nulla, mentre svariati corsi d'acqua nel
Centro-Nord della regione per lo meno hanno visto temporanei
innalzamenti di livello dell'ordine di 0,5-1,5 m.
Sui pendii montuosi, sotto rovesci intensi (con tuoni e talora
grandine piccola ma insistente) ieri sera il ruscellamento
superficiale è stato infatti rapido, e questo non ha favorito
un assorbimento ottimale dell'acqua a beneficio delle falde
eccezionalmente basse.
Peraltro non era atteso e né si poteva sperare in un recupero totale
del deficit pluvio-nivometrico in un tempo così breve, che ci avrebbe
fatti passare dai danni della siccità a quelli di alluvioni e frane,
ma è un inizio, sperando che dopo una settimana di fine aprile nuovo
in prevalenza asciutta ulteriori apporti arrivino in maggio,
tradizionalmente il mese più bagnato dell'anno insieme a novembre
sulle regioni nord-occidentali. Vedremo.
Che in generale la situazione secca non sia risolta appieno lo dice
anche lo stato della neve in montagna. Nonostante al passaggio del
fronte freddo ieri sera la nevicata sia scesa talora sotto i 1500 m,
accumulando sopra i 2000 m spessori di neve nuova anche di 50-70 cm
nelle zone più interessate dalle Valli di Lanzo al Monte Rosa
piemontese, gli spessori nevosi totali (e di conseguenza il
volume d'acqua stoccato) rimangono ampiamente sotto alla media
per il periodo dell'anno (metà aprile - fine maggio) che alla quota
dei ghiacciai conosce di solito il culmine dell'accumulo di tutta la
stagione invernale.
Alla stazione meteorologica SMI del
Ghiacciaio Ciardoney (2850 m, Gran Paradiso, grafico in basso)
la scarsità della neve era davvero eccezionale per il periodo - per
non dire incredibile - con soli 35 cm di spessore residuo al suolo il
22 aprile, poi con l'evento recente il manto è cresciuto fino ai
100 cm totali di stamattina: certamente meglio, ma pur sempre
ben sotto allo spessore medio 2013-2021 per il giorno, circa 210
cm, e anche sotto ai minimi della serie di osservazione.
Quest'ultima è certamente breve, a malapena decennale, ma l'anomalia
resta di sicuro molto significativa anche in stazioni alpine limitrofe
dotate di serie ben più lunga che presto avremo modo di analizzare
meglio.

_GianniCastagneri.jpg)
Risveglio finalmente bianco domenica
24 aprile 2022 sulle Alpi occidentali
a Ceresole Reale (1579 m, alta Valle Orco, foto Pierluigi Cullino) e a
Balme (1450 m, Valli di Lanzo, foto Gianni Castagneri), 8-10 cm di
neve fresca caduti la sera del 23. Nevicate fin presso i 1500 m a fine
aprile non sono per nulla inconsuete, e in questo caso hanno aiutato
ad attenuare sebbene solo in parte la carenza di precipitazioni dei
quasi cinque mesi precedenti.


Immagini webcam dell'asta nivometrica presso la fronte del
Ghiacciaio Ciardoney (2850 m, Gran Paradiso) prima e dopo la recente
nevicata, rispettivamente con appena 35 cm e poi 100 cm di spessore
nevoso
totale al suolo. Un indubbio miglioramento che tuttavia non ha ancora
permesso di uscire da una situazione di straordinaria scarsità.
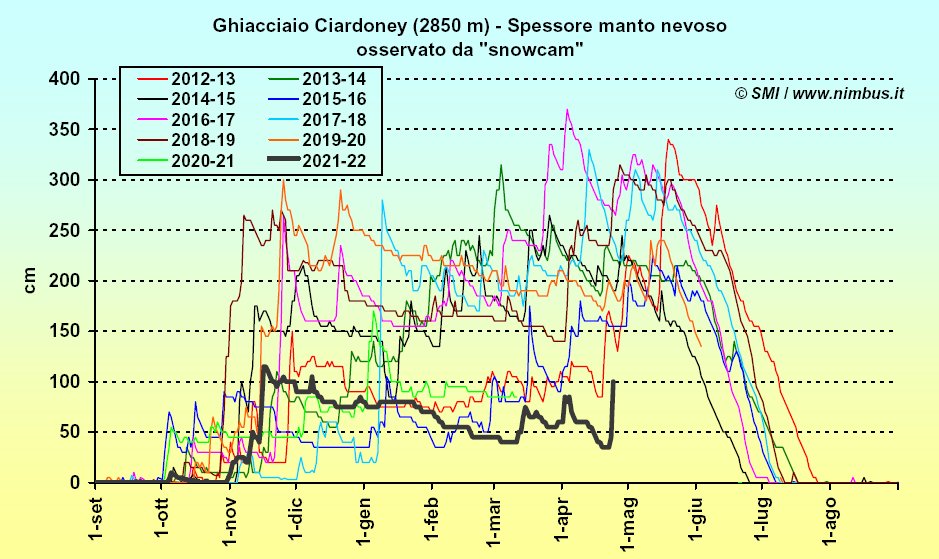
L'inviluppo delle curve
dell'andamento giornaliero dell'altezza della neve al suolo presso il
Ghiacciaio Ciardoney mostra come i 100 cm di oggi, 24 aprile 2022
(curva stagionale 2021-22 nera e spessa) rimangano sotto i precedenti
spessori nevosi minimi rilevati dalla stagione 2012-13 in poi, in
tutto il periodo primaverile tra metà aprile e inizio giugno, che
corrisponde al momento dell'anno in cui di solito si osservano i
massimi accumuli nevosi della stagione prima dell'avvio della fusione
estiva. Una situazione che, qualora non dovessero giungere ulteriori e
copiose nevicate in maggio ad alta quota, predisporrà le condizioni
per ingenti perdite di massa glaciale nell'estate 2022, anche qualora
le temperature non dovessero essere eccezionalmente elevate.
Devolvi il 5 per mille alla SMI!
Sosterrai
le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,
e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|