|
Un marcato episodio di tempo perturbato ha interessato
il Nord Italia (già reduce da tre mesi di frequenti e copiose
precipitazioni) mercoledì 15 e giovedì 16 maggio 2024, allorché una
depressione atlantica sull'Europa occidentale, centrata sul Golfo di
Biscaglia, ha fatto affluire masse d'aria umide e instabili da
Sud-Sud-Ovest.
Già da alcuni giorni i principali centri di calcolo (ECMWF
in primis) delineavano due aree soggette a precipitazioni importanti e
potenzialmente foriere di danni, la prima (mercoledì 15) tra il
Verbano, il Comasco e la pianura intorno a Milano, la seconda (tra
mercoledì sera e giovedì 16) tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia,
previsione poi confermata dai dati osservati.

Soccorsi durante le inondazioni
del 15 maggio 2024 nell'area metropolitana
di Milano (f. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, via
www.rainews.it).
Dalla tarda sera di martedì 14 e per gran parte di
mercoledì 15 rovesci intensi e persistenti hanno interessato una vasta
area tra il Lago Maggiore, il Sottoceneri (Canton Ticino), le Prealpi
lombarde tra Varese, Como e Lecco, e le adiacenti pianure delle
province di Monza-Brianza, Milano e Lodi, accumulando
precipitazioni diffusamente superiori a 100 mm, rare vedersi in una
sola giornata su un territorio così esteso.
Peraltro a stupire sono state non tanto (o non solo) le quantità
d'acqua osservate sulla fascia prealpina, insolite ma non così
eccezionali per un zona soggetta a piogge torrenziali in situazioni di
sbarramento orografico da Sud (a Valganna-Mondonico, in
provincia di Varese, a partire dalle ore 21 del 14 maggio si sono
rilevati 157 mm in 24 ore e 228 mm in 48 ore, con la
continuazione dei rovesci anche il 16 maggio; fonte:
ARPA Lombardia),
ma soprattutto quelle riscontrate in aperta pianura, Milano inclusa.
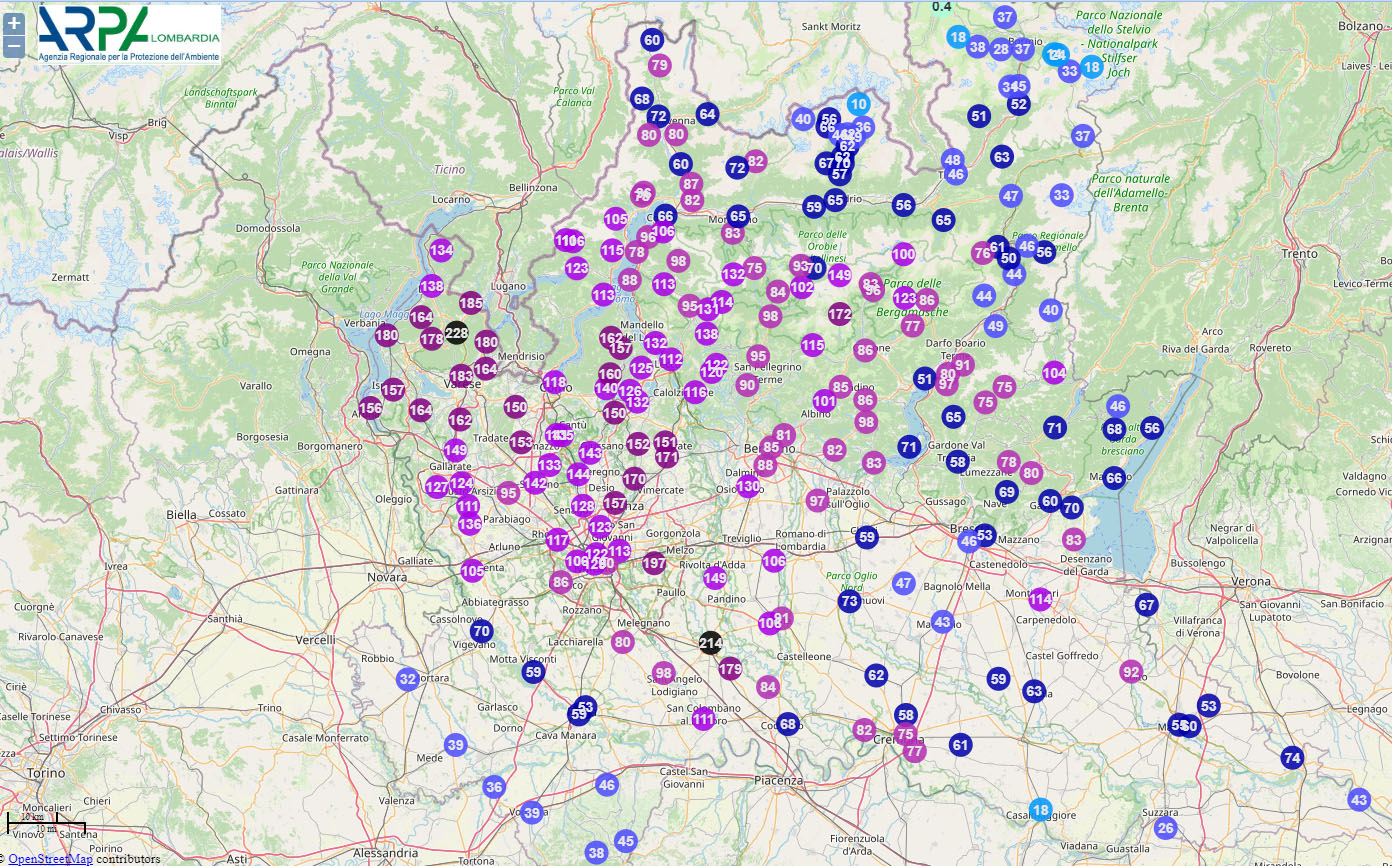
Precipitazioni totali rilevate da
ARPA Lombardia
nelle 48 ore antecedenti le h 21 del 16 maggio 2024 (intero evento).
Apporti diffusamente superiori a 100 mm dai laghi Maggiore e di Como
fino alla pianura lodigiana, massimi di 228 mm a Valganna (Varese) e
214 mm a Lodi (clicca sull'immagine per ingrandirla).
L'osservatorio centenario di Milano-Brera -
attualmente gestito da
ARPA Lombardia
tramite una stazione automatica in continuità con la lunga serie
storica avviata nel 1763 - ha rilevato 97 mm di pioggia
mercoledì 15 (h 00-24), valore molto prossimo al primato
giornaliero per maggio (98,0 mm il 24 maggio 1990), mentre è
rimasto ampiamente insuperato il record assoluto di 161,2 mm
del 18 agosto 1979 così come altri episodi tra cui quelli del
14 ottobre 1892 (155,8 mm), 24 agosto 1987 (141,6 mm) e 23 luglio 1951
(121,2 mm). Considerando tutto l'evento, dalle h 20 del 14 alle
18 del 16, il totale al pluviometro di Brera è di 135 mm.
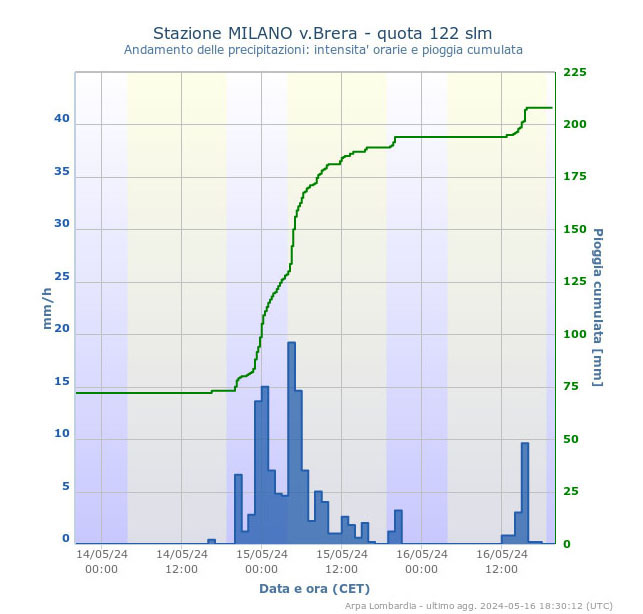
Precipitazioni orarie del periodo
14-16 maggio 2024 a Milano-Brera. La fase principale dell'evento
piovoso si è concentrata tra la tarda sera del 14 e il tardo
pomeriggio del 15, con intensità più elevate tra notte e primo
mattino, fino a 19 mm/1 h. La curva si riferisce alla cumulata dal 1°
maggio
(fonte: ARPA
Lombardia).
Con le piogge intense degli ultimi giorni,
l'osservatorio di Brera è giunto a totalizzare, dal 1° gennaio al
16 maggio 2024, ben 772 mm di precipitazioni, valore che fin da
ora - anche nell'irrealistica ipotesi che non piova ulteriormente da
qui al 31 del mese - costituisce un record per il periodo
gennaio-maggio nell'intera serie pluviometrica dal 1764, superando
di gran lunga il precedente massimo di 695,2 mm che apparteneva al
periodo gennaio-maggio 1984. Rappresenta inoltre più del
doppio della precipitazione normale per i primi cinque mesi
dell'anno, e pari a quanto dovrebbe cadere, di norma, da gennaio a
ottobre.
Nel recente episodio apporti pluviometrici ancora più consistenti si
sono registrati in località a Est e a Sud-Est del capoluogo lombardo,
tra cui:
189 mm in 23 ore di pioggia ininterrotta a Rodano, 6 km
a E-NE di Linate
(h 21 del 14 - h 20 del 15 maggio), e 197 mm in 48 ore (fino
alle h 21 del 16 maggio).
178 mm in 22 ore a Lodi (h 21 del 14 - h 19 del 15
maggio), e 214 mm in 48 ore (fino alle h 21 del 16 maggio).
Queste piogge, agendo in breve tempo su suoli peraltro
ormai saturati d'acqua dalle precipitazioni eccezionali degli
ultimi mesi, hanno determinato l'estesa crisi del reticolo
idrografico, anche con il contributo dell'accelerato deflusso
su superfici diffusamente urbanizzate nell'area metropolitana
milanese.
Importanti piene sono transitate in particolare lungo l'Olona,
il Seveso, il Lambro e il Molgora, i quali sono
straripati inondando campagne, viabilità e centri urbani con pesanti
effetti sugli abitati e sulla circolazione stradale e ferroviaria.
La vasca di laminazione del Seveso - la prima
delle quattro previste, dalla capienza di 250.000 m3 e
terminata nell'autunno 2023 al confine tra i comuni di Milano e
Bresso - è entrata in funzione all'alba del 15 maggio permettendo di
contenere la piena del fiume per alcune ore in corrispondenza
dell'inizio del tratto tombato sotto la città (via Ornato), tuttavia a
seguito del riempimento dell'invaso il corso d'acqua ha ripreso a
scorrere a piena portata, straripando nel quartiere Niguarda.
L'esondazione del fiume alla periferia Nord di Milano, causata da
un'inadeguata sezione di deflusso della tombinatura realizzata
gradualmente a partire dalla fine dell'Ottocento, avviene con elevata
frequenza, talora più volte all'anno (almeno 15 episodi tra il 2010 e
il 2021, con massimo di 6 nel piovosissimo 2014).
Nel pomeriggio del 15 maggio 2024 una serie di
violenti temporali con grandine e vento forte ha colpito le pianure dell'Emilia-Romagna
determinando allagamenti e gravi danni a edifici e colture, con apporti
d'acqua fin superiori a 50 mm in un paio d'ore nel Ravennate (Lugo,
Bagnacavallo), zona che esattamente un anno fa era alle prese con un'alluvione
di storiche proporzioni in un contesto meteorologico però del
tutto differente da quello attuale.
Fenomeni analoghi peraltro si sono rinnovati sulle stesse aree nel
pomeriggio di giovedì 16 maggio.
Pierluigi Randi, meteorologo e presidente
AMPRO,
segnala che a Bagnacavallo (Ravenna) si sono rilevati 47,8 mm il 15
maggio, e 49,0 mm il 16, per un totale di 96,8 mm che rappresenta
l'85% dell'apporto normale del bimestre aprile-maggio, e per di più
concentrato in due ore e mezza di rovesci molto intensi.
Nel pomeriggio del 16 maggio, inoltre, l'abitato di
Villa Poma (Borgo Mantovano) ha subito gravi effetti, tra cui il
sorprendente ribaltamento di numerosi vagoni di un treno merci, a
causa del probabile passaggio di un tornado.

Allagamenti nei frutteti presso
Bagnacavallo (Ravenna) dopo i nubifragi del pomeriggio del 15 maggio
2024 (f.
Condifesa Ravenna,
via
pagina FB Emilia-Romagna Meteo).

Il treno merci ribaltato dal
probabile tornado del 16 maggio 2024 a Villa Poma,
nel Mantovano (foto di Alberto Borsari, sindaco di Borgo Mantovano,
via
pagina FB Tornado in Italia).
L'altra regione che ha ricevuto precipitazioni molto
intense è il Veneto, dapprima con rovesci e temporali più forti
nelle ore centrali del 15 tra le province di Rovigo e Padova, in
intensificazione tra pomeriggio e sera in quella di Vicenza, e in
trasferimento a Est nella notte (ancora nel Padovano, poi province di
Treviso e Venezia).
In una
prima analisi dell'evento, Arpa Veneto segnala massimi apporti
di 66 mm in un'ora a Galzignano (Padova) e di ben 229 mm nell'intera
giornata del 15 maggio presso Velo d'Astico (Prealpi vicentine).
Inoltre, sulla costa, di tutto rilievo sono i 118 mm caduti a Jesolo
(Venezia) nelle 24 ore antecedenti le h 15 del 16 maggio.
Allo sviluppo di celle temporalesche rigeneranti,
accompagnate anche da intensa attività elettrica, ha probabilmente
contribuito la convergenza, nel campo dei venti in superficie,
tra lo scirocco che soffiava da Sud-Sud-Est sul Delta del Po e sul
Polesine, e il flusso nord-orientale nella pianura veneta interna.
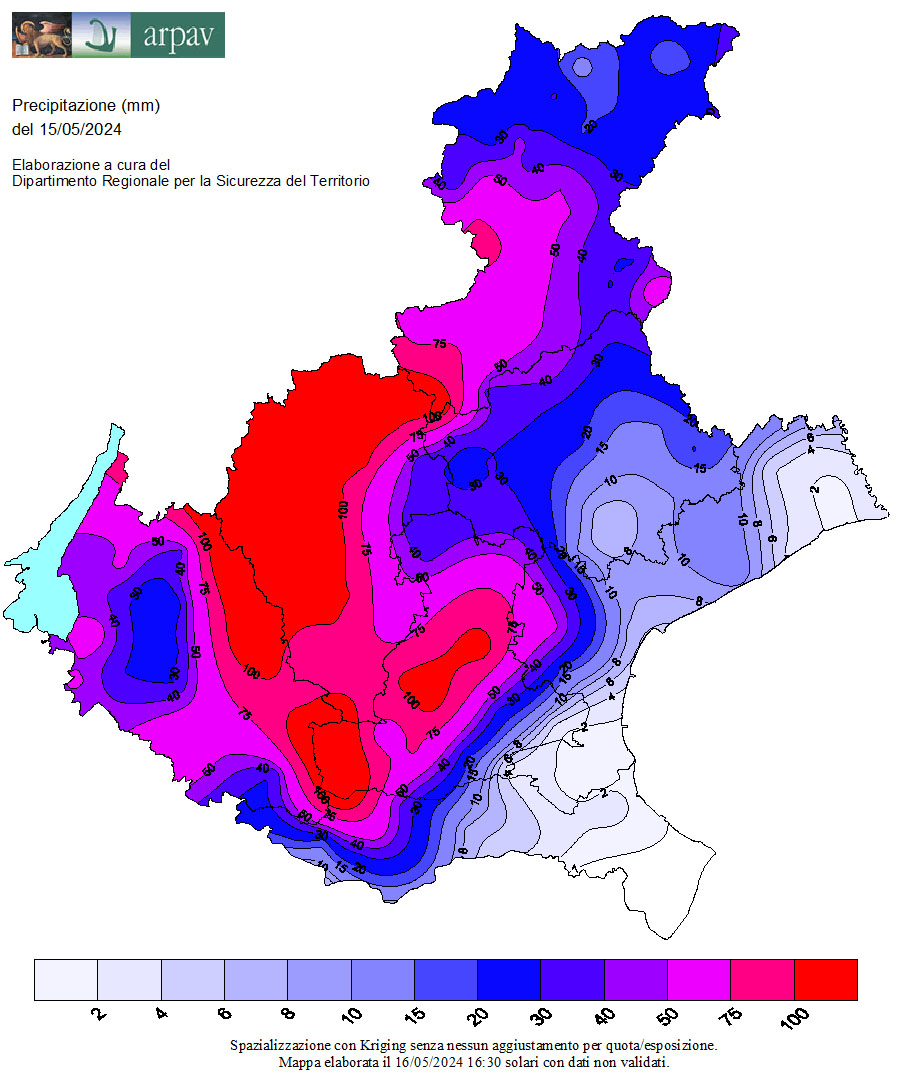
Carte delle isoiete (linee che
uniscono i punti con eguali precipitazioni)
del 15 maggio 2024 in Veneto. Vaste aree oltre 100 mm tra Padovano e
Vicentino
(fonte: ARPA
Veneto).
Anche in questo caso importanti piene si sono
propagate lungo i corsi d'acqua che traggono origine in particolare
dalle Prealpi vicentine, tra tutti il Bacchiglione, che a
Vicenza è salito di quasi cinque metri fino a un livello massimo di
6,04 m al transito del colmo di piena alle h 03 del 16 maggio (durante
l'alluvione di inizio novembre 2010 si giunse a 6,18 m).
Senza dilungarsi sui gravi effetti sul territorio (anticipati
da livelli di allerta arancione e rossa), di cui si occupano
diffusamente le cronache giornalistiche, citiamo solo le numerose
frane con interruzioni stradali nei dintorni di Schio, Recoaro e
Longare, il crollo del ponte sull'Orolo a Malo, fiume che poco a valle
è straripato con effetti rovinosi a Castelnovo di Isola Vicentina,
invadendo 400 edifici, i vasti allagamenti nella zona di Montagnana
(Padova) così come in svariate altre località di pianura tra Vicentino
e Padovano.

Vicenza: l'esondazione del
Bacchiglione nell'area del bacino di laminazione di viale Diaz (f.
Guardia di Finanza, via
"Il
Giornale di Vicenza").
La piena del fiume a Vicenza è stata più elevata delle attese poiché -
nonostante la (comunque utile e salvifica) apertura della cassa di
espansione di Caldogno (capacità di circa 4 milioni di metri cubi) -
vi è stato l'ingente contributo di piena del torrente Orolo,
tributario destro che confluisce nel Bacchiglione a valle del bacino
di Caldogno, e a monte di Vicenza. Questo affluente, gonfiato un
nubifragio localizzato e difficilmente prevedibile (60-70 mm in 45
minuti), è straripato a
Isola Vicentina e Costabissara, contribuendo al mantenimento di
portate e livelli molto elevati lungo il Bacchiglione a ridosso del
capoluogo.
Inoltre un'alluvione-lampo ha colpito l'area
pedemontana alle falde del Monte Grappa, intorno ad Asolo e
Castelfranco Veneto, tra sera e notte di giovedì 16 maggio, a
seguito di un nubifragio autorigenerante che ha scaricato fino a 134
mm di pioggia in due ore a Fonte (Treviso), su una stazione amatoriale
del gruppo
"Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa", determinando lo
straripamento dei torrenti Muson e Avenale. Ad Asolo, il pluviometro
Arpa Veneto ha
rilevato 100,4 mm in 3 ore.
Precipitazioni rilevanti hanno interessato altresì i
rilievi della provincia di Pordenone e in particolare le Dolomiti
Friulane, con un massimo di 168,6 mm in 48 ore tra la sera del 14
e la sera del 16 a Malga Valine (fonte:
ARPA FVG),
ma, trattandosi di bacini idrografici avvezzi a smaltire quantità di
pioggia di questa entità, gli effetti al suolo non sono stati gravosi.
Tuttavia svariati allagamenti di strade e centri abitati si sono
verificati per l'esondazione di canali e rii minori nelle pianure
del Friuli sud-occidentale, nel Pordenonese e giù fino ai dintorni
di Latisana (125,6 mm di pioggia sono caduti il 16 maggio a Gorgo,
lungo il basso corso del Tagliamento).
Al mattino del 17 si sono finalmente affermate
schiarite e le precipitazioni sono cessate pressoché ovunque, ma
restano criticità per il trasferimento delle importanti onde di
piena lungo i tratti di pianura dei fiumi veneti, tra Vicentino,
Trevigiano e Padovano.
Sorprende come al Nord Italia, dopo un
periodo estremamente secco tra il 2021 e i primi mesi del 2023, si
sia rapidamente passati a estremi pluviometrici di segno opposto,
dapprima con le gravi inondazioni di un anno fa in Emilia Romagna, poi
con le incalzanti precipitazioni talora alluvionali di fine
inverno-primavera 2024.
All'esubero di pioggia (e di neve in alta montagna) potrebbe aver
contribuito l'accresciuta disponibilità di vapore acqueo nell'aria,
dovuta sia all'evaporazione dal Mediterraneo che in queste settimane è
1-2 °C più caldo della norma stagionale, sia alla maggiore
propensione dell'aria più calda a contenere vapore, dunque acqua
precipitabile.
L'accentuata alternanza tra periodi estremamente secchi e altri troppo
umidi (situazioni denominate "whiplash", "colpi di frusta"
meteo-climatici) concorda peraltro con quanto descritto alcuni mesi fa
in
questo articolo apparso su Nature Communications, in cui si
evidenzia come il riscaldamento globale antropogenico renda più
frequenti, intense e rapide le transizioni tra estremi di
precipitazione di segno opposto.
Grazie...
... oltre a tutti gli enti citati nel testo, a
Matteo Zanetti (meteorologo del Servizio
Idro-Nivo-Meteo e Clima di
ARPA Lombardia)
per le considerazioni sulla piovosità a Milano-Brera, a Pierluigi
Randi (meteorologo e presidente
AMPRO -
Associazione Meteo Professionisti) per le notizie sui nubifragi in
Romagna, e a Marco Rabito
(meteorologo AMPRO) per i dettagli sulle dinamiche della piena del
Bacchiglione a Vicenza.
Devolvi il 5 per mille alla SMI!
Sosterrai
le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,
e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|