|
Mercoledì 3 giugno
2020 l'équipe della Società Meteorologica Italiana e dell'Ente Parco Nazionale
del Gran Paradiso - in collaborazione
con IREN Energia e nel quadro delle campagne di misura del
Comitato
Glaciologico Italiano - ha condotto i consueti rilievi di spessore e
densità del manto nevoso per la determinazione del bilancio invernale
sul ghiacciaio Ciardoney.
La stagione di
alimentazione nevosa 2019-20 è stata caratterizzata da
straordinarie nevicate
a fine autunno 2019 e in particolare nel mese di novembre (il 25
novembre il manto nevoso era già spesso 300 cm alla fronte del
ghiacciaio, massimo dell'intera stagione),
mentre da Natale fino a metà aprile 2020 ha prevalso tempo
anticiclonico e mite, con precipitazioni rare e modeste, pressoché
assenti in febbraio, quando al contrario hanno soffiato forti venti
nord-occidentali.
Le perturbazioni di fine aprile e maggio 2020 hanno riportato
alcune nevicate alla quota del ghiacciaio, ma senza determinare
accumuli consistenti.

3 giugno 2020:
l'asta nivometrica presso la stazione meteorologica sul pianoro
frontale del Ghiacciaio Ciardoney segna uno spessore nevoso totale di
135 cm, un valore modesto per il periodo, inferiore alla
media del giorno pari a 203 cm (periodo di tele-osservazione da webcam 2013-2019).
Negli ultimi 7 anni, solo nel 2015 c'era meno neve in questa stagione
(sempre il 3 giugno, 105 cm). Purtroppo per un'avaria della
connettività radio a partire dal 9 dicembre 2019 non è stato possibile
ricevere le immagini della webcam in tempo reale (oltre ai dati della
stazione meteorologica) e valutare quotidianamente l'altezza del manto
nevoso, osservato solo alla data del sopralluogo sul ghiacciaio.

Ore 8,30, Colle
Ciardoney: l'aria è calma e il sole splende
sopra al ghiacciaio e alla Grande Uja di Ciardoney, tuttavia durante i
lavori si tiene d'occhio l'orizzonte poiché è atteso a breve un rapido
aumento dell'instabilità atmosferica con sviluppo di folte nubi
cumuliformi e degenerazione temporalesca nel pomeriggio.
La maggior parte dell'alimentazione nevosa della stagione (almeno due
terzi) è dunque attribuibile al tardo autunno 2019, e data la
successiva scarsità di precipitazioni invernali-primaverili,
unita alle temperature primaverili sopra media con precoce avvio
della fusione nel mese di maggio, il giorno del sopralluogo si è
riscontrato sul ghiacciaio un manto nevoso relativamente modesto in
rapporto al periodo.
L'altezza totale della neve stagionale era compresa tra un massimo di 435 cm al Colle Ciardoney e un minimo di 280 cm in
prossimità del cambio di pendenza sul settore mediano del ghiacciaio,
mentre lungo il pendio inferiore il manto tornava un po' a crescere
(300-350 cm) grazie alla morfologia concava della superficie glaciale
che favorisce l'accumulo nevoso (azione eolica e valanghe).
Il
prelievo dei campioni nevosi lungo tutto il profilo del manto ha
rivelato densità di circa 570 kg/m3 al Colle
Ciardoney, dove abitualmente la neve è più densa e compatta (accumuli
di neve soffiata dal vento), e di circa 450 kg/m3 nel settore centrale del ghiacciaio. Quest'ultimo valore è stato
utilizzato per il calcolo degli equivalenti in acqua del manto nevoso
in tutti i punti di misura con l'eccezione del Colle Ciardoney, stante
le caratteristiche omogenee della neve lungo il pendio glaciale.
La neve era umidificata in tutto il suo spessore, ma al
sito del Colle Ciardoney conservava ancora al suo interno una
massiccia e compatta crosta di ghiaccio pressoché vitreo, dello spessore
di alcuni centimetri, a una profondità di circa 150 cm, corrispondente
con buona probabilità alla superficie del manto nevoso rimasta a lungo
esposta all'azione del vento e talora a cicli di fusione e rigelo
nelle tiepide giornate di febbraio 2020.
L’equivalente d’acqua mediato sull’intero
ghiacciaio (bilancio invernale) era di 1510 mm,
8% inferiore alla
media del periodo omogeneo 2012-2019 (1638 mm) in cui è stato
impiegato il
carotiere "Valtecne" per il prelievo dei campioni di neve.
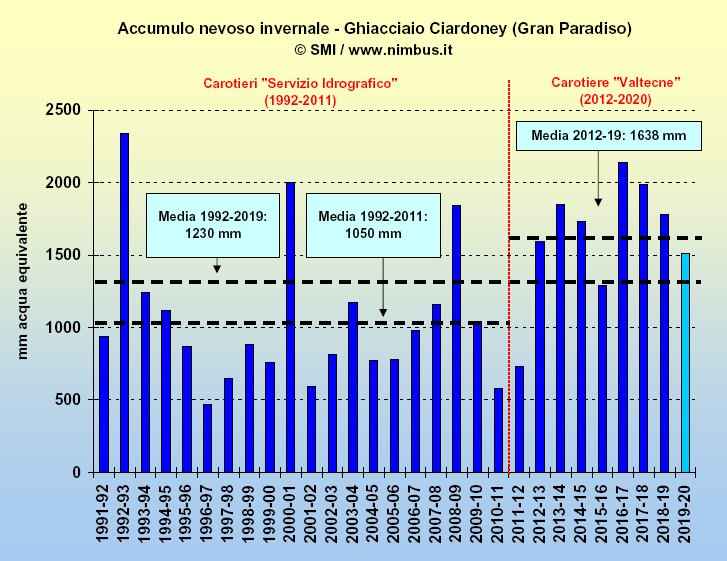
Serie degli
accumuli invernali specifici sul ghiacciaio Ciardoney, espressi in mm
di lama d’acqua equivalente, nelle stagioni idrologiche dal 1991-92 al
2019-20:
il valore di 1510 mm del 2019-20 si colloca un po' al di sotto
della media del periodo 2012-2019: l'utilizzo nel tempo di tubi carotieri con caratteristiche diverse
potrebbe aver introdotto disomogeneità nella serie degli accumuli
invernali, con possibili sottostime in alcune annate antecedenti il
2012 (anno di adozione dell'ottimo carotiere "Valtecne"),
ma non vi
sono comunque dubbi che gli accumuli nevosi di diversi inverni
recenti, segnati da importanti precipitazioni, figurino tra i più
abbondanti dal 1992, in particolare il 2016-17 e il 2017-18 (benché poi sempre vanificati dalla massiccia
fusione di stagioni estive troppo calde). Eventuali disomogeneità
nella valutazione degli accumuli invernali in ogni caso non inficiano
la stima del bilancio complessivo, che dipende dalla misura della
sporgenza dal ghiaccio delle paline ablatometriche a metà settembre.

Daniele Cat Berro
(SMI) misura lo spessore nevoso totale al Colle Ciardoney
tramite sonda da valanga: 435 cm, accumulatisi a partire dalla prima
nevicata significativa della stagione che era avvenuta il 15 ottobre
2019.

Luca Mercalli
(sinistra) e il guardaparco PNGP Stefano Cerise (a destra) estraggono
i primi campioni di manto nevoso al Colle Ciardoney, in vista della
loro pesatura.
Qui la neve è spessa 435 cm, e data la densità di 570 kg/m3,
equivale a una lama d'acqua prossima a 2470 mm.

Si smonta il tubo
carotiere per l'estrazione e la pesatura dei campioni di neve.





Nelle immagini
sopra: Luca Mercalli e i guardaparco PNGP Raffaella Miravalle e
Stefano Cerise scavano una trincea profonda circa 140 cm per poter affondare
il carotiere lungo 3 metri fino alla base del manto nevoso, che qui al
Colle Ciardoney è spesso 435 cm.
In ottemperanza alle disposizioni per
il contrasto alla pandemia di Covid-19, tutti gli operatori indossano
la mascherina anche durante la faticosa spalatura della neve ed
estrazione dei campioni.

I campioni di neve
vengono pesati tramite dinamometro, che ha restituito valori in buon
accordo con quelli ottenuti tramite bilancia tradizionale (differenze
dell'ordine del 4%).

Ore 11: si giunge alla stazione
meteorologica sul pianoro frontale del ghiacciaio.
Gli strumenti sono operativi ma l'assenza della connettività
radio/internet per la perdita di verticalità dell'antenna (danno da
vento e neve a tiranti e traliccio) non consente la trasmissione di
dati e immagini webcam in tempo reale. Si conta di ripristinare la
connessione con un successivo intervento a metà estate, non appena la
coltre nevosa sarà scomparsa.

Dettaglio della
base del traliccio che sostiene la stazione meteorologica: il tubolare
a destra (Nord-Ovest), già oggetto di una riparazione nell'estate
2019, si è nuovamente rotto a pochi decimetri dal suolo per probabile
effetto combinato della pressione della densa neve autunnale sui
tiranti di controventatura, e di violente raffiche di vento.
Il traliccio ha perso così la verticalità, quanto basta per
compromettere l'allineamento dell'antenna con il ponte radio della
borgata Tiglietto (Val Soana) e dunque la connettività internet.
Installazioni come questa, in ambienti estremi ad alta quota,
necessitano di continue manutenzioni e riparazioni per essere
mantenute in efficienza.
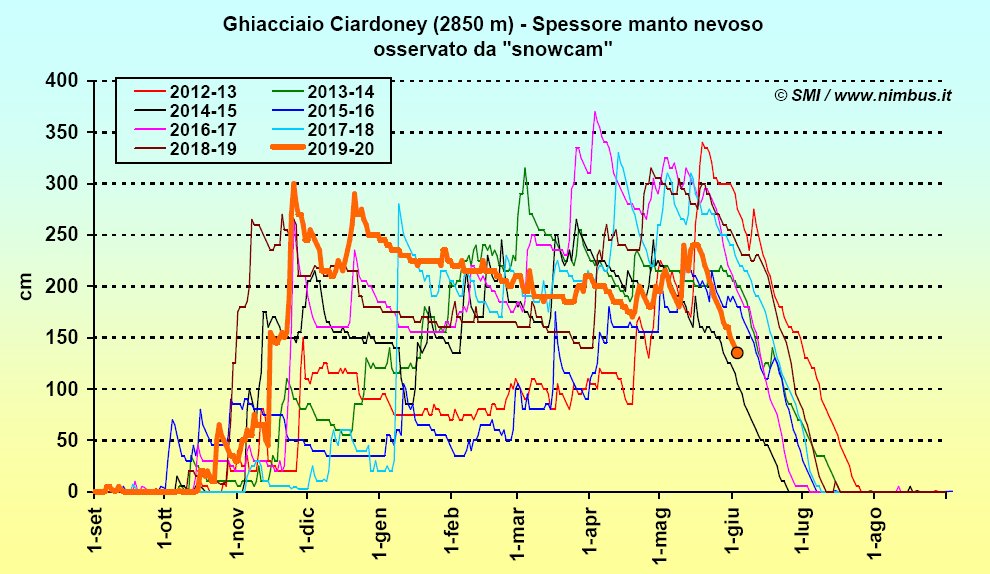
Nonostante l'avaria
della trasmissione delle immagini webcam tramite cui viene
tele-osservata l'altezza neve, è stato possibile ricostruire con
ragionevole affidabilità i dati dal 9 dicembre 2019 in poi tramite
confronti con precipitazioni e spessore nevoso registrati in stazioni
limitrofe (Forzo, Lago Valsoera), e tenendo presenti osservazioni
dirette eseguite il 23 febbraio (205 cm) e il 3 giugno 2020 (135 cm).
Ecco dunque l'andamento giornaliero nell'inverno 2019-20 (linea
arancione spessa) e nelle sette stagioni precedenti (linee sottili).
Si nota la formazione di un potente manto nevoso con le intense
perturbazioni di novembre 2019, in particolare quella che nella terza
decade ha causato
diffusi danni alluvionali al Nord-Ovest italiano (300 cm totali al
suolo il 25 novembre, massimo per il periodo nella pur breve serie di
osservazione, e massimo dell'intera stagione 2019-20). Ulteriore
copiosa nevicata il 16-20 dicembre, dopodiché il periodo da Natale a
metà aprile è stato in prevalenza anticiclonico e asciutto, con poche
e modeste nevicate, per cui lo spessore del manto nevoso è lentamente
diminuito.
Con le perturbazioni primaverili intervenute tra il 19 aprile e la
metà di maggio la coltre nevosa è tornata a crescere, ma in maniera
meno evidente del solito (unico episodio significativo tra il 10 e
l'11 maggio 2020, con 50 cm di neve fresca in meno di 24 ore), e senza
superare il massimo di fine novembre.
Il pallino arancione indica i 135 cm osservati durante il sopralluogo
del 3 giugno: un valore modesto, poco superiore al minimo del 2015 a
questa data (105 cm).

Ore 12: il recupero di personale e
attrezzature da parte della ditta di elitrasporti
Airgreen, in
tempo prima del rapido peggioramento pomeridiano. Folti cumuli
ingombrano il cielo, ma schiarite permettono ancora il volo
dell'elicottero.


Durante il rientro verso il fondovalle
dell'Orco, si sorvola il ghiacciaio Ciardoney: veduta generale a valle
della fronte (immagine in alto) e ripresa del settore superiore e del
Colle Ciardoney (immagine qui sopra).

Veduta dall'elicottero del Vallone di
Valsoera (ripresa in direzione Sud, verso la Valle Orco), con
l'omonima diga a quota 2400 m. Situazione inconsueta, l'invaso
artificiale è già completamente privo di ghiaccio, a causa delle
elevate temperature primaverili
(circa 1 °C sopra media nel trimestre marzo-maggio 2020 al Nord-Ovest
italiano).
Devolvi il 5 per mille alla SMI,
sosterrai le ricerche sul Ghiacciaio Ciardoney!

|