|

Il borgo di Cima
Sappada (UD), sull'omonimo valico a 1292 m tra Carnia e Cadore,
sepolto da circa 2 metri di neve l'8 gennaio 2021
(ripresa da drone di Carlo Bregant).
La straordinaria quantità di neve su Alpi
e Appennini è stata il tratto meteo-climatico distintivo del periodo
natalizio 2020-21.
Dopo un autunno 2020 per lo più
anticiclonico e secco a scala nazionale (deficit
pluviometrico del 20% circa secondo il CNR-ISAC), nonostante le
alluvioni del
2-3 ottobre al Nord-Ovest e del 28 novembre in Sardegna, la
situazione è radicalmente cambiata con l'avvio dell'inverno
meteorologico.
Da inizio dicembre 2020 infatti vaste e
profonde depressioni nord-atlantiche si susseguono sull'Europa,
condizionando il tempo anche in Italia con ripetuti episodi di
libeccio che hanno determinato ingenti precipitazioni
soprattutto sulle Alpi centro-orientali, sull'Appennino Tosco-Emiliano
e giù lungo tutto il versante tirrenico, zone soggette allo
sbarramento orografico dei flussi umidi mediamente sud-occidentali.
Più asciutti invece i versanti adriatici e ionici, nonché il Piemonte
occidentale, sottovento ai
rilievi.
Memorabili in particolare i diluvi del 4-6 dicembre 2020 al Nord-Est,
con massimo di 786 mm in 60 ore a Barcis (Dolomiti Friulane),
grandi nevicate sopra i 1500 m, importanti dissesti, black-out e
interruzioni stradali e ferroviarie.
Nel periodo tra Natale e l'Epifania, poi,
gli episodi perturbati sono avvenuti nel contesto di una
configurazione depressionaria piuttosto fredda e persistente a scala
europea, che ha favorito cadute di neve
abbondanti e quasi quotidiane talora fino a bassa quota in
particolare il
28 dicembre 2020 e tra l'1 e il 6 gennaio 2021.


La situazione di
inizio gennaio 2021 presso il Passo delle Radici (1527 m, Appennino
Tosco-Emiliano tra le province di Luca e Modena). Il manto nevoso è
spesso tra 2 e 2,5 m (f. Fabrizio Bertagni, via
pagina FB Rete Meteo Amatori).
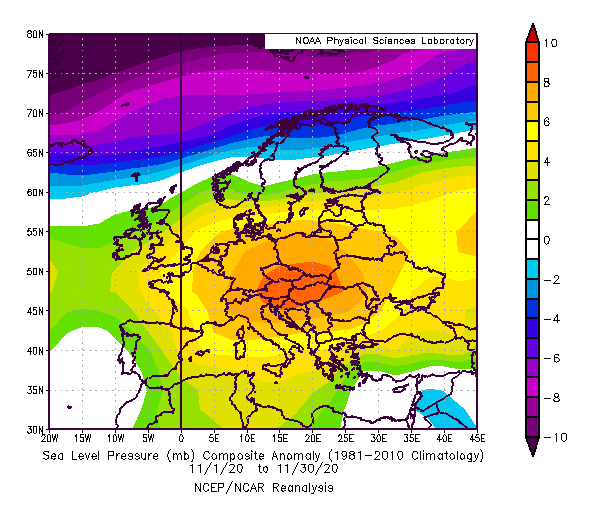 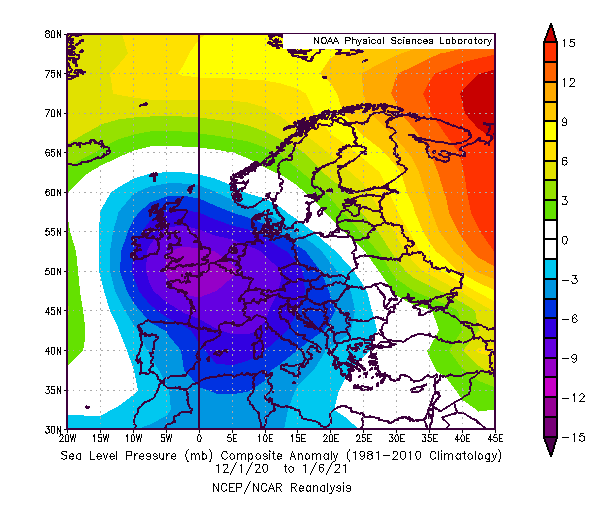
Confronto tra le
anomalie di pressione atmosferica al livello del mare nel novembre
2020 (sinistra) e nel periodo 1° dicembre 2020 - 6 gennaio 2021
(destra): a una
fase ostinatamente anticiclonica e secca, identificata dai colori
giallo-arancio, è seguita un'anomalia opposta, con depressioni più
profonde e insistenti del solito sull'Europa centro-occidentale, in colori blu-viola. Con questo genere di configurazioni
l'Italia rimane soggetta a ripetuti apporti di aria umida meridionale
(libeccio, scirocco) che determinano importanti precipitazioni sul
versante sudalpino e sull'arco ligure-tirrenico (Fonte:
ESRL-NOAA;
clicca sulle immagini per ingrandire).
Due sono state le principali fasi perturbate, nella
prima decade di dicembre e tra Natale 2020 e l'Epifania 2021,
intervallate tra il 10 e il 23 dicembre da un periodo più stabile,
asciutto e mite, benché spesso grigio per nubi basse e nebbie sulle
pianure.
Proprio a ridosso del Solstizio d'Inverno, il 23 dicembre l'apporto di
aria subtropicale ha fatto salire l'isoterma 0 °C alle quote di 3058 m
e 3176 m rispettivamente al di sopra degli aeroporti di Milano-Linate e di
Cuneo-Levaldigi, poco prima dell'improvvisa irruzione fredda da Nord
di Natale e Santo Stefano che ha riportato le temperature nella norma
invernale, temporaneamente al di sotto, soprattutto nelle stazioni di
montagna.
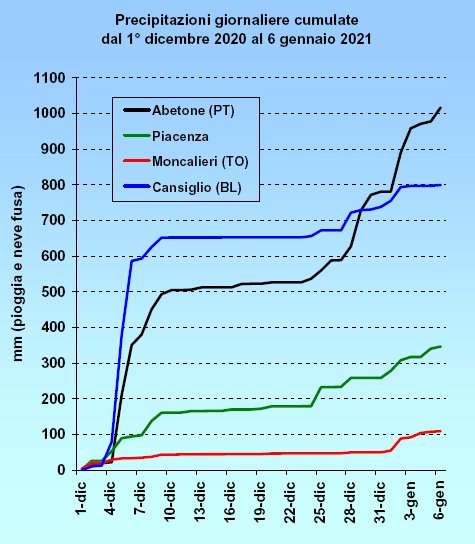
Precipitazioni
giornaliere cumulate in alcune località del Nord Italia
tra il 1° dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021. Gli apporti più esorbitanti
hanno interessato le zone più soggette allo sbarramento orografico da
libeccio, ovvero le Prealpi orientali e i rilievi apuani e quelli
appenninici di confine
tra Toscana ed Emilia, mentre la pianura occidentale del Piemonte
(Moncalieri),
sottovento alle Alpi con i flussi tra Sud e Sud-Ovest,
ha ricevuto apporti ben più modesti.
DICEMBRE 2020: RECORD DI
PRECIPITAZIONI, NUVOLOSITA'
E SCARSO SOLEGGIAMENTO
La ricorrenza e l'intensità dei flussi
umidi meridionali nel dicembre 2020 hanno determinato in molte
località dei record mensili sia di abbondanza di precipitazioni (cui
hanno contribuito in particolare i notevolissimi apporti della prima
decade), sia di nuvolosità e di scarsità di soleggiamento.
Ecco alcuni record storici di precipitazioni decembrine, che
talora superano di gran lunga i primati precedenti:
996,2 mm a
Barcis (PN)
(serie dal 1924, precedente 629,0 mm nel dicembre 2010);
406 mm a
Lavarone (TN)
(serie dal 1921, precedente 321 mm nel dicembre 1959);
394,8 mm a
Tarvisio (UD)
(serie dal 1922, precedente 351,1 mm nel dicembre 1960);
374,8 mm ad
Asiago (VI)
(serie dal 1950, precedente 281,0 mm nel dicembre 2008);
312,4 mm a
Cortina d'Ampezzo
(BL)
(serie dal 1950, precedente 214,0 mm nel dicembre 1960);
304 mm a
Predazzo (TN)
(serie dal 1895, precedente 176 mm nel dicembre 1958);
289 mm a
San
Martino di Castrozza (TN)
(serie dal 1895, precedente 245 mm nel dicembre 1922);
271,2 mm a Parma-Piazzale S.
Croce
(serie dal 1878, precedente 197,4 mm nel dicembre 1959; inoltre, sesto
mese più ricco di precipitazioni in assoluto);
258,2 mm a Piacenza-Alberoni
(serie dal 1871, precedente 176,6 mm nel dicembre 1996; anche qui sesto
mese più ricco di precipitazioni in assoluto).
In Toscana, inoltre, dicembre 2020 è stato il
più ricco di precipitazioni nella serie regionalizzata dal 1955 (comunicato
LAMMA), con apporti totali superiori a 300 mm a Massa, Carrara,
Lucca e Livorno, nonché 1,1 °C più tiepido del normale.
Si tratta, dal Nord-Est alla Toscana, di valori pari a circa 4 - 6
volte la media di dicembre!

Il Bacchiglione in
piena al ponte di Montegalda (VI) alle ore 11 del 6 dicembre
2020, ingrossato dalle grandi piogge sulle Prealpi Vicentine, 424 mm
in tre giorni a Castana (f. Milos Lago).
Essendo dicembre già di per sé il mese
meno illuminato dell'anno per ragioni astronomiche, in presenza di
frequente nuvolosità le durate del soleggiamento e la radiazione
solare globale
registrate nel dicembre 2020 rappresentano anche dei minimi assoluti per qualunque
mese dell'anno in alcune località.
Pontremoli
(MS), stazione toscana rappresentativa delle zone in cui - nei
periodi a prevalenza di libeccio - la nuvolosità indugia più a lungo:
appena 44 ore soleggiate nel mese (eliofania assoluta), 45% del normale
decembrino e solo il 16% di quanto sarebbe possibile con cielo
ipoteticamente sempre sereno (eliofania relativa); 21 i giorni
coperti, 8 quelli in parte nuvolosi e solo 2 i sereni (13 e 14
dicembre).
Il precedente record di mese in assoluto meno soleggiato (serie dal
1994) risaliva peraltro al recente novembre 2019 (50 ore).
Inoltre, nuvolosità media mensile pari a 7,9 decimi, la più
elevata per i mesi di dicembre dal 1976 (precedenti primati 7,7
decimi nel 1978 e 2002).
Moncalieri (TO): 45,9 MJ/m2 di radiazione
solare globale cumulata nel mese, minimo nella serie dal 2002 non solo
per dicembre, ma per qualunque mese dell'anno, sebbene poco sotto i
precedenti casi di dicembre 2009 (97,5 MJ/m2) e dicembre
2014 (98,8 MJ/m2).
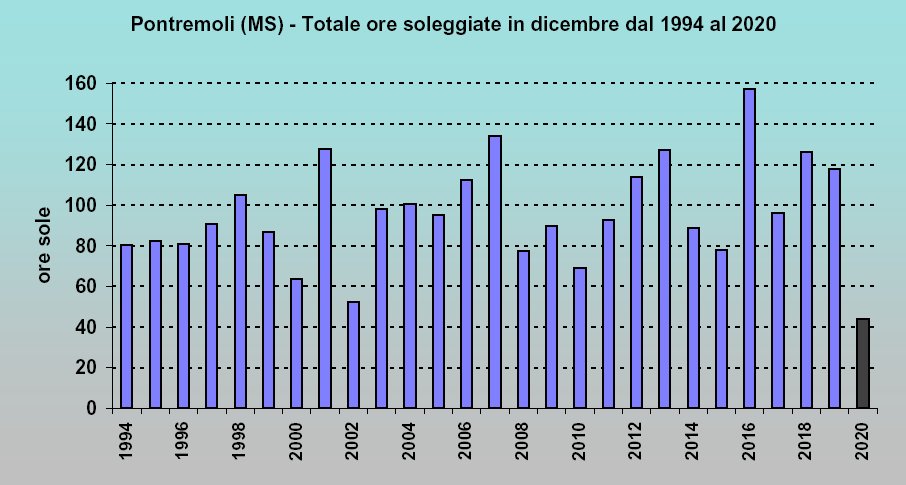
Serie delle ore di
sole totalizzate in dicembre dal 1994 al 2020 a Pontremoli,
con il caso recente meno soleggiato di tutti.
SPESSORI DI NEVE RARI A VEDERSI SULLE
ALPI CENTRO-ORIENTALI
E SULL'APPENNINO SETTENTRIONALE
Durante le festività natalizie 2020-21 la
temporanea combinazione tra copiose
precipitazioni e la circolazione di aria
fredda sull'Europa (sul Nord Italia isoterme oscillanti tra 0 °C e -5
°C al livello di 850 hPa, circa 1300-1400 m) si è tradotta in nevicate abbondanti e
frequenti
anche a bassa quota, soprattutto sulle Alpi centro-orientali e
l'Appennino centro-settentrionale, aggiungendosi al manto nevoso
rimasto da inizio dicembre alle quote oltre i 1500 m.
In alcuni casi la neve si è spinta fin sui fondovalle e sulle
pianure, soprattutto il 28 dicembre al Nord, ma anche l'1, 2 e 6
gennaio in Val d'Adige, l'1, 2 e 5 gennaio sul basso Piemonte, e il 6
gennaio in alta Toscana (es. periferia Nord di Pistoia).
Fino a Capodanno i rilievi tra Monviso,
Torinese e bassa Val d'Aosta erano rimasti scarsamente innevati per la
posizione sottovento rispetto ai flussi umidi da SW (il 31 dicembre
2020, spessori al suolo di appena 10-40 cm a 2000 m, rispetto ai 2 m e
oltre delle Alpi centro-orientali e Appennino settentrionale alla
stessa quota), poi il lungo episodio
perturbato di inizio gennaio, legato alla depressione "Lisa" intorno
al Golfo Ligure ha finalmente deposto nevicate abbondanti anche in
quella zona grazie alla rotazione da E-SE dei venti alle quote
medio-basse della troposfera, e al conseguente instaurarsi di una
situazione di sbarramento.
A Balme (a 1450 m nella Val d'Ala di Lanzo, tra le zone più
interessate dalle nevicate di inizio anno) si è passati da uno
spessore di appena 10 cm al mattino del 1° gennaio, a 115 cm al
mattino del 5 gennaio 2021.
Ai 1311 m del Colle del Lys, tra Val di Viù e bassa Val Susa,
103 cm di neve fresca sono caduti nelle sole 24 ore tra il mattino del
2 e il mattino del 3 gennaio, con somma di circa 160 cm tra il 2 e il
5 gennaio, e manto totale al suolo, via via compattatosi, di poco
superiore al metro a fine nevicata.
11_LucaMercalli.jpg)
6_LucaMercalli.jpg)
Due immagini riprese al Col del Lys
(1311 m, tra Val di Viù e bassa Val Susa - TO) al ritorno del sereno
al mattino del 6 gennaio 2021, dopo l'intensa nevicata dei giorni dal
2 al 5 (somma neve fresca circa 160 cm). Si è trattato del primo
episodio nevoso rilevante dell'inverno 2020-21 in questa zona, rimasta
sottovento alle Alpi occidentali durante gli eventi precedenti di
inizio dicembre 2020. Nevicate ancora più importanti si ebbero
tuttavia negli ultimi anni, ad esempio a metà febbraio 2002 e metà
dicembre 2008 (f. Luca Mercalli).
In zona montana, tra il 3 e il 7 gennaio 2021, sul finire della lunga
fase perturbata, si misuravano i seguenti spessori massimi di neve
al suolo:
sotto i 1000 m
16 cm ad Aosta-aeroporto
(545 m)
82 cm a Priero (610 m, Langa cebana - CN),
notevole, tuttavia inferiore ai casi del dicembre 2008 (116 cm il 15),
febbraio 2004 (98 cm il 22), gennaio 2006 (89 cm il 29), nella breve
serie dal 1993
88 cm al Passo del Brattello (955 m, Appennino Tosco-Emiliano - MS)
117 cm a Tarvisio (708 m, Alpi Giulie - UD)
tra
1000 e 1500 m
51 cm a
Bardonecchia (1353 m, Val
Susa - TO), superiore alla media di inizio gennaio (circa 25 cm) ma di
gran lunga inferiore ai massimi storici del periodo (125 cm il 4
gennaio 1997) e assoluti (170 cm il 13 febbraio 1960) nella serie dal
1926
113 cm ad Alagna Valsesia (1347 m, VC),
ben sotto il massimo assoluto di 230 cm del 3 febbraio 1986 (serie dal
1952)
115 cm a Balme (1450 m, Valli di Lanzo - TO)
120 cm al Colle del Melogno (1028 m, Alpi Liguri - SV)
126 cm a Macugnaga-Pecetto (1360 m, Ossola - VB),
anche qui decisamente inferiore ai 230 cm del 3 febbraio 1986 (serie
dal 1984)
143 cm a San Martino di Castrozza (1470 m, Primiero - TN)
160 cm a Lagdei (1252 m, Appennino Tosco-Emiliano - PR)
162 cm a Terme di Valdieri (1390 m, Alpi Marittime - CN),
inferiore al primato di 268 cm del 6 marzo 2009 (serie dal 1999)
177 cm al Passo di M. Croce Carnico (1362 m, Alpi Carniche - UD)
183 cm al Passo Predil (1130 m, Alpi Giulie - UD)
192 cm al Passo Pradarena (1164 m, Appennino Tosco-Emiliano - RE)
275 cm all'Abetone (1340 m, Appennino Tosco-Emiliano, PT)
tra 1500 e 2000 m
46 cm a
Rhêmes-Notre Dame (1690 m, AO)
94 cm al Monte Grappa (1540, Prealpi Venete - VI)
100 cm a Campodolcino-Alpe Motta (1880 m, Valle Spluga - SO)
110 cm a
Gressoney-D'Ejola (1850 m, Monte Rosa - AO),
lontano sia dal massimo di inizio gennaio (165 cm il 3 gennaio 1972),
sia da quello assoluto (325 cm 12 febbraio 1978), serie dal 1939
149 cm al
Monte Amiata (1700 m, SI)
162 cm all'Alpe Veglia (1740 m, Ossola)
167 cm all'Aprica (1950 m, Valtellina/Val Camonica)
170 cm al P.so M. Croce di Comelico (1627 m, Dolomiti - BL)
183 cm a Valbondione (1784 m, Val Seriana - BG)
187 cm a Misurina (1759 m, Dolomiti - BL)
189 cm al Lago della Ninfa (1550 m, Appennino Tosco-Emiliano - MO)
192 cm ai Piani di Bobbio (1713 m, Valsassina - LC)
202 cm al Passo del Tonale (1875 m, Adamello - TN)
235 cm al Monte Lussari (1750 m, Alpi Giulie - UD)
243 cm al Col dei Baldi (1913 m, Dolomiti - BL)
413 cm al Rifugio Gilberti (1850 m, Prealpi Giulie - UD),
massimo per inizio gennaio nella serie dal 1972.
oltre i 2000 m
34 cm al
Lago Moncenisio (2000 m, Val Susa);
stazione meno innevata delle Alpi a questa quota (vedi commento nella
didascalia sotto).
99 cm a Sestriere (2020 m, Val Susa/Chisone),
superiore al normale per inizio gennaio (circa 65 cm) ma inferiore ai
massimi del periodo (162 cm il 4 gennaio 1997) e assoluti (196 cm il
13 aprile 2018), serie dal 1996
139 cm a Lanzada-Palù (2151 m, Val Malenco, SO)
148 cm all'Alpe di Siusi-Zallinger (2055 m, Val Gardena - BZ)
160 cm al Lago Pantano d'Avio (2108 m, Val Camonica - BS)
184 cm al Passo del Moro (2820 m, Ossola - VB)
184 cm a Livigno-La Vallaccia (2660 m, Alpi Retiche - SO)
234 cm al Passo Rolle (2012 m, Pale di San Martino - TN)
303 cm alla Capanna Presena (2715 m, Adamello - TN)
Per quanto riguarda gli apporti di
neve fresca totale, provvederemo prossimamente alla raccolta più
sistematica di dati e al confronto con i valori storici precedenti, ma
intanto, tra le quantità più impressionanti segnaliamo i 577 cm
(somma delle singole nevicate, via via soggette ad assestamento e
parziale fusione) misurati dal 1° dicembre 2020
al 6 gennaio 2021 al Rifugio Segheria, a 1410 m sull'Appennino
Reggiano.
Aggiornamento al 15 gennaio 2021: al Rif. Segheria totale
neve fresca 614 cm, di cui 15 cm caduti a novembre, 426 a
dicembre e 173 a gennaio; spessore massimo al suolo 240 cm il
10 gennaio; inoltre, in località Presa Alta di Ligonchio, a 1220 m in
comune di Ventasso - RE, totale di 421 cm, e 170 cm di spessore
massimo al suolo sempre il 10 gennaio 2021; fonte: Associazione
Centro Meteo Emilia-Romagna).

Il Rifugio Segheria dell'Abetina
Reale (1410 m, Villa Minozzo - RE), sommerso da un manto nevoso
prossimo a due
metri e mezzo, l'8 gennaio 2021 (autore sconosciuto, da
pagina FB Rete Meteo Amatori).

Immagine della
snowcam del Lago Moncenisio (2000 m, alta Val Susa), pomeriggio
del 9 gennaio 2021. Dopo aver raggiunto un massimo spessore all'asta
nivometrica di 34 cm il 4 gennaio (già modestissimo), la neve al suolo
si è ulteriormente ridotta a soli 15 cm per effetto dell'erosione
eolica. Si tratta di valori di gran lunga inferiori al normale per il
periodo (circa 55 cm), mentre i massimi di inizio gennaio spettano al
1977 (245 cm). Dunque, nonostante l'arrivo di nevicate nei primi
giorni del 2021, questa zona sul confine italo-francese continua a
rimanere la meno innevata di tutte le Alpi a parità di quota.
L'apparecchio è stato installato nell'autunno 2015 grazie a una
collaborazione tra SMI,
CSP Innovazione nelle ICT ed EDF, e permette di mantenere la serie
di innevamento avviata nel 1939, a rischio interruzione a causa della
recente soppressione della guardiania continua alla diga.
Data la situazione, il pericolo di
valanghe nei giorni tra Capodanno e l'Epifania si è portato
diffusamente al livello 4 (forte) sulla
scala europea (consulta i bollettini aggiornati per Alpi e
Appennini sul sito
AINEVA, Associazione Interregionale Neve e Valanghe).
Numerose valanghe spontanee di medie e grandi dimensioni si sono
staccate qua e là con interruzione o chiusura precauzionale di
decine di strade da un capo all'altro delle Alpi. Un distacco ha
ucciso due scialpinisti il 3 gennaio in Val Senales.
ARPA Veneto segnala, in un
comunicato del 4 gennaio, che sui rilievi della regione si tratta
di un inizio
inverno tra i più nevosi da almeno 15 anni,
somigliando ai casi eccezionali (questi a scala pluridecennale) delle
stagioni 2008-09 e 2013-14.
Dopo la nevicata del 28 dicembre 2020 (50
cm), e con le successive riprese, il fondovalle di Trento è
rimasto copiosamente innevato, e lo è tuttora (17 cm al suolo al
mattino del 9 gennaio, fonte
Meteotrentino),
mostrando una persistenza del manto ormai infrequente a bassa quota in
questi tempi di riscaldamento
globale.
Analoga situazione su diversi fondovalle delle Prealpi Venete,
come mostra questa
analisi del socio SMI Davide Rosa, basata su immagini del
satellite Sentinel-2.
Invece su gran parte della pianura padano-veneta, dopo
la forte nevicata del 28 dicembre 2020, a inizio gennaio 2021 ha
prevalso la pioggia per effetto del flusso meridionale relativamente
dolce.
A Piacenza-Collegio Alberoni, ad esempio, i 29 cm di neve fresca
caduti il giorno 28 sono scomparsi completamente entro il 3 gennaio
2021.

Asiago (1000 m, Prealpi
Vicentine), circa un metro di neve al suolo il
1° gennaio 2021 (da
pagina fb Associazione Meteotriveneto).

A Falcade (1130 m, zona
Marmolada - BL) il manto totale si avvicina al metro e mezzo dopo gli
85 cm di neve fresca caduti in circa 48 ore tra
l'1 e il 3 gennaio 2021 (da
pagina fb Associazione Meteotriveneto).

L'Abetone
(1340 m, valico appenninico tra le province di Pistoia e Modena) il
7 gennaio 2021, quando viene rilevato il massimo spessore nevoso al
suolo di 275 cm: è questa la zona interessata dalle nevicate più
esorbitanti a quote inferiori a 1500 m
(immagine webcam da
Paesaggi
Digitali).
_viaMaurizioRatti.jpg)
Il 3 gennaio 2021 oltre 2 metri di manto
coprono anche la zona del Lago Ballano (Appennino Parmense, 1341 m;
autore sconosciuto).
A destra si nota la stazione meteorologica automatica ARPA
Emilia-Romagna che nonostante tutto emerge ancora dalla neve,
mantenendo così l'affidabilità delle misure (dati
qui).


Qui sopra, due immagini del
fiabesco ambiente innevato il 2 gennaio 2021 nei dintorni del Lago
Calamone, a 1403 m nell'Appennino Reggiano
(f. Rosanna Bandieri).

Spettacolari formazioni di calabrosa
in vetta al Corno alle Scale (1945 m, Appennino Tosco-Emiliano) l'8
gennaio 2021, al ritorno del sereno dopo una settimana ininterrotta di
nebbia, gelo e nevicate con vento da Sud-Ovest (f. Gabriele Obino, da
pagina FB Rete Meteo Amatori).
_viaMaurizioRatti.jpg)
Villaggio Aracci di Zeri, a
1200 m in alta Lunigiana (MS): a Capodanno 2021 circa 70 cm di neve
fresca si aggiungono al metro e più già presente, e nei giorni
successivi il manto totale al suolo, eccezionale, supererà i 2,5 metri (autore
sconosciuto).

Innevamento fuori dal comune
anche sull'alto Piemonte, zona ben esposta allo sbarramento dei venti
umidi da Sud, dove le nevicate di inizio gennaio 2021 si sono aggiunte
allo strato nevoso già presente dopo le precipitazioni di inizio
dicembre 2020. Qui la frazione San Gottardo di Rimella (1329 m, Val
Sesia - VC) con quasi 2 metri di neve totale il 5 gennaio (f. Umberto
Scattlini, da
pagina FB Valsesia). Diverse le strade precauzionalmente chiuse
per pericolo di valanghe nella zona.

Il pluviometro
manuale di Balme (1450 m, Valli di Lanzo - TO), attentamente
sorvegliato dal Socio SMI e sindaco del paese Gianni Castagneri,
permette di proseguire una preziosa serie di misura pluvio-nivometrica
attiva dal 1913. Qui lo vediamo sotto le prime schiarite al mattino
del 6 gennaio 2021, con uno spessore nevoso di 107 cm. Il massimo si
era toccato il giorno precedente con 115 cm a seguito dell'intensa
nevicata iniziata la sera del 1° gennaio.
Non è una situazione eccezionale (massimo storico di spessore per la
prima decade di gennaio: 238 cm il 6 gennaio 1974), ma si è comunque
trattato della nevicata più intensa nel periodo natalizio dal 1999,
quando il 1° gennaio si rilevarono 64 cm di neve fresca in 24 ore (f.
G. Castagneri).

Un'altra immagine di Balme sotto la fitta
nevicata nel pomeriggio del
2 gennaio 2021. Al mattino del 3 gennaio l'asta nivometrica indicherà
uno spessore di 85 cm, incrementato di 57 cm rispetto a 24 ore prima
(f. Andrea Vuolo).
_LuigiSchiara.jpg)
Il paese di
Salbertrand (1032 m, Val Susa), con uno strato di neve di 70 cm il 4
gennaio 2021. La media Val Susa tra Chiomonte e Salbertrand è soggetta
a efficaci precipitazioni da sbarramento quando, come in questo caso,
i venti al suolo si orientano da Est, mentre più a monte (Oulx, Cesana,
Bardonecchia) gli apporti si riducono sensibilmente (xericità
intralpina), e la nevicata di inizio gennaio 2021 ha deposto non più
di 30-40 cm di neve fresca (f. Luigi Schiara).

Il
Monte Bignone (1299 m, Alpi Liguri) ripreso da Sanremo al mattino del
5 gennaio 2021, con neve al suolo a partire dai 600 m circa,
situazione con ricorrenza media dell'ordine di 3-5 anni (f. Lorenzo
Bagnoli).
A ridosso della Riviera di Ponente, protetta alle spalle dai venti
settentrionali dai massicci delle Alpi Liguri che superano
talvolta i 2000 m, la neve si fa vedere con una certa rarità, a
differenza dei tratti intorno a Savona e Genova, dove il "travaso" di
aria fredda padana attraverso i bassi valichi del Cadibona, del
Turchino e dei Giovi genera spruzzate di neve fin sulla costa
pressoché ogni inverno (a Savona circa 5 cm il 28 dicembre 2020).

Particolare
veduta della Lanterna di Genova l'8 gennaio 2021, sullo sfondo
dell'entroterra innevato fino a quote collinari (f. Roberto Orlando).

Tra
gli episodi di instabilità del periodo vanno annoverati i ricorrenti
rovesci e temporali tra Istria e Carso, con imbiancate di graupel (o
"neve tonda", chicchi di ghiaccio opaco e morbido, ricorrente nei
fronti freddi di fine inverno o primavera). Qui sopra, un bel
dettaglio del graupel caduto il mattino dell'Epifania a Pesek (TS),
nel Carso meridionale al confine con la Slovenia. La genesi del
fenomeno è spiegata in
questo articolo di Renato R. Colucci, autore della foto, sul sito
della Società
Meteorologica Alpino-Adriatica.
PERIODO NATALIZIO FREDDO SOLO A
CONFRONTO
CON L'ULTIMO DECENNIO TROPPO CALDO
Dopo i tepori anomali dei giorni intorno al Solstizio
(il 22-23 dicembre l'isoterma 0 °C era a oltre 3000 m sulle Alpi),
ordinarie condizioni invernali si sono instaurate con l'irruzione fredda da Nord
di Natale e Santo Stefano (Tmin
-20,4 °C il 27 dicembre ad Asiago-aeroporto, valore che nella gelida località
dell'Altipiano dei Sette Comuni si registra ogni tre anni circa).
Temperature insolitamente basse, ma ancora lontane dai record del
passato, si sono misurate solo
nei fondovalle innevati e soggetti a schiarite notturne dopo le
copiose nevicate del 28 dicembre 2020 e di inizio gennaio 2021.

26 dicembre 2020: venti da
Nord entrano sotto forma di bora con raffiche a 100 km/h nel
Triestino, e invadono l'Italia portando il primo significativo
episodio invernale della stagione 2020-21. Qui, ripreso dal Carso, il
"muro del foehn" che orla l’altipiano del Nanos (la cima più alta è il
Suhi Vrh, 1313 m, Alpi Dinariche Settentrionali, Slovenia),
visualizzando la situazione di sbarramento sul lato interno sloveno
(nord-orientale) contrapposta a quella di "caduta" sottovento, sul
lato rivolto verso il Golfo di Trieste. Questo altipiano costituisce
una delle "porte" principali di ingresso della bora verso la città di
Trieste e l'Adriatico Settentrionale
(f. Renato R. Colucci).
Tra l'8 e 9 gennaio 2021, segnaliamo:
-13,2 °C ad
Aosta-aeroporto (non accadeva solo dal 18 gennaio
2017, e minimo assoluto di -18,1 °C il 17 dicembre 1990, serie dal
1974);
-19,3 °C a Vipiteno-aeroporto
(-22 °C nel gennaio 1985 e 1987, serie dal 1935);
-20,2 °C a Dobbiaco (non accadeva solo dal 28 febbraio 2018, con
-22,9 °C, e minimo assoluto di -29 °C nel febbraio 1969, serie dal
1956).
Inoltre, con
cautela vanno considerati i valori glaciali di depressioni carsiche
trivenete (frost hollows), come i -41,8 °C del 27 dicembre
alla dolina Campo Magro (1612 m, Asiago, misura automatica
Associazione
Meteotriveneto), situazioni locali in siti monitorati da pochi
anni e non rappresentativi del territorio circostante.
Per il resto la frequente nuvolosità e
l'apporto di aria mediterranea più dolce richiamata dalla depressione
"Lisa" a inizio 2021 hanno da un lato contenuto il gelo notturno e
dall'altro ostacolato la salita diurna delle temperature massime al
Nord Italia.
Considerando i dati dell'osservatorio del
Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, zona peraltro un po' più
riparata dall'addolcimento di inizio anno (benché sufficiente a
trasformare la neve in pioggia), il periodo Natale-Epifania ha
mostrato una temperatura media di 2,2 °C, nella norma del
nuovo (e caldo) trentennio di riferimento 1991-2020.
Non faceva così freddo nel periodo natalizio da dieci anni,
dall'inverno 2010-11 (Tmed 1,0 °C), ma in precedenza una situazione
termica di questo tipo a fine dicembre-inizio gennaio era del tutto
ordinaria, con punte di gran lunga inferiori (grafico qui sotto).
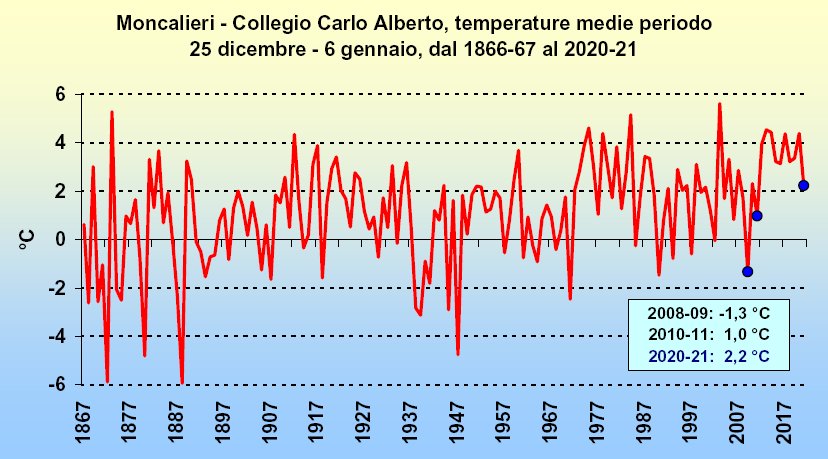
Moncalieri (TO), osservatorio del Collegio Carlo Alberto: serie delle
temperature medie del periodo 25 dicembre-6 gennaio a partire
dall'inverno 1866-67. La media di 2,2 °C delle recenti festività
appare fredda solo nel quadro dei tiepidi inverni dell'ultimo
decennio, mentre in passato era del tutto comune e ordinaria. Ultimo
caso simile nel 2010-11 (1,0 °C), più freddo quello del 2008-09 (-1,3
°C), e nel trentennio precedente situazioni analoghe o più fredde
si verificavano in media due anni su tre!
La carta delle anomalie termiche medie in superficie in
Europa, periodo 25 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021 (qui sotto),
conferma collocando l'Italia nel settore con valori prossimi alla
norma, tra un'area di freddo più anomalo sull'Europa occidentale (aria
fredda in discesa da Nord sul lato posteriore delle depressioni) e di
caldo eccessivo tra Baltico e Balcani (aria calda in risalita da Sud
sul lato anteriore). Su Puglia e basso Adriatico risulta un'anomalia
di circa +2 °C.
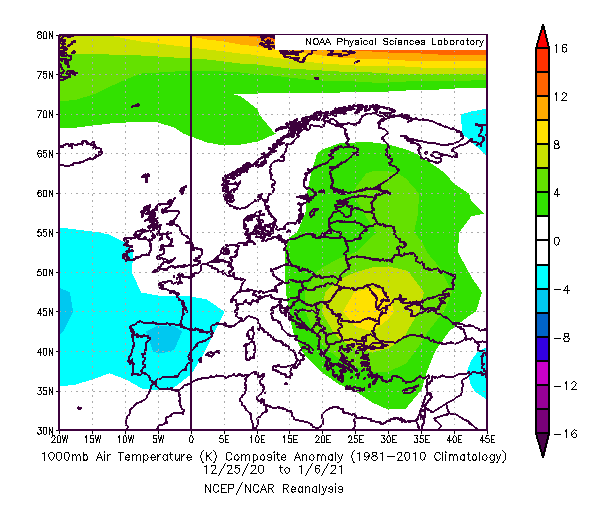
Carta delle anomalie di temperatura in superficie tra il 25 dicembre
2020 e il 6 gennaio 2021. Situazione pressoché normale in Italia
(Fonte:
ESRL-NOAA).
Un po' diversa la situazione in quota: al
livello isobarico di 850 hPa (corrispondente a un'altitudine tra 1200
e 1500 m a seconda della pressione atmosferica) la distribuzione
continentale delle anomalie termiche è la medesima, tuttavia queste
appaiono decisamente amplificate rispetto al suolo.
Così le regioni italiane occidentali sono comprese in una vasta area
con temperature nettamente sotto media (anomalia circa -3 °C sulle
Alpi occidentali) centrata tra Francia e Penisola Iberica (fino a
oltre 5 °C inferiori al normale), mentre all'opposto, tra Mar Nero e
Russia meridionale (nonché sull'Artico), l'aria a quote di circa 1500
m è stata oltre 6 °C più calda del solito.
Tale comportamento è dovuto alla persistente situazione di blocco
atmosferico con depressioni fredde a Est e anticicloni caldi a
Ovest, che esplicano le maggiori anomalie termiche proprio in libera
atmosfera, mentre al suolo situazioni meteorologiche locali e
variegate tendono talora a un maggiore bilanciamento; si pensi ad
esempio ai periodi (come questo) frequentemente nuvolosi, con
temperature diurne basse (massime sotto media) ma con raffreddamento
notturno limitato dai cieli coperti (minime sopra media).
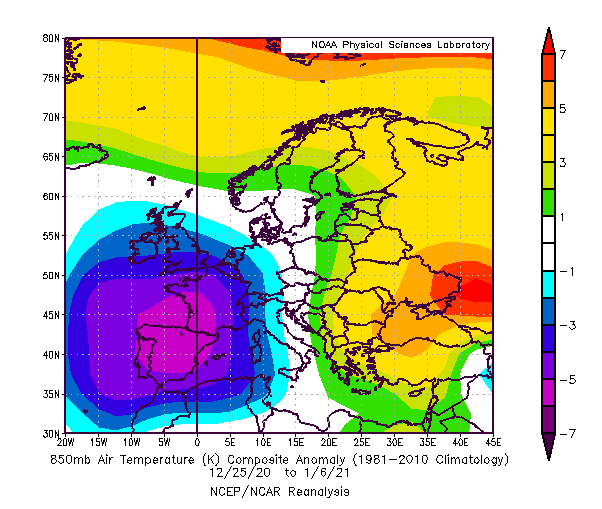
Carta delle anomalie di temperatura al livello di 850 hPa (tra 1200 e
1500 m) tra il 25 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021. In quota le
deviazioni dalla media sono più marcate e riflettono le
caratteristiche delle masse d'aria all'interno delle depressioni
fredde sull'Europa occidentale, e degli anticicloni caldi tra Est
Europa e Russia meridionale (Fonte:
ESRL-NOAA).
In sintesi, ecco che il freddo e la neve
straordinaria di questo periodo in montagna (dovuta per lo più a
un eccesso di precipitazioni) non sono in contraddizione con il
riscaldamento globale a lungo termine, trattandosi di un evento
temporaneo, limitato a scala locale-regionale, e che si verificava con
ben maggiore frequenza in passato.
Peraltro il
Cnr-Isac segnala che, con 1 °C sopra la media 1981-2010, il
2020 in Italia è stato il quinto anno più caldo dal 1800, appena
sotto i recentissimi casi del 2014, 2015, 2018 e 2019.
E a scala mondiale, l'anno
ha pareggiato il primato del 2016
(anomalia +0,6 °C) anche senza l'aiuto riscaldante del Niño di quell'anno,
stando ai dati del servizio di monitoraggio terrestre
EU-Copernicus.
"STRATWARMING": ALTRO FREDDO IN ARRIVO?
I "Sudden Stratospheric Warming" (SSW) sono
improvvisi e massicci episodi di riscaldamento invernale della
stratosfera (10-50 km di altezza), anche di 50 °C in pochi giorni,
i cui effetti di "disturbo" alla circolazione atmosferica possono
ripercuotersi verso il basso fino alla superficie terrestre (con un
ritardo fino a oltre un mese rispetto al momento di innesco).
Determinano un indebolimento del vortice polare con alterazione della
corrente a getto e importanti irruzioni di aria gelida da
latitudini polari verso Europa e Asia (un esempio recente è
l'ondata di freddo che ha raggiunto anche l'Italia a fine febbraio
2018).
Un episodio di SSW si è verificato proprio nei giorni scorsi, attorno
al 5 gennaio 2021: vedremo se sarà associato a un marcato episodio
invernale nella seconda metà del mese...
Un recentissimo
studio coordinato da Richard J. Hall dell'Università di
Bristol indaga tempi e modalità di propagazione dell'anomalia di
circolazione dalla stratosfera alla troposfera fino all'impatto in
superficie, e i conseguenti effetti sul tempo in Europa, in base alla
tipologia di alterazione del vortice polare dopo un SSW (suo
spostamento o suddivisione in due vortici più piccoli: quest'ultimo è
il caso che si manifesta in genere con ondate di freddo più marcate in
Europa nord-occidentale e Siberia).
Infine, una riflessione del coautore della ricerca Dann Mitchell,
professore di scienze dell'atmosfera all'Università di Bristol:
"Gli episodi di freddo estremo che queste alterazioni del vortice
polare causano ci ricordano quanto improvvisamente le condizioni del
tempo possono "capovolgersi". Anche con il riscaldamento globale,
questi episodi possono ancora avvenire, indicando la necessità di
adattarsi a intervalli di oscillazione delle temperature ancora più
estremi".
FREDDO E NEVE NON SONO MERITO DEI LOCKDOWN COVID
Talora si sente attribuire il merito di
questo breve periodo più freddo e nevoso alla temporanea riduzione
delle emissioni inquinanti durante i lockdown imposti dal Covid-19.
Invece non c'è nessuna relazione: si stima che le emissioni
globali di CO2 nel 2020 (34 miliardi di tonnellate, senza
considerare gli altri gas serra, fonte
Global Carbon Budget) siano diminuite solo del 7% rispetto al
record del 2019, e le concentrazioni totali in
atmosfera, frutto dell'inesorabile accumulo di CO2
nell'ultimo secolo segnato dal crescente utilizzo di combustibili
fossili, hanno continuato ad aumentare toccando nuovi massimi
storici (417,1 parti per milione nel maggio 2020 all'osservatorio
del Mauna Loa nelle Hawaii, e 418,4 ppm nel dicembre 2020 all'osservatorio
appenninico del Monte Cimone), così come farebbe l'acqua in una vasca da bagno con
il rubinetto solo un po' meno aperto...
La riduzione delle emissioni serra non darà benefici per il clima
se non sarà mantenuta con serie e durature politiche ambientali dopo
la pandemia, inducendo una stabilizzazione e un calo anche delle
concentrazioni a lungo termine.
RINGRAZIAMENTI
Per la condivisione di dati e informazioni, un grazie a Yuri
Brugnara (Università di Berna, Istituto di Geografia), Maurizio
Ratti (SMI,
Osservatorio di Pontremoli - MS), Gianni Castagneri (SMI,
Osservatorio di Balme - TO), Renato R. Colucci (CNR-Istituto
di Scienze Polari e
Società
Meteorologica Alpino-Adriatica), Paolo Fantini
(Osservatorio e Università di Parma), Davide Rosa (SMI, Quinto
Vicentino), Elia Lombardi
(Associazione
Centro Meteo Emilia-Romagna), e ai seguenti enti nivo-meteorologici provinciali, regionali e nazionali:
ARPA Piemonte,
Centro
Funzionale Regione Autonoma Valle d'Aosta,
ARPA Lombardia,
Meteotrentino,
Ufficio
Idrografico di Bolzano,
ARPA Veneto,
OSMER
Friuli-Venezia Giulia,
Protezione Civile Regione FVG,
ARPA
Emilia-Romagna,
Centro
Funzionale Regione Toscana,
Servizio Meteomont.
Devolvi il 5 per mille alla SMI!
Sosterrai
le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,
e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|