|
PRIMO SEMESTRE
2024: PIOGGE STRAORDINARIE PER FREQUENZA E ABBONDANZA AL NORD
(SICCITA' ESTREMA INVECE AL SUD), POCO SOLE, MA NON FREDDO
18 luglio 2024, SMI / Redazione Nimbus
Mentre il Sud Italia, soprattutto Sicilia e Puglia, vive da mesi una
siccità eccezionale, al Nord il periodo tra fine inverno,
primavera e inizio estate 2024 ha mostrato precipitazioni rare a
vedersi per elevata frequenza e abbondanza.
Responsabile è l'influenza di prevalenti condizioni depressionarie tra
le isole britanniche e la Francia, associate al ripetuto passaggio
di sistemi frontali con apporti di aria umida da Ovest, Sud-Ovest,
Sud, talora Sud-Est (ponente, libeccio, scirocco), situazioni
variamente favorevoli a precipitazioni sulle regioni italiane
settentrionali e specie a Nord del Po, dove lo sbarramento orografico
contro il pendio sudalpino esalta le piogge (e le nevicate in quota).
All'avvicinarsi dell'estate, da maggio in poi, la componente
convettiva (moti dell'aria verticali innescati dal surriscaldamento
del suolo) ha inoltre contribuito favorendo il moltiplicarsi di
temporali spesso violenti e rovinosi per grandine, vento tempestoso e
alluvioni-lampo.
La medesima configurazione atmosferica prevalente a
grande scala ha invece lasciato a secco l'estremo Sud e il
medio-basso versante adriatico, regione rimasta più sotto
l'influenza degli anticicloni che hanno dominato a Est, sui Balcani, o
di regimi di foehn sottovento ai rilievi appenninici.

Torino, 2 giugno 2024: l'ennesimo rovescio interessa la città,
soggetta,
nel primo semestre dell'anno, a una piovosità straordinaria
(f. Claudio Castellano).
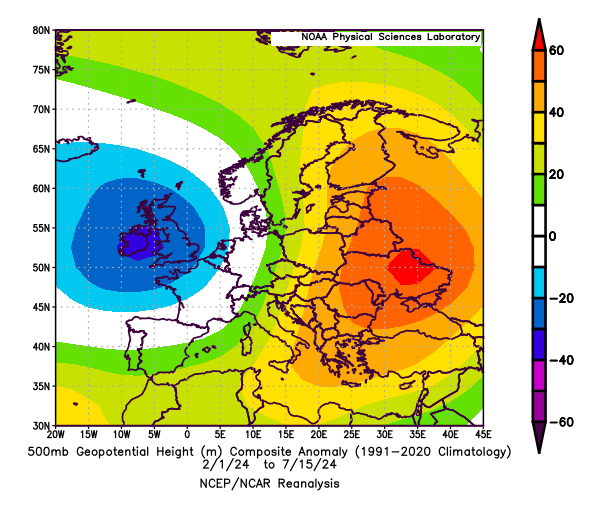
Anomalie di altezza del geopotenziale al livello isobarico di 500 hPa
nel periodo 1° febbraio - 15 luglio 2024 in Europa: depressioni più
profonde e ostinate del consueto intorno alle isole britanniche hanno
influenzato il tempo anche al Nord Italia, con precipitazioni
frequenti e abbondanti, mentre il resto del Paese e soprattutto il Sud
è rimasto maggiormente coinvolto nelle anomalie positive di
geopotenziale (prevalenza di anticicloni) che hanno caratterizzato
l'Est del continente, in netta contrapposizione a quanto verificatosi
a Ovest (Fonte:
Physical Science Laboratory - NOAA).
A Torino-centro (stazione
Arpa Piemonte
di via della Consolata) da febbraio a giugno 2024 si sono conteggiati
55 giorni con almeno 1 mm di precipitazione, +58% rispetto alla
media, e per trovare un caso analogo o superiore nello stesso periodo
dell'anno occorre tornare indietro di mezzo secolo, al
febbraio-giugno 1972 (56 giorni). Nella serie di misure
pluviometriche avviate nel 1802, solo in altre sei occasioni è stata
superata la frequenza di precipitazioni di quest'anno, sempre in
riferimento ai mesi da febbraio a giugno (nel 1810, 1832, 1889, 1905,
1930 e, dunque, nel 1972).
Nel primo semestre dell'anno sono caduti ben 783,8 mm d'acqua
(+79%), terzo caso in oltre due secoli dopo i periodi
gennaio-giugno 1810 (1029,4 mm) e 1936 (834,6 mm).
Estendendo l'analisi fino al 15 luglio si arriva a 846 mm, valore
molto vicino a quanto si dovrebbe rilevare in tutto l'anno (898
mm, media del trentennio climatologico standard 1991-2020), e lo
stesso si può dire per l'insieme del Piemonte: secondo le analisi
regionalizzate
Arpa finora si sono raccolti, come media territoriale, 932 mm,
+85% rispetto alla norma, e pari alla precipitazione che si dovrebbe
totalizzare da gennaio a inizio dicembre!
La situazione è fin più eccezionale in Lombardia,
regione ripetutamente colpita da situazioni alluvionali:
all'osservatorio di Milano-Brera il pluviometro
Arpa Lombardia
ha raccolto 973,8 mm nel primo semestre 2024, figurando come il
periodo gennaio-giugno di gran lunga più bagnato nella serie di
misura avviata nel lontano 1764 (supera gli 848,6 mm del
gennaio-giugno 1876). Incredibilmente, solo due anni fa
(gennaio-giugno 2022) si registrava invece il minimo assoluto della
serie, con 109,4 mm!
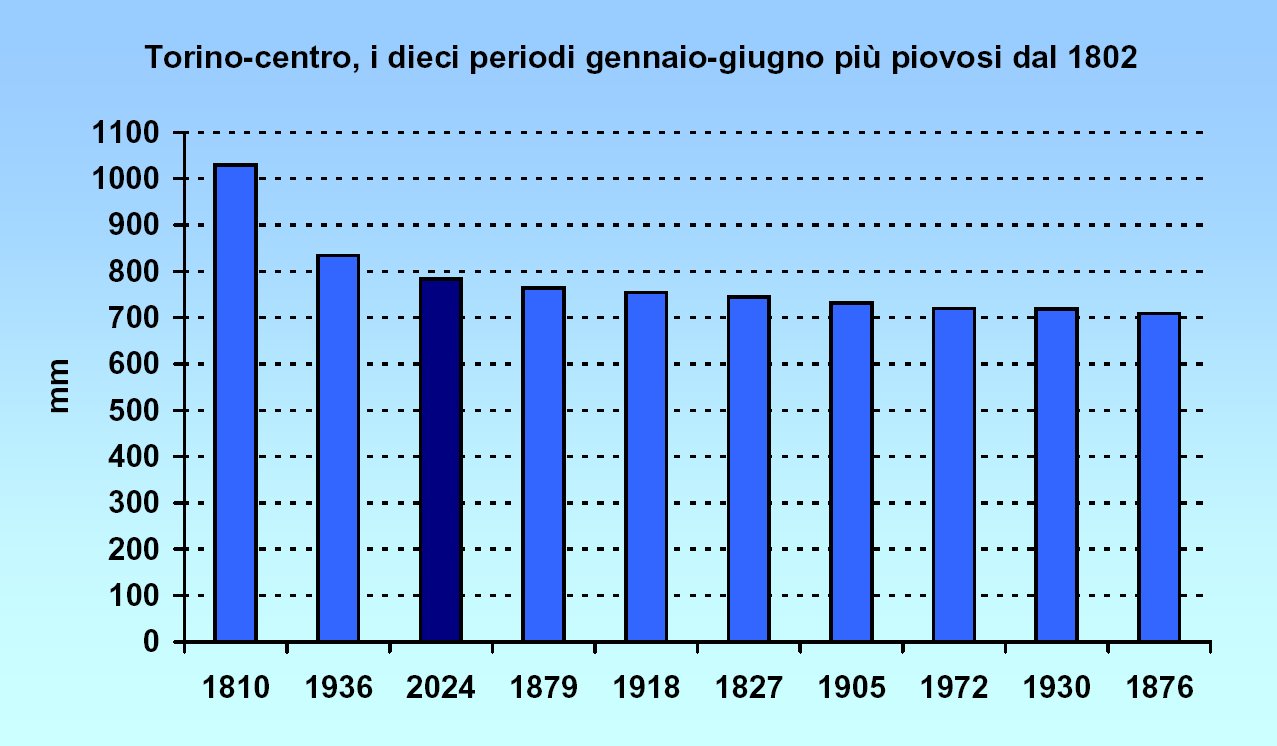
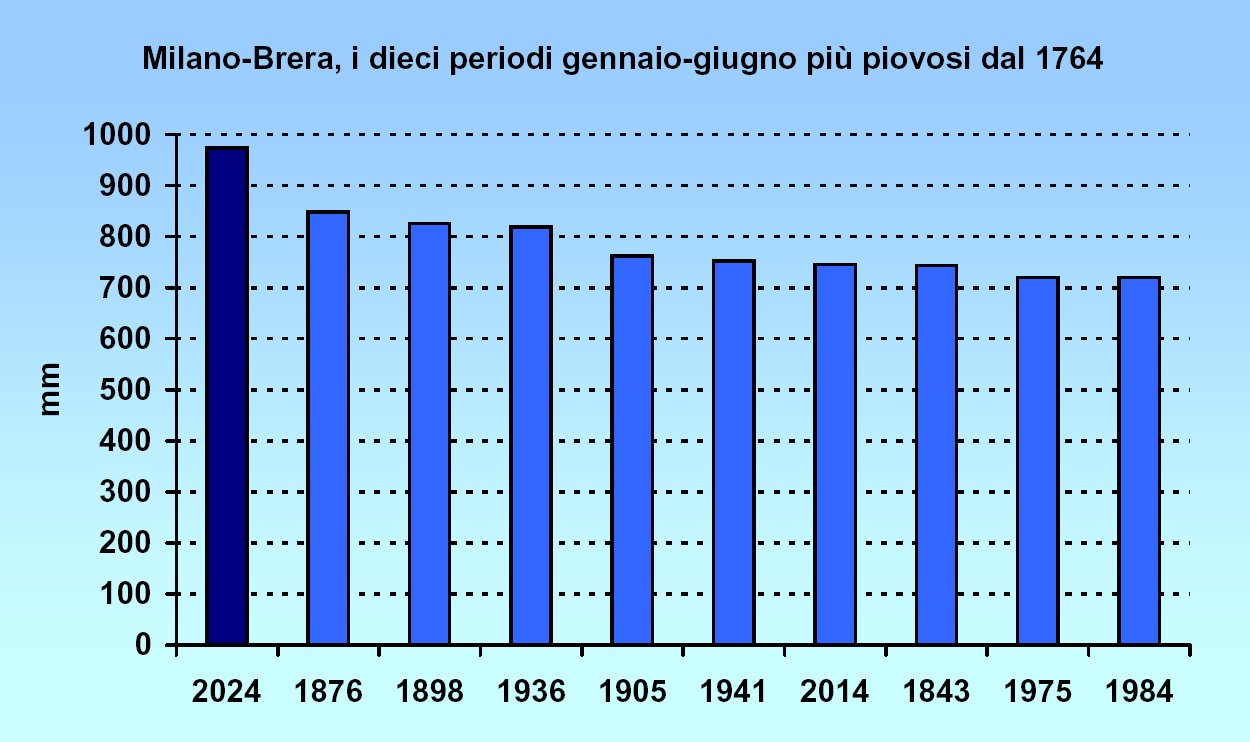
Il semestre gennaio-giugno 2024 a Torino e Milano è stato
rispettivamente terzo e primo più piovoso nelle serie dal 1802 e 1764,
con 783,8 e 973,8 mm di precipitazione totale. Fonte dati:
Arpa Piemonte
e Arpa
Lombardia.
Proprio la frequenza delle piogge (ancor più che la loro quantità
totale), insieme alla carenza di soleggiamento, ha contribuito alla
diffusa e giustificata sensazione di tempo pessimo persistente e di
uno zoppicante avvio d'estate.
Meno determinanti di quanto comunemente si pensi sono state invece le
temperature. E' vero che da metà aprile a inizio luglio 2024 i
periodi più freschi del consueto hanno prevalso su quelli più caldi al
Nord-Ovest italiano, ma nel complesso le anomalie termiche
negative sono state contenute, al confronto delle marcate anomalie
positive (caldo eccessivo) dei mesi precedenti.
Sempre a Torino, rispetto alla norma 1991-2020, risultano scarti
termici mensili di -0,9 °C in maggio e -0,6 °C in giugno, dunque un
po' più fresco ma solo rispetto ai decenni recenti segnati da un netto
riscaldamento atmosferico.
Se si prende a riferimento il clima del precedente trentennio standard
internazionale 1961-1990, che potremmo definire più "normale" e ancora
poco influenzato dal riscaldamento globale antropogenico, vediamo che
la fine primavera e l'inizio estate 2024 risultano allora perfino un
po' più caldi della media, rispettivamente +0,4 °C e +1,1 °C in maggio
e giugno.
Allargando lo sguardo a tutto il primo semestre 2024,
includendo dunque i mitissimi (rispetto alla norma) mesi invernali e
di inizio primavera, questo risulta perfino quinto tra i più caldi
dal 1753 a Torino, con anomalia di +1,0 °C rispetto al 1991-2020 e
+2,3 °C rispetto al 1961-1990.
Ancora, se usciamo dall'angolo nord-occidentale, unica
zona italiana che tra metà aprile e inizio luglio ha risentito
dell'influsso fresco delle depressioni "britanniche", il carattere
caldo del 2024 emerge con ulteriore evidenza, tanto che a livello
nazionale, se si chiudesse qui, l'anno risulterebbe il più caldo dal
1800 con +1,47 °C rispetto alla norma 1991-2020, secondo il
CNR-ISAC.
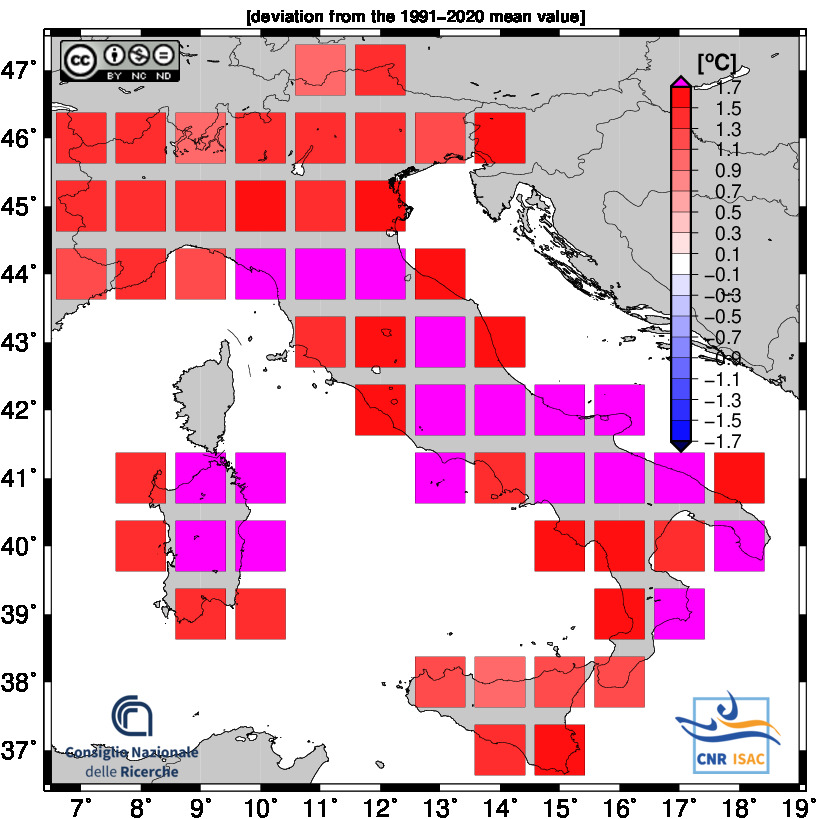
Anomalie di temperatura del periodo gennaio-giugno 2024 in Italia,
rispetto alla norma del trentennio 1991-2020. Il primo semestre
dell'anno è stato molto caldo in tutto il Paese, e soprattutto al
Centro-Sud e in Sardegna
(fonte:
CNR-ISAC, Bologna).
COME L'ESTATE 2014?
Il ricordo va a dieci anni fa, all'estate
2014, che si distinse per nuvolosità e piovosità ostinate
con ripercussioni negative su agricoltura e turismo, tuttavia un
parziale bilancio di metà stagione rivela che siamo abbastanza
lontani da quella situazione, per lo meno nel capoluogo
piemontese.
Nel periodo 1° giugno - 15 luglio si sono contati quest'anno 12 giorni
con precipitazioni, mentre allora furono 16, le temperature medie sono
leggermente superiori (22,7 °C vs 22,5 °C), ma soprattutto all'epoca
fu in particolare luglio a mostrarsi tra i più grigi, bagnati e
freschi a scala pluridecennale, mentre nel 2024 il mese centrale
dell'estate, con il contributo del caldo scoppiato nella seconda
decade, sembra avere altre intenzioni.
Oltre all'eccezionale piovosità già dei mesi
precedenti, per ora l'estate 2024 si fa notare per i nubifragi
frequenti e rovinosi al Nord, ma le settimane centrali della stagione
stanno trascorrendo (per ora) in modo diverso rispetto ai grigiori
persistenti del luglio 2014, che ebbe sembianze autunnali.
In ogni caso considerazioni più significative andranno
fatte a stagione terminata, tra un mese e mezzo, e analizzando i dati
di regioni più estese, in modo da contemplare le varie peculiarità
locali.
Ad esempio nell'alta Lombardia e soprattutto tra Varesotto e
Comasco, le precipitazioni della prima metà di luglio sono state
effettivamente straordinarie: 243,5 mm a
Varese-Centro Geofisico Prealpino (in gran parte concentrati nei
due intensi episodi del 7 e 12 luglio), valore che nella serie avviata
nel 1967 supera i casi del 2009 (232,8 mm) e del 2008 (174,7 mm; com.
pers. del meteorologo CGP Paolo Valisa).
Di certo, dell'estate 2024 ricorderemo gli episodi
alluvionali ravvicinati del 20 giugno nel massiccio francese degli
Écrins e nel Vallese, del 21 giugno in Valle Mesolcina (Grigioni), del
29-30 giugno sulle Alpi dal Gran Paradiso al Canton Ticino, e del
7 e 12 luglio tra Ticino meridionale, Varesotto e Lario (almeno 8
vittime totali in territorio svizzero, durante gli eventi del 21 e
29-30 giugno).
Devolvi il 5 per mille alla SMI!
Sosterrai
le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,
e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|