|
Il 9 giugno 2014 gli operatori della
Società Meteorologica Italiana hanno eseguito le consuete misure di
accumulo nevoso stagionale e la manutenzione della stazione meteorologica
automatica al Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso).
Come sempre,
IREN Energia
ed Ente Parco Nazionale
Gran Paradiso hanno contribuito in modo fondamentale alla
logistica della missione, inoltre le operazioni sono state riprese da
G. Battista Gardoncini e Ivo Bonato della sede RAI
di Torino.

09.06.2014: veduta del Ghiacciaio Ciardoney e
del pianoro antistante la fronte, coperti da un manto di neve
stagionale spesso 1,5 - 4 m. L'anticiclone nord-africano ricopre le
Alpi determinando un mattino sereno, calmo e caldo anche in alta quota
(alla stazione meteorologica, 2850 m, temperatura minima notturna di 6.4 °C, e già 9 °C all'arrivo
degli operatori alle h 8:30).
L'inverno alpino è terminato e bruscamente è iniziata la fusione
nivale: è il momento migliore per compiere le misure di accumulo
nevoso sul ghiacciaio (f. L. Mercalli).
Le misure hanno evidenziato un'abbondante
alimentazione nevosa invernale, con spessori del manto variabili
tra 270 e 400 cm, densità straordinariamente elevate (580-610
kg/m3) e un accumulo specifico pari a 1850 mm di
equivalente d'acqua,
che si pone in terza posizione tra i più notevoli dall'inizio
della serie nel 1992, nonostante la relativa scarsità di nevicate
primaverili.
L'inverno, tra novembre 2013 e inizio marzo 2014, è stato infatti
molto perturbato, segnato da continui afflussi di umidità
atlantica e mediterranea che si sono tradotti in frequenti nevicate
sul versante sudalpino. La zona del ghiacciaio Ciardoney, come
gran parte delle Alpi Torinesi, trovandosi in parte sottovento ai
venti prevalenti da Sud-Ovest, non ha ricevuto precipitazioni
eccezionali, come invece avvenuto sul Cuneese e dal Monte Rosa verso Est, ma gli
apporti sono stati pur sempre superiori al normale.

Arrivo in
elicottero
al Colle Ciardoney del gruppo di lavoro che si occuperà delle misure
di innevamento e delle riprese televisive RAI
(f. D. Cat Berro).

Uno sguardo dal
Colle Ciardoney verso i ghiacciai di Valsoera (versante Valle Orco).
Numerose, come di consueto, le valanghe scaricatesi dai canaloni delle
Punte di Teleccio e Scatiglion, significative per l'alimentazione di
questi due minuscoli ghiacciai tuttavia ormai al limite dell'estinzione
(f. D. Cat Berro).

Colle Ciardoney:
qui, sul settore più elevato del ghiacciaio (3100 m), sullo spartiacque
Orco-Soana, lo spessore nevoso risultava di 380 cm, nella
norma del periodo 1992-2013, ma con densità molto elevate (610 kg/m3)
probabilmente imputabili all'inverno mite (nevicate più umide e
pesanti associate ai frequenti flussi meridionali) e al prolungato
assestamento del manto nevoso nel corso della primavera, durante
la quale non sono più avvenute importanti cadute di neve. Di
conseguenza il contenuto d'acqua era molto copioso e pari, in questo
sito di misura, a ben 2324 mm (f. D. Cat Berro).

Colle Ciardoney:
l'ing. Luigi Bonifacino (Direttore
Produzione Idroelettrica IREN Energia),
di fronte alle telecamere RAI - Torino, spiega l'importanza delle
misure di
innevamento e bilancio di massa glaciale per la
gestione delle risorse idriche in ambiente alpino
e degli impianti idroelettrici del bacino dell'Orco (f. D. Cat Berro).

Al di sopra della
Val Soana il cielo
è sereno ma la visibilità orizzontale è limitata
a 20-30 km per la presenza di foschia e polvere sahariana in sospensione
nell'aria, qui in direzione della Rosa dei Banchi (3164 m, vetta a
sinistra) e della bassa Valle d'Aosta (f. D. Cat Berro).

Colle Ciardoney:
l'operatore SMI-CGI
Fulvio Fornengo si accinge a prelevare i campioni di neve tramite il
carotiere "Valtecne" per la determinazione di densità ed equivalente
d'acqua
del manto nevoso
(f. D. Cat Berro).


Prelievo tramite
carotiere "Valtecne" dei campioni di neve
lungo tutto il profilo del manto stagionale.
A seguito di un semestre
invernale-primaverile particolarmente mite (a Torino anomalia
termica dicembre-maggio di +1.4 °C, terzo caso più tiepido dal 1753) e
dei primi intensi calori della prima decade di giugno (Tmax 15
°C a 2850 m l'8, giorno precedente alle misure), il manto nevoso si
presentava ormai completamente intriso d'acqua,
in isotermia e in condizioni prossime alla fusione in tutto il suo
spessore.
Poche e relativamente morbide le «croste» da fusione e rigelo o da
vento
all'interno del manto, probabilmente sia per l'assenza di lunghi
periodi anticiclonici o ventosi durante l'inverno, sia per l'azione
dei processi di metamorfismo primaverile,
più avanzati del consueto.

Dettaglio di un
campione di neve estratto dal tubo carotiere
(f. D. Cat Berro).
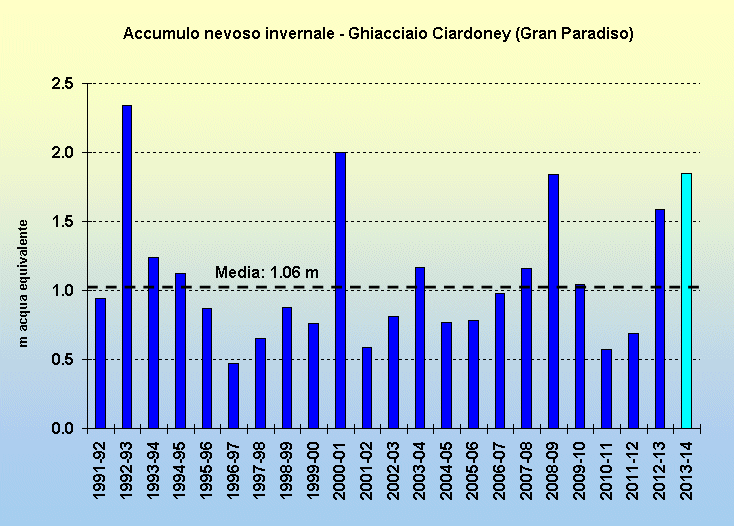
Serie dei valori di accumulo specifico (acqua
equivalente) sul ghiacciaio Ciardoney dalla
stagione idrologica
1991-92 al 2013-14: l'ultimo inverno occupa la terza posizione, con
1850 mm (ben oltre la media 1992-2013 di 1060 mm), pari merito con la
stagione 2008-09. Una situazione favorevole, che
predispone a una buona disponibilità d'acqua per la produzione
idroelettrica e per l'agricoltura padana nelle prossime settimane
estive,
ma per quanto riguarda la salute del ghiacciaio, tutto dipenderà
dall'andamento meteo-climatico dell'estate 2014: se le temperature
medie della stagione saranno normali, una parte dell'abbondante neve
caduta potrà conservarsi e contribuire così all'alimentazione del
Ciardoney (situazione divenuta rara negli ultimi anni); se invece,
ancora una volta, dovesse essere molto calda, allora il manto nevoso
stagionale potrà fondere completamente nonostante l'abbondanza di neve
primaverile, come accaduto di recente anche nel
2009 e
2013.

Le misure di spessore nevoso vengono eseguite
tramite una sonda da valanga lungo un transetto pressoché rettilineo
dal Colle Ciardoney fino alla fronte glaciale: si sono rilevate
altezze del manto decrescenti da 380 cm in prossimità del Colle
Ciardoney (3100 m) fino a 270 cm tra i siti di misura 6 e 7 (2950-2900
m), ma con locali accumuli di 400 cm nella valletta nivale presso la
fronte del ghiacciaio (f. D. Cat Berro).

Il pendio
frontale del ghiacciaio e il pianoro antistante,
al fondo del quale si trova la stazione meteorologica.
Improvvisamente, tra sabato 7 e domenica 8 giugno 2014, sono apparse
numerose pozze di fusione, a causa dell'arrivo del caldo estivo
che ha agito su un manto nevoso già in precedenza umidificato dagli
eccessivi tepori primaverili (quarta primavera più mite dal 1753 a
Torino). Tra la neve spessa circa 1,5 m inizia a farsi strada anche il
torrente emissario del ghiacciaio, indice che la fusione,
sebbene da un paio di giorni soltanto,
è già cominciata
(f.
D. Cat Berro).

Anche le colate
detritiche trascinate dagli abbondanti rivoli di fusione sulle
morene laterali sinistre del ghiacciaio mostrano gli
effetti dell'improvvisa ondata di caldo (f. D. Cat Berro).

Il laghetto proglaciale formatosi dagli
Anni 1990 a destra della fronte inizia a riaffiorare
tra la neve in rapida fusione (f. D. Cat Berro).

A pochi metri dalla stazione meteorologica il
torrente glaciale, riattivatosi da poche ore,
si apre un percorso di deflusso tra la neve fradicia, trasportando a
valle a impulsi successivi una miscela di acqua e neve il cui colore
bianco brillante contrasta con la superficie nevosa circostante, più
scura per la presenza di abbondante polvere sahariana caduta
durante gli episodi sciroccali del 19 febbraio e 4 aprile 2014. La
superficie ingiallita diminuisce l'albedo (riflettività della
superficie terrestre, in questo caso della neve) e concorre ad
aumentare l'assorbimento di radiazione solare, dunque ad accelerare la
fusione (f. L.
Mercalli).
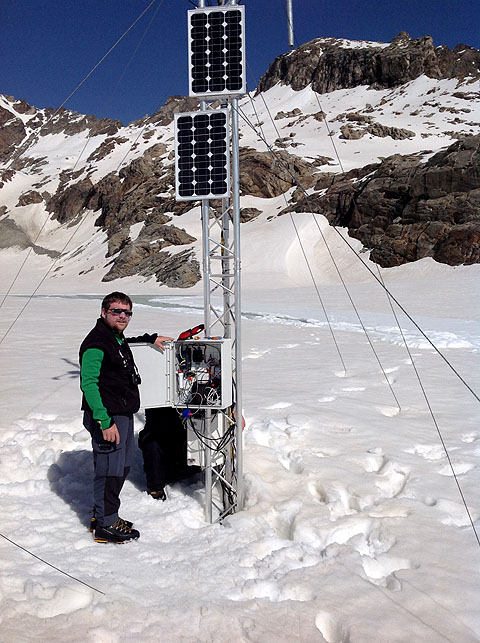
Oltre che per le
misure di bilancio invernale, la missione è stata anche l'occasione
per eseguire il periodico scarico dei dati
meteorologici e per la manutenzione delle
apparecchiature. Qui il presidente SMI Luca Mercalli accanto alla
stazione meteorologica Campbell, la cui operatività si è sempre
dimostrata ottima fin dall'installazione nell'agosto 2010. Tuttavia a
metà marzo 2014 la pressione esercitata dalla neve pesante ha causato
la rottura del cavo seriale per la trasmissione dati in remoto,
determinandone così un black-out nella pagina web,
attualmente risolto. Gli strumenti tuttavia hanno continuato a
funzionare regolarmente in locale (f. D. Marzo).
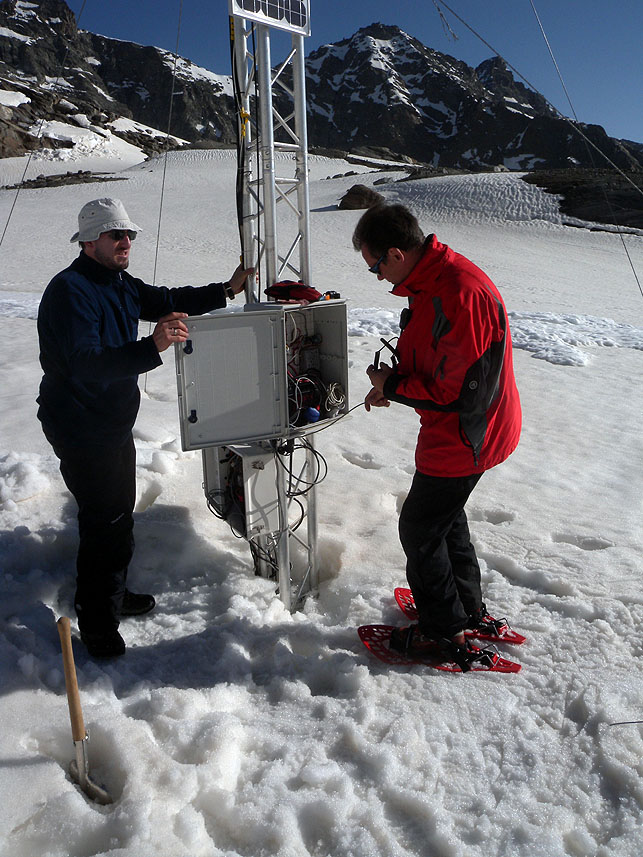
I tecnici Sylvain Jobard e Diego Marzo, in
contatto radio e telefonico con
CSP - Innovazione nelle
ICT (Torino), provvedono alla riparazione del guasto e allo
scarico dei dati meteo.
In prossimità del traliccio la neve era alta 160 cm e gli armadietti
dell'elettronica erano già affiorati dal manto, permettendo di
lavorare agevolmente (f. L. Mercalli).
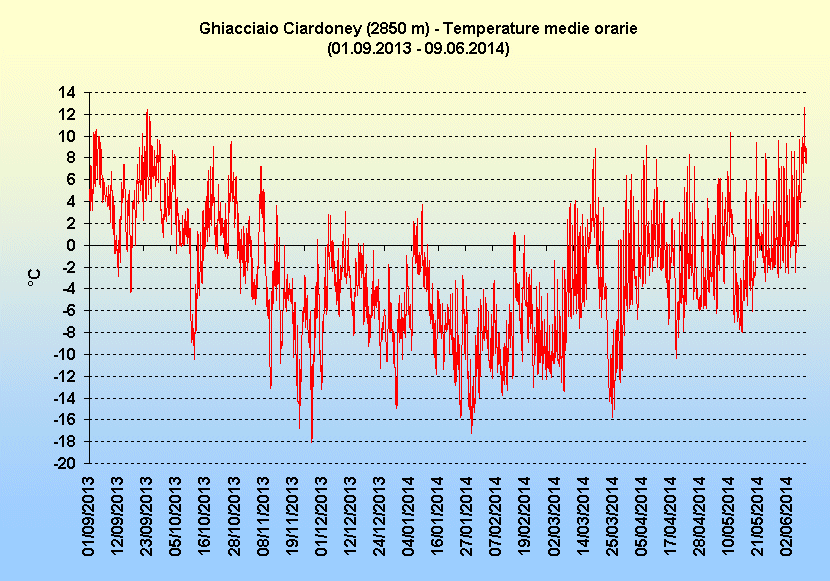
Temperature medie
orarie al Ghiacciaio Ciardoney dal 15 settembre 2013 al 9 giugno
2014: l'inverno si è contraddistinto per l'assenza di significative
ondate di freddo, e le temperature, a quota 2850 m, non sono
scese sotto i -18.1 °C del 27 novembre 2013. Una prima
ragguardevole ondata di tepore si è osservata in marzo, con una
massima di 8.9 °C il giorno 18, e - in seguito - solo alla metà di
maggio si sono ancora avute alcune giornate gelide con temperature
costantemente sotto 0 °C tra il 13 e il 15. Infine l'improvviso
aumento termico a partire dal 7 giugno ha determinato l'avvio della
stagione di fusione sul ghiacciaio.
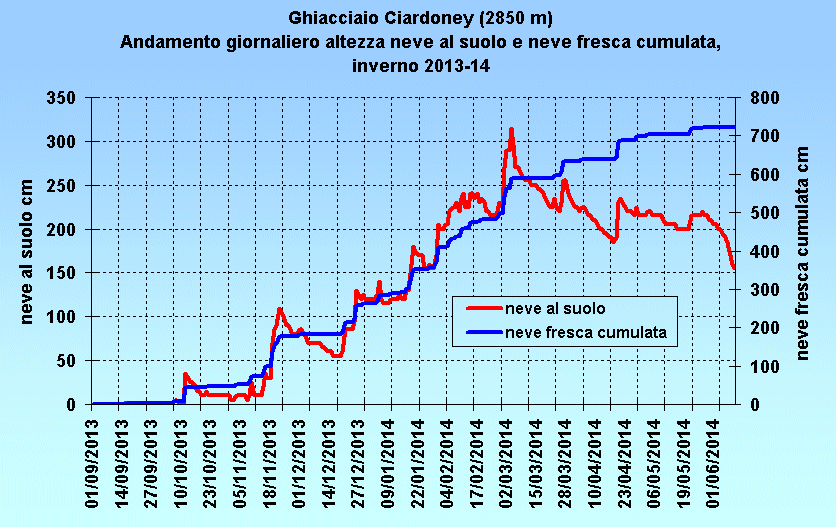
Andamento giornaliero dello spessore
nevoso totale al suolo (linea rossa) nella stagione 2013-14 presso la stazione
meteorologica del ghiacciaio Ciardoney, desunto dalla lettura dell'asta
nivometrica attraverso le immagini webcam.
La prima nevicata consistente è avvenuta l'11-12 ottobre 2013 (35 cm),
e dal quel momento il suolo è rimasto costantemente innevato con
spessori progressivamente crescenti fino ai
315 cm del 4 marzo 2014, massimo stagionale. Ma nelle
successive settimane primaverili si sono verificate solo un paio di
nevicate consistenti (es. 50 cm tra il 18 e il 21 aprile) e lo
spessore del manto si è lentamente ridotto, stabilizzandosi attorno ai
200-220 cm per gran parte del mese di maggio. All'estremità destra del
grafico (linea rossa) si nota l'avvio della rapida fusione a inizio
giugno (perdita di 15 cm di spessore in sole 24 ore tra l'8 e il 9).
La curva blu rappresenta i valori cumulati della neve fresca
giornaliera, che a fine stagione 2013-14 ha toccato i 724 cm
(massimo apporto giornaliero h 08 - 08:
45 cm tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2014).
Si tenga presente che di norma sopra la superficie del ghiacciaio la
neve si accumula in quantità maggiori rispetto alla zona in cui è
posta l'asta nivometrica, non solo per la quota un po' più elevata, ma
anche per la più efficace deposizione e conservazione del manto sul
ghiaccio nei primi periodi autunnali, a differenza delle circostanti
aree detritiche,
ancora tiepide dopo l'estate.
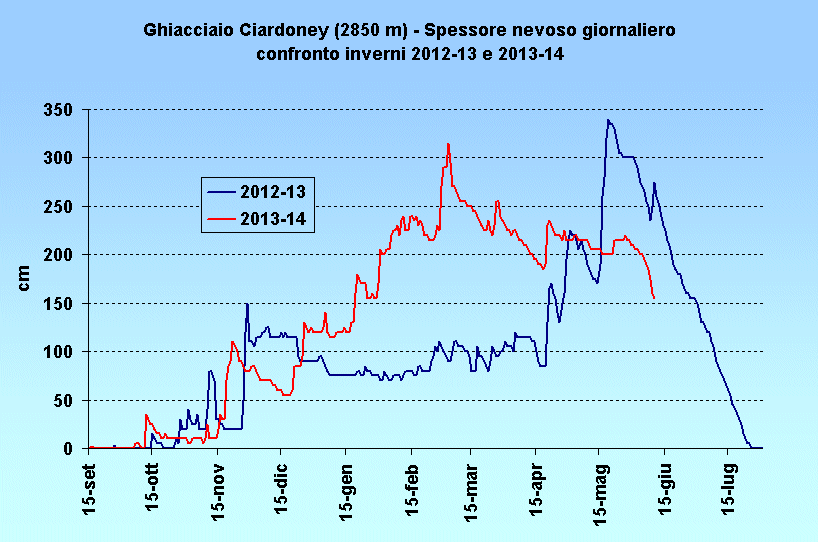
Confronto tra
l'andamento dell'altezza giornaliera della neve al suolo nelle
stagioni 2012-13 e 2013-14. Nell'inverno-primavera 2013-14 lo spessore
massimo (315 cm il 4 marzo) è stato un po' inferiore a quello
dell'anno precedente (340 cm il 19 maggio), tuttavia l'innevamento
è stato cospicuo durante tutta la stagione, risultando in una
media degli spessori nettamente più elevata (139 cm) rispetto al
2012-13 (100 cm), quando grandi nevicate giunsero solo a primavera
avanzata.

Ore 13: la missione è terminata, e i pochi
cumuli che si sono sviluppati nonostante il forte anticiclone non
disturbano l'elitrasporto di personale e materiali a valle (f. L.
Mercalli).
Un particolare ringraziamento a
Valtecne
per il supporto alle campagne di misura sul Ciardoney

|