|

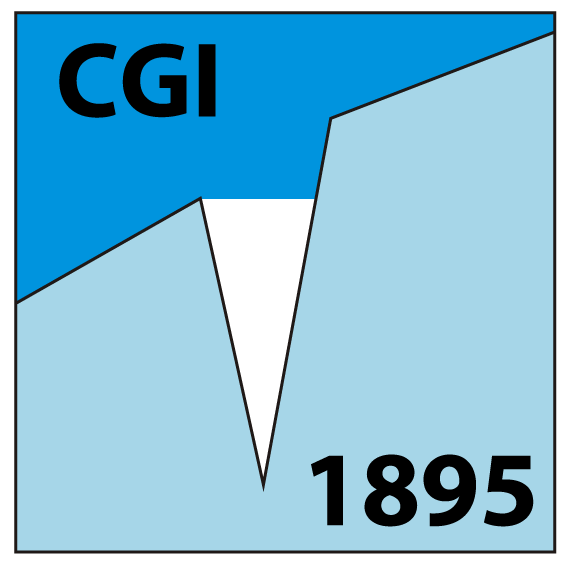
 


IL CROLLO DEL 16-17 DICEMBRE 2015 ALLA
PUNTA TRE AMICI
(MACUGNAGA, MONTE ROSA)
di Marta Chiarle,
Gianni Mortara, Andrea Tamburini, Davide Martelli,
Luca Sergio,
Daniele Cat Berro
19 gennaio 2016
Nella notte tra il 16 e il 17 Dicembre
2015 una frana di grandi dimensioni si è staccata poco sotto la
sommità della Punta Tre Amici, a quota 3400 m circa, nell’alto bacino
del Ghiacciaio Settentrionale delle Locce (testata della Valle Anzasca,
Monte Rosa; Fig. 3).
Il materiale franato si è propagato lungo il versante, sino a
raggiungere la sponda meridionale del Lago delle Locce, a quota
2300 m (Fig. 4 e 6).
Un contrafforte roccioso alla base della
nicchia di distacco ha determinato la suddivisione del materiale franato
in due distinti rami, che a tratti sembrano mostrare un’attività
indipendente. La frana ha coinvolto anche un settore di parete collocato
dietro la porzione di nicchia di distacco visibile dal lago.

1. Vista panoramica
della frana della Punta Tre Amici nell’alto bacino
del Ghiacciaio
Settentrionale delle Locce (f. Marta Chiarle, 19.12.2015).

2.
Veduta aerea della nicchia di distacco, posta all'estremità orientale
della cresta subpianeggiante della Punta Tre Amici (3425-3780 m) che,
a destra, si raccorda alla Punta Gnifetti (4558 m). A sinistra, il
Colle delle Locce che dà accesso all’alta Valsesia
(f. Ettore Schranz, 28.12.2015).
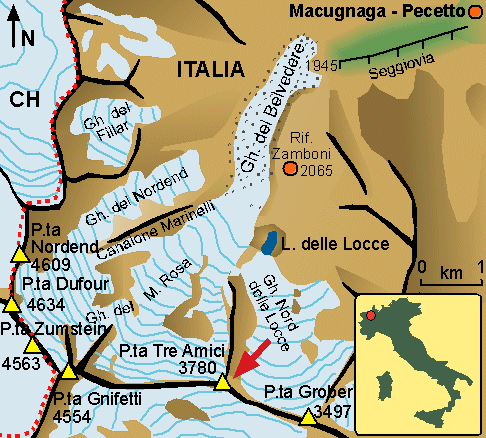
3. Carta di
inquadramento del bacino dei ghiacciai del Belvedere e delle Locce: la
freccia rossa indica la posizione della nicchia di distacco della
frana (dis. SMI).
E’ in corso il reperimento e l’analisi delle registrazioni di alcune
stazioni sismiche poste nell’area circostante quella del distacco. In
via preliminare si può affermare che almeno tre sismometri hanno
registrato un segnale attribuibile al distacco e alla messa in posto
del materiale franato attorno alle ore 20:25 del 16 dicembre 2015.

4. Vista frontale della frana ripresa il 17
dicembre 2015 da Gianni Tagliaferri dai ruderi dell’ex Rifugio Paradiso,
sulla sommità della morena frontale del Ghiacciaio delle Locce.
Lo
scatto ha fissato anche la nube generata da una valanga.

5.
I due principali flussi di detrito generati dal crollo hanno
ampiamente coperto
il lato sinistro del Ghiacciaio Settentrionale
delle Locce
(sorvolo aereo di Ettore Schranz, 28.12.2015).

6. Limiti dell’area interessata dalla frana
(elaborazione di Stefano Perona). L’accumulo ventagliforme si è distribuito
sul sottostante Ghiacciaio delle Locce, arrestandosi sulla sponda
meridionale del lago omonimo. Si può notare la ridottissima
copertura nevosa, parzialmente colorata dalla nube polverosa generata
dalla frana
(f. Gianni Mortara, 19.12.2015).
Un’immagine antecedente l’evento (Fig. 7a) evidenzia come l’ammasso roccioso
franato, costituito da paragneiss e graniti del Monte Rosa,
corrispondesse ad un settore di parete rocciosa acclive e non glacializzata. Sono state tuttavia coinvolte anche porzioni sommitali
del Ghiacciaio del Signal lungo il coronamento della nicchia di frana
(Fig. 8).


7 a, b. Il confronto fotografico evidenzia la notevole
trasformazione morfologica della parete a seguito del crollo che ha
coinvolto anche un settore, non visibile, posto dietro la nicchia di
distacco individuata dalle frecce rosse (sopra: foto in data novembre
2005, fonte www.summitpost.org; sotto: foto Gianni Mortara,
19.12.2015).

8.
Il margine netto e frastagliato del Ghiacciaio del Signal segue
esattamente l’orlo della nicchia di distacco. Ciò lascia intendere che
porzioni di ghiaccio di spessore plurimetrico siano state coinvolte
nel crollo (foto P. Lometti,
www.lavalledelrosa.it, 21.12.2015).
Il ramo più attivo della frana è risultato essere quello più
occidentale, al cui sbocco si è formato un vistoso cono detritico. In
occasione del sopralluogo effettuato il 19 dicembre 2015, nel canalone
si sono osservate tracce evidenti del passaggio di acque di fusione
(Fig. 9).

9. Traccia lasciata da acqua di fusione nel
grande canalone che collega la nicchia di distacco
alla base del versante (f. Gianni Mortara, 19.12.2015).
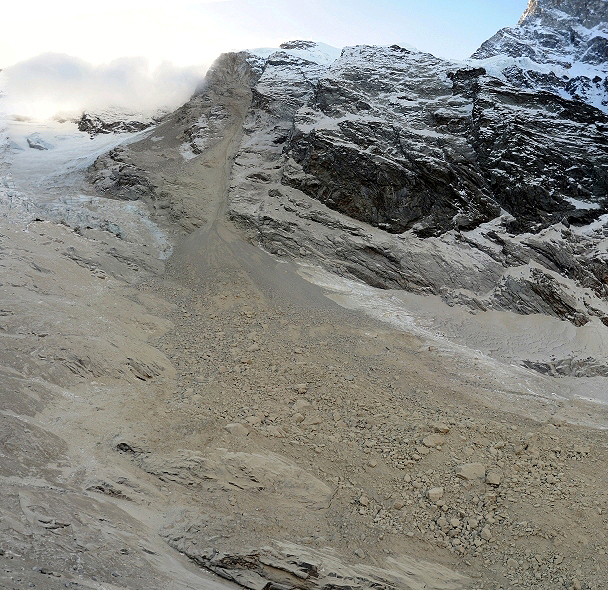
10.
Il deposito di frana presenta settori a differente granulometria che
localmente appare particolarmente grossolana, con blocchi di
dimensioni metriche e plurimetriche
(f. Andrea Tamburini, 01.01.2016).

11. La parte distale dell’accumulo di frana (evidenziata in
rosso) è in parte sovrascorsa sulla superficie ghiacciata del Lago
delle Locce. Non si può escludere che, in assenza di
questa tavola di ghiaccio spessa 10-15 cm, l’impatto della frana nel
lago avrebbe potuto generare un’onda di sommersione, sia pure di
modesta energia
(f. Gianni Mortara, 19.12.2015).
La nube di polvere prodotta dal crollo ha depositato una patina
rossastra di spessore millimetrico sul manto nevoso circostante (Fig.
12-13),
propagandosi a valle fino a raggiungere la piana dell’Alpe Pedriola.

12. I seracchi del
Ghiacciaio Settentrionale delle Locce, ricoperti da un deposito di
polvere di spessore millimetrico. In alto a destra è visibile parte
dell’accumulo di frana
(f. Gianni Mortara, 19.12.2015).

13.
Le impronte lasciate dalla guida alpina Lamberto Schranz durante il
sopralluogo del 19 dicembre 2015 rivelano il sottile strato di polvere
che ha ricoperto la superficie innevata
(f. Marta Chiarle).
La webcam collocata dall'associazione
Meteo Live VCO in collaborazione con il
CNR-ISE
alla biforcazione dei lobi terminali del Ghiacciaio del Belvedere, ha
ripreso, alle prime luci del 17 dicembre, l’area coinvolta dal crollo
(Fig. 14 b),
nonché le ripetute scariche che si sono susseguite nei giorni e nelle
settimane successive. Particolarmente degne di nota sono state le
repliche del pomeriggio del 18 dicembre 2015, quando la nube
polverosa, trasportata dal vento, ha raggiunto l’abitato di Macugnaga,
e dell'8 gennaio 2016, intorno alle ore 12.30 (Fig. 15). La cortese
disponibilità del Sig. Luca Sergio, attento gestore della webcam e
dell’annessa stazione meteorologica, ha consentito di accedere anche
alle registrazioni precedenti l’evento (Fig. 14 a).


14 a, b. L’area interessata dal distacco il 15 dicembre
(sinistra) e il 17 dicembre 2015 (destra) alle ore 7:46 (fonte:
Meteo Live VCO).

15.
Immagine ripresa in diretta durante la prolungata replica dell'8
gennaio 2016, ore 12.30. Il contrasto cromatico con le aree innevate
evidenza i settori di frana maggiormente attivi (f. M. Cornaggia).
Alcune avvisaglie di instabilità del settore interessato dalla frana
del dicembre 2015 erano state osservate a metà agosto 2015, quando una
nevicata precoce in alta quota aveva consentito di notare una striscia
di detriti proveniente dalla porzione medio-superiore della Punta Tre
Amici (fonte:
Meteo Live VCO).

16. La nicchia di distacco della frana
ripresa dalla sommità della morena laterale destra del Ghiacciaio
delle Locce il 1° gennaio 2016 (f. Andrea Tamburini).
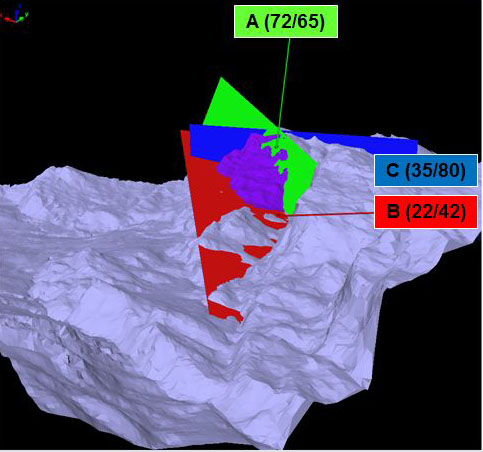
17. Modello 3D della nicchia di distacco (DEM Lidar Regione
Piemonte, 2010), che presenta la situazione precedente al crollo; i
tre piani colorati A-B-C rappresentano schematicamente i limiti del
volume crollato e corrispondono ai sistemi di discontinuità principali
lungo i quali si è verificato presumibilmente il distacco. In colore
viola il settore mancante
(elaborazione di Davide Martelli).
Nelle due immagini qui sopra vengono rispettivamente proposte una ripresa di
dettaglio della nicchia di distacco e il corrispondente modello
tridimensionale ottenuto dall’elaborazione dei risultati del volo Lidar Regione Piemonte 2010. Il modello tridimensionale
(Fig. 17) si riferisce
naturalmente alla situazione precedente al distacco, e la sua analisi
ha consentito di effettuare una stima del volume crollato ed
identificare, tra i sistemi di discontinuità che scompongono l’ammasso
roccioso, quelli che possono aver avuto un ruolo nel controllare il
fenomeno.
Da un punto di vista geometrico, i sistemi di discontinuità
individuati, attraversando l’ammasso roccioso, potrebbero isolare un
ulteriore volume coinvolgente il settore orientale della Punta Tre
Amici, non visibile nella ripresa fotografica di Fig. 16.
Ci si
potrebbero quindi aspettare ulteriori crolli di volume considerevole.
Il continuo verificarsi di crolli, sia dalla nicchia di distacco
principale che dal settore non visibile della porzione sommitale della
Punta Tre Amici, assieme alle riprese della cima scattate da aereo (Fig.
18) e
le osservazioni effettuate nel corso dei sopralluoghi alla frana,
sembrerebbero confermare questa ipotesi.
In base alle valutazioni preliminari effettuate, il volume crollato
potrebbe essere dell’ordine dei 200.000 m3.

18. Questa ripresa aerea consente la visione
dell’intera nicchia di distacco, compresa la porzione più orientale,
non osservabile dal fondovalle. Si possono apprezzare i principali
sistemi di discontinuità che scompongono l’ammasso roccioso, il quale,
localmente, si presenta molto fratturato e suscettibile di ulteriori
crolli
(f. Ettore Schranz, 28.12.2015).
L’evento attuale è la replica, ben più importante, del crollo che
aveva già coinvolto la Punta Tre Amici il 26 settembre 2010 (Cat Berro
et al., 2014; Mortara, 2010). In quell’occasione fu interessata la
porzione più occidentale della parete (Fig. 19), già imbiancata da una nevicata
precoce. L’accumulo di questa frana (circa 100.000 m3 secondo Fischer
et al., 2013) è stato totalmente obliterato dal crollo del dicembre
2015.
Il settore di parete interessato dai crolli del 2010 e 2015 è
caratterizzato da condizioni di permafrost, secondo quanto indicato
nell’Alpine Permafrost Index Map
(Boekli et al., 2012).


19. (a sinistra) I
settori di parete coinvolti dal crollo del 26 settembre 2010 (in
rosso)
e del 16-17 dicembre 2015 (in giallo). F. Gianni Mortara,
29.09.2010.
20. (a destra) L’accumulo della frana del 2010 si era arrestato
a poche decine di metri dalla sponda del Lago delle Locce (f. Ettore Schranz, 26.09.2010).
Anomalie climatiche del periodo:
breve raffreddamento in un periodo estremamente mite
Il tardo autunno 2015 sulle Alpi è stato segnato da persistenti
anticicloni subtropicali, dunque mitezza eccezionale e assenza
di nevicate, come descritto in dettaglio in
questo approfondimento.
In particolare un periodo di tepori estremi si è osservato nei giorni
intorno al 10 novembre (Fig. 21), di entità mai rilevata in precedenza in quel
periodo, con temperature di circa 7 °C a circa 3000 m in libera
atmosfera al di sopra del Nord Italia e del Monte Rosa, dunque con
valori termici ampiamente sopra 0 °C e probabile presenza di acqua liquida
ancora in circolazione anche alla quota del distacco della frana
(circa 3400 m).
A fine novembre è intervenuto un temporaneo intervallo freddo
(-15 °C a 3000 m) recato da un'irruzione di venti settentrionali,
seguito da settimane nuovamente più miti in dicembre, tuttavia
senza più raggiungere gli estremi del mese precedente, mentre intanto
continuava la straordinaria carenza di neve, limitata a pochi
centimetri sui versanti in ombra.
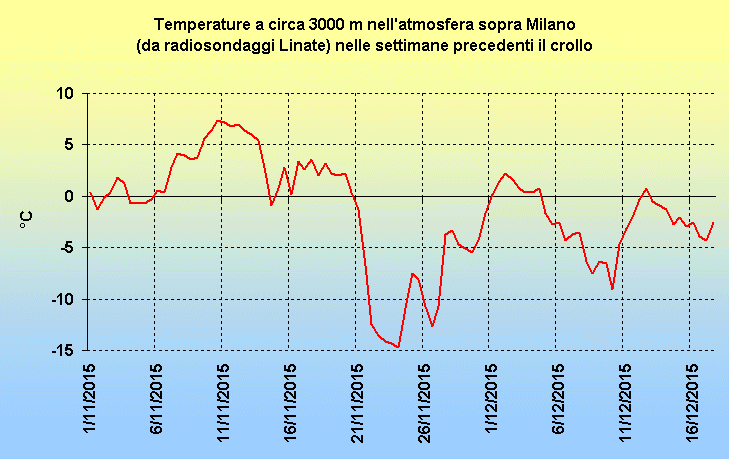
21. Evoluzione delle temperature misurate tra il
1° novembre e il 17 dicembre 2015 a circa 3000 m tramite i
radiosondaggi eseguiti all'aeroporto di Milano-Linate.
Evidente la persistenza di temperature anomale, quasi sempre sopra 0
°C, nelle prime due decadi di novembre, seguite da un improvviso
raffreddamento a fine mese, e poi dal ritorno di valori nuovamente più
elevati (sebbene meno estremi) in dicembre
(elaborazione dati SMI).
Alcune considerazioni
Il versante della Punta Tre Amici che si affaccia sul Lago delle Locce
denota da alcuni anni una manifesta instabilità naturale. Lo
testimoniano sia gli importanti crolli del settembre 2010 e del
dicembre 2015, sia le colate detritiche che, nel periodo estivo,
prendono in carico il detrito di frana presente nei canaloni rocciosi
e sul ghiacciaio, espandendosi alla base del versante prevalentemente
in direzione del Lago delle Locce.
Al momento, in assenza di un accurato controllo visivo ravvicinato,
non è possibile stabilire con precisione:
1) la reale estensione dell’area in frana e
quindi i volumi rocciosi effettivamente coinvolti;
2) lo spessore dell’accumulo;
3) l’assetto geo-strutturale e lo stato di fratturazione dell’ammasso roccioso in
prossimità della nicchia di distacco;
4) l’eventuale presenza di
fessure perimetrali di neoformazione e di ghiaccio interstiziale.
Con riferimento all'andamento delle temperature nelle settimane precedenti l'evento
(Fig. 21), si può avanzare l'ipotesi che la causa di questo
tipo di fenomeni sia da ricercare non tanto direttamente nei tepori
eccezionali che nel complesso hanno caratterizzato il periodo, quanto nel
temporaneo ma considerevole abbassamento della quota dell'isoterma 0 °C
registrato nell'ultima decade di novembre.
Il conseguente
congelamento potrebbe aver temporaneamente sigillato
in prossimità della superficie le vie di deflusso dell'acqua
circolante entro il reticolo di fratture che scompongono l'ammasso
roccioso, provocando l'aumento delle pressioni interstiziali
all'interno dell'ammasso stesso e causandone la destabilizzazione.
Tale meccanismo è stato invocato in più occasioni per spiegare il
verificarsi di fenomeni di crollo in altri settori della catena alpina
occidentale all'inizio della stagione invernale (Mont Crammont, 24 dicembre 2008;
Brenva, 18 gennaio 1997).
Con il ritorno della stagione primaverile e del disgelo, valanghe,
acque di fusione nivo-glaciale e piogge potrebbero mobilizzare il
materiale di frana presente sul versante roccioso. In tal caso colate
detritiche potrebbero raggiungere il Ghiacciaio delle Locce e le
sponde del lago omonimo, né si possono escludere altri crolli
rocciosi.

22.
Nel luglio 2011 un forte evento pluviometrico in quota ha mobilizzato
l’accumulo della frana del 2010 generando una notevole colata
detritica che si è in parte sovrapposta all’accumulo stesso. Eventi
come questi stanno conferendo al Ghiacciaio Settentrionale delle Locce
l'aspetto tipico di un "ghiacciaio nero", o debris-covered glacier
(f. Gianni Mortara).
I fenomeni qui descritti possono costituire motivo di rischio per
quanti sostano o transitano alla base del versante o lungo la sponda
meridionale del Lago delle Locce, settore frequentato in ogni stagione
dell’anno da escursionisti, alpinisti, scialpinisti (Fig. 23-24). Va anche valutata
la possibilità che la configurazione morfologica assunta dal versante
a seguito del crollo sia predisponente all’innesco di valanghe da un
settore in precedenza non interessato.
Inoltre, la presenza del Lago delle Locce al piede del versante
rappresenta un elemento di ulteriore criticità nel caso in cui
dovessero verificarsi crolli di dimensioni superiori a quello del
dicembre 2015, per la possibilità che si producano onde anomale nel
lago. Si consideri anche che l’attuale sfioratore del lago si presenta
in condizioni di per sé critiche, a seguito degli effetti di erosione
rimontante documentati nel corso di questi ultimi anni.
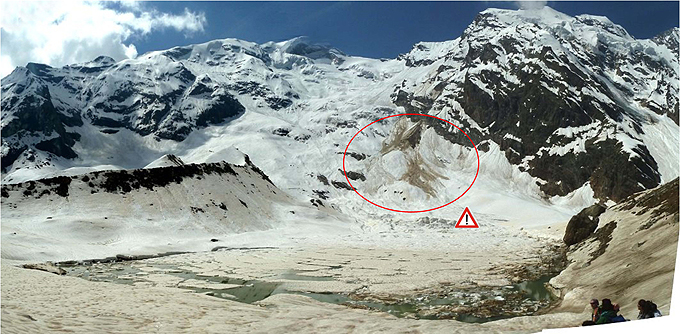
23. Il Lago delle Locce e la testata del bacino
glaciale omonimo, il 20 giugno 2013
(f. Francesco Rota Nodari, SGL).
Nonostante l’aspetto ancora pienamente invernale, alla base della
parete della Punta Tre Amici sono già presenti accumuli detritici di
neoformazione allo sbocco del canalone coinvolto dal crollo del
settembre 2010
(e nuovamente nel dicembre 2015).

24.
L’accumulo di valanga abitualmente presente fino a inizio estate
sulla sponda meridionale del Lago delle Locce costituisce un forte
richiamo per gli escursionisti. Nell’immagine si notano numerose
persone sostare incautamente proprio nella zona di arresto delle frane del
settembre 2010 e del dicembre 2015, nonché della colata detritica del
luglio 2011
(f. Marta Chiarle, 20.08.2013).
Il crollo del dicembre 2015 non rappresenta un fenomeno straordinario
per l’ambiente in cui si è sviluppato. Gli ambienti glacializzati e in
via di deglaciazione si sono infatti dimostrati in questi ultimi anni
particolarmente vulnerabili alle modificazioni climatiche e ambientali
in atto per effetto del riscaldamento globale.
Il bacino glaciale del
Belvedere, in particolare, è stato teatro negli ultimi 10-15 anni di
una considerevole sequenza di episodi d’instabilità di varia natura
(rotte glaciali, valanghe di ghiaccio e di roccia, collassi di morene,
colate detritiche) che, tutti, hanno trovato condizioni predisponenti
nei rapidi cambiamenti avvenuti a carico della criosfera (neve,
ghiacciai e permafrost), con particolare intensità a partire dagli
Anni 1990 (Mortara & Tamburini, 2009).
Considerando il trend in atto a scala globale, fenomeni d’instabilità
come quello qui analizzato potrebbero riproporsi nello stesso settore
o in altre parti dell’ampia testata della Valle Anzasca ed è pertanto
opportuno mantenere un elevato grado di attenzione sull’area, al fine
di consentire una frequentazione in ragionevoli condizioni di
sicurezza di uno dei più affascinanti ambienti delle Alpi.
Bibliografia
Boeckli L., Brenning A., Gruber S., Noetzli J., 2012 - Permafrost
distribution in the European Alps: calculation and evaluation of an
index map and summary statistics.
The Cryosphere, 6, 807- 820.
Cat Berro D., Mercalli L., Mortara G., Tamburini A., Mosello R.,
Rogora M., 2014 -
I ghiacciai dell’Ossola: una breve sintesi. Nimbus,
XXII, 72, 130-138.
Fischer L., Huggel C., Kääb A., Haeberli W., 2013 - Slope failures and
erosion rates on a glaciarized high-mountain face under climate
changes. Earth Surf. Process. Landforms, 38, 836-846.
Mortara G. - Il crollo del 26 Settembre 2010 dai contrafforti
nord-orientali della Punta Tre Amici (testata della Valle Anzasca,
Macugnaga). CNR-Irpi Torino, Rapporto inedito,
12 ottobre 2010.
Mortara G., Tamburini A., a cura di, 2009 - Il Ghiacciaio del
Belvedere e l'emergenza del Lago Effimero. SMS, Collana Memorie
dell'Atmosfera, n.8, 190 pp.
Si ringraziano per la preziosa collaborazione: Lamberto e
Ettore Schranz, Clarissa Sgarbi, Gianni Tagliaferri, Maurizio Vittone,
Luigi Corsi, il personale della seggiovia del Belvedere, Massimo
Cornaggia, Piero Lometti, Michela Rogora, Stefano Perona, Paolo
Federici.
Devolvi il 5 per mille alla SMI!
Sosterrai
le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,
e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|