|
Lunedì 17 giugno
2019 l'équipe della Società Meteorologica Italiana - in collaborazione
con IREN Energia
e l'Ente Parco Nazionale
del Gran Paradiso, e nel quadro delle campagne di misura del
Comitato
Glaciologico Italiano - ha condotto i consueti rilievi di spessore e
densità del manto nevoso per la determinazione del bilancio invernale
sul ghiacciaio Ciardoney.
La stagione di
alimentazione nevosa è stata caratterizzata da abbondanti nevicate a
fine ottobre-novembre 2018 e nell'aprile 2019, intervallate da un
lungo periodo di precipitazioni scarse tra dicembre 2018 e marzo 2019.

17 giugno 2019: dopo
un'alba serena, nubi cumuliformi si sviluppano rapidamente sopra al
Ghiacciaio Ciardoney, senza tuttavia disturbare i rilievi nivometrici
e l'elitrasporto di personale e attrezzature.
Il
freddo inconsueto di maggio 2019 ha poi determinato - rispetto
alle calde primavere recenti - un certo ritardo nell'avvio della
fusione della neve, che il 17 giugno 2019 sul ghiacciaio era spessa
tra 305 cm (pendio frontale, 2900 m) e 440 cm (Colle Ciardoney, 3100
m), valori circa 20% superiori alla media del periodo 1992-2018,
con densità variabili tra 445 kg/m3 (settore
mediano) e 657 kg/m3 (Colle Ciardoney).
A causa della frequente instabilità
atmosferica che a fine primavera rendeva difficile l'accesso al
ghiacciaio, le misure sono avvenute con una decina di giorni di
ritardo rispetto al solito, tuttavia - essendo cominciati solo da
pochi giorni il caldo estivo e la fusione nivale in alta quota - la
situazione riscontrata alla data del sopralluogo si può considerare
rappresentativa del massimo accumulo nivale a fine stagione.
L’equivalente d’acqua mediato sull’intero
ghiacciaio (bilancio invernale) era di 1780 mm,
(+45% rispetto alla media 1992-2018, pari a 1220 mm), e indicativo di
una buona disponibilità idrica per gli utilizzi idroelettrici
nell'estate 2019.
Tuttavia saranno le temperature estive a decidere il bilancio
finale, ovvero se una parte di questa neve riuscirà o meno a
conservarsi per alimentare un ghiacciaio in agonia...

17 giugno 2019, ore 8,30: vista dal Colle
Ciardoney in direzione Sud, verso la Valle Orco e le basse Valli di
Lanzo. Il cielo è sereno sotto un blando anticiclone che interessa le
Alpi.
Si noti, sullo sfondo, la coltre di caligine e fumi che staziona sopra
la pianura piemontese.
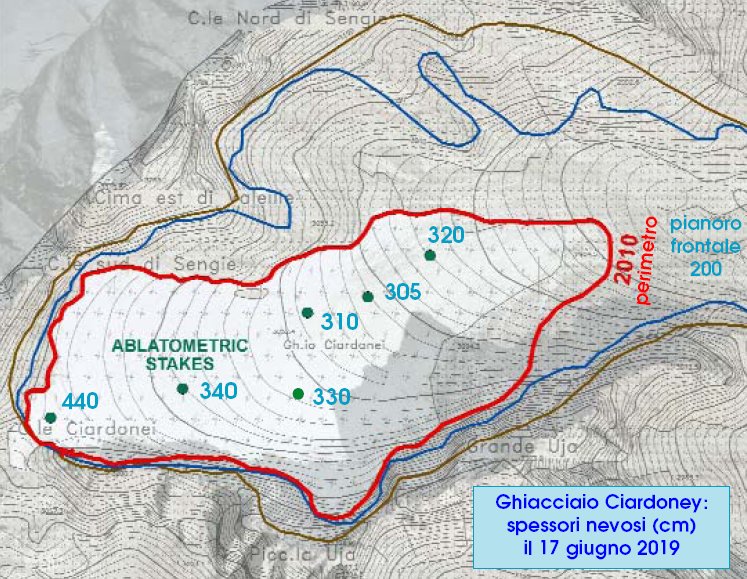
Spessori nevosi rilevati il 17 giugno
2019: graduale decremento dai 440 cm del Colle Ciardoney ai 305 cm
del pendio frontale (sito n. 6), poi nuovo lieve aumento più a valle,
in corrispondenza della fronte (320 cm, sito n. 7), dove spesso si
verificano accumuli nevosi più consistenti per valanghe o trasporto
eolico.
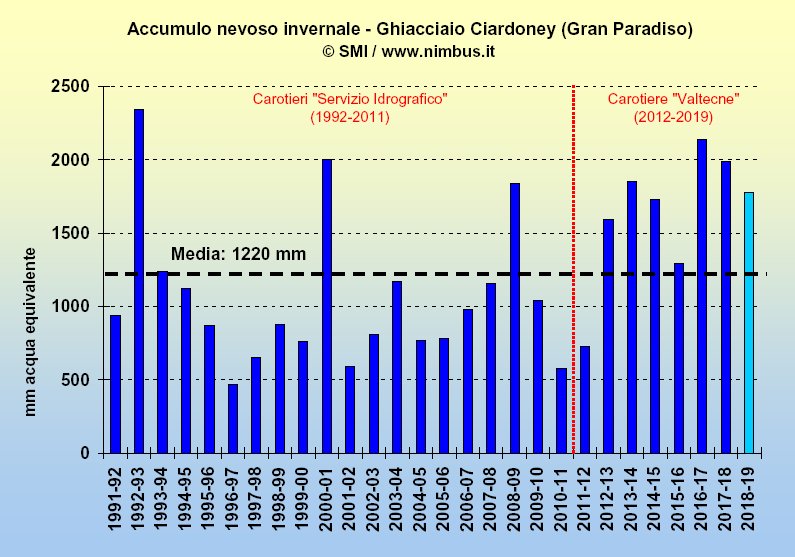
Serie degli
accumuli invernali specifici sul ghiacciaio Ciardoney, espressi in mm
di lama d’acqua equivalente, nelle stagioni idrologiche dal 1991-92 al
2018-19:
il valore di 1780 mm del 2018-19 si colloca in settima posizione.
L'utilizzo nel tempo di tubi carotieri con caratteristiche diverse
potrebbe aver introdotto disomogeneità nella serie degli accumuli
invernali, con possibili sottostime in alcune annate antecedenti il
2012 (anno di adozione dell'ottimo carotiere "Valtecne"),
ma non vi
sono comunque dubbi che gli accumuli nevosi di diversi inverni
recenti, segnati da importanti precipitazioni, figurino tra i più
abbondanti dal 1992 (benché poi sempre vanificati dalla massiccia
fusione di stagioni estive troppo calde).

Ore 8,30: si inizia
a lavorare per la misura di spessore, densità ed equivalente in acqua
del manto nevoso. Come sempre, i rilievi vengono effettuati a partire
dal Colle Ciardoney, alla quota più elevata del ghiacciaio (3100 m).
Luca Mercalli, presidente SMI, e Raffaella Miravalle, guardaparco del
Gran Paradiso, inseriscono il tubo carotiere "Valtecne"
per il prelievo dei campioni di neve lungo tutto il profilo del manto
depositatosi nell'inverno 2018-19, fino a toccare la superficie di
ghiaccio che affiorava nel settembre 2018.

I primi tre metri
di carotiere sono completamente inseriti nel manto nevoso ...

... ma in totale qui la neve è spessa 440
cm, dunque occorre spalare fino a 140 cm di profondità per poter
giungere - con il carotiere da 3 m - fino alla base del manto,
in modo da campionarlo lungo tutto il suo profilo.

Luca Mercalli
sorregge una delle "carote" di neve estratte e pesate al Colle
Ciardoney:
la densità del manto nevoso è di 657 kg/m3. In questo punto
alla sommità del ghiacciaio si misurano sempre le densità più elevate,
per la presenza di strati di neve molto compattati dall'azione eolica
durante le burrasche invernali ("lastroni" da vento).

Raffaella Miravalle
(Parco Nazionale Gran Paradiso) prosegue con le misure di spessore
nevoso tramite sonda da valanga, seguendo il consueto transetto
Ovest-Est lungo il ghiacciaio, verso la fronte.

Nel settore mediano
del ghiacciaio (in prossimità della palina ablatometrica n. 2, sepolta
dalla neve in questa stagione), si esegue un secondo carotaggio del
manto nevoso, che fornisce una densità di 445 kg/m3 (neve
meno compatta e pesante).
Un terzo prelievo, sul pendio frontale, rivelerà una densità di 577
kg/m3.

Il
videomaker Erik Gillo
riprende e intervista Luca Mercalli sui primi risultati delle misure
nivometriche e sulle relazioni tra cambiamenti climatici e ghiacciai.

Ci si avvicina alla
fronte glaciale, e il lavoro è quasi terminato. Sono le 10,30, cumuli
si formano anche al margine del pianoro frontale, tuttavia l'atmosfera
è anticiclonica e relativamente stabile, per cui il loro sviluppo è
limitato e non degenera in situazioni temporalesche.

Un segno delle
vigorose correnti ascensionali caratteristiche dei mesi estivi
(brezze termiche diurne o violenti moti verticali dell'aria
all'interno dei temporali) è dato dal trasporto da valle fino ad alta
quota di numerosissimi insetti, in gran parte destinati a soccombere
per le temperature troppo fredde di un ambiente per loro inospitale.
Qui un'esemplare di
Vanessa cardui, farfalla che in tarda primavera migra
dall'Africa all'Europa centrale (info guida ambientale Luca Anselmo,
collaboratore Parco Alpi Cozie), rivenuta morta sulla superficie
innevata del Ciardoney a circa 2950 m.

Il Ghiacciaio
Ciardoney ripreso dall'asta nivometrica presso la
stazione meteorologica a valle della fronte, a quota 2850 m. Sul pianoro
frontale durante il sopralluogo del 17 giugno 2019 la neve era ancora
spessa 200 cm (situazione simile solo al caso del 2013, negli ultimi 7
anni di teleosservazione da webcam, vedi grafico sotto), e non vi era
ancora traccia di imminente apertura del canale di deflusso del
torrente glaciale (tuttavia probabilmente già attivo sotto la coltre
nevosa).
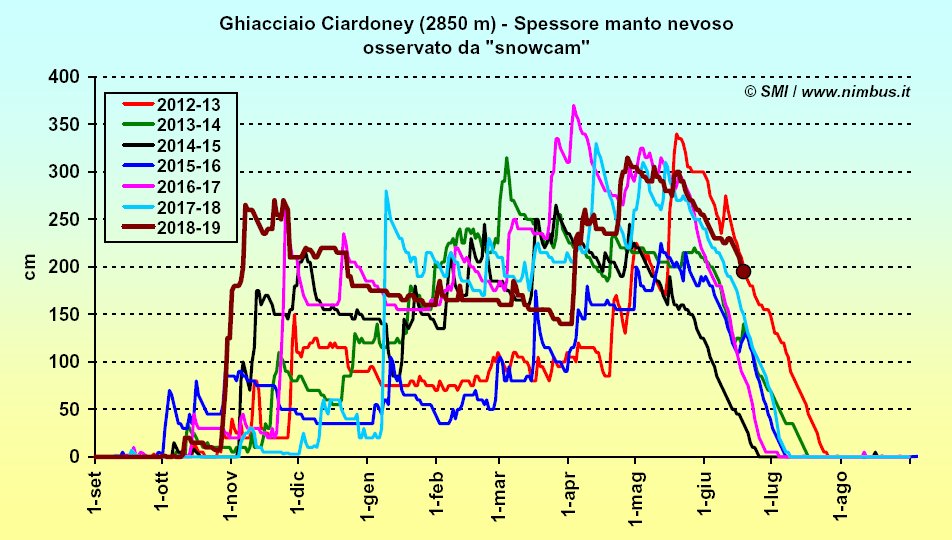
Andamenti
giornalieri dello spessore nevoso totale al suolo osservato
tramite la
“snowcam” presso la stazione meteorologica a 2850 m nelle ultime
sette stagioni idrologiche (monitoraggio disponibile dall’inverno
2012-13).
La linea marrone della stagione 2018-19 mostra la precoce
formazione di un potente manto nevoso con le intense perturbazioni di
fine ottobre-inizio novembre 2018, tra cui la
tempesta "Vaia" del 29 ottobre (265 cm totali al suolo già il 6
novembre, massimo per il periodo nella pur breve serie di
osservazione), dopodiché i mesi invernali, in assenza di altre
nevicate importanti, hanno visto una lenta diminuzione di spessore.
Come quasi sempre avviene, copiose nevicate sono riprese in
primavera, e hanno portato il manto nevoso al massimo
stagionale di 315 cm del 27 aprile 2019.
Tra maggio e inizio giugno 2019 la fusione è stata piuttosto lenta a
causa delle temperature fresche, e alla data del sopralluogo
(17 giugno) vi erano ancora 200 cm in corrispondenza dell'asta
nivometrica, situazione analoga al 2013 (210 cm, alla stessa data).

Ore 11,30: il gruppo dedito alle
misure nivometriche sul ghiacciaio si ricongiunge a quello impegnato
nella manutenzione della stazione meteorologica automatica "Campbell",
che non ha manifestato avarie durante
l'inverno, ed è giunta al suo decimo anno di funzionamento.
Tuttavia, nonostante il consolidamento del basamento e dei tiranti di
controventatura eseguito un anno fa, le violente tempeste di vento (in
particolare
"Vaia" il 29 ottobre 2018), hanno strappato alcuni cavi in acciaio
e piegato leggermente il traliccio della stazione meteo, che sarà
oggetto di prossime riparazioni a fine estate.
Inoltre si è resa
necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione della webcam
(rimasta off-line dal 27 maggio 2019), pure esso strappato dalle
intemperie.
Si noti la leggera
tonalità ocra della superficie del manto nevoso, dovuta
alle polveri sahariane cadute soprattutto con le precipitazioni
sciroccali del 23 aprile 2019: la
conseguente diminuzione dell'albedo e dunque l'aumento
dell'assorbimento di radiazione solare da parte del manto nevoso è in
grado di rendere più rapida (a parità di temperatura dell'aria e di
radiazione solare incidente) la fusione della neve a inizio estate,
come attestato dallo studio
"Saharan dust events in the European Alps" coordinato da
ricercatori dell'Università di Milano-Bicocca e apparso nell'aprile
2019 su “The Cryosphere”.

L'armadietto
contenente gli apparati radio di trasmissione in tempo reale dei dati
meteo
e delle immagini della webcam.

Alla rottura di uno
dei tiranti di controventatura della stazione meteorologica ha
contribuito anche un fulmine, come mostrano le estremità annerite e
parzialmente fuse degli spezzoni di cavo. Per fortuna la scarica
elettrica non ha compromesso i sensori e l'elettronica della stazione,
che in 10 anni di misura non ha perso nemmeno un'ora di dati.
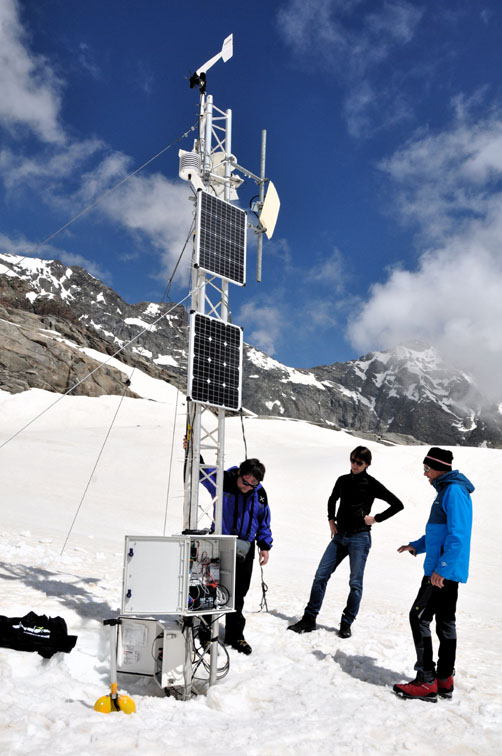
Luca Mercalli,
insieme ai tecnici-elettricisti Diego Marzo e Mario Berger, esamina lo
stato della stazione meteorologica, in vista delle ulteriori
manutenzioni (in particolare l'ulteriore stabilizzazione del
traliccio) che verranno eseguite con la prossima missione
di settembre 2019.

I pannelli
fotovoltaici, sostituiti nel 2018, erano in ottimo stato.

Ore 13: il gruppo di lavoro in attesa dell'elicottero per il rientro
alla centrale IREN di Rosone. Da sinistra, Daniele Cat Berro,
Raffaella Miravalle, Luca Mercalli, Diego Marzo, Mario Berger.

Ore 13,15: il recupero di personale e
attrezzature da parte di
Airstar
elicotteri.
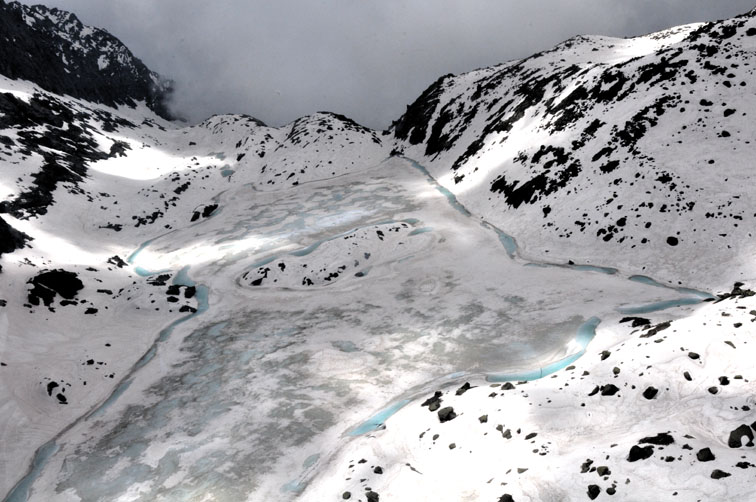
Durante il rientro verso il fondovalle
dell'Orco, si sorvola il remoto Lago di Motta
(2656 m, alto vallone di Valsoera), con il suo caratteristico isolotto
roccioso.
In prossimità delle rive, ai margini della coltre di ghiaccio
superficiale appaiono i primi segni di fusione.
Segui in in tempo reale la situazione
sul Ghiacciaio Ciardoney (dati
meteo e webcam)
Devolvi il 5 per mille alla SMI,
sosterrai le ricerche sul Ghiacciaio Ciardoney!

|