|
Per quanto la ricostruzione della dinamica glaciologica dell'evento
sia ancora in corso e richiederà tempo per un’analisi accurata,
l’ipotesi più accreditata tra i glaciologi chiama in causa la
penetrazione all’interno della massa glaciale – attraverso un
crepaccio poco sotto la vetta - di abbondante acqua di fusione
durante le recenti e anomale ondate di caldo, e il conseguente
generarsi di sovrapressioni in grado di “staccare” parte
del ghiacciaio e di innescarne il repentino collasso.
L'analisi delle
immagini raccolte subito dopo il distacco lascia presupporre la
formazione di una sacca d'acqua endoglaciale, il cui drenaggio
era forse ostacolato:
1) da un reticolo idrografico dai condotti ancora
poco sviluppati all'interno e alla base del ghiacciaio all'inizio dell'estate;
2) dal continuo processo di ricongelamento dell'acqua di fusione
a contatto con il ghiaccio "freddo" posto all'interno e alla base del
ghiacciaio.
Alla stazione meteorologica
ARPA Veneto a
Punta Rocca della Marmolada (3250 m, poco a monte del luogo del
fenomeno), salvo un’effimera e lieve gelata il 25 giugno 2022
(temperatura minima -0,5 °C), le temperature sono rimaste sopra 0 °C
per ben 23 giorni consecutivi (estremo di 13,1 °C il 20 giugno, e
circa 10 °C nel primo pomeriggio del 3 luglio), producendo fusione
intensa e anomala che peraltro aveva già spogliato quasi tutto il
ghiacciaio della (scarsa) neve invernale con un anticipo di oltre un
mese rispetto a stagioni passate già negative.
Alla
drammaticità dell’esito dell’evento, di per sé molto raro benché in
potenziale aumento di frequenza in questi tempi di riscaldamento
globale, hanno contribuito l’ora diurna e il giorno festivo,
propizi all’intensa frequentazione della zona.
Peraltro
l'ora del distacco si è collocata solo incidentalmente nelle ore
centrali della giornata: eventi che coinvolgono volumi di ghiaccio
così elevati, dotati dunque di grande inerzia termica, e in cui
probabilmente ha giocato un ruolo l'accumulo di acqua verificatosi in
svariati giorni se non settimane precedenti, difficilmente sono
connessi alle fluttuazioni di temperatura giorno/notte.
L'unico
precedente analogo sulle Alpi italiane negli ultimi decenni è
quello che avvenne il 6 luglio 1989 sulla parete Nord del
Monviso con il
collasso del Ghiacciaio Superiore di Coolidge, che - a
differenza di stavolta - non fece vittime anche grazie all’ora
notturna e al giorno infrasettimanale in cui avvenne (due alpinisti
monegaschi che pernottavano al bivacco Falchi-Villata, poco discosto
dalla traiettoria della valanga di ghiaccio, rimasero illesi).


Il Ghiacciaio Superiore di Coolidge
(Monviso) prima e dopo il collasso
dell'8 luglio 1989 che coinvolse un volume di ghiaccio di circa
250.000 m3
(foto settembre 1987 di Mattia Vanzan, archivio CGI; foto luglio
1989
di Roberto Tibaldi,
studio fotografico
"Immaginare", Bra - CN).
Leggi anche la
nota di Mortara & Dutto apparsa nel 1990 su
Geografia Fisica
e Dinamica Quaternaria, bollettino del
Comitato
Glaciologico Italiano.
EVENTO
IMPREVEDIBILE: FUORI LUOGO CERCARE RESPONSABILI,
CHIUDERE ALTRE MONTAGNE
E INTRODURRE BOLLETTINI DI RISCHIO GLACIALE
Per quanto in
stagioni molto calde come questa - con intensa e precoce fusione e
deglaciazione - e nel quadro del riscaldamento globale attuale, la
frequentazione della montagna glaciale e periglaciale presenti in
generale rischi maggiori, tra cui appunto il collasso di porzioni di
ghiacciai sospesi e/o ripidi, nessun elemento lasciava presagire
che proprio lì e in quel momento (rispetto ad altri ghiacciai in
condizioni analoghe da un capo all’altro delle Alpi) potesse
verificarsi un evento di tale portata.
Pertanto
riteniamo del tutto fuori luogo tanto la ricerca di responsabilità
quanto la richiesta, più volte sollevata dall'opinione pubblica e
da esponenti politici, di una discutibile "messa in sicurezza" del
territorio tramite indiscriminate chiusure degli accessi ai
ghiacciai o l'introduzione di scale di pericolo glaciologico,
di pressoché nulla significatività scientifica ed efficacia pratica.
Infatti, a differenza delle valanghe invernali di neve, maggiormente
prevedibili con livelli
di pericolo differenti da una regione alpina all'altra sulla base
di parametri nivo-meteorologici, il verificarsi di episodi di
rischio glaciale è altamente aleatorio e dipendente da un insieme di
fattori (meteo-climatici, morfologici e di fisica del ghiaccio)
molto locali, complessi e mutevoli nel tempo e da ghiacciaio a
ghiacciaio.
Il solo fatto
che da molti giorni grandi quantità d'acqua di fusione rombassero
all'interno del ghiacciaio della Marmolada - situazione peraltro
comune alla maggior parte dei ghiacciai alpini in estati roventi
come quella del 2022! - non era sufficiente per immaginare il collasso
di una parte dell'apparato glaciale che non mostrava anomalie
morfologiche di sorta, dunque neanche per diramare la preventiva
interdizione dell'accesso alla montagna.
Nemmeno è
immaginabile un monitoraggio geofisico costante e dettagliato di tutti
i 4400 ghiacciai delle intere Alpi (italiane e non), sia per i
numeri astronomici dei costi e del personale tecnico necessario, sia
perché questo non garantirebbe di accorgersi in tempo di fenomeni il
cui innesco rimane difficilmente prevedibile e localizzabile.
Ciò d'altra
parte non significa affatto che la ricerca e il monitoraggio
glaciologici siano inutili. Questi garantiscono infatti il continuo
miglioramento delle conoscenze sullo stato della criosfera (neve,
ghiacciai, permafrost) e sulla sua complessa risposta ai
cambiamenti climatici in corso, nonché l'adozione di misure di
protezione civile in caso di ghiacciai di pericolosità nota ed
esplicita, già sede di precedenti episodi di instabilità (come il
ghiacciaio di Planpincieux in Val Ferret/Monte Bianco, monitorato da
Fondazione Montagna Sicura per il pericolo di crolli di porzioni
di ghiaccio su strade, infrastrutture ed edifici sottostanti).
Di certo
l'evento del 3 luglio, inquadrato in un periodo di intenso e rapido
riscaldamento atmosferico che pone la criosfera in condizioni di
forte disequilibrio, apre una nuova era nella percezione dei
rischi glaciali, e anche ghiacciai che - come quello della
Marmolada - per quanto penalizzati dalla deglaciazione, apparivano
finora scevri da instabilità di sorta, andranno guardati con altri
occhi, da parte sia dei ricercatori sia dei frequentatori dell'alta
montagna.
Leggi gli
articoli di Luca Mercalli apparsi su
Il Fatto
Quotidiano e dedicati all'evento
della Marmolada (5 luglio 2022) e ai
rischi glaciali nelle Alpi (6 luglio 2022).
GLACIORISK (2001-2003):
UN PROGETTO EUROPEO
PER CENSIRE E MONITORARE I RISCHI GLACIALI
I rischi glaciali sulle montagne europee, dalle Alpi
alla Scandinavia, sono stati oggetto di un progetto europeo dipanatosi
negli anni dal 2001 al 2003, al quale partecipò anche la Società
Meteorologica Italiana proprio mentre erano in corso le crisi dovute
alla formazione dei laghi effimeri dei ghiacciai del
Belvedere (Monte Rosa) e del
Rocciamelone (Alpi Graie).
Il progetto sfociò nella compilazione da parte dei
singoli partner del
database Gridabase contenente tutte le informazioni
disponibili sugli episodi pregressi di instabilità glaciale
(crollo di seracchi/ghiacciai sospesi, svuotamento improvviso di laghi
sbarrati da ghiaccio o da morene...). Il ghiacciaio della Marmolada
non rientrava tra quelli censiti come pericolosi in base alla storia
glaciologica nota.
Un aggiornamento del database con gli eventi di instabilità più
recenti è in corso (luglio 2022).
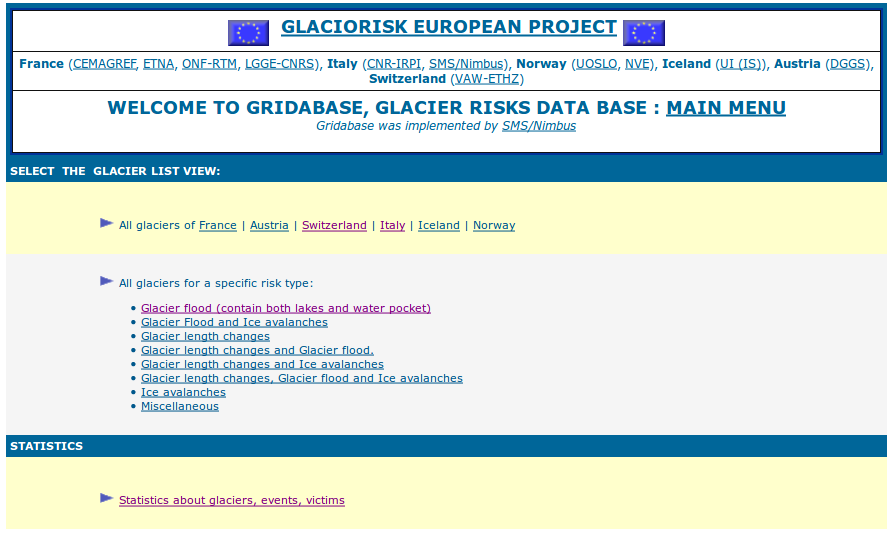
Quello della Marmolada è, per numero di vittime (11), il peggior
evento di instabilità glaciale storicamente noto sulle Alpi italiane,
rappresentando quasi metà delle vittime complessive (23) note per
precedenti eventi glaciologici dal XV secolo in poi, tra valanghe di
ghiaccio e svuotamento di laghi glaciali! (vedi le statistiche
qui, suddivise per categorie di rischio e per Paese; aggiornamento
degli eventi italiani in corso nel luglio 2022).
Ulteriori risorse sui rischi in area glaciale e
periglaciale sulle Alpi occidentali (Valle d'Aosta e province di
Torino e Cuneo) si trovano anche sul sito del più recente
progetto Alcotra
IT-FR Glariskalp.
ALTRE RISORSE SULL'EVENTO DELLA MARMOLADA
Dinamica dell'evento secondo il CNR-Istituto di Scienze Polari (CNR-ISP).
Video da drone
del settore sommitale del ghiacciaio della Marmolada ripreso dalla
Commissione Glaciologica SAT il giorno precedente all'evento del 3
luglio (senza che si potessero individuare indizi di imminente
collasso).
Stima preliminare del volume di ghiaccio crollato (CNRS/Observatoire
Midi Pyrenées).
Riflessioni di Luca Bonardi (Università degli Studi di Milano e
Servizio Glaciologico Lombardo), esperto in clima storico delle Alpi.
Ricostruzione video del crollo della Marmolada.
Dichiarazioni del WSL, Istituto federale di ricerca per la
foresta, la neve e il paesaggio (Svizzera).
Devolvi il 5 per mille alla SMI,
sosterrai le ricerche sul Ghiacciaio Ciardoney!

|