|
|
|
OSSERVATORI
METEOROLOGICI IN QUOTA |
|
.
|
|
IL GHIACCIAIO
CIARDONEY: UN SORVEGLIATO SPECIALE
Il
ghiacciaio Ciardoney si trova alla testata del vallone di Forzo
(bacino del Torrente Soana, tributario di sinistra del Torrente Orco),
angolo remoto del Parco
Nazionale del Gran Paradiso, al confine tra il Piemonte e la Valle
d'Aosta.
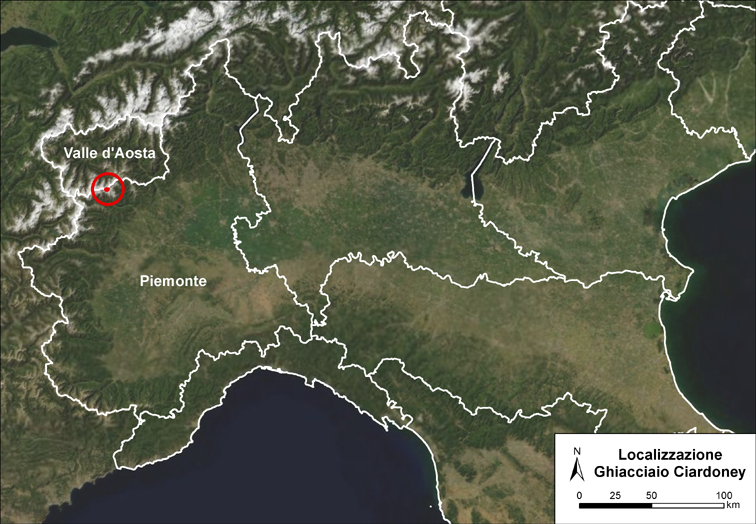
Nel
cerchio rosso il ghiacciaio del Ciardoney, nelle Alpi Graie.
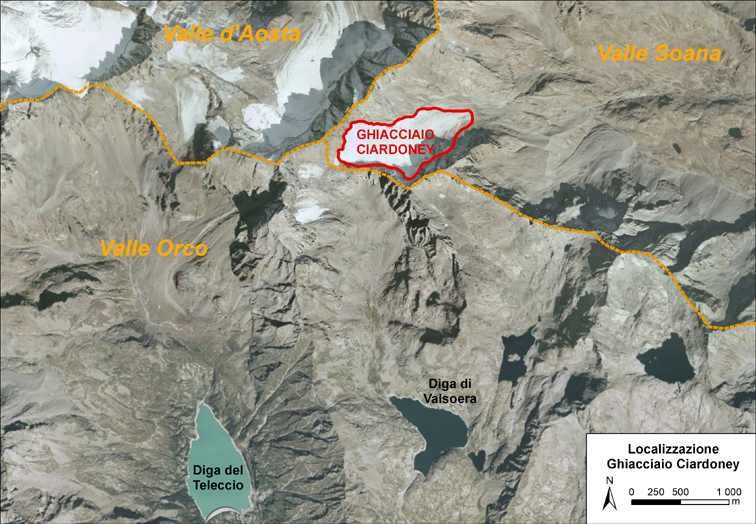
Come visibile nell'immagine satellitare, il ghiacciaio (in rosso) si trova al
confine tra le piemontesi Valli Orco e Soana e la Valle d'Aosta, non
distante dagli invasi idroelettrici
IREN del Teleccio e Valsoera.

Il ghiacciaio
ripreso nel suo insieme dalle roccette sovrastanti il Colle Ciardoney,
sulla sinistra.
La fronte glaciale, verso est, è visibile all'estrema destra
nell'immagine (6 agosto 2010, f. G. Badino).

Veduta generale del ghiacciaio dalla stazione fotografica S2, a pochi
metri
dalla stazione meteorologica (6 settembre 2010, f. SMI).
|
|
Secondo le più recenti misure effettuate
tramite GPS portatile, grazie al quale è stato possibile localizzare
alcuni punti significativi, il ghiacciaio Ciardoney risulta avere
attualmente una superficie di circa 0.58 km2,
collocandosi dunque al
3° posto
per estensione nelle valli Orco e Soana dopo i ghiacciai di Nel e
Noaschetta Occidentale.
L'inclinazione media è di 10°, la lunghezza massima di circa 1350 m,
la larghezza massima 580 m, presenza di pochi crepacci.
L'apparato si estende attualmente tra i 2850 e i 3140 m di quota e
l'altitudine mediana si colloca intorno ai 3040 m.
In base all'osservazione delle morene e alle fotografie d'epoca, è stato possibile ricostruire l'area del
ghiacciaio nel periodo di massima espansione della Piccola Età
Glaciale (anni 1820-50). Il ghiacciaio si estendeva verso nord ed est,
in zone attualmente del tutto scoperte, con un'area stimabile in
circa 1.7 km2,
quando la lingua si protendeva a oriente fino a circa 2650 m di
quota nei pressi dell'attuale Bivacco Revelli.
Grazie alla carta disegnata da F. Sacco nel 1939, è stato inoltre
possibile risalire all'area in un'epoca intermedia tra l'attuale e la
Piccola Età Glaciale, notando il già importante l'arretramento della
fronte e la perdita di spessore: dall'analisi cartografica risulta che
intorno al 1939 l'area potesse essere di circa 1.1 km2.
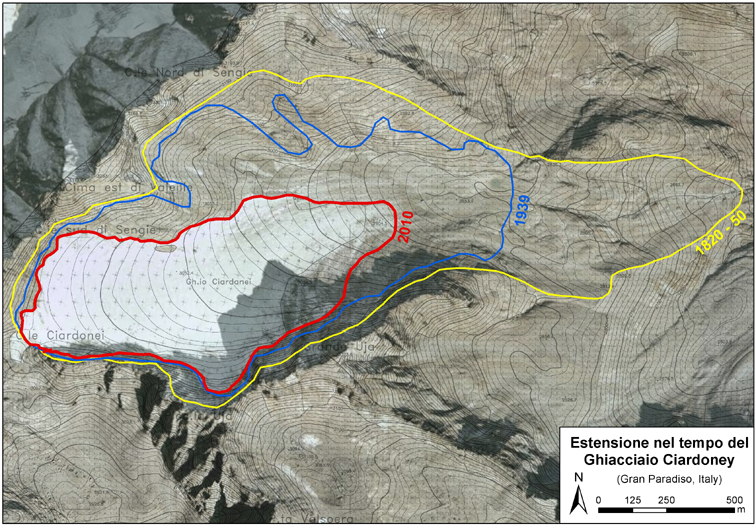
In rosso, l'area attuale ricostruita dalle immagini satellitari e dai
punti GPS georiferiti in situ.
In blu, l'area del 1939 ricostruita in base
alla cartografia di F. Sacco.
In giallo, l'area della
Piccola Età Glaciale desunta dall'apparato morenico ben individuabile.
Nonostante la posizione remota, le caratteristiche morfologiche del
ghiacciaio (soprattutto la superficie regolare a
scarsa pendenza e la crepacciatura limitata) lo rendono particolarmente
adatto ad essere percorso per le misure glaciologiche: fin dal
1985 il ghiacciaio è visitato con continuità da Luca Mercalli e Fulvio Fornengo nell'ambito delle campagne del
Comitato
Glaciologico Italiano, dopodiché dal 1992 è oggetto anche di
dettagliate ricerche sul bilancio di massa, condotte dagli operatori
della Società Meteorologica Italiana con il sostegno logistico di
Iren Energia e
del Parco Nazionale del
Gran Paradiso.
Ogni anno, tra fine maggio e inizio giugno, si misurano spessore e
densità della neve
accumulatasi nell'inverno, che rappresenta l'alimentazione del
ghiacciaio, mentre nella prima metà di settembre si valutano le perdite di
spessore glaciale tramite paline ablatometriche in legno infisse nel
ghiaccio.
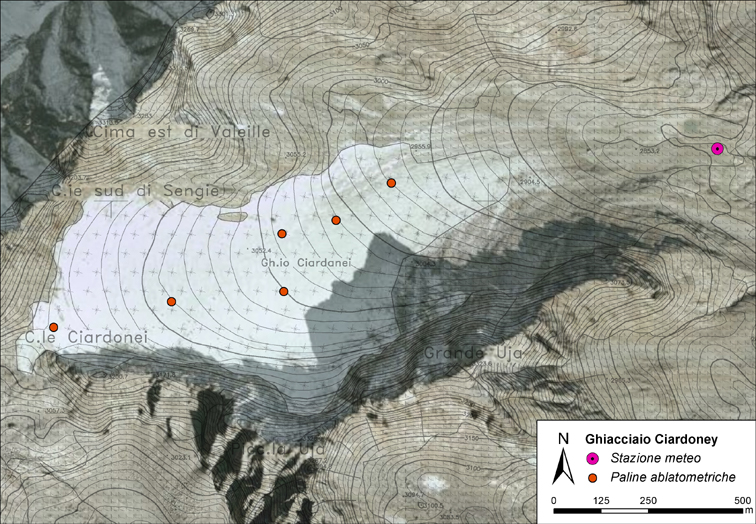
I
punti rossi rappresentano le 6 paline ablatometriche installate
sul ghiacciaio, a partire dal
Colle Ciardoney (a sinistra, sito più elevato, 3140 m)
sino al settore frontale a 2900 m circa.
|
|
 |
 |
|
A
sinistra, il gruppo SMI al lavoro
per il prelievo dei campioni di neve per la misura della densità,
tramite tubo carotiere (9 giugno 2011, f. SMI). A destra, gli
operatori glaciologici misurano
l'emergenza di una palina ablatometrica (6 settembre 2010, f. SMI).
Il grafico
riportato sotto
mostra i risultati delle misure: l'andamento degli accumuli nevosi
invernali (in blu), dell'ablazione
(in rosso), e del bilancio di massa (in giallo) dalle stagione 1991-92
in poi. Salvo l'isolato caso della stagione 2000-01, il ghiacciaio ha sempre subito perdite di massa
con una considerevole accelerazione a partire dal 2003.
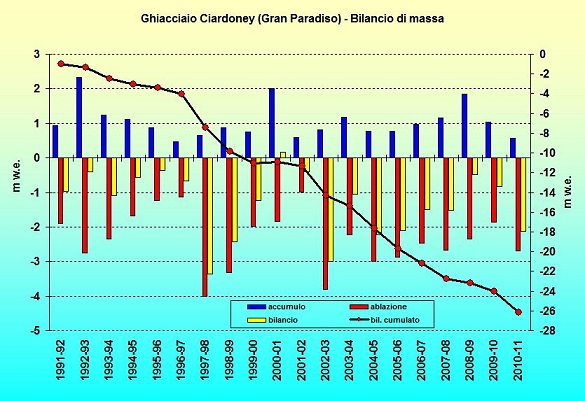
Gli istogrammi
rappresentano i valori annuali di accumulo invernale, ablazione
e bilancio. La curva nera indica
invece il bilancio cumulato. I valori sono tutti espressi in metri di
equivalente d’acqua e rappresentano una media ponderata rispetto alle
aree rappresentate da ciascuna palina ablatometrica.
|
|
Le
prime misure di variazione frontale risalgono al 1971, e sono
divenute regolari a partire dal 1986. Alcuni blocchi (segnali)
rocciosi stabili costituiscono un riferimento per eseguire ogni anno
le misure di distanza rispetto al margine del ghiacciaio, da cui per
differenza si ottengono i valori di regresso o di avanzata. Dopo un
moderato e temporaneo progresso degli anni 1973-78 (estati fresche e
piovose), il ghiacciaio è sempre arretrato, con intensità crescente
soprattutto negli anni 2000 (-28.5 m/anno nel 2003, anno più
sfavorevole della serie).

Un momento delle misure di variazione
frontale tramite
rotella metrica al segnale A3C (f. SMI, 6 settembre 2010).
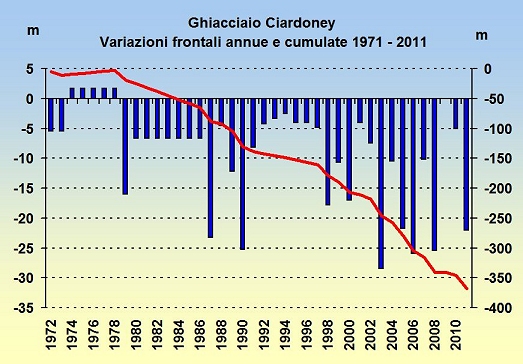
Variazioni frontali al ghiacciaio Ciardoney. I valori annuali sono
espressi
come media delle misure condotte dai diversi segnali frontali
(attualmente 2).
Oggi, la
disponibilità dei dati meteorologici consente dunque di studiare
meglio le correlazioni tra il clima locale e le variazioni del
ghiacciaio, particolarmente sensibile da un lato alle precipitazioni
invernali (ottobre-maggio), dall'altro a temperatura e radiazione
solare estive (giugno-settembre).
|
|
MAGGIORI DETTAGLI:
•
Stazione meteorologica al ghiacciaio Ciardoney, dato online
•
Glaciologia,
ultimi aggiornamenti
|
|
Progetto realizzato con il contributo di |
 |
 |
|

|
|
Guida
al sito
| Contattaci
|
Segnala
il sito |
Credits
|
Copyrights
|
|