|
Martedì 15 settembre 2015 il team della
Società Meteorologica Italiana ha coordinato la campagna di misure di
fine estate sul Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso), quest'anno
particolarmente articolata e comprendente - oltre ai consueti rilievi
di bilancio di massa e variazione frontale, e la
manutenzione della stazione meteorologica - anche prospezioni
georadar per la determinazione degli spessori del ghiaccio, e
le riprese di un documentario per l'edizione 2016 della
trasmissione RAI - "ScalaMercalli".

15 settembre 2015:
prospezione georadar (GPR, Ground Penetrating Radar)
per la
determinazione dello spessore del ghiacciaio Ciardoney, a cura di
Imageo Srl (f.
SMI).
Il tempo frequentemente nuvoloso di questo periodo non
ha permesso di individuare una giornata dall'atmosfera ottimale, ma la
missione si è comunque svolta con successo - nonostante l'andirivieni
di nebbie in regime di correnti umide da Sud-Ovest - soprattutto grazie alla ormai trentennale disponibilità di
IREN Energia
e all'esperienza del pilota di
Pellissier Helicopter.

Rosone, ore 8,30:
si definisce la logistica delle rotazioni d'elicottero per il
trasporto di personale e materiali sul ghiacciaio. A sinistra, Dario
Farys, esperto pilota di "Pellissier Helicopter"
(f. SMI).
Dopo la
seconda estate più calda in oltre due secoli sulle Alpi
occidentali, il ghiacciaio era interamente coperto da 10-30 cm di neve
fresca caduta il 13 settembre 2015, al di sotto della quale tuttavia
non c'era più traccia di neve stagionale, con massicce perdite di
spessore glaciale variabili tra 155 cm (palina ablatometrica n.
2, settore superiore) e 375 cm (palina n. 7, presso la fronte).
Di conseguenza il bilancio di massa è stato molto negativo, pari a
-1,90 m
di acqua equivalente, sebbene "solo" in settima posizione tra i più
sfavorevoli dal 1992 (vedi grafico e commento più in basso).

La palina n. 1 affiorante al Colle Ciardoney,
dove la calura estiva ha fuso circa 145 cm di nevato accumulato nelle
stagioni 2013 e 2014, e 170 cm di ghiaccio sottostante.
Tuttavia l'aspetto del ghiacciaio è ormai invernale, coperto qui da
circa 30 cm di neve caduta al mattino del 13 settembre 2015 che
nascondono alla vista i "disastri" causati dalla seconda estate più
calda in oltre due secoli al Nord-Ovest italiano.
Il cielo è coperto da estese nubi alte (Altostratus, Altocumulus
lenticularis), ma attorno a quota 3000 m il flusso umido meridionale
sta pure formando un insidioso strato di nebbie,
per fortuna intermittenti; la temperatura è intorno a 1 °C
(f. SMI).

Il settore superiore del Ghiacciaio e
il Colle Ciardoney, con 15-30 cm di neve fresca
(f. SMI).

L'operatore RAI Ivo
Bonato riprende Luca Mercalli e
Fulvio Fornengo mentre perforano il ghiacciaio tramite sonda
a vapore per l'installazione di una nuova palina ablatometrica fino
alla profondità di 10 m al sito di misura n. 6 (pendio frontale), in
affiancamento a quella esistente ormai in procinto di fuoriuscire del
tutto dal ghiaccio a causa della rapida fusione glaciale dell'annata.
La sonda a vapore è stata gentilmente concessa in prestito
dal CNR-IRPI, sede
di Torino
(f. SMI).
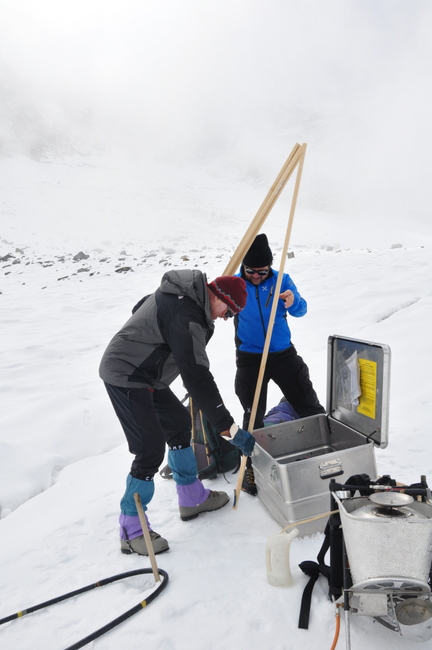

Terminato il foro
da 10 m, si inserisce la nuova palina,
composta da 5 elementi da 2 m ciascuno (f. SMI).

La palina n. 7 era
stata precedentemente sostituita nel settembre 2012, e da allora in
questo punto, poco a monte della fronte glaciale, il ghiacciaio ha
perso ben 720 cm di spessore!
Fulvio Fornengo e Luca Mercalli qui sorreggono le sezioni della palina
fuoriuscite dal ghiaccio in appena tre estati.
Anche qui viene affiancato un nuovo elemento fino a 10 m di
profondità,
che permetterà le misure nei prossimi anni
(f. SMI).
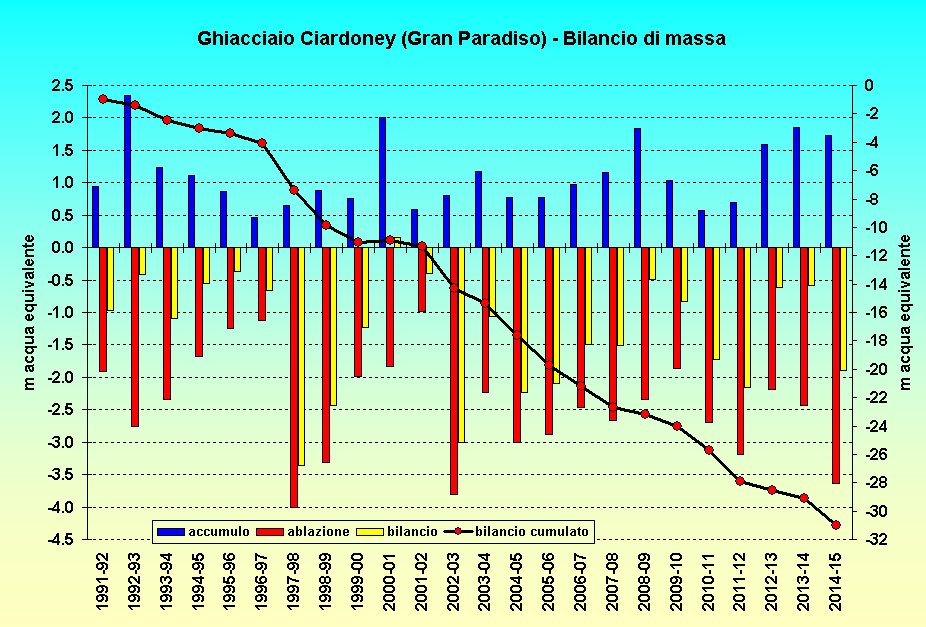
La forte fusione
dell'estate 2015 è risultata in un bilancio di massa specifico di
-1,90 m di acqua equivalente, particolarmente sfavorevole, tuttavia
"solo" in settima posizione tra i peggiori in 24 anni di misure (dal
1992). Dall'inizio dei rilievi di bilancio la curva cumulata
ha raggiunto i 31 m.
Le perdite nette di ghiaccio, pur notevoli, non sono risultate così
eccezionali come la stagione calda avrebbe fatto immaginare solo in
virtù del copioso accumulo nevoso invernale (quinto per abbondanza
da inizio misure, colonna blu) e dell'interruzione della fusione
nella settimana successiva a Ferragosto; peraltro l'ablazione
totale di neve e ghiaccio (colonna rossa), ben correlata all'entità
della calura estiva, si pone al terzo posto,
molto vicino ai casi straordinari del 1998 e 2003.
Dopo una
stagione invernale 2014-15 di abbondante accumulo nevoso, il ghiaccio aveva iniziato ad affiorare
sul pendio frontale precocemente, già intorno al 7 luglio 2015,
scoprendosi poi completamente verso la metà di agosto, a seguito di un
mese e mezzo di calura estrema.
Tuttavia la nevicata di Ferragosto (5 cm) ha interrotto
la fusione per almeno una settimana, quanto è bastato per impedire
alla stagione di ablazione 2015 di raggiungere le perdite di massa
glaciale osservate in annate di poco più negative (-2,23 m nel
2004-05, -2,10 m nel 2005-06, -2,16 m nel 2011-12), nonché in quelle
eccezionali del 1997-98 (-3,36 m), 1998-99 (-2,43 m) e 2002-03 (-3,00
m).
Con la più copiosa imbiancata del 13 settembre (10-30 cm) la stagione
di fusione 2015 sul ghiacciaio si può ragionevolmente ritenere
conclusa.
Tra i due sopralluoghi del 21 luglio e del 15 settembre 2015
l'ablazione media giornaliera - considerando soltanto i giorni senza
copertura di neve fresca sul ghiacciaio, stimati in 44 -
è stata
variabile tra 3,6 cm/giorno alla palina n. 4 (posizione più
ombreggiata sotto le Uje di Ciardoney, su pendio glaciale lievemente rivolto a
Nord) e 6,9 cm/giorno alla palina n. 7 (esposizione più soleggiata e
circa 100 m più a valle).
Misure georadar di
profondità del ghiacciaio
Il sopralluogo è stato occasione per eseguire anche una campagna di
misure georadar (GPR, Ground Penetrating Radar) per il
rilievo delle profondità del ghiacciaio, finora pressoché sconosciute
(un primo tentativo con modesti risultati si era svolto nel lontano
1994, e in seguito l'esplorazione
dei mulini glaciali nel 1999 e 2003 aveva permesso di individuare
spessori glaciali di almeno 40 m nel settore mediano).
Il metodo GPR consiste nel trascinare lungo superfici
morfologicamente significative
un’antenna da cui si propagano le onde in profondità in modo diverso a
seconda del
mezzo attraversato (ghiaccio o roccia). L’onda riflessa
verso la superficie è intercettata da una seconda antenna ricevente e
registrata per le elaborazioni successive.
I risultati preliminari indicano spessori dell'ordine di
20-30 m sul settore superiore verso il Colle Ciardoney, e fino a
una settantina di metri nella porzione intermedia, a monte del
cambio di pendenza presso cui si trovano la palina n. 3 e i pozzi
glaciali. Quest'ultimo dato lascia ipotizzare la presenza di una
depressione subglaciale che entro pochi decenni, con il regresso del
ghiacciaio, potrebbe essere colmata da un nuovo lago.
Ma le elaborazioni complete e definitive sono in corso e verranno
presentate prossimamente.

Gli operatori di
Imageo percorrono il ghiacciaio lungo diversi transetti
con il georadar (GPR) georeferenziato con
GPS. Qui sopra, in primo piano, Andrea Tamburini con l'acquisitore dei dati,
seguito da Fabio Villa, che trascina l'antenna GPR
(f. SMI).

Fabio Villa trascina l'antenna GPR lungo
la superficie del Ghiacciaio Ciardoney,
operazione facilitata dalla crosta portante da fusione-rigelo sulla
neve recente
(f. SMI).
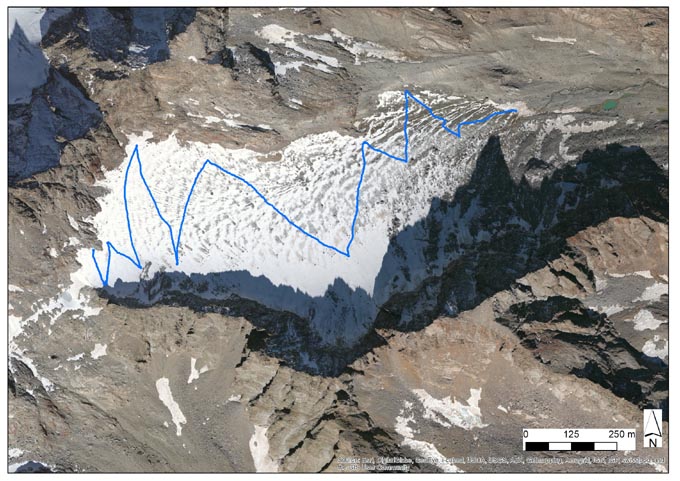
Tracce dei profili
georadar eseguiti da monte (sinistra) verso valle (destra).
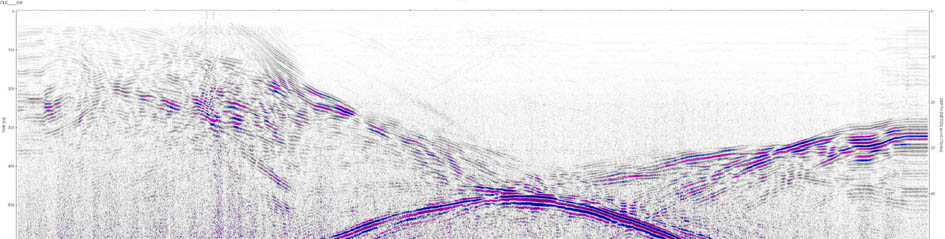
Esempio di sezione
radar della parte alta del ghiacciaio, orientata da Nord-Ovest a
Sud-Est, che mostra uno spessore massimo di ghiaccio pari a circa 30
metri
(elaborazione preliminare
Imageo).
Variazioni
frontali: drastico ritiro
Le forti perdite di massa della stagione
si sono tradotte anche in un massiccio ritiro della fronte, di ben
33,5 m al segnale A4D (sinistra orografica) e di 13,5 m al
segnale A5C (destra orografica), in posizione più protetta dalla
fusione per l'abbondante copertura detritica superficiale, e in
media il regresso frontale è stato di 23,5 m, portando così a ben
412 m il ritiro cumulato dal 1971.
Presso la fronte, oltre a nuovi affioramenti rocciosi, si è osservato
lo sprofondamento e la frammentazione di grandi porzioni di ghiaccio,
fenomeni favoriti molto probabilmente anche da piene impulsive del torrente subglaciale durante i numerosi temporali che hanno caratterizzato
l'estate 2015, in particolare quelli dell'8-9 e 13-14 agosto (grafici
al fondo dell'articolo).
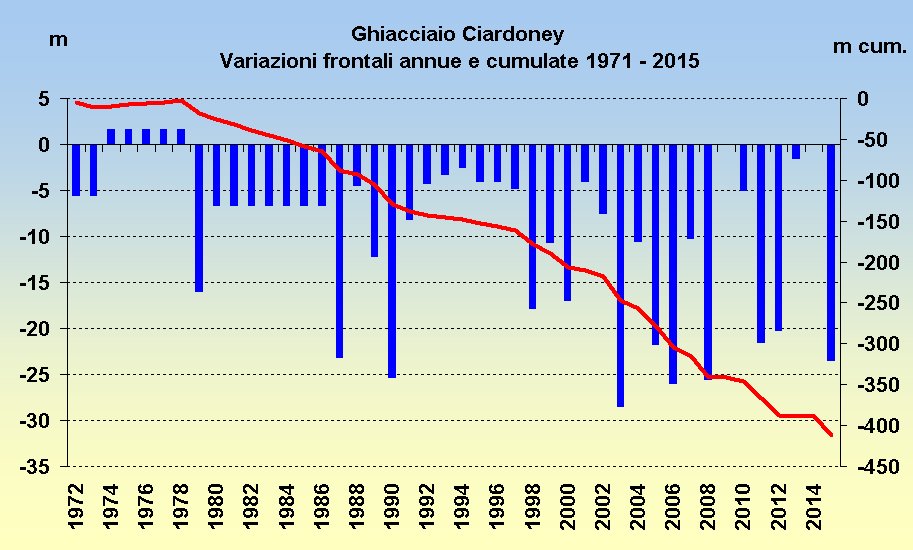
Serie delle
variazioni frontali annue dal 1971 al 2015: in 44 anni il ritiro
cumulato è stato di ben 412 m, e solo nel 1990, 2003, 2006 e 2008
l'entità del regresso annuale fu superiore a quanto osservato nel 2015
(23,5 m).

Veduta del pendio
frontale del ghiacciaio dall'elicottero: alcuni cm di neve recente
mettono in risalto il percorso delle bédières, profonde anche 1 m,
incise dall'acqua di fusione che ha ruscellato sul ghiaccio vivo per
circa due mesi. Al momento dell'osservazione, con presenza di neve
fresca, cielo nuvoloso e circa 1 °C, la fusione era molto scarsa (f.
SMI).

Veduta d'insieme del Ciardoney dalla stazione fotografica S2,
presso la stazione meteorologica:
la recente copertura nevosa che imbianca la
superficie (già fusa invece sulle limitrofe zone rocciose e
detritiche) rende ben visibile il perimetro del ghiacciaio, ma
impedisce di cogliere la reale situazione dell'apparato glaciale, fino a pochi giorni prima diffusamente spoglio e annerito
dal detrito al termine di una stagione particolarmente sfavorevole (f.
Diego Marzo).
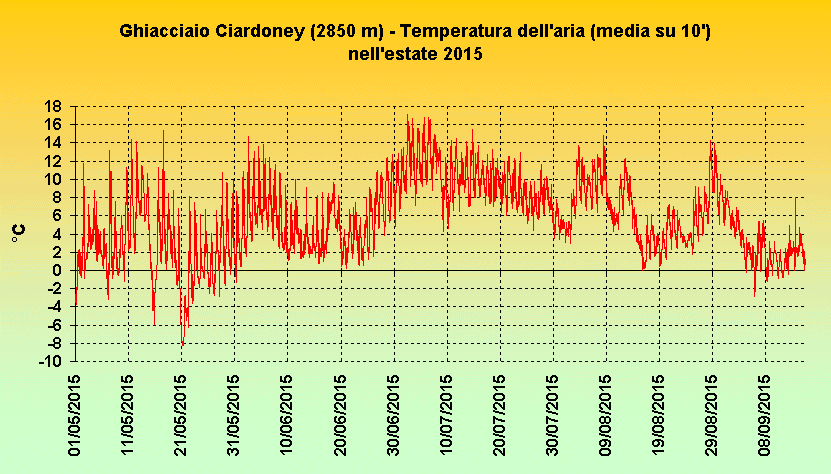
I tecnici Diego
Marzo e Riccardo Chiotti hanno lavorato alla manutenzione della
stazione meteorologica, sempre in ottima efficienza a 5 anni
dall'installazione.
Ecco un grafico della temperatura dell'aria (medie su 10') durante la
stagione di fusione
nivo-glaciale 2015, dal 1° maggio al 15 settembre.
Colpisce l'anomala durata del periodo ininterrottamente senza gelo,
ben 76 giorni tra il 31 maggio e il 15 agosto, inoltre nei 31
giorni tra il 29 giugno e il 29 luglio
non si è mai scesi sotto i 4 °C.
Si segnalano anche l'estremo massimo di 17.4 °C del 2 luglio, e
la notte particolarmente tiepida tra il 7 e l'8 luglio, con minima di
10.4 °C.
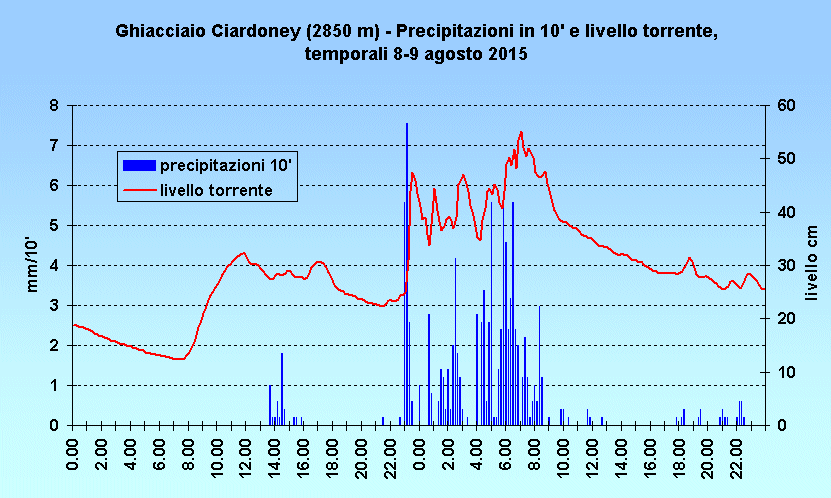
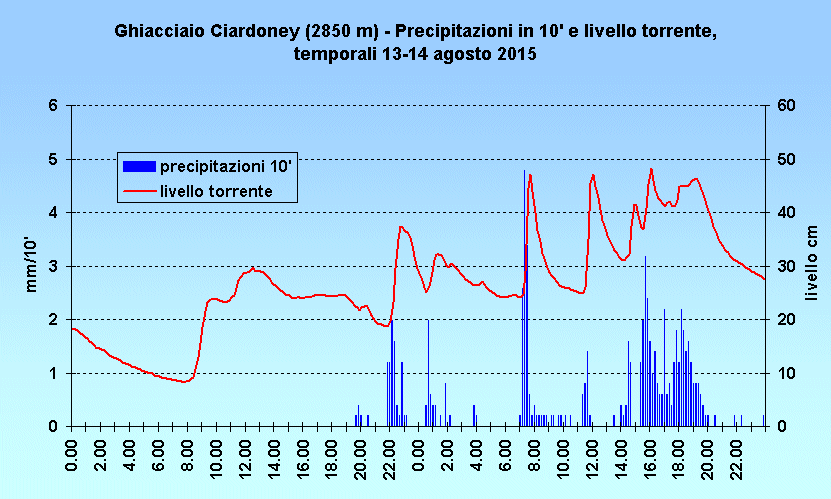
Violenti temporali
si sono abbattuti sul ghiacciaio verso la metà di agosto, al transito
di attivi fronti atlantici che hanno interrotto le ondate di calore,
in particolare nei giorni 8-9 e 13-14:
la caduta di abbondante acqua liquida (106 mm in meno di 36 ore l'8-9
agosto) con temperature talora di 5-7 °C ha contribuito alla fusione
del ghiaccio e all'impetuoso ruscellamento superficiale sul
ghiacciaio.
I grafici mostrano le quantità di precipitazione in intervalli di 10
minuti e l'andamento del livello del torrente glaciale nei due
episodi: si nota la rapidissima risposta del corso d'acqua ai
rovesci caduti nel piccolo bacino d'alta quota (< 2 km2),
con tempi di corrivazione dell'ordine di 10-20 minuti. Lo scroscio
più intenso (7,6 mm in 10') si è rilevato tra le h 23:00 e le h
23:10 locali dell'8 agosto, seguito da altri copiosi rovesci notturni
che entro l'alba del 9 hanno fatto salire il torrente fino al livello
di 55 cm (non frequente, ma inferiore al massimo di 72 cm del 4
settembre 2011). L'episodio pomeridiano del 14 agosto ha prodotto
anche una forte grandinata (qui sotto).

Il pianoro frontale del Ciardoney imbiancato dalla grandinata del 14
agosto 2015, ripreso alle ore 16 dalla webcam. Si noti il torrente
ingrossato e torbido (livello 48 cm), e i rivoli d'acqua che
percorrono le morene laterali sinistre, erodendone i depositi.

Ore 13, missione
compiuta... Ecco il gruppo di lavoro al rientro alla centrale IREN di
Rosone: da sinistra, Dario Farys (pilota Pellissier Helicopter),
Andrea Tamburini (Imageo), Ivo Bonato (cineoperatore RAI), Fabio Villa
(Imageo), Luca Mercalli (SMI), Diego Marzo e Riccardo Chiotti
(elettricisti - tecnici stazione meteo), Fulvio Fornengo (SMI).
Segui in in tempo reale la situazione sul Ghiacciaio Ciardoney
(dati
meteo e webcam)
Devolvi il 5 per mille alla SMI,
sosterrai le ricerche sul Ghiacciaio Ciardoney!

Un particolare ringraziamento a
Valtecne
per il supporto alle campagne di misura sul Ciardoney

|