|
FINE INVERNO E
MARZO
2024 AL NORD ITALIA:
MITEZZA E PRECIPITAZIONI SOVRABBONDANTI,
GRANDI NEVICATE IN ALTA MONTAGNA
4 aprile 2024, SMI / Redazione Nimbus
Da metà febbraio 2024 lo schema di circolazione atmosferica
prevalente a scala europea è radicalmente cambiato.
Dopo una prima parte di inverno complessivamente avara di
precipitazioni, depressioni atlantiche sull'Ovest europeo hanno
inviato ripetuti sistemi frontali associati a venti umidi con
direzione di provenienza al suolo tra Sud-Ovest, Sud e Sud-Est,
situazioni favorevoli al ritorno di precipitazioni abbondanti e
talora straordinarie nel bimestre febbraio-marzo 2024 soprattutto a
ridosso della fascia montana e pedemontana dall'alto Piemonte al
Friuli, e sull'Appennino settentrionale.

Durante gli episodi perturbati di febbraio-marzo 2024 il limite pioggia-neve, mediamente
piuttosto elevato, si è collocato nella maggior parte dei casi tra
1000 e 1500 metri, e a quote superiori gli accumuli nevosi sono stati
importanti. Particolarmente intensa la nevicata del 2-4 marzo sulle
Alpi occidentali, con quantità di neve fresca fino a 100-120 cm in 36
ore oltre i 1300-1500 m sulle zone più esposte allo sbarramento del
flusso umido da Sud-Est (Valli di Lanzo, Valli Orco e Soana). Qui
sopra, si apre una via nel manto nevoso spesso in totale 160 cm a
Ceresole Reale (1600 m, Valle Orco, Gran Paradiso) al termine della
nevicata il 4 marzo 2024 (f. Raffaella Miravalle).
Sei eventi perturbati principali
(9-10 e 26-28 febbraio 2024, 2-4, 8-10 e 26-27 marzo, 29 marzo-1°
aprile) hanno definitivamente chiuso l'eccezionale
episodio
secco del biennio 2022-2023 anche al Nord-Ovest, dove la siccità era
stata più prolungata ed estrema. A parte il breve e dannoso episodio
di maggio 2023 con le
alluvioni in Romagna, il Settentrione non vedeva un regime di
precipitazioni così estese e abbondanti da almeno tre anni.
Salvo fugaci apparizioni a quote di fondovalle, le masse d'aria per lo
più miti in circolazione hanno confinato le nevicate in
media-alta montagna, ma sopra i 1500-2000 m sulle Alpi lo spessore
del manto nevoso è cresciuto fino a valori notevoli e poco
usuali soprattutto negli ultimi decenni segnati da una diffusa
diminuzione dei parametri di innevamento, mentre in Valpadana
occidentale (Milano, Torino) l'inverno 2023-24, il più tiepido in
oltre due secoli, si è chiuso senza alcuna nevicata misurabile.
2_MilosLago.jpg)
Pur
senza innescare dissesti geo-idrologici estesi e rovinosi, le piogge
sovrabbondanti di febbraio-marzo 2024 hanno determinato numerosi
eventi franosi su Alpi e Appennino settentrionale, e allagamenti in
pianura. L'episodio più rilevante è rappresentato dalla piena di fine
febbraio nel bacino del Bacchiglione tra le province di Vicenza e
Padova. Nell'immagine, il fiume invade alcune abitazioni a Bovolenta,
Padova
(29 febbraio 2024, f. Milos Lago).
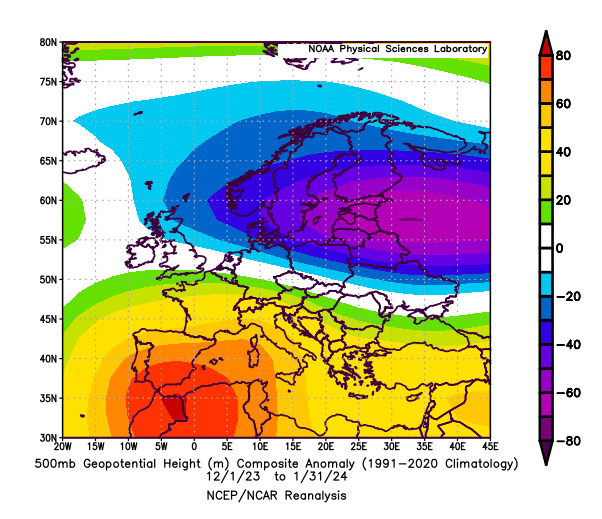 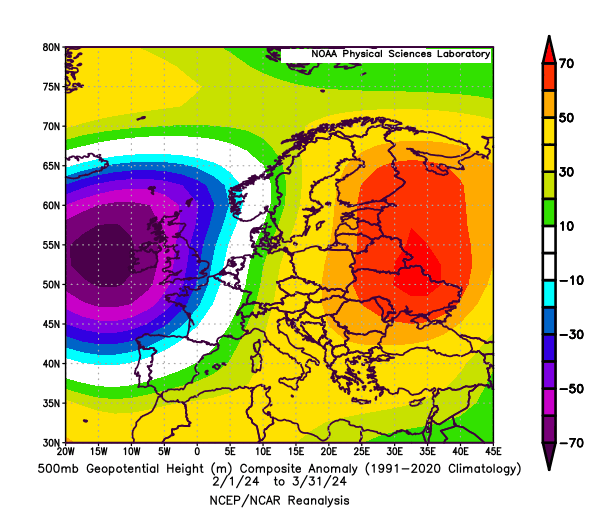
Confronto tra le anomalie di altezza del geopotenziale al livello
isobarico di 500 hPa nei periodi dicembre 2023-gennaio 2024 e
febbraio-marzo 2024. Evidente il passaggio da anomalie positive
(anticicloni più robusti del consueto, colori giallo-rossi) tra Europa
meridionale e Nord Africa, a valori negativi (depressioni più profonde
del solito, blu-viola) in zona atlantica, transizione responsabile del
ritorno di flussi di libeccio e scirocco con sbarramento orografico e
incentivazione delle precipitazioni sull'Appennino settentrionale e
sul pendio sudalpino.
SINTESI DEGLI
EVENTI PERTURBATI PRINCIPALI
9-11 febbraio 2024
La perturbazione del 9-11 febbraio, a cui va il merito di aver
attenuato la siccità e l'inquinamento atmosferico al Nord, scarica le precipitazioni più copiose dall'alto Piemonte al Friuli e
sull'arco ligure-tirrenico, dove i fiumi riprendono vita ma senza
fare danni. Solo qualche interruzione stradale per frane nell'Imperiese
e in Val di Ledro (Trento). La località di Urbe, sull'Appennino
savonese ma già afferente al bacino padano dell'Orba, riceve ben
315 mm d'acqua (fonte:
ARPA Liguria);
notevoli per la Riviera di Ponente i 101 mm di Sanremo, e benvenuti, a
Torino, i 43 mm in tre giorni, quantità ordinaria ma che non si era
più vista da fine agosto 2023. Salvo locali apparizioni sotto i 1000
m, come in Val Sesia, le correnti miti meridionali confinano la
neve in media-alta montagna (fino a 50-80 cm in quota dal Monte Rosa
alle Alpi lombarde).
26-28 febbraio 2024
Il sistema perturbato dei giorni tra lunedì 26 e mercoledì
28 febbraio, associato a un flusso di scirocco, è molto attivo al Nord e in Toscana, scaricando
diffusamente più di 100 mm di precipitazioni dalla Liguria alla
Montagna Pistoiese, e dall'Emilia e Lombardia fino al Veneto e Friuli,
con punte di 202 mm a
Monte Oppio (Pistoia; fonte
CFR Toscana) e
259
mm a Valpore
(Monte Grappa, Vicenza; fonte
ARPA Veneto). Proprio il Vicentino, in allerta rossa della protezione
civile, vive gli effetti più vistosi con diffusi allagamenti di
strade e abitati e una notevole piena del fiume Bacchiglione,
fortunatamente attenuata da due efficaci casse di espansione fluviale
realizzate a monte.
Ma a essere bagnatissimo – in questa zona così
come altrove al Settentrione - è stato febbraio 2024 nel suo insieme, con
totali fin oltre 500 mm sulle Prealpi e di 290 mm a Vicenza, record
per questo mese dall'inizio delle misure in città nel 1919. In piena
anche i fiumi emiliani, gonfiati dalla pioggia caduta fin quasi sul
crinale appenninico, specie il Reno nel Bolognese. Sulle Alpi
occidentali dal Cuneese al Gran Paradiso in tre giorni
cade anche un metro di neve fresca oltre i 1500 m, poi rapidamente
intriso da pioggia e fusione nivale.

Allagamenti a Milano sotto la pioggia del 27 febbraio 2024. Stando
alla serie storica di riferimento di Brera, attualmente gestita da
ARPA Lombardia,
il capoluogo ha vissuto il bimestre febbraio-marzo più ricco
di precipitazioni dall'inizio delle misure pluviometriche nel 1764,
con un totale di 416 mm, pari a tre volte e mezzo la norma. Il pluviometro
ha rilevato pioggia ogni giorno dal 22 febbraio al 6 marzo,
accumulando 208 mm in un'insolita sequenza di 14 giorni piovosi
consecutivi (f. Davide Santini).
2-4 marzo 2024
Brevissimo intervallo, poi una nuova e intensa fase perturbata -
associata alla depressione "Fedra" (nomenclatura
Eumetnet) in
formazione sulla Costa Azzurra - si sviluppa a ridosso del primo
weekend di marzo, tra sabato 2 e lunedì 4. I massimi effetti si
avvertono al Nord-Ovest,
dove in 36 ore cadono fino a 150-200 mm di pioggia sui fondovalle dal
Monviso al Biellese, e oltre 70 cm di neve fresca oltre i 1300-1500 m
dal Cuneese, alla bassa Valle d'Aosta, al Monte
Rosa e Ossola, con punte fino a 100-120 cm sulle zone più esposte allo
sbarramento del flusso umido da Sud-Est (Valli di Lanzo, Valli Orco e
Soana). Sotto i rovesci più intensi il suolo si imbianca talora fino a
500-600 m.
La nevicata - tra le più copiose quanto meno dell'ultimo decennio e insolitamente umida e pesante, caratteristica accentuata da
inverni sempre più miti - determina interruzioni stradali per
valanghe (tremila residenti e turisti isolati nella Valle di Gressoney,
Valle d'Aosta),
lo schianto di centinaia di alberi nei boschi e black-out elettrici.
Al mattino del 4 marzo si misurano spessori nevosi totali al suolo (inclusa dunque
la neve presente in precedenza) che talora non si erano più osservati
da 5-10 anni. Si tratta di valori poco usuali soprattutto nei recenti
anni caratterizzati da una nevosità sempre più modesta, tuttavia per
nulla eccezionali in serie di osservazione di 50-100 anni.
Alcuni
esempi (in parentesi il mese in cui si era osservato l'ultimo spessore
nevoso analogo o superiore):
* 124 cm a Balme (1450 m, Valli di Lanzo), info del socio SMI Gianni
Castagneri (metà marzo 2016);
* 147 cm a Gressoney-D'Ejola (1850 m, Monte Rosa), dato SMI/CFR VdA
(metà aprile 2018);
* 160 cm a Ceresole Reale-diga (1579 m, Valle Orco-Gran Paradiso),
dato IREN Energia (inizio febbraio 2014);
* 195 cm al Lago Telessio (1917 m, Valle Orco-Gran Paradiso), dato
IREN Energia (fine novembre 2019);
* 255 cm al Ghiacciaio Ciardoney (2850 m, Val Soana-Gran
Paradiso), dato SMI (fine dicembre 2019).
A valle, le forti piogge gonfiano i corsi d'acqua
con bacino collocato per lo più sotto i 1000 m (es. Ghiandone, Chisola
e Banna tra Saluzzese e Torinese), e una
moderata piena transita lungo il Po senza effetti
significativi.
Alcune frane in Liguria e sull'Appennino Parmense, ma senza danni
gravi. Imbiancata pure la Sardegna sopra gli 800 m.
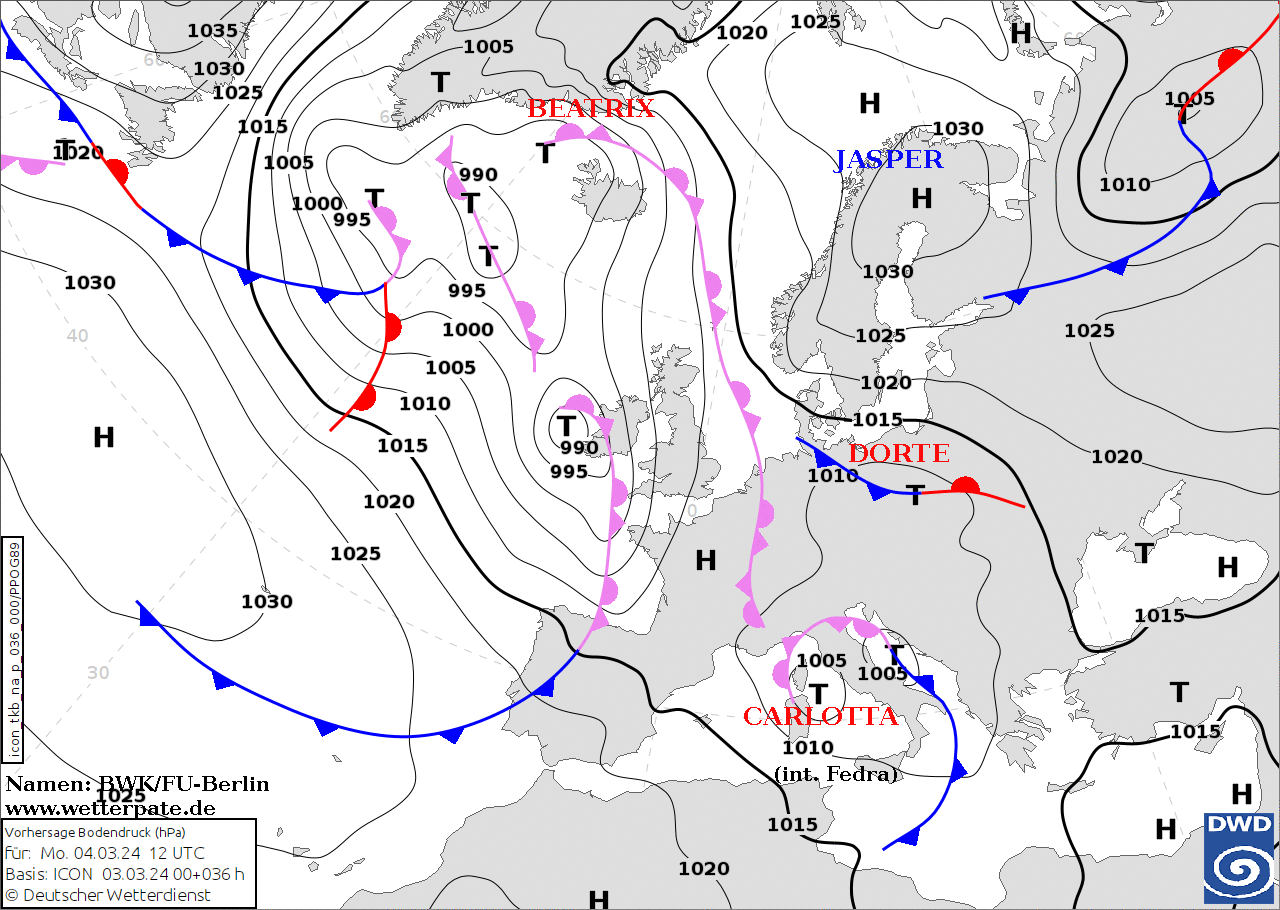
Carta
della pressione e dei fronti in superficie prevista per le ore 12 UTC
del 4 marzo 2024, con la depressione Fedra (Carlotta per l'Istituto
di Meteorologia della Libera Università di Berlino) collocata sul
Tirreno e il sistema frontale in occlusione e progressivo
indebolimento sul Centro-Nord Italia.

Gressoney-La Trinité (1630 m, Valle d'Aosta), 4 marzo 2024. Il vicino
osservatorio di Gressoney-D'Ejola (1850 m) rileva 81 cm di neve fresca
in tre giorni (f. Arnold Welf).

La
media-alta Valle di Gressoney, ai piedi del Monte Rosa, rimane isolata
domenica 3 marzo 2024 per la caduta della valanga "Bounitzon" a Gaby.
La massa nevosa ostruisce l'imbocco della galleria paravalanghe
realizzata a protezione della SR 44, alla base di un canalone
storicamente percorso da slavine. La valanga cadrà nuovamente domenica
10 marzo (foto La
Stampa).

Pian
del Frais (1500 m, Chiomonte, Val Susa), 130 cm di neve al suolo a
poche ore dalla fine della grande nevicata del 2-4 marzo 2024 (f.
Daniele Cat Berro).

Alberi
abbattuti (a decine) dal carico di neve umida e pesante lungo la
strada Susa - Pian del Frais, attorno ai 1300 m di quota (f. Daniele
Cat Berro).
La generale riduzione dei parametri di innevamento - soprattutto a
quote inferiori a 2000 m sulle Alpi - a causa dell'aumento delle
temperature medie, non esclude il verificarsi di quando in quando
di nevicate di forte intensità, potenzialmente anche più dannose
proprio per la maggiore densità del manto nevoso stanti le
temperature più elevate, con diffusi danni al patrimonio forestale
(che talora amplificano quelli già dovuti a tempeste di vento, siccità
e attacchi di parassiti) e alle linee elettriche. Diffusi
schianti di alberi da neve pesante si ebbero a
metà novembre 2019
(dal Torinese all'Alto Adige) e, a quote più elevate intorno a 2000 m,
a
fine novembre 2016 (alta Val Susa).
8-10 marzo 2024
Intense precipitazioni - esaltate dallo sbarramento orografico di
un flusso di scirocco - si ripresentano a distanza di appena una
settimana, nel weekend 8-10 marzo, e subissano d'acqua
soprattutto l'alto Piemonte, l'Appennino settentrionale e le Prealpi
orientali. Piogge talora superiori a 100 mm (e fino a 180 mm a Mele,
Genova, fonte
ARPA Liguria) su suoli ormai saturi attivano
piene ordinarie lungo
fiumi quali Bisagno, Orba, Bormida e Sesia in Liguria e Piemonte
(allagamenti nell'Alessandrino), Taro e Arda in Emilia, e frane qua e
là sui rilievi.
Nuove copiose nevicate sulle Alpi
occidentali, oltre i 700-1000 m nelle valli torinesi, ma ben più in
basso nel Cuneese e nell'Ossola (fino ai circa 550 m di Cuneo e ai
270 m di Domodossola, a causa dell'isotermia nei bassi strati
atmosferici conseguente all'intensità delle precipitazioni). Oltre i
1200 m lo strato di neve fresca è diffusamente spesso 50-100 cm e innalza il pericolo valanghe al livello
4-forte; numerose le strade interrotte, uno sciatore ucciso da una
slavina sulle alture di Monesi (Alpi Liguri), e il manto nevoso totale,
come già avvenuto una settimana prima, cresce fino a spessori poco usuali negli ultimi decenni di
decrescente innevamento.
150 cm totali al suolo ai 1450 m di Balme,
Valli di Lanzo, valore che a
questa data o in un periodo più tardivo, in questa località dotata di
serie nivometrica dal 1929, non si era più osservato dal 1996.
Sempre notevoli ma meno rari i 170 cm totali al suolo a
Gressoney-D'Ejola (1850 m, Monte Rosa), superati più volte nella
serie storica dal 1927 e anche in date ben più tardive, nel 1958 (180
cm il 14 aprile), 1963 (220 cm il 7 aprile), 1972 (1975 cm il 21
aprile), 1975 (215 cm il 10 aprile), 1978 (210 cm il 2 aprile), 1986
(230 cm il 9 aprile) e 2018 (205 cm il 13 aprile).
Al passaggio del fronte freddo nel pomeriggio di domenica 10 marzo si
formano temporali dalla Toscana alla Campania,
e perfino un tornado con danni a edifici viene segnalato presso
Mantova, fenomeno
ripetutosi lunedì 11 marzo a Sabaudia (Latina) in una giornata temporalesca e ventosa al
Centro-Sud.

Balme (1450 m, Valli di Lanzo,
Torino), situazione al mattino di domenica 10 marzo 2024: il sindaco e
socio SMI Gianni Castagneri (oltre a scattare l'immagine) rileva 92 cm
di neve fresca in circa 48 ore e 150 cm di neve totale al suolo, uno spessore che - a
questa data o in un periodo più tardivo - in questa località dotata di
serie nivometrica dal 1929 non si era più osservato dal 1996
(con 155 cm il 18 marzo).

Ceresole Reale (Valle Orco, Torino)
si sgomberano i circa 60 cm di neve fresca caduti nelle 36 ore
precedenti (f. Renzo Bruno Mattiet).
Come una settimana prima, il manto nevoso totale al suolo si è
riportato a circa 160 cm.

10 marzo 2024, il
Rifugio
Onelio Amprimo (1385 m, bassa Val Susa)
al termine della nevicata di 70 cm, con 123 cm di neve totale al
suolo, massimo spessore dell'inverno 2023-24 (f. Daniele Cat Berro).
26-27 marzo 2024
La perturbazione di martedì 26 - mercoledì 27 è accompagnata
da scirocco con copiosa polvere sahariana che rende rossastri i cieli al Centro-Sud. Danni per le
violente raffiche
di vento in Sicilia (106 km/h a Palermo) e specie all'aeroporto di
Trapani, precipitazioni importanti in zona prealpina e Liguria e
nevicate scese con uno strato di alcuni centimetri in località a quota
300-500 m, come Cuneo, Ceva e Domodossola (isotermia), mentre sulle Alpi orientali
con il flusso caldo meridionale il limite pioggia-neve sale fino a 2000 metri.
Mercoledì 27 una valanga investe alcuni veicoli che si erano
avventurati al Colle della Maddalena (1996 m, Cuneo) nonostante il
divieto di transito istituito proprio in vista della nevicata da 60
cm: gli occupanti vengono soccorsi e salvati.
29 marzo-1° aprile 2024
L'ultimo episodio perturbato prima in un ritorno a condizioni
anticicloniche (e straordinariamente calde) si verifica a ridosso
della Pasqua, tra venerdì 29 e lunedì 1° aprile. Tre distinte
fasi di precipitazioni, talora temporalesche, interessano con i
maggiori apporti d'acqua i rilievi del Nord, e in particolare la
fascia montana dall'alto Piemonte, alle Alpi Orobie, al Friuli, con
centri di scroscio superiori a 300 mm in 4 giorni in collocati in Val
Strona di Omegna (371 mm a Sambughetto, fonte
Arpa Piemonte)
e sui rilievi alle spalle di Pordenone. I forti rovesci caduti su
suoli ormai sovrassaturi d'acqua determinano frane e interruzioni
stradali in varie località, sulla SS45 a Bargagli-La Presa
(Genova), in Val Strona di Omegna (Verbania), con circa 450 evacuati,
sulla SP11 a Tartano (Sondrio); inoltre, colata detritica sulla
SS39 dell'Aprica a Edolo (Brescia), con straripamenti anche in zona
abitata; caduta di massi su una falegnameria a Ora (Bolzano) e sulla
A23 presso Amaro (Udine); infine una valanga interrompe la SS33 del
Sempione tra Trasquera (Verbania) e il confine con la Svizzera.
Anche in questo caso una massiccia nube di polvere sahariana
accompagna l'evento rendendo molto torbida l'atmosfera in tutta Italia
e colorando le precipitazioni (vedi più avanti), e il flusso tiepido
meridionale confina le nevicate in gran parte sopra i 1500-2000 m
sulle Alpi. In alta montagna cadono comunque nevicate
imponenti, fino a un metro e mezzo di neve fresca in Val d'Ossola,
come ai 2453 m della stazione Arpa Piemonte di Formazza-Pian dei
Camosci, dove il manto nevoso totale al suolo il 1° aprile tocca 402
cm, valore notevole e poco frequente, ma non eccezionale sul lungo
periodo, superato dai 462
cm del 28 aprile 2009; al prospiciente Lago del Sabbione, a
quota identica (2462 m) la soglia dei 4 metri di neve al suolo è
stata raggiunta o superata in media un anno su quattro nella serie
di misura giornaliera cominciata nel 1950.
Nel corso della giornata di Pasquetta, con
l'allontanamento del corpo nuvoloso principale seguito dall'ingresso
di venti da Nord-Ovest, schiarite si sono propagate a partire dalle
regioni nord-occidentali. Tuttavia nel pomeriggio intense celle
temporalesche si sono riformate sul Verbano producendo copiose
grandinate nei dintorni di Arona - notevoli per il periodo
dell'anno - spingendosi poi fino a Milano e alla pedemontana veneta
(piccolo tornado e grandine con elementi anche di 5 cm di
diametro sulla pianura a Nord-Est di Vicenza).
Nel contempo al Sud lo scirocco - ulteriormente
surriscaldato per effetto foehn sul versante tirrenico della Sicilia -
portava temperature da piena estate, culminate nei 35,0 °C
del 1° aprile a Torregrotta (Messina, fonte
SIAS
Sicilia), valore decisamente raro per il mese centrale della
primavera.

Precipitazioni alla base del temporale a supercella che ha interessato
Milano e dintorni nel tardo pomeriggio di lunedì 1° aprile 2024
producendo forti grandinate, peraltro non le prime di questa annata.
E' notevole, infatti, che la zona di Milano-Sud abbia già contato 5
episodi grandinigeni entro il 1° aprile! (f. Davide Santini).
_RiccardoScotti.jpg)
L'imponente innevamento presente in quota sulle Alpi Orobie
valtellinesi al ritorno del sereno il 2 aprile 2024, dopo le intense
precipitazioni del 31 marzo, giorno di Pasqua (130 mm in 8 ore a
Pescegallo di Gerola Alta, Sondrio, fonte
ARPA Lombardia), responsabili anche di frane con
interruzione di strade di bassa montagna. Nell'immagine, il Pizzo di
Coca, vetta più elevata delle Orobie con i suoi 3052 m (f. Riccardo
Scotti).
_RiccardoScotti.jpg)
Sempre
il 2 aprile 2024, il Pizzo di Rodes (2829 m) e la Punta di Santo
Stefano (2697 m). Al vicino Lago Reguzzo (2450 m) la stazione
meteo-nivometrica
ARPA Lombardia indica uno straordinario spessore
nevoso totale di circa 450 cm, analogo a quanto rilevato nel 2014 (f.
Riccardo Scotti).
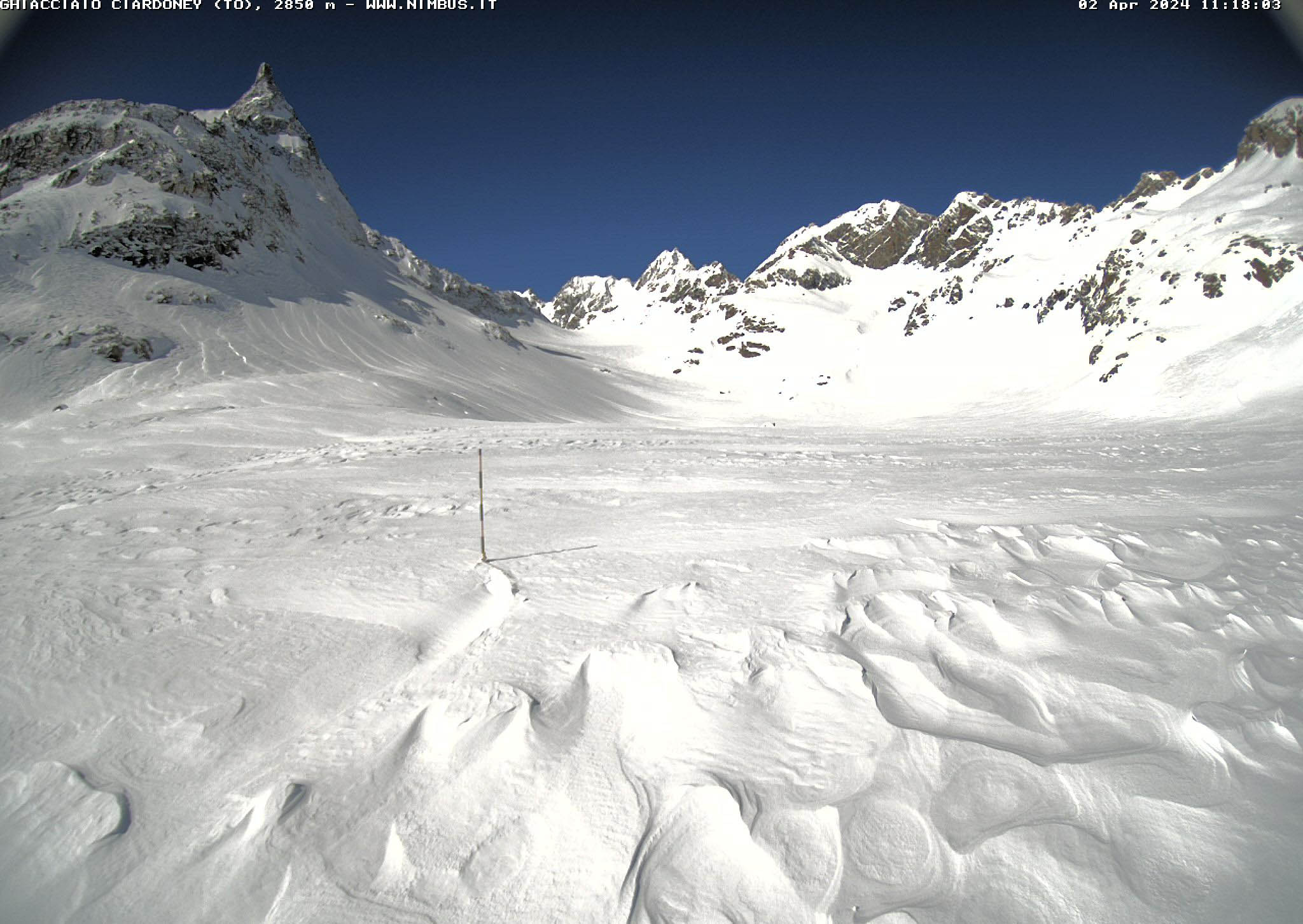
Immagine ripresa alle h 11 del 2 aprile 2024 dalla
webcam annessa alla stazione meteorologica SMI del Ghiacciaio
Ciardoney (2850 m, Gran Paradiso). Da poco terminata l'intensa
nevicata del 30 marzo-1° aprile, il manto nevoso totale al suolo è di
290 cm, valore ben superiore alla media del breve periodo di
osservazione 2013-2023 (173 cm a questa data), tuttavia non
eccezionale.
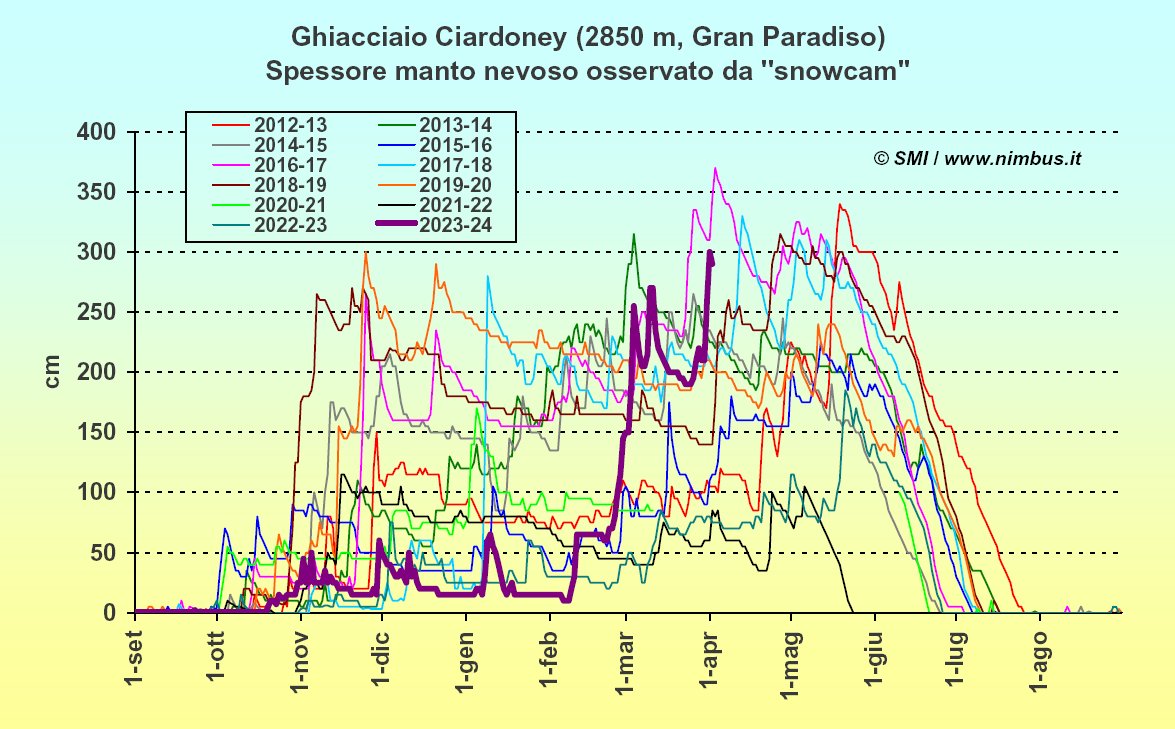
Andamento giornaliero dello spessore totale della neve alla
stazione
meteorologica SMI presso il Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso) nelle
stagioni dal 2012-13 al 2023-24.
L'inverno 2023-24 (linea viola più spessa) si è distinto per un
innevamento molto carente fino a inizio febbraio, talora ai
minimi della breve serie di osservazione da snowcam, dopodiché le ripetute e
copiose nevicate susseguitesi dall'8 febbraio in poi hanno
portato il manto su valori sopra media, fino a 300 cm il 1° aprile
(massimo della serie: 370 cm il 3 aprile 2017).
Notevoli i 190 cm di neve fresca caduti in due episodi tra il 26
febbraio
e il 4 marzo 2024.
FINE MARZO 2024: DUE NOTEVOLI TRASPORTI
DI
POLVERE SAHARIANA
Nell'ultima settimana di marzo 2024, in occasione di
due distinti episodi sciroccali (26-27 marzo, 29 marzo-1° aprile), si
sono verificati massicci trasporti di polvere sahariana verso Nord. In
particolare nel secondo caso la nube di polvere, oltre a invadere
tutto il Mediterraneo, ha raggiunto latitudini scandinave, e in Italia
il carico totale di polvere in sospensione nell'intera colonna della
troposfera ha superato l'inconsueto valore di 4 grammi per metro
quadrato (30-31 marzo).
In tutto il Paese il cielo densamente offuscato ha
assunto tinte grigio-ocra-rossastre (a seconda della nuvolosità e
delle ore della giornata), e laddove erano presenti precipitazioni,
dunque soprattutto al Nord, la polvere è ricaduta al suolo come
rilevante "deposizione umida" (wet deposition), colorando
vistosamente la pioggia, e la neve sulle Alpi.
Si tratta di episodi naturali dai risvolti sia
positivi, come il contributo alla fertilizzazione dei suoli
su distanze anche di migliaia di chilometri (vedi il caso dell'Amazzonia
qui), sia negativi, come il temporaneo peggioramento
della qualità dell'aria e l'accelerata fusione del manto nevoso
nelle settimane e mesi successivi a causa della diminuzione
dell'albedo (la superficie del manto nevoso, non più bianca e
altamente riflettente, assorbe più radiazione solare; vedi
questo studio condotto in Valle d'Aosta).
La loro ricorrenza è sostanzialmente annuale, ma gli
eventi di fine marzo 2024 sono stati tra i più estesi e appariscenti
dell'ultimo ventennio (notevolissimo, sulle Alpi, fu quello del 21
febbraio 2004).
Inoltre, secondo una
ricerca disponibile in preprint sulla piattaforma EGUsphere (Sharp
increase of Saharan dust intrusions over the Western Mediterranean and
Euro-Atlantic region in winters 2020–2022 and associated atmospheric
circulation), questi trasporti di polvere verso l'Europa sono stati più accentuati del
solito nel periodo 2020-2022. Ricordiamo, tra i
vari, gli episodi del
6 febbraio e
23-24 febbraio 2021, avvenuti tuttavia in contesto anticiclonico e
senza deposizione umida significativa.
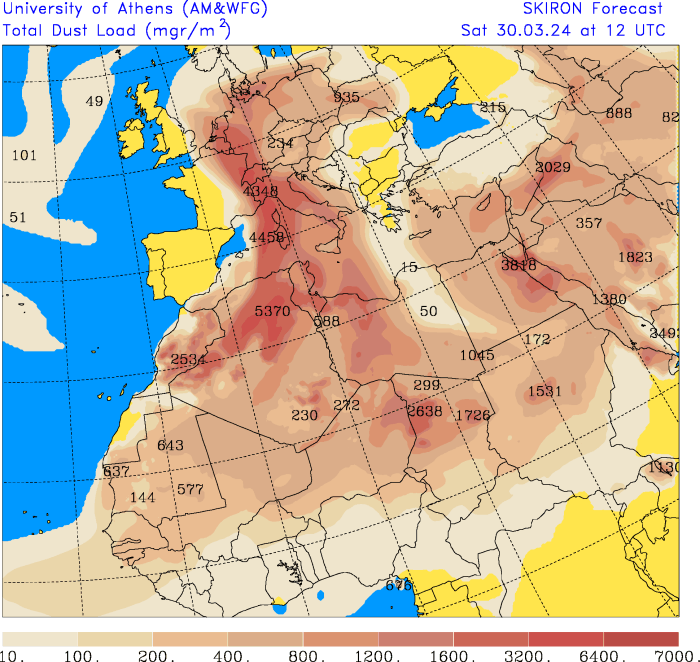
Carico
totale di polvere sahariana nella troposfera (milligrammi al metro
quadrato) previsto dal
modello Skiron dell'Università di Atene per le h 12 UTC di sabato
30 marzo 2024. Il pennacchio di polveri sospinto dallo scirocco giunge
fino al Mare del Nord, con quantità, rare a vedersi, superiori a 4 g/m2
sui cieli dell'Italia e delle Alpi.
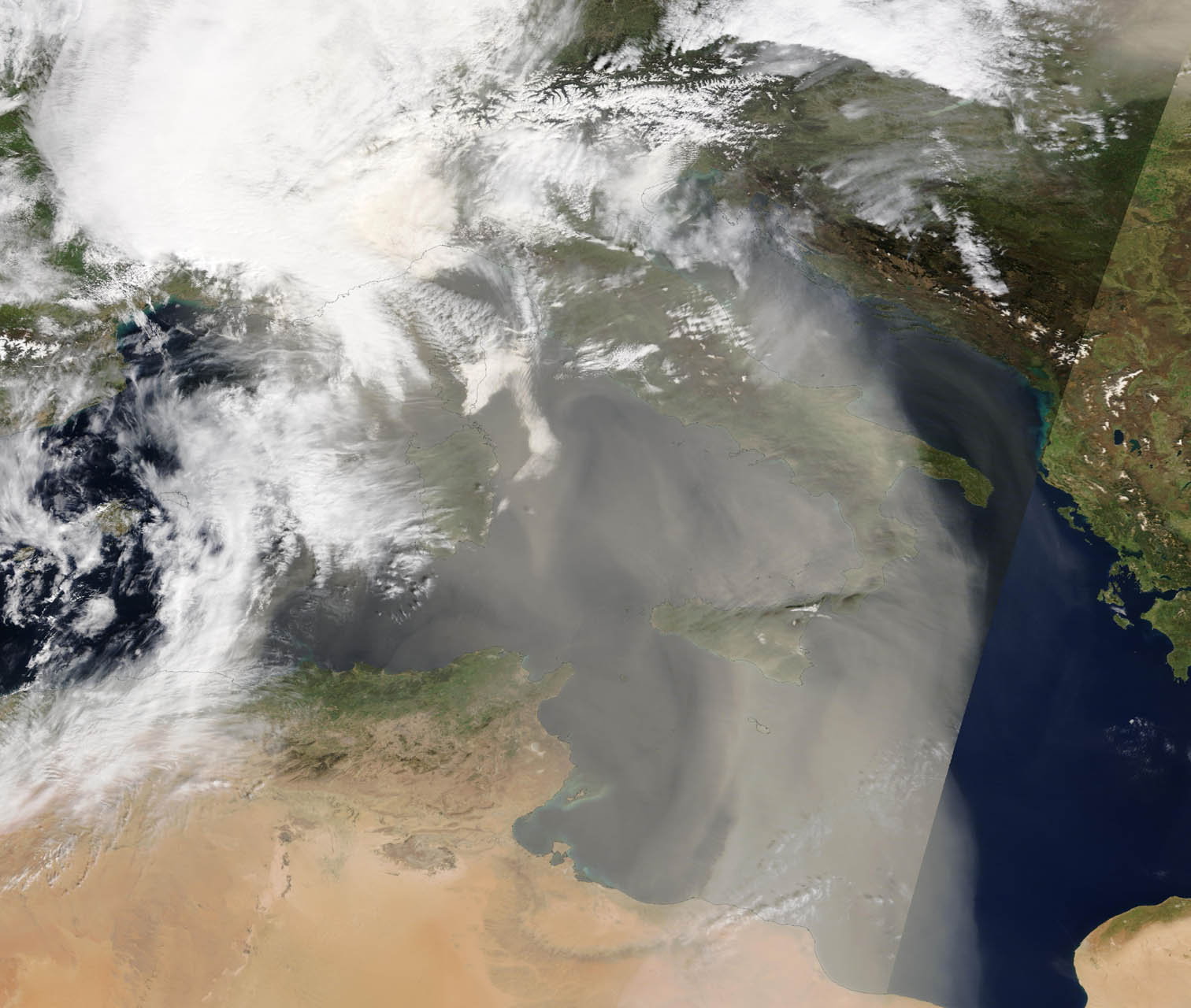
La
vasta nube di polvere in viaggio dall'entroterra desertico di Algeria,
Tunisia e Libia verso l'Italia, nell'immagine composita del satellite
NASA-Terra del 30 marzo 2024 (canale visibile).

31
marzo 2024: la marcata deposizione di polvere desertica sulla neve a
Prato Nevoso, Cuneo (f. Enrico Cavallo,
www.enricocavallo.com).

Nebbia
e neve dai toni giallognoli il 30 marzo 2024 alla stazione
meteorologica automatica dell'Istituto Angelo Mosso (2901 m, Monte
Rosa), fondato nel 1907 per lo studio del clima, dei ghiacciai e della
fisiologia umana ad alta quota
(f. Michele Freppaz).

Al
primo mattino di Pasqua (31 marzo 2024) i raggi solari si fanno strada
a fatica tra la nube di polvere sahariana che offusca il cielo di Roma
e di gran parte dell'Europa centro-meridionale (f. Filippo Thiery).
BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO TRA I PIU' BAGNATI AL NORD, RECORD SECOLARI A
MILANO E OROPA (BIELLA)
Al susseguirsi di marcati eventi di precipitazione tra
febbraio e marzo 2024 si è sviluppata una forte anomalia pluviometrica
positiva soprattutto al Nord-Ovest e sulle zone a Nord del Po, tanto
che sia i due singoli mesi, sia il bimestre nel suo insieme, sono
risultati tra i più bagnati in numerose località dotate di
lunghe serie storiche di misura.
Sull'Appennino Ligure e lungo la fascia prealpina
dall'alto Piemonte al Friuli-Venezia Giulia si sono registrati
totali febbraio-marzo di pioggia e neve fusa anche superiori a
800-1000 mm. Da Ovest a Est:
1198,2 mm a Urbe-Vara Superiore (Savona,
Arpa Liguria)
838,0 mm all'osservatorio
del Santuario di Oropa (Biella)
1020,6 mm a Valstrona-Sambughetto (Verbania,
Arpa Piemonte)
1065,6 a Seren del Grappa-Valpore (Belluno,
Arpa Veneto)
1064,2 a Piancavallo (Pordenone,
Arpa FVG)
1047,8 mm a Musi (Udine,
Arpa FVG)
Si tratta di apporti circa tripli o quadrupli rispetto alla media,
e l'anomalia è stata resa particolarmente evidente dal verificarsi di
precipitazioni così copiose in un periodo di norma tra i più secchi
dell'anno.
All'osservatorio di Oropa risulta il bimestre
febbraio-marzo più ricco di precipitazioni nella serie di dati
continua dal 1920 (4,1 volte la norma 1991-2020).
Record anche a Milano-Brera (Arpa
Lombardia) nella serie storica avviata nel 1764, tra le più
longeve d'Italia, con totale bimestrale di 416,2 mm (3,5 volte
la norma 1991-2020).
A Torino-centro (via della Consolata,
Arpa Piemonte)
il totale di 335,2 mm (3,7 volte la norma 1991-2020) è invece
il terzo più elevato dal 1802 dopo i casi del 1974 (367 mm) e 1972
(345 mm).
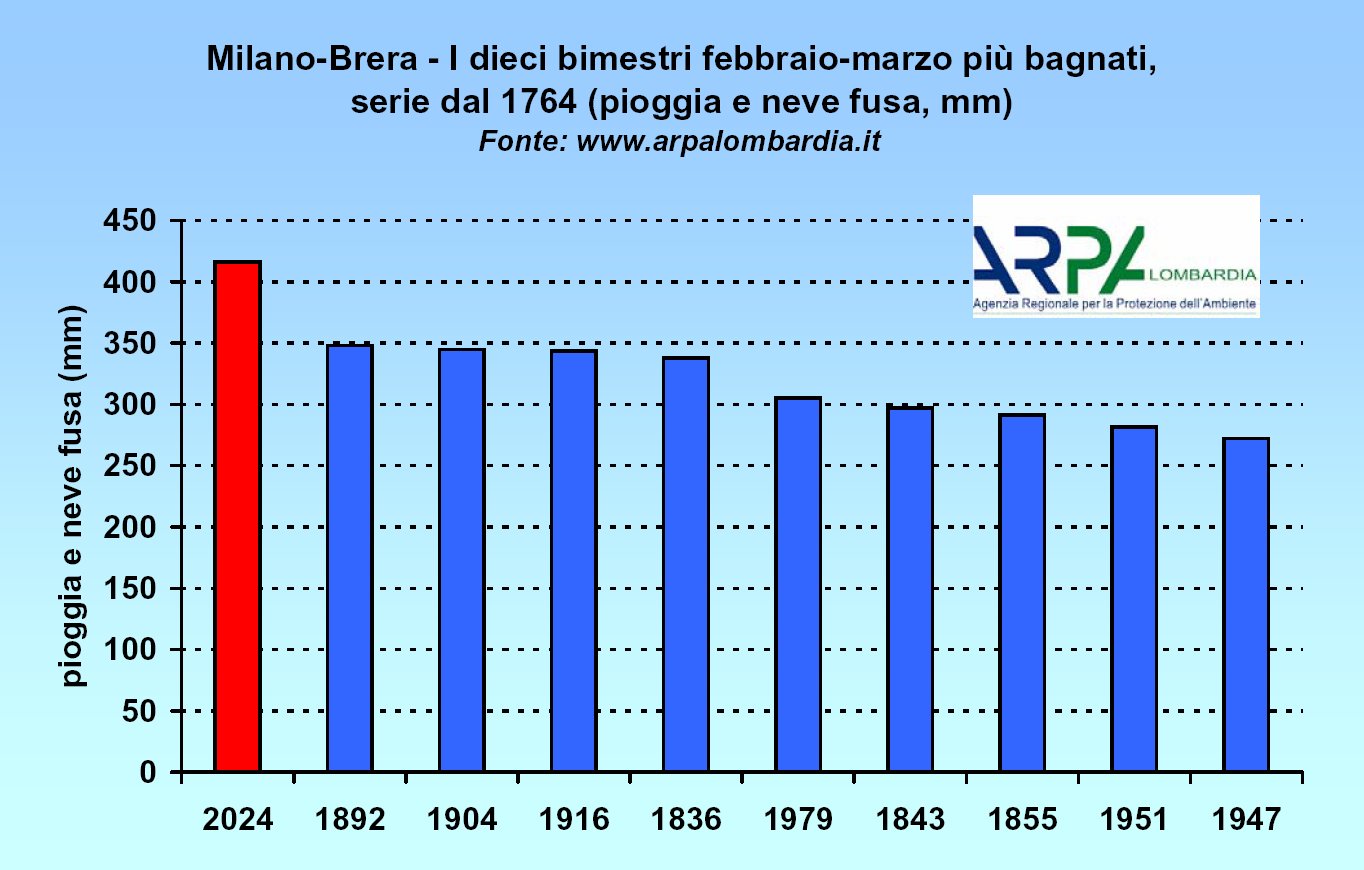
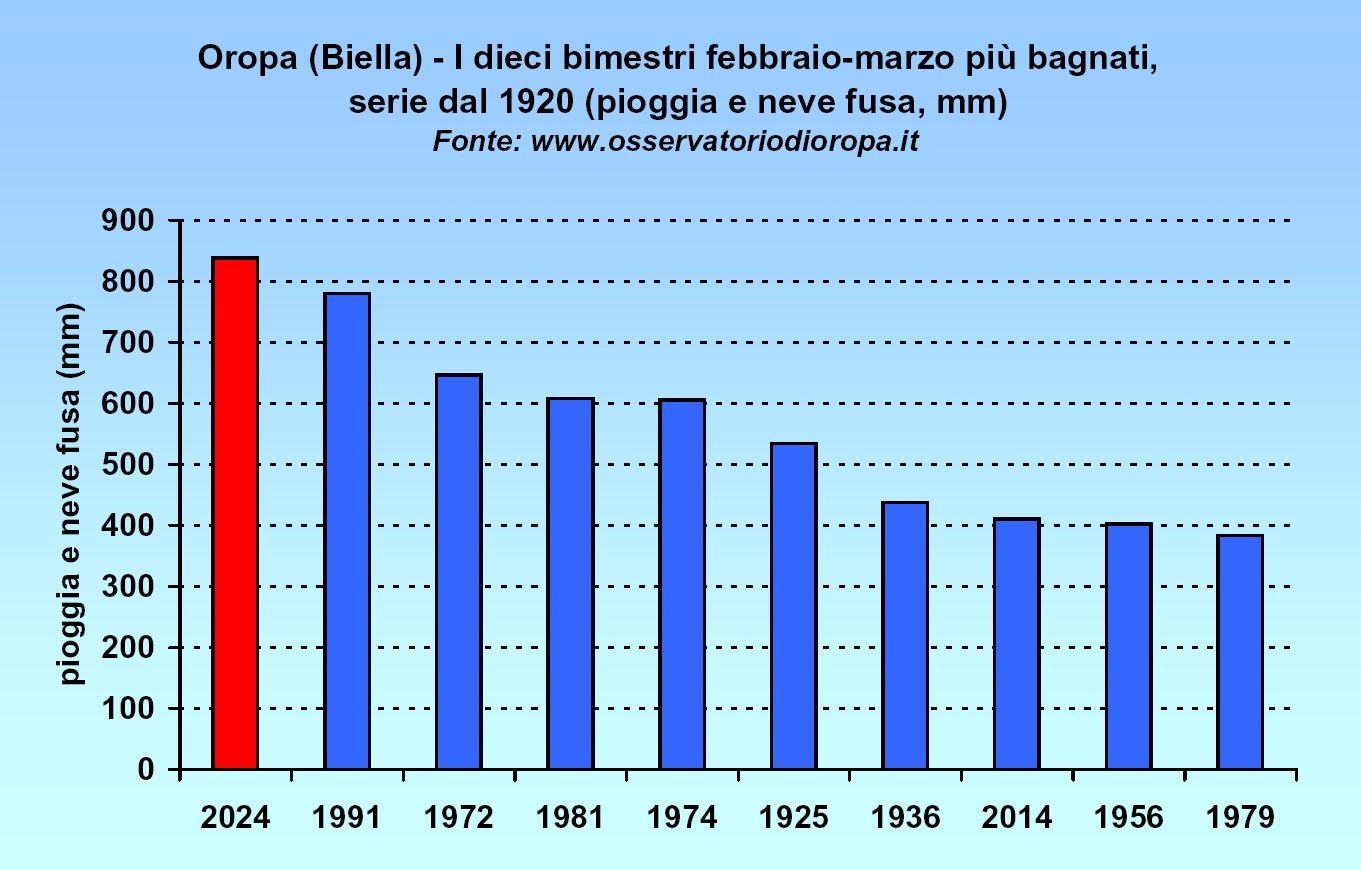

Santuario di Oropa (Biella), la torre dell'osservatorio
meteo-sismico istituito nel 1874 nel quadro della "Corrispondenza
Meteorologica Alpino-Appennina"
di padre F. Denza, con serie di dati pluviometrici completa dal 1920.
L'osservatorio è gestito dall'amministrazione del Santuario (don
Silvano Cuffolo), e dal 1988 vi si affianca anche una stazione Arpa
Piemonte.
Il 12 marzo 2024, in una brillante parentesi di foehn, restavano al
suolo 33 cm di neve dopo l'intensa perturbazione dei giorni 8-10 marzo
che - al limite tra precipitazioni liquide e solide - ha scaricato 147
mm di pioggia e neve fusa e 39 cm di neve fresca (f. Daniele Cat Berro).
L'intera stagione invernale 2023-2024 (novembre-marzo) ha totalizzato
94 cm di neve fresca, pari al 58% della norma 1991-2020. Dunque, a
questa quota di bassa montagna, un inverno povero di nevicate, che
nello straordinario recupero pluviometrico di fine stagione ha visto
la pioggia prevalere spesso sulla neve a causa dell'anomala mitezza.
Rapidi passaggi da un estremo di precipitazioni a quello opposto
(siccità -> eccesso, o viceversa) si sono verificati anche in passato,
ma sorprende la frequenza con cui questi eventi - di recente
denominati "whiplash" (colpi di frusta) in letteratura scientifica -
si stanno presentando (si pensi anche alle
alluvioni di maggio 2023 in Romagna, giunte dopo un anno e mezzo
di straordinario deficit idrico).
La frequenza, intensità e rapidità di queste transizioni è attesa
in aumento nel corso di questo secolo in risposta al
riscaldamento globale antropogenico, come proposto su Nature
Communication nel 2023 nell'articolo
"Increasing global precipitation whiplash due to anthropogenic
greenhouse gas emissions".
INVERNO 2023-24
ECCEZIONALMENTE MITE IN ITALIA
Il trimestre invernale dicembre 2023-febbraio 2024 si è
distinto per mitezza eccezionale in tutta Italia, ponendosi in
prima posizione per temperatura media elevata nella serie termometrica
nazionale CNR-ISAC
dal 1800 (anomalia +2,19 °C rispetto alla norma 1991-2020),
superando i precedenti primati degli inverni 2006-07 (ora passato al
2° posto) e 2019-20 (3°).
A conferma della significativa tendenza al riscaldamento atmosferico,
ormai tutti i dieci inverni italiani più caldi dal 1800 sono
concentrati dal 1990 in poi, mentre il più recente dei dieci più
freddi è il lontano inverno 1928-29, noto per il crudissimo febbraio.
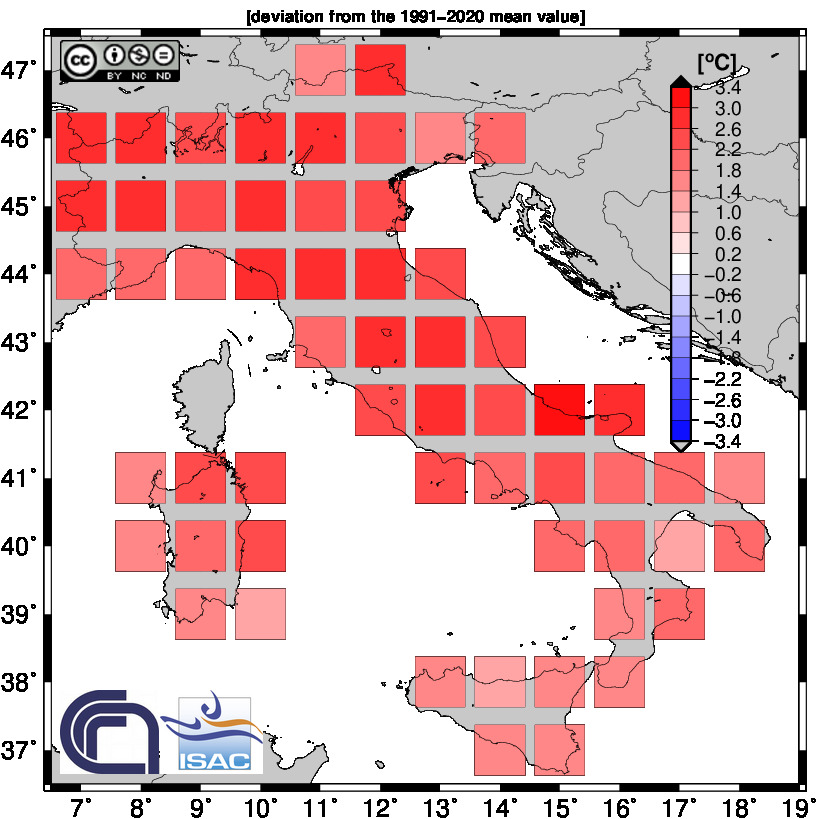
Carta
CNR-ISAC delle anomalie termiche nazionali, inverno 2023-24. Gli
scarti dalla norma 1991-2020 sono stati più accentuati al Nord (+2,46
°C) che al Centro (+2,25 °C) e al Sud (+2,01 °C).
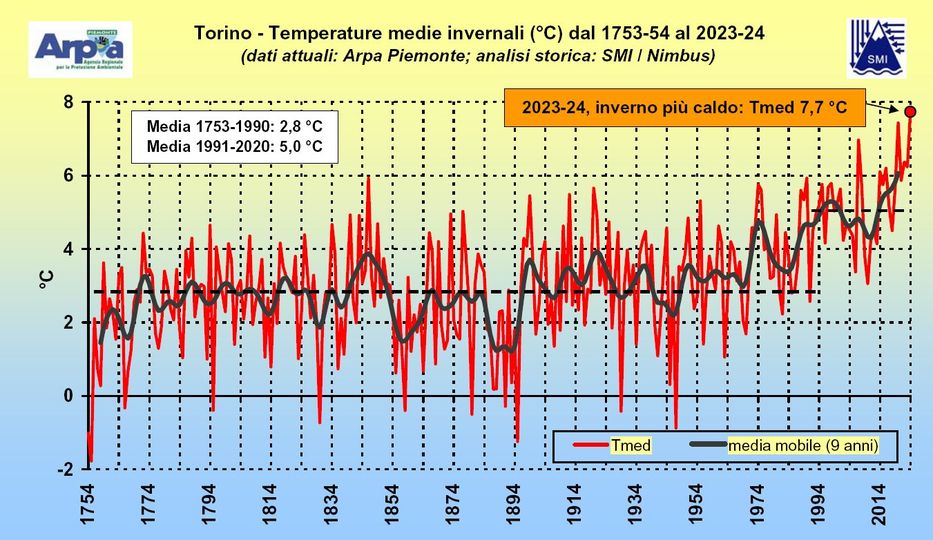
Torino-centro, serie delle temperature medie invernali dal 1753-54. Il
podio delle stagioni più calde è analogo a quello nazionale, con il
2023-24 in prima posizione (media 7,7 °C alla stazione di riferimento
di via della Consolata,
Arpa Piemonte,
ben 2,7 °C sopra la norma 1991-2020), e l'unica differenza risiede nel
fatto che la posizione del 2006-07 (qui secondo in classifica) e del
2019-20 (terzo) è invertita rispetto all'insieme del Paese.
Nonostante tra dicembre 2023 e gennaio 2024 le
inversioni termiche (con nebbie e ristagno di inquinanti nell'aria)
abbiano prodotto quasi quotidianamente gelate notturne su pianure e
fondovalle (salvo nelle isole di calore urbane), pochi sono stati i
giorni con temperature minime prossime o inferiori a -5 °C perfino
nelle zone extraurbane più fredde.
Inoltre su gran parte della Valpadana occidentale l'inverno è
trascorso completamente senza neve, come a Torino
e a Milano, e anche altrove in pianura gli apporti sono stati
minimi: pochi fiocchi con deposito non misurabile e Parma (per il
secondo inverno consecutivo, mai accaduto prima nella serie iniziata
nel 1878), appena 1 cm a Varese, Piacenza e Modena, nell'unico evento
del 4-5 dicembre 2023.
La situazione italiana si inquadra
in un più ampio contesto europeo e globale di anomalie termiche
eccezionali. In attesa dei dati di marzo 2024 che verranno resi noti a
breve, secondo il servizio di monitoraggio satellitare Copernicus
febbraio 2024 è stato il più caldo del mondo (anomalia termica
dell'atmosfera in superficie +0,81 °C), nono mese record
consecutivo!
Inoltre, nonostante l'attenuazione di El Niño, sempre in febbraio
le temperature medie oceaniche hanno raggiunto il valore in assoluto
più elevato mai registrato in qualunque mese dell'anno (media mensile
21,06 °C), battendo il primato di agosto 2023; per questo gli
scienziati Noaa temono che sia alle porte il peggior episodio di
sbiancamento delle barriere coralline, preludio al collasso di questi
santuari di biodiversità marina estremamente sensibili a incrementi di
temperatura anche di pochi decimi di grado.
Molto mite l'inverno boreale, record a scala emisferica e secondo
solo alla stagione 2019-20 in Europa, benché sia stato assai
freddo in Scandinavia.
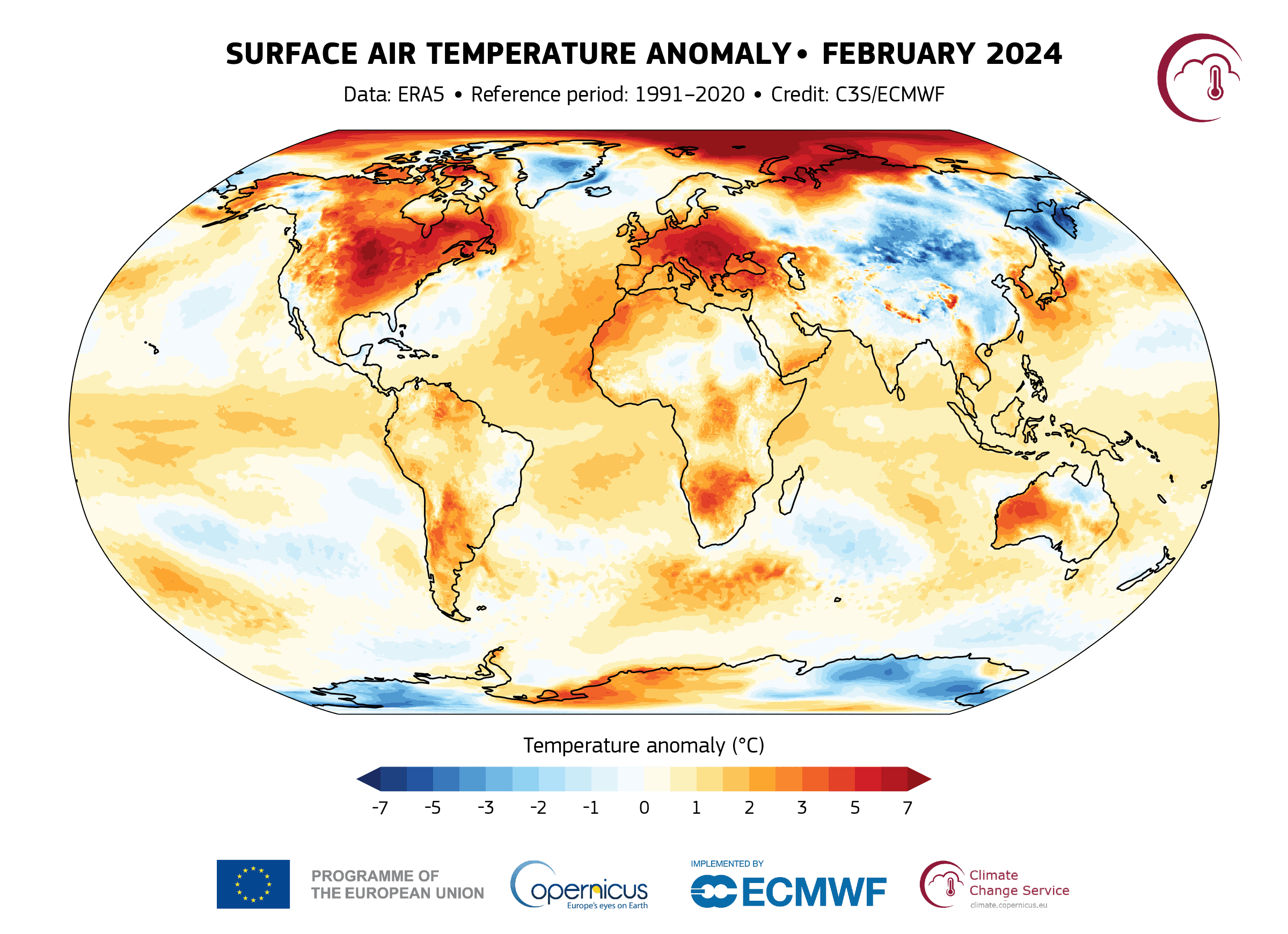
Anomalie termiche di febbraio 2024 nel mondo, rispetto alla norma
1991-2020. Spiccano in particolare le eccezionali deviazioni dal
normale superiori a +5 °C in Europa orientale, Stati Uniti centrali e
Artico
(fonte:
Copernicus - Climate Pulse).
COLMATO IL DEFICIT NAZIONALE DI RISORSA IDRICA NIVALE, MA CON FORTI
DIFFERENZE REGIONALI
Il 4 aprile 2024 la
Fondazione di
ricerca CIMA ha emesso il suo
ultimo bollettino sulla risorsa idrica nivale della stagione
2023-24.
L'analisi indica che le copiose precipitazioni di fine inverno e
inizio primavera hanno determinato un rapido recupero della
disponibilità idrica immagazzinata sotto forma di neve (SWE,
Snow Water Equivalent), con +1% a livello nazionale rispetto alla
mediana del periodo 2011-2022 (era -29% all'aggiornamento dell'8 marzo
2024), dunque una situazione complessivamente normale che non si era
più osservata da due anni.
Tuttavia si notano forti differenze a scala regionale: infatti, a
fronte di un esubero marcato nel bacino del Po (+29%) e
soprattutto in alta montagna, lungo gli Appennini e sui rilievi
delle isole l'innevamento a fine stagione continua a essere fortemente
deficitario (-80% nel bacino del Tevere, -87% in quello del Crati
in Calabria e in quello del Tirso in Sardegna), e a questo punto -
giunti ad aprile - non avrà più modo di risollevarsi.
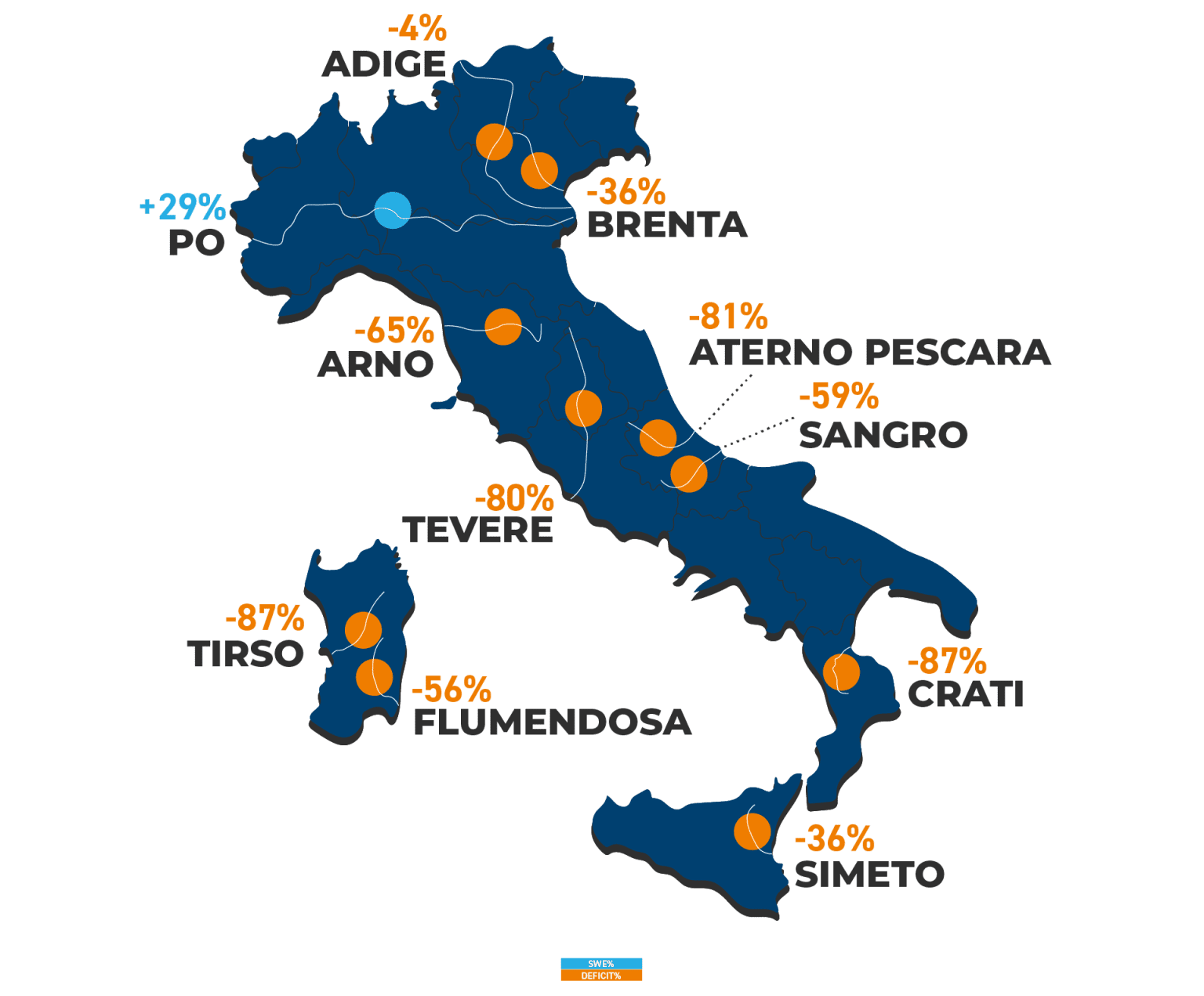
Carta della disponibilità idrica in forma nevosa a inizio aprile 2024,
rispetto alla mediana 2011-2022, in vari bacini fluviali d'Italia
(fonte:
Fondazione CIMA).
ARPA Piemonte, nel suo
report sulla risorsa idrica a fine marzo 2024, conferma
l'abbondanza idrica fuori dal comune, con lo Snow Water Equivalent nel
bacino del Po chiuso al Ponte della Becca (Pavia) ai massimi storici
per il periodo (circa 3750 milioni di m3), e la portata
media mensile del Po a Isola Sant'Antonio (Alessandria) ai livelli più
elevati per ciascun mese di marzo dall'installazione della stazione
idrometrica nel 1998 (1065 m3/s, quasi il triplo della
norma).
GRAZIE...
a tutti i soggetti che hanno condiviso dati,
informazioni e immagini con la redazione di Nimbus, e in particolare i
responsabili degli osservatori aderenti al neonato
gruppo ROSMI (Rete Osservatori Storici Meteorologici Italiani),
nonché a Matteo Zanetti di
Arpa Lombardia,
a Paolo Fantini (già responsabile dell'osservatorio di
Parma-Università) a Michele Brunetti del
CNR-ISAC di Bologna.
Devolvi il 5 per mille alla SMI!
Sosterrai
le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,
e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|